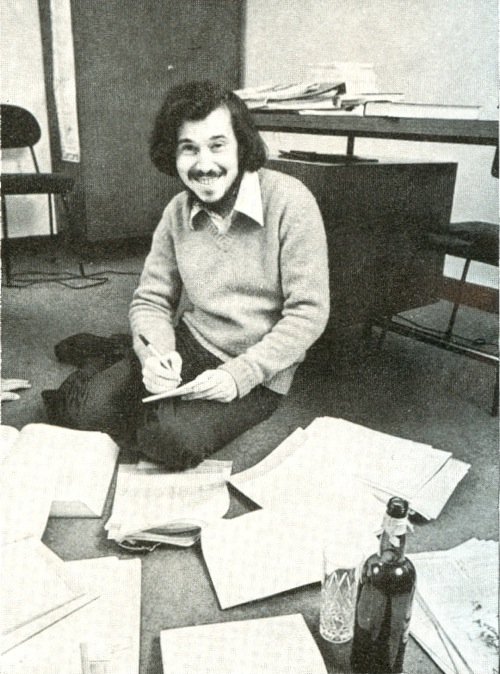
Furio Jesi durante la lavorazione dell’Enciclopedia Europea Garzanti, 1976
«È un brutto indizio che si regredisca ai feroci e cupi anni Settanta con un trattato di criminologia culturale.»
(Marcello Veneziani, commento alla riedizione 2011 di Cultura di destra di Furio Jesi)
–
«Furio Jesi, il germanista dottissimo ma completamente paranoico, i cui deliri godono ancora di gran credito a sinistra…»
(A. Scianca, “responsabile cultura di Casapound”, in una recensione a Un Grillo qualunque di Giuliano Santoro)
–
«Non conosco la biografia del personaggio, ma sono pronto a giurare che sia stato affetto da turbe psichiatriche serie.»
(Discussione su Furio Jesi dal forum neofascista Vivamafarka)
–
«Furio Jesi, l’intellettuale ebreo morto prematuramente a causa di una fuga di gas del suo scaldabagno…»
(Gianfranco De Turris, Elogio e difesa di Julius Evola)
–
[Quella che segue è una conversazione a tre voci su Furio Jesi (1941 – 1980), archeologo, filologo, studioso di mitologia e cultura tedesca, scrittore e militante della “nuova sinistra”. L’occasione è la recentissima uscita della monografia di Enrico Manera Furio Jesi. Mito, violenza, memoria (Carocci, 2012). Per molti giapster, Manera è una vecchia conoscenza: su Giap, a fine 2010, discutemmo della sua precedente uscita “jesiana”, ovvero il n. 31 della rivista Riga, curato da lui e da Marco Belpoliti, interamente dedicato allo studioso torinese. Numero che resta il miglior “punto d’ingresso” in un labirinto di pensiero e in un’elaborazione radicale purtroppo troncata da un banale incidente domestico. Il libro appena uscito vuole essere un “compagno di viaggio”, un vademecum da tenere accanto una volta deciso di intraprendere la lettura di Jesi.
La conversazione si svolge tra Manera, Wu Ming 1 e un’altra conoscenza dei giapster, Giuliano Santoro, recentemente criticato da un fascista per aver usato Jesi nel suo libro Un Grillo qualunque. Approfittiamo dell’occasione per aggiungere che le edizioni Nottetempo stanno per ripubblicare il testo di Jesi Il tempo della festa, a cura di Andrea Cavalletti. Buone letture.
P.S. Ricordiamo che in calce a ogni post di Giap ci sono due link: uno apre l’impaginazione ottimizzata per la stampa (o per il pdf), l’altro salva il post in formato ePub.]
–
Wu Ming 1
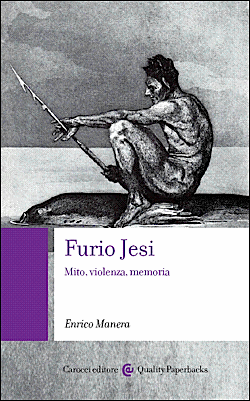 Jesi sembra essere l’unico intellettuale di sinistra del Novecento italiano che metta davvero a disagio il neofascismo (“classico” e postmoderno) e le destre più o meno «nuove» e «riciclanti». Nel calderone del loro discorso confusionista, queste ultime possono citare più o meno chiunque, da Pasolini a Rino Gaetano agli Area, da Guevara a Debord a chissà chi altro, ma di fronte a Jesi si fermano inquieti e sudaticci. A più di trent’anni dalla sua morte continuano a praticare esorcismi ingiuriandolo, dandogli del «paranoico», qualificando le sue riflessioni come «deliri», irridendolo e tirando in ballo in modo allusivo il suo essere di famiglia ebraica e le modalità della sua morte (un ebreo ucciso dal gas, che risate!), cercando in tutti i modi di tenerlo a distanza.
Jesi sembra essere l’unico intellettuale di sinistra del Novecento italiano che metta davvero a disagio il neofascismo (“classico” e postmoderno) e le destre più o meno «nuove» e «riciclanti». Nel calderone del loro discorso confusionista, queste ultime possono citare più o meno chiunque, da Pasolini a Rino Gaetano agli Area, da Guevara a Debord a chissà chi altro, ma di fronte a Jesi si fermano inquieti e sudaticci. A più di trent’anni dalla sua morte continuano a praticare esorcismi ingiuriandolo, dandogli del «paranoico», qualificando le sue riflessioni come «deliri», irridendolo e tirando in ballo in modo allusivo il suo essere di famiglia ebraica e le modalità della sua morte (un ebreo ucciso dal gas, che risate!), cercando in tutti i modi di tenerlo a distanza.
In effetti, pensiamo all’approccio di Jesi e alle conclusioni a cui giunge:
1. Non c’è Mito ma solo «materiali mitologici» variamente manipolati e «tecnicizzati» (cioè usati per scopi contingenti).
2. «L’origine» è un momento sempre inventato ex post e comunque poco significativo.
3. Sulle «idee senza parole» della destra – concetti dati in partenza per indicibili e indibattibili come Spirito, Patria, Italianità o Tradizione – non può fondarsi alcun pensiero critico (quindi, aggiungo, l’espressione «intellettuale di destra» è il più delle volte una contraddizione in termini).
4. Certi «pensatori» della tradizione di destra non meritano alcuna patente di «rispettabilità» culturale. Per esempio, Evola era in buona sostanza un rimasticatore da strapaese, uno che in Italia era tenuto in conto perché vendeva ai piccoli borghesi frustrati una versione casereccia e dozzinale di idee che altrove, pur discutibili, erano esposte con maggiore serietà (es. da parte di René Guénon). Qualche giorno fa, ho definito Evola “un mago Otelma con più pretese”.
5. Il continuo evocare l’Alto, l’Antico, il Puro, il Nobile è solo kitsch, affastellamento di cianfrusaglie per ottenere un effetto di «lusso spirituale».
Ebbene, niente di tutto questo è integrabile in alcun modo nel bric-à-brac di destra alla Casapound o chi altri. Non può proprio far parte dell’assemblaggio, della macchina mitologica fascista o fascistoide. Ciascuna di queste conclusioni sarebbe ossidante o corrosiva per le giunture e guarnizioni di quel precario marchingegno. Questo fa di Jesi «il più odiato dai fascisti». Lo abbiamo visto anche di recente, da parte di tale Scianca, che è indicato come «responsabile cultura di Casapound» (quindi è quello che mescola la minestrina). Recensendo sul «Secolo d’Italia» il libro di Giuliano Un Grillo qualunque – dove l’arsenale teorico di Jesi è utilizzato in modo intelligente e non scontato – costui non ha rinunciato a insultare il mitologo e germanista torinese, definendolo «completamente paranoico».
Enrico Manera
 La tua sintesi è pienamente corretta: riprendo la definizione di “cultura di destra” che Jesi diede nel 1979 a «L’espresso» in occasione dell’uscita di Cultura di destra, un libro che ebbe una certa notorietà. E’ la cultura in cui «il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare […] nel modo più utile, […] in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari», in cui «esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola». “Di destra” è ogni discorso che abbia forma assertiva indiscutibile, cioè autoritaria e quindi “mitica”: è soprattutto il linguaggio di «parole spiritualizzate» elaborato dalla destra tradizionale, fascista e neofascista, con le iniziali maiuscole (Tradizione, Razza, Patria, Famiglia, Sangue, Terra…) ma è anche il linguaggio del «sinistrese […] più dinamitardo» dei comunicati delle Brigate Rosse o la celebrazione del Risorgimento e della Resistenza quando si fa discorso basato sulla mistica del sacrificio e del martirio. Tutto questo sono le ‘idee senza parole’: retoriche del sublime, monumentali e celebrative che legittimano la sfera politica riferendosi al passato e imitando il linguaggio del sacro. Alludono e non spiegano nulla. Sono forme verbali dell’azione, gestuali e rituali per le quali in termini di filosofia del linguaggio Austin ha parlato di funzione perlocutiva, producono effetti pragmatici in chi le condivide.
La tua sintesi è pienamente corretta: riprendo la definizione di “cultura di destra” che Jesi diede nel 1979 a «L’espresso» in occasione dell’uscita di Cultura di destra, un libro che ebbe una certa notorietà. E’ la cultura in cui «il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare […] nel modo più utile, […] in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari», in cui «esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola». “Di destra” è ogni discorso che abbia forma assertiva indiscutibile, cioè autoritaria e quindi “mitica”: è soprattutto il linguaggio di «parole spiritualizzate» elaborato dalla destra tradizionale, fascista e neofascista, con le iniziali maiuscole (Tradizione, Razza, Patria, Famiglia, Sangue, Terra…) ma è anche il linguaggio del «sinistrese […] più dinamitardo» dei comunicati delle Brigate Rosse o la celebrazione del Risorgimento e della Resistenza quando si fa discorso basato sulla mistica del sacrificio e del martirio. Tutto questo sono le ‘idee senza parole’: retoriche del sublime, monumentali e celebrative che legittimano la sfera politica riferendosi al passato e imitando il linguaggio del sacro. Alludono e non spiegano nulla. Sono forme verbali dell’azione, gestuali e rituali per le quali in termini di filosofia del linguaggio Austin ha parlato di funzione perlocutiva, producono effetti pragmatici in chi le condivide.
Per Jesi, «la maggior parte del patrimonio culturale […] è residuo culturale di destra». La destra non è che l’estrema propaggine di un linguaggio aristocratico e alto-borghese che ha trovato la propria codificazione a partire dal tardo Settecento, nel momento in cui gli elementi delle culture nazionali sono emersi con forza e hanno elaborato una metafisica che trovava nel mito una voce dell’essere.
Di qui il mito dell’origine e il mito come qualcosa di originario. L’uso del “mito”, un uso metafisico del mito che serva a fondare uno stato di cose considerandolo “natura”, è ciò che fattivamente distingue il pensiero reazionario da quello emancipativo: se le parole “di sinistra” diventano “mitiche” smettono di essere emancipative.
Questo riguarda a sinistra, per farla molto veloce, tanto lo stalinismo, come mito totalitario del potere, quanto le magliette di Che Guevara, per dire una mitologia che ricicla simboli e luoghi comuni dell’immaginario di sinistra in modo kitsch e anche commerciale, quali che siano le buone intenzioni.
Un discorso molto simile è quello del romanziere rumeno, esule negli Stati Uniti, Norman Manea (Clown. Il dittatore e l’artista, 1992, ed. it. 1995 e 2005), che ha parlato di «mitologie comunitarie» che forniscono risposte facilitate per società in crisi. Fascismo, socialismo reale, fondamentalismo religioso, democrazie post-moderne, pur con gradi diversi di intensità e su contenuti di segno anche molto diverso, dal punto di vista della teoria della cultura operano allo stesso modo nel plasmare modelli cristallizzati di identità.
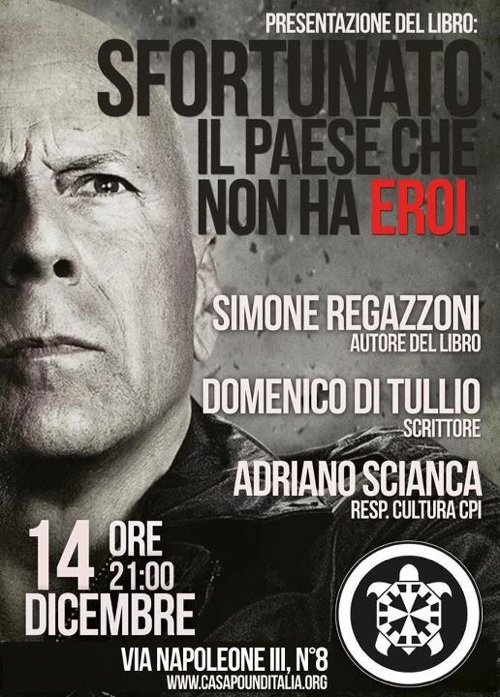
I fasci di Casapau, quando pensano a un Eroe, il primo esempio che gli viene in mente è Bruce Willis. Forse per il crapone pelato che ricorda Lui. Ma non erano contro l’americanismo? Forse gli va bene qualunque energumeno che faccia pum pum? (Purché bianco e occidentale, naturalmente)
Ogni mito politico, da Georges Sorel in poi, è dunque di destra e si rivolterà contro chi voglia cavalcarlo anche per fini di emancipazione: non si possono, dice Jesi a ogni rivoluzionario, muovere le forze inconsce del potere simbolico e poi sperare di controllarle razionalmente. Da questo punto di vista mi sembra che Jesi parli soprattutto ai suoi compagni di lotta, una Nuova sinistra libertaria e luxemburghiana, mettendoli in guardia da errori e fallimenti, come avviene con Spartakus (1967-1969) che è una riflessione sulla simbolica del potere, sulle ipoteche escatologiche della filosofia della storia marxista, ma anche una critica del mito sacrificale e suicida della rivolta.
Questa imposizione rende impossibile utilizzare Jesi a destra, perché il suo pensiero è quella di una sinistra post-strutturalista e post-metafisica, semiotica, antropologica e letteraria difficilmente maneggiabile. La forza teorica di Jesi è la sua profondità, mentre la cultura di destra italiana, soprattutto a causa del fascismo, è stata provinciale e priva di personalità intellettuali: il fatto che Jesi lo abbia espresso duramente è uno dei motivi del livore nei suoi confronti.
Mi colpisce come Veneziani o Scianca, leggibili nei recenti commenti a Cultura di destra,non abbiano argomenti che non siano vaghe insinuazioni: si parla sempre di «odio», «delirio» e «paranoia» e alla fine si ha l’impressione che non conoscano il discorso, non ne comprendano la portata o non sappiano come controbattere. Sono soprattutto risentiti perché Evola, che dovrebbe essere il loro Marcuse, viene smascherato come un divulgatore di cose altrui, ed Eliade, un grande studioso antimoderno e primitivista, viene inchiodato al suo fondale ideologico filofascista. Colpisce piuttosto che anche Cacciari abbia criticato duramente il libro, forse si sente chiamato in causa perché in passato leggeva Schmitt da sinistra poi è stato impegnato in uno schieramento moderato e post-ideologico.
Giuliano Santoro
Aggiungerei questo: il fatto che Furio Jesi venga scambiato per un “paranoico” dimostra che i fascisti non solo non possono utilizzare i suoi lavori, magari recuperandolo: non possono neppure capirli. I fascisti, si sa, non si trovano a loro agio con meccanismi concettuali che non costituiscano strutture rigide, schemi predeterminati o che non consistano in format (non uso a caso questa parola) culturali da applicare di volta in volta. Ci troviamo davanti a uno di quegli autori che ti costringono continuamente a sollevare lo sguardo dalla pagina, riassumere la questione e mettere a verifica il percorso mentale che hai compiuto fino a quel punto. Enrico spiega bene nel suo libro che ciò avviene perché negli scritti di Jesi la relazione tra il soggetto e l’oggetto di un discorso non solo non è negata, è continuamente messa in scena, dichiarata: i due poli di una questione (chi osserva e chi viene osservato) si influenzano costantemente. Non vorrei forzare troppo il nostro ragionamento, ma aggiungerei che questo stile, questa attitudine alla complessità, ci aiuta a evitare che si tracci una linea netta tra un “noi” e un “loro”, tra chi parla e chi viene parlato o semplicemente tra chi scrive e chi è destinato a leggere. Questa caratteristica della lezione di Furio Jesi è utilissima anche decifrare il linguaggio che ci bombarda ogni giorno.
Wu Ming 1
E’ verissimo che la destra, prima ancora di rigettarla, fraintende completamente l’impostazione di Jesi, e proprio per il motivo che dice Giuliano. Questo riverbera sul modo in cui i commentatori di destra leggono chiunque usi le sue intuizioni, i concetti che negli ultimi anni di vita (ma nessuno, men che meno lui poteva sapere che erano gli ultimi!) aveva iniziato a far lavorare.
Mi rifaccio ancora alla recensione di Un Grillo qualunque scritta da Scianca, non perché abbia qualche rilievo, ma proprio perché è tipica, del tutto conforme alle aspettative, quindi funziona bene come esempio. L’intellettuale «fascista del terzo millennio» rivolge a Giuliano un’accusa che suonerà bizzarra a chiunque abbia letto il libro: «per l’autore solo la destra si esprime attraverso frame, mentre si dà a intendere che la sinistra parli un linguaggio perfettamente trasparente a se stesso e consapevole».

George Lakoff
Innanzitutto segnalo, perché significativa, la totale incomprensione del concetto linguistico-cognitivo di frame, che in italiano si può tradurre con “cornice concettuale”, o “inquadratura concettuale”. Ogni essere umano dotato dell’uso del linguaggio si esprime “attraverso frame”, cioè quadri di riferimento, insiemi di immagini e relazioni tra concetti che strutturano il nostro pensiero, alcuni sin dalla primissima infanzia. Giuliano (come George Lakoff prima di lui) non stigmatizza affatto l’uso di frame da parte di Grillo o della destra: sarebbe come stigmatizzare l’uso della grammatica e della sintassi. Giuliano invita a riconoscere, decodificare e disinnescare l’uso strumentale («tecnicizzato», direbbe Jesi) e la diffusione di certi frame.
Nella comunicazione politica non c’è parola o frase che non inquadri un dato problema secondo la prospettiva ideologica di chi la usa. Ogni vocabolo porta con sé un mondo. Per esempio, imporre l’uso di “centrodestra” e “centrosinistra” al posto di “destra” e “sinistra” è stata un’operazione di framing che ha avuto conseguenze devastanti: a destra l’eufemismo è servito a legittimare soggetti lercissimi e fascisti nemmeno ripuliti; a sinistra ha imposto la credenza nella necessità di “spostarsi al centro” altrimenti… “non si vince”. Solo che, nella realtà concreta, il “centro” non esiste. Chi si dice “di centro” è in realtà di destra e fa cose di destra, vedi Casini, Monti, Montezemolo, adesso addirittura il postfascista Fini… E poi: chi “vince”? Per fare cosa? “Spostandosi al centro” non si fa altro che andare a destra (in cerca dei fantomatici “moderati”) e di certo non si faranno politiche di sinistra.
Un altro esempio è il discorso sulla “sicurezza”: se, come accade ogni giorno, un politico usa nella stessa frase le parole “sicurezza” e “immigrazione”, sta evocando nella mente di chi ascolta una comunità omogenea minacciata da una differenza proveniente dall’esterno, e questo è il quintessenziale framing di tutte le destre, in primis di quella fascista. Infatti (e non sono certo il primo a farlo notare), la distinzione primaria tra sinistra e destra è proprio questa:
– per la sinistra ogni società è costitutivamente divisa al proprio interno, perché ci sono interessi contrapposti e contraddizioni intrinseche. I conflitti principali avvengono lungo le linee di queste contraddizioni, che sono principalmente di classe e di genere, e derivano dai rapporti di proprietà (se ci sono i poveri è perché ci sono i ricchi), di produzione (gli sfruttatori non fanno gli interessi degli sfruttati), di “biopotere” (esistono dispositivi che favoriscono i maschi a scapito delle femmine) etc. Da questa premessa generale, che vale per tutta la sinistra, derivano numerose visioni macrostrategiche: socialdemocratica, comunista, anarchica… Tutte si basano sulla convinzione che la società sia in partenza divisa e diseguale e le cause della diseguaglianza siano endogene.
– per la destra, invece, la nostra società era un tempo armoniosa e concorde, ma oggi non lo è più per colpa di agenti esterni, intrusi, nemici che si sono infilati e confusi in mezzo a noi e ora vanno ri-isolati ed espulsi. A seconda dei momenti, corrispondono all’identikit il musulmano, l’ebreo, il negro, lo slavo, lo zingaro, il terrone, il comunista che tifa per potenze straniere, il “pervertito” (da dove saltano fuori tutti ‘sti froci? Una volta mica c’erano!), la “Casta” intesa come altro da noi, la finanza ridotta ai complotti di “speculatori stranieri”, “Roma” etc.
Non vi è dubbio che nell’Italia di oggi il discorso egemone, anche presso gente che si pensa e dichiara di sinistra, sia quello di destra.

Roger Scruton
Ovviamente, l’idea che una volta (quando?) la società fosse armoniosa è il non plus ultra del “mito tecnicizzato”, idealizzazione di un passato mai esistito, un passato che viene evocato allo scopo di prendersela col “diverso” di turno. Diverso perché arrivato dopo. Solo che tutti noi siamo “arrivati dopo”, perché il tempo del mito precede tutto.
[Qualche giorno fa, su Twitter, ho riassunto in questo modo il pensiero del filosofo tory Roger Scruton (in Italia lo ha molto citato e promosso Giuliano Ferrara dopo la svolta teo-con): «Quand’ero piccolo, postini e lattai fischiettavano per la strada, poi la sinistra ha distrutto quel mondo».]
Qui torna a bomba il discorso jesiano: Jesi non stigmatizza il ricorso a mitologie, perché tutti quanti vi ricorriamo ogni giorno, non potremmo comunicare senza condividere elementi di alcune narrazioni di fondo. Jesi invitava a riconoscere che non c’è Mito o Tradizione, ma un continuo riassemblaggio di materiali mitologici. La destra crede o finge che più in alto e prima di questo bricolage vi sia qualcos’altro, qualcosa di astorico e sovrumano, un significato eterno e ineffabile, diretta espressione dello Spirito. Per non dire di fantomatici caratteri innati nella stirpe che corrisponderebbero a valori trascendenti impossibili da definire. Sono le famose “idee senza parole” (Spengler), i “simboli riposanti in se stessi” (Bachofen).
Jesi anticipò il dibattito sulla «invenzione della tradizione», che alcuni storici anglosassoni avviarono pochissimi anni dopo la sua morte. Anche in quel caso, si provò che molti simboli ritenuti antichissimi, ancestrali (es. il tartan dei clan scozzesi e l’uso del kilt), erano invenzioni molto recenti, “tecnicizzazioni” funzionali a politiche nazionalistiche, come del resto la “celticità”. Tutto bricolage ottocentesco.

Uscite a destra dal leghismo: la Comunità Antagonista Padana. Il tizio nelle foto in bianco e nero è Augustin Cochin (1876-1916), storico ultrareazionario e complottista, autore di saggi contro la Rivoluzione Francese. In uno dei manifesti sul muro si legge: “Ancien Régime, un modello contro la modernità?” La foto è del 2009 e la prima volta che l’abbiamo vista abbiamo commentato: se non licenziano il grafico, non vanno da nessuna parte. All’Università Cattolica hanno intitolato un’aula a Robert Brasillach, scrittore francese collaborazionista coi nazi. Sul loro sito scrivono di essere “contro i pericoli immigrazionistici, il multiculturalismo estremo e il mescolazionismo religioso”. Si vantano anche della loro “ampia produzione cartellonistica, vera e propria offerta formativa muraria”. Un caso di pittoreschismo cialtroncellistico, senz’altro, ma il loro assemblaggio di materiali mitologici è tutto fuorché estraneo alla fase che attraversa l’Europa. Nel parlamento ungherese non si odono cazzatismi molto diversi, e c’è poco da ridere. Una versione ritenuta (non da noi) più “presentabile” di questi discorsi si ritrova nella produzione di Massimo Fini, che infatti la CAP cita con simpatia.
Detto ciò, quello che l’intellettuale di destra non riesce a capire, poveretto, è che Giuliano ricorre a Lakoff e Jesi per criticare innanzitutto la sinistra, le sue manchevolezze, il suo comunicare opaco, inconsapevole, ideologicamente subordinato. E’ colpa della sinistra – cioè nostra – se esistono fenomeni come il grillismo (o, appena ieri, il leghismo), come è sempre colpa della sinistra (dei suoi “residui culturali di destra”) se spadroneggiano narrazioni di destra. Questa è la premessa tanto delle riflessioni di un linguista cognitivista americano e liberal come Lakoff, quanto di un filologo sui generis europeo e marxista come Jesi. Sono riflessioni in larga parte autocritiche.
Enrico Manera
Dico qualcosa sul «grillismo»: ho seguito su Giap il dibattito e anch’io credo che ci sia una forte analogia tra le retoriche del grillismo e quelle del fascismo delle origini. L’uso della cassetta degli attrezzi jesiani da parte di Giuliano è pienamente condivisibile. Grillo è riuscito a mettere insieme una serie di parole magiche, che indubbiamente intercettano un disagio reale ma che diventano parole-bandiera, in questo caso producendo una visione tecnocratica del futuro con la rete al centro. Mix di «politica, spot pubblicitari e sentimenti» mi sembra una descrizione pienamente calzante. Ma questo futuro è semplicemente un’altra modalità del passato idealizzato e mai esistito usato dai fascisti.
Ne è una controprova l’uso autoritario della rete nel Movimento 5 Stelle, un tema su cui ad esempio il Partito Pirata è più avanti, con la discussione sul software e sulle modalità di partecipazione decisionale.
In ogni caso mi sembra che Grillo sia un esempio particolarmente evidente di dinamiche diffuse. La retorica contro la «casta», oramai insopportabile, è qualcosa di più del qualunquismo, è diventata una formula magica così come la «rottamazione»: slogan fortunati che diventano conoscenza presunta dei fatti da chi ne fa uso grazie alla loro circolazione pervasiva.
L’altro dato su cui vale la pena di riflettere è il personalismo, la componente carismatica e idolatra della mitologia, in base alla quale ogni idea tende a coincidere con un leader che non è mai il terminale di un meccanismo di rappresentanza, ma è invece un idolo, un busto, un monumento, un simbolo che deve avere qualcosa di vistoso, roboante e kitsch per funzionare.
Mi sembra che l’immaginario politico italiano sia malato di mitologia cattiva e sia imbonificabile: probabilmente il male peggiore che si possa imputare a Berlusconi è di aver stabilizzato con la sua discesa in campo questa situazione dettando gli standard e dando vita a un’escalation. E’ stato lui a iniziare, come dire, la pesca con le bombe a mano…
Giuliano Santoro

Gianluca Casseri, un bianco che ha fatto pum pum e che troppi fingono di non aver mai conosciuto. Nella foto, mostra orgoglioso la bandiera di Casapau.
Quando abbiamo cominciato questo dialogo, non era ancora successo che Beppe Grillo dichiarasse al candidato alla presidenza della Regione Lazio di CasaPound (e dunque allo scafato dirigente di quel partitino, non a un “ragazzotto”, come ha scritto qualcuno) che l’antifascismo non gli compete.
Successivamente, il CapoComico ha pensato di rettificare, fornendoci ulteriori elementi d’analisi: ha scritto sul suo blog che siccome «il tempo delle ideologie è finito”, allora il Movimento 5 Stelle non “è fascista”, tenendoci a ribadire che allo stesso tempo questo «non è né di destra né di sinistra”. Dunque, registriamo la difficoltà da parte di Grillo a definirsi “antifascista”: si dichiara semplicemente “non fascista” in quanto agnostico rispetto alla faccenda. Evidentemente, essere antifascisti implica che si riconosca una storia passata, un’eredità culturale, uno schieramento. Ma se ciò avvenisse, in qualche misura il passato smetterebbe di essere la «pappa omogeneizzata» da modellare a proprio uso e consumo di cui parlava prima Enrico citando l’intervista a Jesi del 1979, per costruire una narrazione «del tutto estranea a ogni dimensione concreta della storia» della quale si parla in Cultura di destra.
Qualcuno ha avuto l’efficace idea di mettere insieme alcune delle definizioni che il primo Mussolini dava del fascismo per scoprire che alcune assomigliano pericolosamente agli umori che ruotano attorno al grillismo e che questa somiglianza più che negli elementi programmatici si trova in questa esaltazione ingenua di elementi in fin dei conti irrazionali. Il fascismo, scrive ad esempio il futuro Duce sul Popolo d’Italia nell’ottobre del 1919, è «una mentalità speciale» fatta «di inquietudini, di insofferenze, di audacie, di misoneismi, anche avventurosi, che guarda poco al passato e si serve del presente come di una pedana di slancio verso l’avvenire».
Altrove, ragionando su analogie e differenze tra Grillo e il fascismo, ho fatto riferimento alla capacità di Grillo di parlare a persone spesso rimaste senza parole, ammutolite dall’orrore della precarietà e dalla negazione del futuro, incantandole con formule magiche. Sono parole, quelle di Grillo che, come avviene per il linguaggio pubblicitario e più in generale con quello televisivo, non hanno bisogno di essere considerate “vere”. Discutendo, de visu e on line, con molti seguaci di Grillo mi sono accorto che questo processo è andato più avanti di quanto noi – che pure in tempi non sospetti avevamo colto nel grillismo qualcosa di anomalo – immaginiamo. A conferma del fatto che la razionalità non è l’elemento centrale per spiegare questo fenomeno, mi sono accorto che la maggior parte dei miei interlocutori, pur essendo in perfetta buona fede, viveva le mie critiche al Movimento 5 Stelle con sofferenza e fastidio, come se stessi impicciandomi della loro intimità, come se parlando della relazione con il Capo stessi entrando nella loro sfera sentimentale ed emotiva. Come se fossi colpevole di un atto di violenza, impicciandomi in questioni che non mi competono.
Wu Ming 1
Sempre in tema di “cultura e spettacoli”: sia Lakoff sia Jesi, tra le altre cose, invitano a indagare la popular culture, perché è lì – nelle fiction televisive, nelle riviste di gossip etc. – che si afferma il «residuo culturale di destra» (Jesi) o si consolidano i «frame della narrazione conservatrice» (Lakoff). E pensa cosa avrebbe pensato dei social network! Appena mezz’ora fa ho visto su Rai Storia un’orribile intervista a quel deprecando personaggio che era Liala, una roba svenevole girata e trasmessa dalla Rai negli anni Settanta, super-concentrato di kitsch e “lusso spirituale” reazionario, e ho pensato che forse Jesi scrisse la parte di Cultura di destra dedicata a Liala dopo aver visto quell’intervista. Era davvero emetica. Ho anche pensato: Liala è stata la più abile e influente spacciatrice di cultura di destra nell’Italia del Novecento, e Jesi lo aveva intuito. Altro che Corradini, Bottai, Preziosi, Evola, Rauti, Freda, Romualdi… Quelli erano dei poveracci, al confronto. La giustapposizione di Evola e Liala può sembrare strana (e alla destra sembra blasfema), ma a me pare perfetta, Jesi ci vide davvero giusto affrontando entrambi nello stesso libro.
In quel libro, va ricordato, Jesi metteva anche in guardia da un giovane “marchesino dei bolidi”, cioè Luca Cordero di Montezemolo, e anche qui aveva visto giusto, perché poi quel tizio ce lo siamo sorbiti per trent’anni e ancora ce lo sorbiamo. Montezemolo è una specie di Lialo dell’industria e della politica.
Enrico Manera
 Parlando di Jesi, diversi insistono sulla sua natura ideologica e fanno di lui un vetero-marxista, ma questo è un equivoco, nella misura in cui Jesi è un post-marxista che riconosce l’inevitabilità di ogni posizione ideologica, in quanto situazionalità e postura esistenziale, a partire dalla propria. Dunque Jesi è prima di tutto uno studioso, un antropologo delle idee con una metodologia raffinata e articolata: c’è lo studio dell’ideologia come sfondo intellettuale comune a più ambiti della cultura di una società o di un’epoca ma anche la consapevolezza della propria visione ‘ideologica’ come insieme di interessi, bisogni e aspirazioni; consapevolezza di sé, come individuo e come appartenente a un vasto e articolato movimento politico, in contrasto con il gruppo sociale degli intellettuali accademici, per non dire di quello borghese di provenienza. Jesi considerava il suo lavoro come un continuo romanzo e una autobiografia ‘cifrata’ e lo ha fatto a mio avviso nei termini di un’«auto-socio-analisi» metasociologica, per usare le parole di Pierre Bourdieu, in cui il sé è un agente in azione nel campo dell’oggetto studiato.
Parlando di Jesi, diversi insistono sulla sua natura ideologica e fanno di lui un vetero-marxista, ma questo è un equivoco, nella misura in cui Jesi è un post-marxista che riconosce l’inevitabilità di ogni posizione ideologica, in quanto situazionalità e postura esistenziale, a partire dalla propria. Dunque Jesi è prima di tutto uno studioso, un antropologo delle idee con una metodologia raffinata e articolata: c’è lo studio dell’ideologia come sfondo intellettuale comune a più ambiti della cultura di una società o di un’epoca ma anche la consapevolezza della propria visione ‘ideologica’ come insieme di interessi, bisogni e aspirazioni; consapevolezza di sé, come individuo e come appartenente a un vasto e articolato movimento politico, in contrasto con il gruppo sociale degli intellettuali accademici, per non dire di quello borghese di provenienza. Jesi considerava il suo lavoro come un continuo romanzo e una autobiografia ‘cifrata’ e lo ha fatto a mio avviso nei termini di un’«auto-socio-analisi» metasociologica, per usare le parole di Pierre Bourdieu, in cui il sé è un agente in azione nel campo dell’oggetto studiato.
Dunque, è la coscienza vissuta della macchina mitologica come modello di conoscenza che rende ragione dei livelli, logicamente successivi, di ideologia e di tecnicizzazione. La teoria della macchina mitologica è un modello trascendentale e metodologico al tempo stesso. In altri termini, l”io’ servendosi di una macchina mitologica (i suoi processi mentali) produce una macchina mitologica-teoria (la macchina mitologica come modo di conoscere).
Con questa si possono conoscere le diverse macchine mitologiche (i processi mitopoietici) in atto nella storia della scienza del mito, della letteratura, della politica (la macchina mitologica come oggetto di conoscenza).
Nell’analisi delle varie forme della mitopoiesi il soggetto risale così a una teoria della ricezione e dell’uso che mentre spiega il suo oggetto descrive anche le sue modalità di pensare, conoscere e agire.
Per tornare alla “inservibilità” di Jesi se non in senso critico, un simile discorso implica più livelli di analisi, non è immediato né facilmente comprensibile; in più Jesi ha una scrittura a volte molto tortuosa, che testimonia il suo “corpo a corpo” con la teoria della macchina mitologica per tutti i primi anni settanta. Poi, dal 1975-1976 in poi i testi risplendono di una stato di grazia e di una scrittura felicemente risolta.
Per quanto riguarda la sinistra il problema non è stato tanto quello di perdere l’egemonia culturale lasciando agli altri la narrazione: intendo dire, questo è vero ma è più un problema nostro, è ciò che vediamo trent’anni dopo, negli anni Settanta i problemi riguardavano la modalità con cui erano condivisi e diffusi i miti del comunismo mainstreamo della socialdemocrazia, entrambi per Jesi residuo culturale di destra.
Nel 1978 su «l’Ora» di Palermo Jesi viene intervistato sulle ragioni della nuova edizione de Il tramonto dell’occidente di Spengler, un monumento della cultura reazionaria tradotto da Evola. Tra l’altro: Longanesi lo ha nuovamente riedito rimuovendo l’introduzione di Jesi e sostituendola con quella di Stefano Zecchi che si legge ancora oggi.
Alla domanda: «la cultura di destra è quindi la «palude squisita» nella quale, per eccellenza, prosperano i miti», Jesi risponde:
«La macchina mitologica funziona, là, molto bene, ma non meglio che in altre zone paludose – se la qualità palustre implica un giudizio politico-morale – come quelle della cultura di sinistra. La macchina mitologica funziona ovunque altrettanto bene e con il medesimo ritmo. […] La cosiddetta cultura di destra probabilmente si è meno autocensurata della cosiddetta cultura di sinistra per quanto riguarda i compiacimenti verso le proprie componenti mitologiche».
Per Jesi, professore ordinario non ancora quarantenne, proveniente da una famiglia colta e benestante, si trattava anche di una questione ‘privata’: criticare i «residui culturali» di destra era anche un modo per fare i conti con la propria provenienza borghese e con i suoi codici che intendeva rifiutare; Jesi era cresciuto nella cultura classica più raffinata, poi, com’è noto, aveva abbandonato la scuola per una formazione irregolare e da autodidatta all’estero, aveva lavorato nell’editoria e solo dopo, e per vie traverse, in università. E’ una storia di rottura con il mondo dei ‘padri’, negli anni sessanta, nei cruciali ’67 e ’68, fino al ’77 quando da docente sostiene le occupazioni delle università, anche personalmente nell’ateneo palermitano.
La sua produzione rientra in una controcultura militante. Escludendo le tecnicizzazioni più grossolane, il marxismo standard si è costruito dal punto di vista espistemologico come una dogmatica, irrigidendo i propri contenuti come una mitologia che si fa dogma. Le sue strutture logiche di fondo sono hegeliane, idealiste e sostanzialiste, e i suoi teorici sono sempre stati poco disposti a riconoscerlo come un sistema semiotico, immaginativo-concettuale di rappresentazione di massa.
Per quanto riguarda la cultura ‘popolare’ Jesi ha fatto proprio il discorso della critica francofortese all’industria culturale, in Italia del Gruppo 63 o di intellettuali come il già citato Fortini. Non c’è una teoria sviluppata ma una serie di intuizioni folgoranti. Leggendo un’intervista a Liala nel 1974 su «Grazia» si sofferma sul «”linguaggio che capiscono tutti”» e sulla lettera di una lettrice che parla di «parole come acqua sorgiva che lava tutto».
In Liala, in Cultura di destra, vede il linguaggio reificato della codificazione quotidiana, stereotipato e veicolato dai mezzi di comunicazione di massa come «feticcio che serve a dare il piacere che deriva dalla riduzione della fatica di pensare»; Liala è lo specchio di un pubblico «appartenente al proletariato o alla piccolo borghesia […] esposto all’urto contro il prossimo e contro le cose» a cui è offerta l’occasione di un «linguaggio degli affetti» normalmente negato.
Il suo linguaggio, dice Jesi, è «il linguaggio della vacanza organizzata, da chi ha il potere per chi non lo ha», è il linguaggio dell’alienazione in quel momento in cui si compie la «trasformazione antropologica» denunciata da Pasolini. C’è anche tenerezza quando immagina una lettrice che segue «con il dito» le parole su un libro di Liala, parole che fanno sognare un mondo diverso di riscatto attraverso un buon matrimonio, amore, lusso e avventura, denaro e prestigio. Il passaggio chiave è quello dell’architettura logica che unisce ‘lusso’ materiale e spirituale in una stessa forma mentis capace di cancellare la questione della giustizia sociale.
Quel linguaggio dell’intrattenimento e del disimpegno, che non deve essere capito ma solo ripetuto, ha la stessa funzione sociale che aveva la lettura di Rilke per l’alta borghesia, che non lo poteva capire ma lo venerava come simbolo di distinzione e cultura. In un passo molto divertente su Rilke, si prende gioco del cosiddetto «rilking», l’arte di citare Rilke nei salotti buoni per fare bella figura… Ancora una volta, l’uso lussuoso della cultura è un tratto di destra.
Jesi raccoglieva riviste e ritagli, era un lettore onnivoro, con grande senso dell’ironia; un sociologo della cultura capace di trarre spunto dai titoli dei giornali come da un necrologio (a casa sua, tra mille materiali di ‘lusso spirituale’ ho trovato quello di Badoglio!). Da torinese aveva una predilezione per irridere la «La Stampa», perbenista e liberalissima, di fatto un bollettino della Fiat negli anni caldi dello scontro sociale e della migrazione dal sud: è opportuno ricordare che Jesi era attento nella sua militanza a seguire il settore metalmeccanico, con cui aveva reali contatti.
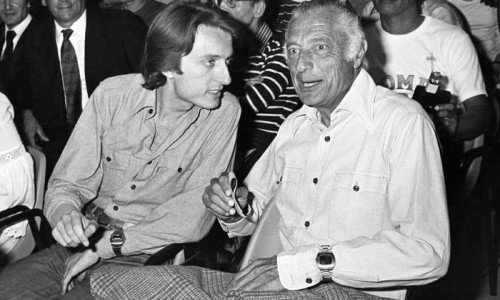
Il “marchesino dei bolidi” e il suo role model. Notare l’orologio sul polsino. “Incontro redentore tra lusso spirituale passé e lusso materiale attualissimo”. L’essenza del “lusso spirituale” si conserva sempre attuale “grazie al lusso materiale che circonda il grand’uomo profano ed essoterico”.
L’attualità di Jesi sta nell’aver colto il legame tra destra liberale e mercato, come nelle mitologie di Barthes, un libro del 1958 che diviene un modello per cogliere i ‘nuovi’ miti del consumo: molti, come De Luna o Agamben, sostengono la profeticità di Jesi nell’aver individuato la macchina mitologica del narcisismo di massa e dell’invidia sociale, caratteristiche della destra populista berlusconiana. In qualche modo davvero il Drive In era già un programma di governo, era chiaro ad esempio per un lettore-tipo di Cuore nel 1994 di fronte alla nascita di Forza Italia…
Ricordiamoci però che Jesi muore nel 1980: è l’Italia del dopo-Moro, del riflusso ideologico, della Marcia dei Quarantamila e della strage di Bologna. Gli osservatori più attenti avevano intuito il trionfo del pensiero economico, la cancellazione dall’immaginario collettivo di decenni di storia dell’emancipazione delle classi subalterne e la fine della coscienza di classe come visione del mondo capace di mutarlo. E Jesi non conosceva l’esplosione delle televisioni private, così come non scrive di cinema… Metodologicamente però, riflessioni analoghe sono state portate avanti dalla semiotica, pensa a Eco, non solo il semiologo e intellettuale pubblico ma anche lo scrittore. Ne La misteriosa fiamma della regina Loana…
Wu Ming 1
Pensa che io lo ritengo il suo romanzo migliore…
Enrico Manera
Beh, lì c’è un lavoro raffinatissimo di decostruzione della cultura di massa fascista: l’ideologia non era solo nei discorsi del duce o negli scritti della Scuola di mistica fascista e di Gentile, ma anche nel profluvio di biografie di Mussolini, romanzi di evasione, avventura, fumetti, letteratura di consumo. Un’analisi insomma ‘micrologica’ della cultura secondo l’indicazione di Benjamin, che su quella generazione ha avuto grande influenza e oggi gode di una buona fortuna.
Il Pendolo di Foucault poi è a mio avviso un libro che concentra molti temi tipici di Jesi, coestensivo alla critica ‘illuminista’ che Eco nelle lezioni di Interpretazione e sovrainterpretazione muove all’esoterismo e a certa ermeneutica ‘gnostica’, alla ricezione americana di Derrida, che si regge sull’effetto di segretezza e sull’aura di mitologicità.
Ma tornando all’attualità sono molti gli spunti per una critica dell’oggi. Se dovessi scegliere oggi un equivalente di Liala, anche in virtù del suo potenziale pedagogico ‘negativo’, e lo dico da insegnante di scuola superiore, sceglierei Federico Moccia che con il suo linguaggio semplificato ha stregato gli adolescenti e un contromondo fatto di moto, marche, scuola, palestra e discoteca. Nessuna fatica, identificazione immediata, costruzione di un immaginario perfetto per mantenere gli assetti di potere.
Oppure indicherei un nuovo uso lussuoso e ossequioso della cultura ‘a sinistra’ nelle interviste di Fabio Fazio, che contando su un livello medio televisivo spaventoso per pochezza porta in studio ospiti anche di un certo valore (non sempre). Del resto è diventata una vetrina promozionale eccezionale per l’industria del libro o cinematografica. Ma gli aspetti conflittuali e i problemi reali non emergono mai, non ci sono mai domande scomode e il pubblico di tifosi è pronto a applaudire per la battuta edificante di turno mentre il presentatore e l’ospite gongolano di fronte alla propria superiore distinzione e intelligenza.
Giuliano Santoro
Il fatto è che l’utilizzo di “miti tecnicizzati”, di “parole magiche” e il ricorso a “idee senza parole” è in qualche modo il metro di quanto siamo immersi dentro una crisi. Tutto questo ha a che fare con la profondità delle fratture che vanno aprendosi, degli smottamenti, l’incapacità delle logiche dominanti di spiegare quanto accade e di stabilire relazioni di causa ed effetto. La funzione del “mito” è quella di cercare di dare un senso al mutamento, di rendere accettabile l’ignoto, di spiegare come una situazione si sia trasformata in un’altra. In Cultura di destra Jesi cita le parole illuminanti della lettrice che scrive a Liala per dichiararle la sua ammirazione e per spiegare «parole come acqua sorgiva che lavano tutto», in relazione alla loro capacità di costruire un mondo. Da questo punto di vista, oggi si comprende bene quanto rischiamo di trovarci in mezzo a parole che hanno lo scopo di ridisegnare la realtà che ci circonda e offrire una sponda di fronte ai cambiamenti in cui siamo immersi.

Da cronista, per quanto anomalo, mi accorgo di come molti discorsi siano infarciti di “parole spiritualizzate”. Mi spiego meglio partendo da un esempio. Sono stato per anni un lettore appassionato di Cronaca Vera. È una pubblicazione costruita su più livelli. Da una parte strizza cinicamente l’occhio al lettore “consapevole”, dall’altra traffica con parole e immagini pensate apposta per rapire l’attenzione di decine di migliaia di lettori che ogni settimana vanno in edicola per comprare un giornale che non parla di televisione o di divi della musica e raccoglie unicamente storie – pruriginose, curiose o semplicemente cruente – di gente comune. Insomma, si tratta di una vera miniera di indicazioni sull’universo della maggioranza silenziosa, sulle parole che la affascinano e i codici che la ipnotizzano: i titoli urlati (“L’alieno stava resuscitando e così gli ho tagliato la testa”, un cult), gli occhielli schietti (tipo “Cervello in briciole”, con riferimento alle gesta di qualche squilibrato) e la media di quasi ventimila lettere ricevute all’anno (stiamo parlando di lettere di carta, con busta e francobollo, come usava una volta) .
In uno dei suoi ritrovati sprazzi di brillantezza, Michele Serra ha ricordato che uno dei titoli emblematici di Cronaca Vera è “Violentata sei ore dallo zio su un tappeto di gran pregio”. La notizia dello stupro viene infiocchettata per i lettori aggiungendo un elemento che solo all’apparenza non aggiunge nulla (il “tappeto di gran pregio”) ma che contribuisce a rendere il titolo più evocativo, a conferirgli un elemento di realismo, a disegnare un mondo. Addirittura, l’arredamento del salotto occupa la scena terribile descritta dal titolo: lo scandalo non consiste nell’orribile violenza sessuale, sta nel fatto che questa si sia consumata in una casa borghese. Su un tappeto di gran pregio.
I discorsi che ci circondano quotidianamente, le notizie che vengono selezionate dai mass media, le storie che leggiamo e i fatti che compongono il paesaggio comunicativo che attraversiamo sono pieni di trucchetti di questo tipo, magari meno grossolani ma altrettanto pericolosi. Corriamo continuamente il rischio di rimanere incantati e inciampare camminando sui tappeti di gran pregio. Jesi aveva colto benissimo questo rischio descrivendo la relazione e il passaggio dal “’tesoro’ dei miti antichi” al “moderno bene di consumo che dà prestigio”. Il suo lavoro di scavo nel linguaggio e nelle strutture logiche, si pensi al caso dei romanzetti rosa di Liala o alle citazioni del linguaggio pubblicitario, è arrivato fino al punto di dimostrare come la “macchina mitologica” sia all’opera quotidianamente e abbia tracimato il campo della cultura reazionaria classica per contaminare il linguaggio e la cultura di massa. Peraltro, pensarci bene, pare strano che si parli di “massa”. Ma è andata proprio così: la cultura elitaria della destra borghese e di certo esoterismo fascista, che faceva vanto del suo essere destinata a pochi eletti, ha avuto il destino di mutare forma e contagiare parole che esprimono il “lusso spirituale” e che lo diffondono collegandolo alla mistica del possesso dei beni di consumo, che non è il provocatorio “diritto al lusso” rivendicato dai movimenti contro l’austerità ma l’esaltazione feticistica degli oggetti, considerati tanto più preziosi quanto più inarrivabili.
Ma non si tratta soltanto di oggetti materiali: il “mito” in tempo di crisi prospera in virtù della sua capacità di costruire una parvenza di ordine della realtà e di spiegare quello che ci circonda. I concetti di Furio Jesi, le sue indicazioni utili a decostruire le “parole d’ordine” sono fondamentali per districarsi nell’info-sfera internettiana. Di fronte al fiume in piena di post, notifiche Facebook, tweet, breaking news e informazioni che travalicano in ogni modo la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, viene quasi spontaneo aggrapparsi a qualche ramo apparentemente solido, trovare il filo conduttore di un’immagine-meme capace di condensare il nostro stato d’animo e illuderci di ritrovare un qualche criterio. Ma l’ordine che andiamo cercando, con ogni evidenza, non c’è.
Infine, e mi ricollego a quello che dicevo all’inizio e a quanto sottolineate giustamente voi, l’efficacia di questo ragionamento sta proprio nel fatto che non esaurisce la sua funzione tracciando un confine invalicabile per la “cultura di destra”, ma al contrario riesce a metterci in guardia anche di fronte a certi tic retorici e schemi politico-culturali che riguardano la “sinistra” in senso lato. Ad esempio, la storiella di una società armoniosa, di cui parlava Wu Ming 1 prima, il cui ordine “naturale” è stato sconquassato da un qualche evento venuto dall’esterno è inconsapevolmente riprodotta in alcuni “miti tecnicizzati” che alcune volte circolano nel mondo ecologista: come se la fine dello sfruttamento (dell’uomo e della natura) fosse situata nel ristabilimento di un qualche equilibrio originario o, peggio ancora, nella difesa di una qualche “purezza”. O ancora, per fare un esempio di questi giorni, all’uso e all’abuso elettorale della parola passepartout “società civile”, che rimanda ad una sfera incantata fatta di civismo e competenze dal quale rimpinguare le forze esanimi della politica.
Wu Ming 1

Il filosofo Andrea Cavalletti, uno dei principali artefici della “Jesi Renaissance” a partire dalla fine degli anni Novanta.
Una domanda per Enrico: hai dedicato anni e sinapsi a ricostruire la biografia intellettuale di Jesi, in un corpo-a-corpo col suo pensiero, cercando di prolungarne la gittata fino a oggi, come si vede anche da questa conversazione. Un pensiero purtroppo interruptus e forse troncato “sul più bello”, ma che aveva fatto in tempo a seminare concetti e suggerimenti importanti. Questo tuo lavoro si è inserito in una sorta di piccola “Jesi renaissance” che era appena iniziata, grazie all’impegno di David Bidussa e Andrea Cavalletti. A quest’ultimo dobbiamo l’edizione di Spartakus, già alla fine degli anni Novanta. L’anno scorso, insieme a Belpoliti, hai curato un bellissimo numero monografico di “Riga”, che forse è il miglior punto d’ingresso a Jesi. Questo libro è un’operazione diversa, vuole essere una sorta di vademecum, di sintesi da avere accanto mentre ci si avventura nelle opere del mitologo torinese. Vorrei che ci raccontassi di questo tuo rapporto ormai “intimo” con questo concittadino, visto che anche in te la “torinesità”, un certo retaggio etico, politico e culturale, pulsa con forza. Quando hai sentito nominare Jesi per la prima volta? Come sei arrivato a conoscerne l’ormai anzianissima madre, e la vedova, e a consultare l’archivio? Cos’ha significato per te? E non ti senti ormai preso da una sorta di “Jesi fatigue”? Ti stiamo coinvolgendo in una conversazione che è l’ennesimo “tour de force”, qualche scrupolo di coscienza ce l’abbiamo…
Enrico Manera
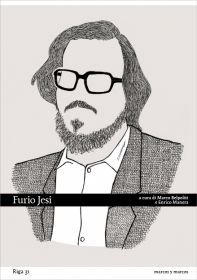
La copertina di Riga n. 31, interamente dedicato a Furio Jesi (ed. Marcos y Marcos)
Come per molti un interesse privato è diventato una tesi di dottorato e poi, forse questo è più raro, dei libri: ‘Riga’, curata insieme a un vero maestro come Marco Belpoliti, di cui sono molto felice perché è visivamente bellissima e per nulla accademica e ora questo, che si candida a essere un’introduzione e una prima sistemazione teorica complessiva. Jesi interessa gli ambiti della filologia più raffinata come quelli militanti più ragionanti: ‘Riga’ è stato presentata in luoghi e con pubblici differenti, dalla Biblioteca Ariostea di Ferrara al Bartleby di Bologna e ogni volta non si era fuori posto.
Sono entrato in contatto con quasi tutti quelli che hanno scritto su lui, con chi lo ha conosciuto personalmente e con chi lo ha scoperto anni dopo la sua scomparsa. Penso che sia un potente catalizzatore di intelligenze e mi colpisce, anche in diverse generazioni, l’affinità e la somiglianza dei percorsi in cui la dimensione politica, teorica e umana sono strettamente connesse. Tutti quelli che ho conosciuto hanno mondi intellettuali vastissimi, complessi e ramificati.
Effettivamente è da molto che lavoro sul tema e forse nasce tutto dal classico senso di inadeguatezza dello studente: nel 2000 avevo appena concluso un corso di specializzazione post-laurea, studiavo il dibattito sul mito e Hans Blumenberg in particolare. In Jesi mi ero già imbattuto, l’avevo trovato mostruosamente complesso e inarrivabile, l’avevo messo da parte come si fa con le cose belle e preziose, più belle di noi e che ci superano; la bellissima postfazione all’Accusa del sangue fatta da Bidussa mi ha aperto la possibilità di poterlo leggere e incominciare a padroneggiarlo e da lì in poi, ho sfruttato ogni possibile occasione di studio per lavorarci sopra fino al dottorato, fatto mentre già insegnavo, durante il quale non nascondo che ho passato anche giorni difficili, a sbattere contro un muro per poi scavarlo con un cucchiaino…
Detto questo in Jesi ho trovato un caleidoscopio di quello che mi interessa e che non puoi affrontare in una volta sola: l’antico, la mitologia, il sacro, la letteratura e la politica. È un’autore cerniera tra la cultura novecentesca di Mann, Kerényi e Cassirer e quella di Benjamin, Foucault e Derrida, e ci trovi dentro Rousseau, Pavese, Rilke, i vampiri, Pascal, la preistoria, la psicanalisi, lo strutturalismo, Spartaco, Mann, il nazismo, John Dee e Liala…
Man mano che mettevo insieme i pezzi cercando di costruire un quadro unitario mi sono accorto di stare anche scrivendo una pagina di storia della cultura italiana degli anni settanta e per di più di Torino.
Sono nato lo stesso anno in cui Jesi pubblicava il suo libro più importante, Mito, in un quartiere della stessa città, che è la città di di Gobetti, di Gramsci, di Primo e Carlo Levi, di una grande università e di importanti scuole filosofiche; ma anche della Fiat, di una grande militanza politica, delle migrazioni interne e poi internazionali e Jesi è stato un modo per ragionare di tutto questo.
Che nel mio lavoro si avverta questa tradizione è un meraviglioso complimento e un impegno che spero di non tradire. Se pensi che studio il mito seriamente dal 1998, è stato il mio modo di fare i conti con vecchie inquietudini religiose, interessi politici, l’essere studente prima e il lavoro di insegnante poi. Oltre che di leggere libri meravigliosi.
Il fattore umano è centrale comunque. In modo molto semplice ho contattato la famiglia Jesi. Grazie alla moglie Marta, che mi ha accolto con grande gentilezza e disponibilità, ho avuto accesso all’archivio domestico, sono stato diverse volte a casa sua con uno scanner ed è stata una esperienza molto intensa: ho voluto ricostruire una trama dei suoi lavori leggendo insieme opere, appunti, le sue letture e le sue lettere, incrociandole con testimonianze e interpretazioni. Ho cercato di essere il più delicato possibile nei confronti della memoria dolorosa di famiglia, in punta di piedi e ‘ritagliando’ solo quello che riguardava l’uomo pubblico.
La madre di Jesi invece vive a Torino ed è ultranovantenne, è stata un insegnante di arte nei licei di Torino e una studiosa. Sono arrivato a lei anche grazie un professore dell’Università che era stato suo allievo, ovviamente non senza essermi assicurato che le avrei fatto piacere. Da lei ho trovato scritti introvabili ma soprattutto un grande affetto per il lavoro che stavo facendo. Vado a trovarla portandole libri e articoli di giornale, dolci e foto di mia figlia e ascolto racconti di un mondo ormai lontano e di una vita densamente vissuta. Credo che il fine di ogni lavoro intellettuale sia incontrare persone e scambiare esperienze e penso che l’interpretazione sia una sorta di dialogo con i morti e un rituale di rammemorazione.
Sarebbe interessante studiare ancora l’epistolario di Jesi, detto questo non mi stanco di rileggerne i libri. Adesso lavoro a un libro sulla filosofia del mito del novecento, per seguire tracce aperte in questi anni, in ogni caso la mia vita privata e la scuola mi hanno evitato di farmi divorare dall’ossessione monotematica, un rischio serio. Per finire, come sai bene, un libro comincia a vivere se altri lo leggono e si ha la fortuna e il privilegio di poterne parlare.
Wu Ming 1
 Una prima “sistemazione teorica complessiva” mi sembra l’espressione perfetta per descrivere il tuo libro. Non “sistematizzazione”, impresa che con Jesi è impossibile e direi anche inauspicabile, ma sistemazione, anche nel senso di “dare una sistemata”, un riassetto, mettere un po’ d’ordine dentro scatoloni e faldoni che sembrano riempiti alla rinfusa, documenti in parte rovinati dall’umidità etc. “Riga” metteva già in fila parecchi frammenti, componendo un itinerario finalmente percorribile, arricchito da immagini e testimonianze esterne… compreso un mio bizzarro racconto ispirato a Spartakus :-) In fin dei conti, anche in quel numero di “Riga” si perseguiva la famosa, jesiana/benjaminiana “conoscenza per composizione”. Qui invece cerchi una sintesi, asciughi anni di lavoro e permetti di seguire i fili delle varie tematiche affrontate da Jesi.
Una prima “sistemazione teorica complessiva” mi sembra l’espressione perfetta per descrivere il tuo libro. Non “sistematizzazione”, impresa che con Jesi è impossibile e direi anche inauspicabile, ma sistemazione, anche nel senso di “dare una sistemata”, un riassetto, mettere un po’ d’ordine dentro scatoloni e faldoni che sembrano riempiti alla rinfusa, documenti in parte rovinati dall’umidità etc. “Riga” metteva già in fila parecchi frammenti, componendo un itinerario finalmente percorribile, arricchito da immagini e testimonianze esterne… compreso un mio bizzarro racconto ispirato a Spartakus :-) In fin dei conti, anche in quel numero di “Riga” si perseguiva la famosa, jesiana/benjaminiana “conoscenza per composizione”. Qui invece cerchi una sintesi, asciughi anni di lavoro e permetti di seguire i fili delle varie tematiche affrontate da Jesi.
In particolare, vorrei che ci parlassi del rapporto tra Jesi e la letteratura stricto sensu, perché leggendo il tuo libro lo vediamo chiaramente mutare il suo approccio: il Furio Jesi degli anni Settanta si occupa di letteratura con una “postura” diversa da quella del decennio precedente (quello pre-Spartakus, diciamo). Tagliando con l’accetta, e riprendendo quanto abbiamo detto poc’anzi, direi che si passa da Kerenyi al post-strutturalismo francese, dall’umanesimo a un approccio ironico, decostruttivo e ricombinante. Si passa da uno Jesi intento a cercare e interrogare nella letteratura sopravvivenze di mito che consentano “epifanie” e facciano esperire almeno in parte la dimensione “genuina” del mito, a uno Jesi che compie scorribande più libere nella tradizione letteraria, isolando certe figure ricorrenti, rintracciando i “discorsi” (nel senso foucaultiano) sul mito, smontando le ideologie veicolate, senza credere in una possibile “epifania”.
Correggimi se sbaglio: quando Jesi critica l’anelito al “lusso spirituale” come residuo culturale di destra, e come ricordavi irride la pratica di citare Rilke senza capirlo, tra le righe sta anche criticando il se stesso di qualche anno prima, quello Jesi ancora troppo “umanista”, ancora troppo influenzato dall’idea che nei “misteri” della letteratura (alta, naturalmente) risiedesse la potenziale esperienza di un mito ancora in parte “genuino”.
Non intendo dire che esiste una cesura netta tra i due Jesi, come Althusser quando separava in modo rigidissimo il “giovane Marx” (umanista e dialettico) dal Marx maturo (scientifico e senza grilli per la testa)… salvo poi ammettere, in tarda età, che di Marx sapeva poco o niente e aveva millantato letture e conoscenza tanto del giovane quanto del vecchio. Il confine è sfumato: già lo Jesi degli anni Sessanta era arrivato ad alcune conclusioni quando criticò Kerenyi (il famoso diverbio sulla parola “mascheratura”). Ma sicuramente c’è un momento in cui Jesi scopre Foucault, il primo Derrida e altri francesi, e questa scoperta si innesta su una base marxista e sulla precedente conoscenza di Benjamin (anch’egli un marxista sui generis), permettendogli di superare alcune aporie del suo pensiero precedente. Soprattutto, gli consente di “guardarsi da fuori”: il mitologo che si credeva già sufficientemente disincantato si scopre parte della “macchina mitologica” che sta criticando, e allora cerca strategie testuali (e un’etica della lettura) che gli permettano di descriverla senza farsi irretire.
Tu sicuramente puoi dirlo in un modo meno confuso: che cos’è la letteratura per lo Jesi “decostruttivo” degli anni Settanta?
Enrico Manera
Con Belpoliti e Paola Lenarduzzi, che ha curato la grafica di ‘Riga’, l’idea è stata quella di ricreare un tavolo di lavoro da cui emergesse per frammenti, testi, foto, ritagli e appunti, l’officina di montaggio di Jesi, che operava praticamente in epoca pre-computer mettendo insieme citazioni dai libri che schedava e che rimontava con la macchina da scrivere. Questo è un aspetto fondamentale di Jesi, che fa coincidere la pratica della scrittura con la teoria della letteratura: mette in pratica le sue convinzioni sulla ricombinazione e sulla reazione reciproca tra testi anche molto diversi: per chi scrive, questi convivono in modo anacronico, a dispetto della differenza.
Questo libro invece nasce anche da una precisa richiesta dell’editore di scrivere una ‘Introduzione a’, una pratica pedagogica nobile per come la vedo io, che permette l’accesso ai più giovani e ai meno attrezzati, utile per autori che chiedono requisiti di ingresso molto alti. Inoltre mi piaceva l’idea di un libretto come le monografie del Castoro-La Nuova Italia degli anni settanta, lo stesso Jesi ne aveva fatte su Rilke, Mann, Brecht. Sono libretti che trovi ancora sulle bancarelle o nelle biblioteche scolastiche, perle dimenticate.
Quindi ho cercato di semplificare la sintassi e ridurre allo stretto indispensabile gli elementi di informazione, rinunciando alle molte citazioni della tesi di dottorato (oltre 1700 in 300 pagine) e cercando la chiarezza: non si rende un buon servizio a un autore se ne si mima lo stile, si tratta di riconoscere la sua voce e di raccontarla parafransandola. Ho riservato gli aspetti più spericolati della mia tesi al blog Tracciatore di cerchi o agli angoli oscuri del mio hard-disc, in attesa di capire cosa volessi dire quando ho scritto certi passaggi…
Hai colto comunque perfettamente: Jesi cresce nel mito del genio creatore di Rilke, venera Pettazzoni, Kerényi, Jung, Mann come grandi maestri, sogna di essere studioso, scrittore e poeta. Ho avuto tra le mani una sua copia delle Lettere di un giovane poeta, fittamente glossata e sottolineata con molta probabilità nel 1958 e ho visto molta della sua produzione lirica e delle prove generali di romanzo che lui stesso censurò. In parallelo ha una concezione della storia delle religioni con una forte base metafisica; poi Jesi si avvicina allo strutturalismo alla semiologia e alla teoria critica della cultura, abbandona l’umanesimo, perché coinvolto con il sostanzialismo conservatore e ‘fascista’ della teoria mitologica che pensa il mito come un’essenza che si manifesta nella realtà, di cui Eliade può essere considerato l’esponente tipico.
Ma l’esito maturo di Jesi, tristemente l’ultimo, è una scrittura folgorante che, oltre a essere legata al suo ruolo di docente di Lingua e letteratura tedesca è anche una meta-riflessione sulla letteratura, e non è un caso che la letteratura di Jesi sia il tema attorno a cui si muove la sua ricezione più recente : ‘Riga’, Cavalletti, ma anche Riccardo Ferrari ( «Nuova Corrente» 143, 2009) e Carlo Tenuta («Intersezioni» 3, 2010).
Schematicamente: per Jesi la mitologia nasce nel sacro, sopravvive nel politico e si trasfigura in letteratura. Una volta che dispone di uno strumento epistemologico come la teoria della ‘macchina mitologica’ riesce a liberarsi delle aporie precedenti, come la diade genuino/tecnicizzato. La macchina mitologica produce il fatto mitologico, «concentra in un sol punto, extra temporale, extraspaziale, le luci che provengono dal passato e dal futuro», scrive Jesi ne L’accusa del sangue. Ovvero, decostruito, neutralizzato e messo a distanza il mito-sacro e il mito-politica, questa sospensione della temporalità o anacronìa, la capacità di giocare tra i diversi strati del tempo, è lo specifico della produzione di immaginario e di ogni narrazione, del raccontare storie.
C’è in Jesi coincidenza tra saggistica, critica e narrativa e la lisi della distinzione tra filosofia e letteratura: in una introduzione inedita a Materiali mitologici scrive che il suo lavoro è di «natura paradossale, scientifica e artistica» e che alla domanda «Non le viene voglia di scrivere un romanzo?» «può solo rispondere: non smetto mai di scriverlo».
Condivido la felice definizione che Belpoliti ha dato di Jesi come «straordinario scrittore di idee e problemi», «con una forte componente di «invenzione».
Ogni scrivere riflette la propria soggettività, che non è mai isolamento, parla simultaneamente degli oggetti ‘altri’ della propria ricerca e di sé. Da qui la serendipità che caratterizza Jesi, e la sua ironia, l’approccio parodistico alla tradizione come Il linguaggio delle pietre, La casa incantata o L’ultima notte. Letteratura come pratica sovversiva linguistico-letteraria che mostri le contraddizioni del presente e come scrive Barthes «utopia del linguaggio» che apre mondi nuovi.
La mitologia-letteratura continua ad avere valore collettivo e istituivo di comunità e affinché non diventi oggetto di una nuova idolatria è opportuno che sia alleggerita, nel senso – questo tema caro a Wu Ming è venuto fuori negli incontri che abbiamo fatto assieme – che deve essere umanizzata: ogni racconto dal respiro epico deve mostrare i segni del lavoro dell’autore, attraverso il montaggio e la citazione, essere un mito umanizzato.
Il racconto, ha scritto Lacoue-Labarthe, viene dal luogo in cui appaiono i fenomeni alla coscienza: praticarlo significa fare un «funambolismo metafisico senza parapetto metafisico», «esperienza metafisica svuotata, pura esposizione al nulla». Questo retroterra anti-metafisico, derridiano, libero dalle ipoteche idealiste, è alla base della coincidenza tra mitologia e letteratura.
Nei Materiali mitologiciemerge a più riprese come la letteratura sia il prodotto della mitopoiesi, attività essenzialmente linguistica che sorge spontaneamente dal modo umano di pensare, di concepire la realtà, di costruirla e condividerla. I libri sono i miti incarnati, vivono nei libri. Calvino, con analoga sensibilità post-strutturalista, scrive che ognuno «è una combinazione d’esperienze, d’informazioni, di letture e di immaginazioni»: «ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili». In altri termini, ognuno è una macchina mitologica.
Giuliano Santoro
 Se tocca a me concludere, vorrei farlo citando un film. Quando Enrico spiegava che per Jesi la cultura di destra è di fatto ancora egemone e che questa ripropone, in un altro contesto il “linguaggio aristocratico e alto-borghese che ha trovato la propria codificazione a partire dal tardo Settecento”, a me è venuto in mente Gosford Park, il film di Robert Altman del 2001. Nel contesto del declino dell’impero britannico, negli anni Trenta del Novecento, un gruppo di aristocratici si incontra in una grande villa della campagna inglese. Ogni aristocratico ha il suo doppio costituito dal suo valletto o dalla sua cameriera. I servi, secondo gli usi dei padroni di casa, nei giorni di permanenza nella villa assumono, con imbarazzo e senso di inadeguatezza, il cognome del loro superiore. Ogni personaggio, dunque, si muove ai piani alti, mentre il suo doppio di basso lignaggio familiarizza con gli altri suoi simili: i lavoratori. Questi ultimi, tuttavia, non trovano le loro parole: parlano quasi esclusivamente dei loro padroni, agiscono come se fossero loro agenti nei bassifondi, scambiano informazioni coi loro parigrado agendo per rendere la loro villeggiatura il più confortevole possibile. Un meccanismo perfetto, parrebbe: in cucina o nel lavatoio risuonano le parole e i ritmi scanditi dai ricchi in sala da pranzo o durante la battuta di caccia. Questo ingranaggio, una messa in scena corale e claustrofobica che coinvolge ventisei attori e che viene gestita magistralmente da Altman, viene inceppato da due eventi: dall’omicidio del padrone di casa ad opera di un figlio non riconosciuto e una madre abbandonata e dal corto circuito operato da un attore venuto dall’America che, spacciatosi servo per studiare una parte, attraversa i piani nobili e quelli servili mettendoli in relazione e svelandone le finzioni e le inutili consuetudini. Gli elementi deflagranti, insomma, sono due: l’irruzione della storia, quella vera, che fa precipitare le contraddizioni e le colpe sull’aristocratico e l’entrata in scena di un artista, un uomo che ha il solo scopo di raccontare quel mondo per metterlo a nudo. Mi pare che questo possa esprimere due delle principali attitudini di Furio Jesi: la storia e la narrazione. Il suo essere filologo, archeologo dei saperi e delle strutture di potere e la sua attenzione ai meccanismi narrativi e letterari.
Se tocca a me concludere, vorrei farlo citando un film. Quando Enrico spiegava che per Jesi la cultura di destra è di fatto ancora egemone e che questa ripropone, in un altro contesto il “linguaggio aristocratico e alto-borghese che ha trovato la propria codificazione a partire dal tardo Settecento”, a me è venuto in mente Gosford Park, il film di Robert Altman del 2001. Nel contesto del declino dell’impero britannico, negli anni Trenta del Novecento, un gruppo di aristocratici si incontra in una grande villa della campagna inglese. Ogni aristocratico ha il suo doppio costituito dal suo valletto o dalla sua cameriera. I servi, secondo gli usi dei padroni di casa, nei giorni di permanenza nella villa assumono, con imbarazzo e senso di inadeguatezza, il cognome del loro superiore. Ogni personaggio, dunque, si muove ai piani alti, mentre il suo doppio di basso lignaggio familiarizza con gli altri suoi simili: i lavoratori. Questi ultimi, tuttavia, non trovano le loro parole: parlano quasi esclusivamente dei loro padroni, agiscono come se fossero loro agenti nei bassifondi, scambiano informazioni coi loro parigrado agendo per rendere la loro villeggiatura il più confortevole possibile. Un meccanismo perfetto, parrebbe: in cucina o nel lavatoio risuonano le parole e i ritmi scanditi dai ricchi in sala da pranzo o durante la battuta di caccia. Questo ingranaggio, una messa in scena corale e claustrofobica che coinvolge ventisei attori e che viene gestita magistralmente da Altman, viene inceppato da due eventi: dall’omicidio del padrone di casa ad opera di un figlio non riconosciuto e una madre abbandonata e dal corto circuito operato da un attore venuto dall’America che, spacciatosi servo per studiare una parte, attraversa i piani nobili e quelli servili mettendoli in relazione e svelandone le finzioni e le inutili consuetudini. Gli elementi deflagranti, insomma, sono due: l’irruzione della storia, quella vera, che fa precipitare le contraddizioni e le colpe sull’aristocratico e l’entrata in scena di un artista, un uomo che ha il solo scopo di raccontare quel mondo per metterlo a nudo. Mi pare che questo possa esprimere due delle principali attitudini di Furio Jesi: la storia e la narrazione. Il suo essere filologo, archeologo dei saperi e delle strutture di potere e la sua attenzione ai meccanismi narrativi e letterari.
***
Furio Jesi, “Sul mito di Europa”, in L’uomo europeo, vol. 8, 1978, di Folco Quilici. In questo raro documento video Jesi compare in qualità di esperto all’interno di un documentario sull’identità europea, nei primi minuti del film. Ne L‘Uomo europeo (1976/1980) Quilici si è avvalso della collaborazione di Fernand Braudel, Claude Lévi Strauss, André Leroi-Gourhan, oltre che di Jesi. L’immagine è poco definita e irreale: lo studioso cammina… (La scheda a cura di Enrico Manera prosegue in calce al video su YouTube)
LINKOGRAFIA RAGIONATA
MACCHINE MITOLOGICHE E CULTURA DI DESTRA: IL RITORNO DI FURIO JESI
MACCHINE MITOLOGICHE E CULTURA DI DESTRA: IL RITORNO DI FURIO JESI- 1h 32′ 58″
Audio della presentazione di Riga 31. Con Enrico Manera (curatore del volume insieme a Marco Belpoliti) e Wu Ming 1. Bartleby, Bologna, 18 febbraio 2011. La registrazione dura un’ora e trentadue minuti. L’intervento introduttivo di WM1 patisce alcuni problemi di microfono, poi l’audio si stabilizza.
Andrea Cavalletti – Tecniche di produzione del vuoto (sulla recensione di Marcello Veneziani a Cultura di destra)
Speciale Riga 31 su Furio Jesi (nel menu in basso, segnaliamo in particolare “Extra”)
Audio della conferenza su Jesi tenuta da Sergio Givone al Festival della Filosofia 2007
Cultura di destra, neofascismi e populismi digitali. Giuliano Santoro e Wu Ming 2, live

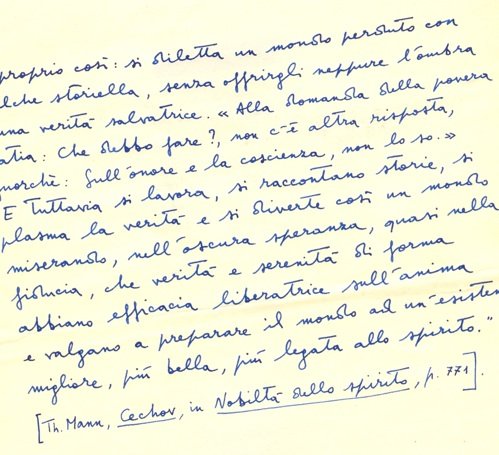
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

De Turris un vero gentleman. Ma la Bompiani le conosce queste sortite?
Be’, sono sortite pubbliche, nero su bianco, quindi nessuno è legittimato a ignorarle. Mai espressione fu più adatta al caso di “fare orecchie da mercante”… Ad ogni modo c’è gente che lavora alla diffusione della conoscenza delle suddette sortite anche Oltremanica, affinché certi avvocati di uno studio di Oxford e un signore che lavora alla Tolkien Estate e porta lo stesso cognome siano tratti fuori dall’ignoranza.
De Turris é anche il titolare delle rubriche di recensioni librarie di Radio Uno Rai, sia all’interno dei GR che con un suo programma la domenica http://www.largonauta.rai.it/dl/radio1/2010/programmi/Page-53544148-4c78-4e4a-8f13-2f9333848f68.html vale la pena ascoltare qualche podcast…
Giustissimo, però adesso non concentriamoci su De Turris, la sua frase era solo uno degli esempi dell’intenso fastidio che a destra (nelle destre) si prova per Jesi.
hai perfettamente ragione, é che mi capita di ascoltare quella porcheria di trasmissione e quando ho letto il suo nome mi é venuto il voltastomaco e ho dovuto dirlo.
me ne scuso.
A proposito di frame oggi particolarmente popolari a sinistra che meriterebbero di essere sottoposti ad una critica stringente:
“Escludendo le tecnicizzazioni più grossolane, il marxismo standard si è costruito dal punto di vista espistemologico come una dogmatica, irrigidendo i propri contenuti come una mitologia che si fa dogma. Le sue strutture logiche di fondo sono hegeliane, idealiste e sostanzialiste, e i suoi teorici sono sempre stati poco disposti a riconoscerlo come un sistema semiotico, immaginativo-concettuale di rappresentazione di massa.”
E’ più o meno il secondo frame oggi più popolare dopo quello che afferma la necessità di “spostarsi al centro altrimenti non si vince.” A dirla tutta, secondo me ne costituisce una delle più insidiose legittimazioni teoriche, diffusa soprattutto negli ambienti intellettuali di sinistra (ma non solo).
E questo sia che l’idea del marxismo come “sistema semiotico” sia utilizzata per sminuirne il significato politico, sia che sia utilizzata per valorizzarne il presunto potenziale emancipativo in termini puramente rappresentativi o “narrativi”. Ad essere disconosciuti, in entrambi i casi, sono il significato e il valore della base materialistica e dialettica del pensiero marxista.
Se la deriva dogmatica (che c’è stata eccome!) ha fatto i suoi bei danni, anche lo schiacciamento dell’intero sviluppo del pensiero marxista su questa deriva (come se la cosa dipendesse dalle sue stesse basi filosofiche!) non è che faccia ‘sto gran favore al potenziale critico ed emancipativo che si ritrova in quel pensiero; il rischio non è forse quello di alimentare involontariamente proprio le peggiori mitologie revisioniste?
Però, però… Nell’espressione usata da Enrico – e che io ho inteso come sarcastica – “marxismo standard”, non c’è già un riconoscimento che “marxismo” (inteso come termine-valigia che nel corso del Novecento è stato usato a ogni sproposito) non è solo quello, e ci sono “marxismi” che non si sono conformati a quello “standard”? Io leggendo “marxismo standard” ho pensato al dia-mat e altre dogmatiche a noi note. Fermo restando che un conto sono questi “marxismi”, un conto è il pensiero di Marx.
Uhm… se lasciata nell’ambiguità (ossia se non si fanno, per così dire, nomi e cognomi), un’espressione come “marxismo standard” diventa del tutto inservibile. Il fatto è che, nelle parole di Enrico, io non vedo particolari ambiguità; mi sembra che il problema lui lo individui senza troppi giri di parole precisamente nell’impianto filosofico del marxismo; sicché “marxisti standard” sarebbero tutti quelli che, in fasi storiche diverse, si sono riconosciuti (e si riconoscono) nel materialismo dialettico.
Poi capisco sempre meno questa insistenza nel distinguere i “marxismi” dal “pensiero di Marx”. Perché se da un lato gli sviluppi della teoria vanno sempre colti storicamente, contestualizzati, evitando di appiattirli in un pastone omogeneizzato (la dottrina stalinista del marxismo-leninismo per intenderci), dall’altro va anche rifuggito il desiderio di vedere in un presunto “marxismo di Marx”, puro ed originario, qualcosa che contraddirrebbe tutto quello che è venuto dopo, appiattendolo indistintamente in un non meglio definito… “marxismo standard” dal quale si sarebbero distaccate poche virtuose eccezioni.
Insomma: prima di vedere dogmatismi ovunque, o di accomunare cose molto diverse sotto il marchio d’infamia del dogmatismo, secondo me bisognerebbe individuare con precisione quali sono i “terreni di contesa” (la filosofia materialista? la critica dell’economia politica? l’interpretazione della storia come storia dello scontro di classe? ecc.) dove un sano atteggiamento critico può contribuire a tenere a bada certe inevitabili tendenze dogmatiche.
Altrimenti – e lo dico a partire da una preoccupazione sulle conseguenze *politiche* di tutto questo – anche l’operazione critica, demistificante, de-mitologizzante rischia di diventare a sua volta un’operazione… mitologica.
Non vorrei aprire una digressione in punta di dottrina filologica marxiana, voglio solo precisare che per “pensiero di Marx” – espressione che va sempre usata problematicamente, sia chiaro – intendo un insieme di scritti che, quando si formarono le principali versioni del marxismo, erano in gran parte ancora sconosciuti. Volevo dire proprio il contrario di quello che hai letto nella mia frase.
Nel corso della sua vita Marx lasciò incompiuto un gran numero di testi, alcuni dei quali cruciali (a cominciare dal “Capitale”). La militanza e il giornalismo “alimentare” – direbbe Jesi – lo portavano a continue “digressioni”, lo distoglievano dall’opus magnum, che infatti non riuscì a terminare. I libri del “Capitale” successivi al primo li finì Engels cercando di colmare i buchi.
Di alcuni testi marxiani molto importanti abbiamo diverse stesure, continuano a emergere “false partenze”, varianti, riproblematizzazioni di cose che prima aveva asserito con grande sicurezza…
Insomma, qualunque marxismo, anche il meno dogmatico, non può che compiere delle scelte, decidere su quale Marx (e su “quanti” Marx) costruire un edificio concettuale, e quale e quanti Marx lasciar cadere.
Per fare un esempio, c’è un Marx convinto che per costruire il socialismo e poi il comunismo sia necessario passare per il capitalismo, ed è il più conosciuto; poi c’è il Marx degli ultimi anni, meno convinto del fatto che quel passaggio sia indispensabile. E’ il Marx delle tre stesure della risposta alla socialista russa Vera Zasulich (lettera che mi sono trovato a citare spesso), molto interessato – direi quasi preveggentemente – alla Russia e alle sue istituzioni comunitarie rurali, sulle quali – azzarda – si potrebbe puntare per costruire il socialismo anche in condizioni di forte arretratezza capitalistica. E’ più o meno lo stesso Marx dei “Taccuini etnologici”, cronologicamente parlando.
Quando Lenin perfezionò la versione del marxismo già semi-elaborata da Plekhanov e altri, questi testi non esistevano. Il corpus marxiano si limitava a un pugno di testi già editi. Non si conoscevano nemmeno i Grundrisse.
E’ anche per questo, non solo per le losche manovre di pravi “deviazionisti”, che esistono più marxismi: perché ogni volta che si sono scoperti testi nuovi, qualcuno li ha usati per cambiare prospettiva sul proprio marxismo.
Quando sono emersi i testi del “giovane Marx” (su tutti i “Manoscritti economico-filosofici del 1844”), dal phylum principale si sono diramati marxismi “umanisti” e libertari. Quando si sono scoperti i “Grundrisse”, hanno fornito l’occasione di un ripensamento che ha generato il filone operaista/post-operaista. I “Taccuini etnologici” e la lettera a Vera Zasulich sono alla base di riflessioni di carattere… “ecomarxista”. E così via.
E’ un dato di fatto che bisogna accettare serenamente. Non ci si può proprio far nulla: Marx ha scritto tantissimo, i suoi scritti sono una miniera, ma una miniera di metalli diversi, e probabilmente tutti ha una loro utilità, ma non per le stesse cose.
Poi ci sono i “marxismi” cialtroneschi, basati su giochi di prestigio, truffe ideologiche, letture intenzionalmente distorte… Ma quelli non piacciono a nessuno dei presenti :-)
Queste digressioni non sono inutili. Anzi. Non si tratta neppure di digressioni, perché secondo me l’invito, più volte ribadito nel testo, a “fare pulizia in casa propria” (ossia a liberare anche la “cultura di sinistra” dalle mitologie dogmatizzanti come dalle contro-mitologie revisioniste) rappresenta forse il migliore tributo che si può fare oggi alle analisi di Jesi. E, soprattutto, il miglior contributo *intellettuale* che possiamo dare alla lotta delle classi oppresse per un mondo migliore :-)
Ogni volta che si muove una critica a una teoria filosofica che ha interagito grandemente con il corso della storia si rischia di alimentare involontariamente le mitologie revisioniste. A meno di non accettare acriticamente e dogmaticamente, appunto, la suddetta teoria, bisogna rassegnarsi a muovere le critiche assumendosi il rischio, e cercare sempre di fare tutti i distinguo del caso.
Per intenderci (e per precisare meglio quello che intendo dire). Il potenziale emancipativo e critico del marxismo secondo me va salvato da due possibili derive.
Da un lato c’è, naturalmente, il dogmatismo, la mitologizzazione, la trasformazione dell’adesione politica in liturgia (esemplare, a questo proposito, il “culto di Lenin” avviato dallo stalinismo e che trova una delle sue manifestazioni più “graphic” nell’invereconda imbalsamazione della salma del povero Vladimir Ill’ic, manco fosse un santo della chiesa ortodossa).
Dall’altro c’è, invece, la tendenza a spostare il dibattito dalla teoria alla meta-teoria, come se fosse possibile staccare il dibattito teorico dagli sviluppi storici concreti che lo hanno animato, spingendolo in vicoli ciechi, diatribe, scontri aperti.
Mi sembra che sulla prima deriva ci si concentri, oggi, anche troppo, lasciando il fianco scoperto sul secondo aspetto. Con le conseguenze politiche che vediamo: la trasformazione di Marx da rivoluzionario a “filosofo”, le continue reviviscenze del revisionismo in varie forme, la progressiva scomparsa dell’analisi marxista dal dibattito e dalla lotta politica.
La storia delle idee, secondo me, diventa un vacuo esercizio accademico se non viene continuamente riportata al contesto concreto, storico, materiale che funge da terreno per il suo sviluppo. E, per non essere tacciato di cadere in una petizione di principio (ossia per non essere tacciato di essere a mia volta… dogmatico), questa attenzione non appartiene soltanto alla critica marxista (materialista per vocazione), ma si ritrova anche in molte espressioni del pensiero borghese. Penso solo alle brillanti de-mistificazioni dell'”anarchico” Feyerabend rispetto alla storia della scienza e del metodo scientifico!
Detto questo, secondo me l’unico modo per far “vivere” una tradizione di pensiero ricca di conseguenze a livello emancipativo e critico, l’unico modo per evitarne l’imbalsamazione, consiste nel riportarla costantemente nel vivo della società e delle sue contraddizioni, nel metterla alla prova nella pratica. La “teoria” è tale solo in un rapporto organico (e dialettico) con la “pratica”; altrimenti rischia di diventare meta-teoria sterilizzata, buona per l’archiviazione museale e sempre disponibile al fraintendimento e alla strumentalizzazione.
Sul nocciolo della questione, d’accordissimo, come potrei non esserlo? Anche in questo post si parla di discorsi che sono sempre legati a prassi. Se quello che individui è un rischio (il fare “meta-teoria”), è giusto segnalare i rischi, ma se dici che qui si sta già facendo “meta-teoria”, allora non sono d’accordo, mi sembra una discussione che “tocca il reale” eccome, e verte su questioni brutalmente concrete! Infatti, ci tengo a precisare che “semiotico” (nell’accezione usata nel post: inerente ai segni) e “materialistico” (nell’accezione a cui ti riferisci) non si elidono a vicenda ma per come la vedo io vanno assieme.
[Tra l’altro, le neuroscienze mostrano che i frame che utilizziamo nella nostra comunicazione sono *incorporati*, hanno precise collocazioni neurofisiologiche.]
Non dimentichiamo che Jesi scriveva quel che scriveva avendo sempre come quadro concettuale la lotta di classe.
Sul rapporto fra semiosi e materia da un lato sfondi una porta aperta, dall’altro temo che un’intepretazione “materialistica” della semiosi (anche se non necessariamente nel senso del materialismo marxista) si scontri parecchio duramente con quello che la teoria semiotica (o quel poco che ne rimane) è oggi a livello accademico, soprattutto in Italia e in Francia (scontro di cui ho fatto diretta esperienza ormai qualche secolo fa da laureando “contestatore” :-P).
Il rischio non lo vedo certamente in Jesi e neppure nelle tue risposte; lo vedo invece, purtroppo, nella frase di Enrico Manera che ho citato nel primo commento. E mi sembra un rischio particolarmente insidioso. Perchè la critica di Enrico Manera mira proprio alle basi filosofiche del marxismo… “standard”; basi che secondo me non possono essere scisse dalla lettura generale della storia e dell’economia, e quindi neppure dalle loro conseguenze sull’intervento politico.
Per questo, spero che lo stesso Enrico abbia occasione di intervenire nella discussione; più che altro, vorrei capire meglio a cosa faceva riferimento. Al materialismo dialettico in quanto tale? Alla dottrina marxista-leninista? A qualsiasi marxismo che non sia quello (tutt’altro che coerente e unitario) di Marx? :-)
chiamato in causa, eccomi, stavo rileggendo per cercare di essere il più chiaro possibile.
Premetto che più che voler insegnare qualcosa a qualcuno intendo interpretare Jesi.
In ogni caso:nella mia frase molto veloce, intendevo indicare innanzitutto la teoria marxista-leninista che si è trasformata in dottrina di stato, con la deriva stalinista e il socialismo reale che sono tecnicizzazioni grossolane; ma effettivamente il discorso potrebbe essere fatto in genere per ogni successivo atteggiamento dogmatico che nelle varie correnti degli anni settanta si è poi ipostatizzato (trotzkismo, maoismo etc) per il modo in cui sono stati vissuti da molti militanti.
Con questo non intendo delegittimare l’azione politica del marxismo, ma penso che se il marxismo non si contamina con la semiotica, con le neuroscienze e con il post-strutturalismo, indebolendo le sue strutture metafisiche l’impianto logico del materialismo rischi di condurre alla dogmatizzazione.
Intendo dire all’accettazione acritica di esso da parte dei soggetti che ne fanno portatori.
Il marxismo è condannato a riprodurre uno schema metafisico e secolarizzante? Nel Novecento è andata così. Però Foucault era nella sinistra radicale, così Barthes, eppure il loro insistere sulle ‘pratiche’ e sui ‘discorsi’ mi sembra abbia aggiunto piuttosto che distrutto.
Derrida pensava che fosse impossibile uscire dalla metafisica, effettivamente si può provare a indebolire il dogmatismo: pensare un marxismo come ‘sistema semiotico, immaginativo-concettuale di rappresentazione di massa’ significa per me pensare un discorso critico che preluda ad un’azione critica.
Sono qui per imparare, ma da quel che so della storia dei pensatori marxisti, non mi pare che infilarci dentro la semiotica e le neuroscienze significherebbe “contaminare” il marxismo.
La riflessione di Marx su coscienza e ideologia mi pare anche una riflessione di semiotica. Il punto di vista difeso da Marx sicuramente non rappresenta uno studio completo sull’argomento ma non mi sembra alieno a riflessioni molto più recenti. Questa parte del pensiero marxiano era sconosciuta a Lenin (“L’ideologia tedesca” venne pubblicata 8 anni dopo la sua morte), ma questo non gli ha impedito di fare ragionamenti simili partendo dalle stesse basi. In particolare Lenin fa un’operazione assolutamente rivoluzionaria in “Materialismo ed empiriocriticismo” e cioè parla di filosofia basandosi sulle neuroscienze (che all’epoca avevano ottenuto ben pochi risultati rispetto ad oggi!). Del tutto immeritatamente quel testo ha fama di essere dogmatico e meccanicista, forse addirittura “metafisico”, solo perché va giù pesante contro i suoi avversari – si confonde cioè lo stile dell’esposizione con il suo contenuto.
Quel che dice Lenin è che il mondo esterno esiste a prescindere dal soggetto che lo esperisce; questo evidentemente è una premessa fondamentale per pensare che le neuroscienze (il cervello del singolo essere umano) e la semiotica (la società ovvero gli altri esseri umani) possano avere un’importanza filosofica decisiva. Il soggetto autosufficiente contro cui si scaglia Lenin non avrebbe niente da imparare né dal funzionamento dei suoi neuroni né dai segni usati dagli altri.
Credo che l’incomprensione di queste caratteristiche del pensiero filosofico di Marx e di Lenin abbia avuto un ruolo molto nefasto, perché ha messo gradualisti, stalinisti e maoisti nell’indegno ruolo di ortodossi (quando in realtà erano artefici di una evidente distorsione metafisica e meccanicistica) e ha spinto molti pensatori marxisti a considerarsi degli eretici a tutti i costi, fissandosi sull’idea balorda (e forse anche un po’ seducente) che bisognasse salvare il marxismo da sé stesso per via filosofica, quando molti strumenti concettuali in realtà stavano già dentro la sua storia ed era per ragioni molto diverse (e molto terra terra) che si erano persi per strada – o che qualcuno aveva fatto in modo che venissero persi per strada.
Leggere per credere:
http://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1846/ideologia/index.htm (in italiano)
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/mec/index.htm (in inglese)
Tutto questo per dire che questa roba non avrebbe dovuto e non dovrebbe interessare solo a dei marxisti “inquieti”, ma anche a quelli “soddisfatti”. :-)
Intanto grazie per la risposta! :-)
L’idea di una contaminazione del marxismo “con la semiotica, le neuro-scienze e il post-strutturalismo” è davvero stimolante sul piano intellettuale. Per la cronaca, mi tocca molto “sul personale” :-D perché oggi mi trovo spesso, da marxista, a ripensare ai miei studi universitari di filosofia e semiotica; purtroppo il tempo e le energie che ci posso dedicare sono davvero poche, ma la questione non l’ho mai mollata del tutto.
La butto in battuta: la cosa che mi lascia più perplesso nella tua risposta è proprio la “triade malefica” :-P semiotica/neuroscienze/post-strutturalismo, che immagino non sia frutto di una semplice giustapposizione, ma sia legata ad un tentativo di sintesi organica fra le tre cose.
E’ proprio su questa sintesi che non mi ritrovo ora, come non mi sono ritrovato da studente; e questo proprio perché le prospettive che nascono da quella sintesi (quelle con cui mi sono confrontato direttamente, almeno) mi sembrano escludere in modo piuttosto radicale la possibilità di mantenere un approccio realmente materialista – oltre che capace di dialogare proficuamente con un pensiero *rivoluzionario* orientato non solo alla comprensione, ma anche alla trasformazione del mondo.
All’epoca, quando scrissi la tesi (pare passata una vita!), non ero ancora marxista. Ero già materialista, però; di quel genere di materialismo che i marxisti definirebbero “materialismo volgare”. Alla base del mio tentativo (maldestro) di critica dei paradigmi “classici” della semiotica da un punto di vista materialista ci stavano la biologia teorica (la cosiddetta “biologia semantica”, in particolare), la cibernetica e la teoria dei sistemi.
Per me, all’epoca, fu un sano bagno ristoratore rispetto alla confusione che avevo in testa, aggravata dalle miriadi di lezioni e seminari in cui sentivo professori e ricercatori utilizzare paroloni (“concetti senza parole”…?) come “trasduzione”, “autopoiesi”, “significazione” ecc. citando i vari Deleuze, Eco, Peirce, Blanchot, Baudrillard, Maturana e Varela ecc. più o meno come tanti “principia auctoritatis”. Studiando Ashby, Wiener, von Bertalanffy, von Foerster, Prigogine, Barbieri, S.J. Gould, Jablonka e Lamb ecc. mi si aprì letteralmente un mondo nuovo… un mondo che mi pareva molto più preciso, empirico e “ben segmentato” rispetto a quello che conoscevo prima.
Per venire al punto: secondo me cambia parecchio, in termini di prospettiva generale, se si vedono i processi di significazione come qualcosa che nasce “a parte naturae”, come frutto di una stratificazione di complessità che parte dalla singola cellula e arriva alla mente, alla cultura, alla società; oppure se si vedono i processi di significazione come qualcosa che, a prescindere, restano intrappolati nella “semiosfera” culturale.
Mi sembra che, complice soprattutto la pesante eredità dello strutturalismo, la semiotica accademica non si sia mai liberata del secondo tipo di approccio, neppure quando, alla ricerca di “sponde” nelle scienze empiriche, ha aperto agli studi di scienze cognitive e neuroscienze; e neppure quando si è rivolta alla filosofia post-strutturalista (Deleuze soprattutto) per svecchiare un po’ il suo apparato analitico, messo alla prova dal fatto che l’analisi strutturale era ormai diventata… una “moda intellettuale” d’altri tempi :-)
Argomentare questa posizione sarebbe lungo – e in più penso che avrei qualche difficoltà a farlo, non essendo più “fresco di università”. Resta però il fatto che quando, più recentemente, mi sono confrontato vis-a-vis con il materialismo dialettico, i circuiti neurali che credevo di aver messo definitivamente in pensione dopo la laurea si sono improvvisamente riattivati… e nel materialismo dialettico mi è sembrato di trovare una conferma delle convinzioni che avevo maturato scrivendo la tesi!
Ovviamente il materialismo dialettico di Marx ed Engels risente ancora molto, (anche solo a livello… sintattico-lessicale) dell’hegelismo; però già solo l’idea di rovesciare la dialettica, riportando l’analisi “sui suoi piedi” per “scoprirne il nocciolo razionale entro la scorza mistica”, rappresenta una rottura radicale, dalla quale non si torna indietro. Per cui ci si può tranquillamente spiegare la continuità con Hegel con il fatto semplice e banale che molti degli sviluppi scientifici e filosofici (ma scientifici soprattutto) che avrebbero potuto alimentare ulteriormente il materialismo marxista erano ancora di là da venire; ed era inoltre difficile, per degli intellettuali ottocenteschi, sottrarsi alla forza gravitazionale di un “gigante” come il sistema filosofico hegeliano, che all’epoca forniva la migliore esposizione disponibile del *metodo* (la dialettica) di cui Marx ed Engels avevano bisogno per demistificare i concetti dell’economia, della storia e della sociologia borghesi.
In questo senso, secondo me (ma magari questa provocazione intellettuale è una cazzata che sarà immediatamente censurata :-)), il materialismo marx-engelsiano ha molto più in comune la teoria dei sistemi complessi, di quanto non abbia in comune con l’idealismo hegeliano.
Mentre, al contrario, la semiotica contemporanea (penso ad esempio al “Trattato di semiotica generale” di Eco), ha molto più in comune con l’idealismo hegeliano di quanto non abbia in comune con gli sviluppi più interessanti e più stimolanti della fisica e della biologia tardo-novecentesche.
La dialettica di Marx ed Engels, in altri termini, mi sembra parecchio più “sistemica” ed “empirica” dell’idealismo implicito nelle semiotiche generali dei vari Hjelmslev, Pierce, Greimas, Eco, Lotman ecc.
Io dico solo di stare attenti a usare il termine “post-strutturalismo”, che è un altro termine-valigia dentro cui si è sempre messo un po’ di tutto, anche riflessioni inconciliabili e teorici che non avevano quasi nulla in comune (es. Baudrillard e Foucault).
A rigore, “post-strutturalismo” vorrebbe dire semplicemente “filosofia francese che, in qualche modo, prende le mosse dallo strutturalismo per poi giungere a esiti diversi”. Dentro ci troviamo filosofi che amavano Marx e addirittura si sono in più occasioni – magari più provocatoriamente che altro ma è comunque una scelta di campo – definiti marxisti (lo stesso Deleuze disse “io e Guattari siamo forse gli ultimi marxisti”!), oppure si sono ritrovati *molto vicini* al marxismo (il Foucault del confronto televisivo con Chomsky suona più marxista-leninista dei marxisti-leninisti!), e altri che invece dal marxismo restarono lontanissimi.
In ogni caso, va fatto notare che nell’eterogeneo novero “post-strutturalista” si trova la più alta percentuale di filosofi compagni di strada dei movimenti, praticanti di strada e di piazza, animatori di inchieste sociali (quella promossa da Foucault sul sistema carcerario francese) etc.
Lo stereotipo dei “pensatori francesi” ineluttabilmente astratti, meta-teorici e “tetrapilectomani” è stato diffuso a partire dagli USA e da una ricezione iper-accademica di quelle teorie (ricezione che comunque, come facevi notare, non è mancata nemmeno da noi) e poi dalla reazione di destra a tale ricezione, vedi appunto uno come Scruton, che odia molto di più i post-strutturalisti dei comunisti (e figurarsi cosa pensa dei comunisti post-strutturalisti! :-)) Ma finché erano rimaste in Francia erano ben più “materialiste” :-)
Ad ogni modo, io propongo di tornare a bomba sulle riflessioni al centro del post: Jesi, parole magiche e “mitologie comunitarie” da Grillo ai fasci der terzo millennio, framing di destra, differenza tra destra e sinistra, come disinnescare certe narrazioni etc.
Come vuoi. Però penso che, al netto della deriva forse troppo filosofica che sta prendendo questo segmento di discussione, le due cose non siano affatto scollegate – e infatti nel vostro “dialogo a tre voci” siete tornati più volte sull’argomento. D’altronde, se vogliamo “dare corpo” a quello che ci distingue dal pensiero di destra (ed evitare di cadere in trappole analoghe) certi nodi teorici li possiamo evitare o aggirare fino a un certo punto.
Ti sembra che qualcuno abbia evitato o aggirato qualcosa? Riassumo quel che è appena successo qui sopra:
Si è creato subito un sotto-thread lungo sulle implicazioni di *una* frase di Manera detta en passant.
Una volta spiegata meglio la frase, si è capito che significava semplicemente che marxismo e neuroscienze, marxismo e post-strutturalismo, marxismo e semiotica dovrebbero integrarsi e produrre un marxismo che corra meno rischi di diventare una “metafisica”.
A quel punto Mauro ha fatto notare che il marxismo è già potenzialmente integrato con tutte quelle cose lì, e se non lo sembra è per via di certi fraintendimenti e distorsioni.
Quindi, arguisco, Manera non ha detto niente di particolarmente eretico o pericoloso, anzi, si è posto nel solco di una tradizione.
Mauro ha fatto notare che c’è stato uno scambio di caselle tra “eretici” e “ortodossi” (uso la parola in senso buono, come la usava Bordiga), con gli ortodossi che si sono creduti eretici e gli eretici che si sono creduti ortodossi.
Se questo è vero, Manera è il vero marxista ortodosso, proprio perché “eretico”, aperto alla semiotica e alle neuroscienze come dovrebbe essere un buon marxista.
E quindi non capisco:
1) chi avrebbe “aggirato” cosa, dal momento che l’equivoco è stato sviscerato;
2) giunti a questo punto, dove altro potremmo andare a parare.
3) perché ritieni utile soffermarsi ancora su una frase en passant che è già stata non solo chiarita ma addirittura rovesciata e resa paradosso fecondo, quando il post voleva stimolare soprattutto su altre questioni. Non è meglio far tesoro di quanto emerso nello scambio, rifletterci sopra e parlarne in un altro momento?
Messa così, però, sembra quasi che stessimo facendo a gara a chi è più “ortodosso”… :-D
Non è così, ovviamente. Come ho cercato di argomentare, in maniera abbastanza confusa, l’ibridazione fra marxismo e semiotica, per quanto stimolante, è tutto salvo che scontata (un punto sul quale Mauro ha espresso la sua posizione, che può essere condivisa o meno, senza però che questa posizione diventi il metro per misurare il grado di adesione all’ortodossia – o all'”ortodossia eretica” – di questo o quel partecipante alla discussione…).
A maggior ragione, l’ibridazione diventa molto meno scontata se per “semiotica” si intende quello che è *oggi* la semiotica soprattutto in Italia e in Francia, e sia nelle sue varianti più “ortodosse” (generativa, interpretativa, culturale), sia in quelle che cercano sponde nel post-strutturalismo (più precisamente: in Deleuze) o nelle scienze cognitive.
Non era mia intenzione utilizzare quella frase en passant “contro” Enrico o contro chicchessia, ma come spunto per riflettere (un po’ più a fondo, magari) sui limiti e sulle possibilità di un’operazione di ibridazione come quella proposta. E questa riflessione è importante (per me almeno), perché, oltre che interessante dal punto di vista intellettuale, mi sembra avere anche delle implicazioni pratiche da non sottovalutare.
Quando parlo di “aggirare”, non mi riferisco all’atteggiamento tenuto da qualcuno in questa discussione, e mi spiace che la cosa sia stata intesa così. Il senso era: *in generale*, in un qualsiasi dibattito su ciò che distingue il pensiero di sinistra da quello di destra, e in un ragionamento che miri a valorizzare il potenziale critico ed emancipativo del marxismo, prima o poi nodi teorici del genere saltano fuori, e vanno affrontati.
In questo pezzo di discussione si è cercato di farlo, con tutti i limiti “logistici” del caso (stiamo discutendo a distanza su un blog, dopo tutto), e sono d’accordo con te sul fatto che non abbia senso continuare.
Dopo di che, spero che la discussione non decada qui e che ci siano altre occasioni, magari più propizie, per riprenderla :-)
Bella discussione.
Ho chiesto lumi a gente più anziana di me che frequentava l’università di Palermo in quegli anni, e appena pronunciato il nome di Furio Jesi ho visto i loro occhi illuminarsi.
Chi seguì le sue lezioni (cattedra di germanistica, credo) ancora si ricorda con entusiasmo un suo mirabolante ciclo di lezioni sul tema del vampirismo… Un genio vero, ben venga questo revival.
A Palermo in quel periodo alla facoltà di Filosofia regnava Armando Plebe, un “professorone” verso il quale, mi dicono, Jesi non nutriva grossa stima.
saluti.
Oggi ho sentito Giorgia Meloni alla radio. Diceva che lei aveva “portato nel PdL la storia della destra identitaria”.
“Portare storie” a Berlusconi, come una dote di nozze? Sembra quasi una confessione: ci siamo inventati una storia e l’abbiamo usata per i nostri scopi. Questo è il pattume con cui si fa “elaborazione politica” in Italia, e il materiale da costruzione della destra: storie che vengono assemblate a cazzo di cane, raccolte di miti inventati a tavolino. Il “Polo delle Libertà” del ’94 era un mostro tricipite con 3 storie inventate: il mito del self-made man Berlusconi, il mito celto-padano di Bossi, il mito della Destra Nazionale di Fini. Ciascuno di questi miti era a sua volta composizione eclettica di storie che non c’entravano un tubo una con l’altra, Craxi e De Gasperi e Iva Zanicchi, e poi i celti e i longobardi e la Lega Lombarda e Carlo Cattaneo, e poi il pantheon di Fiuggi con Evita e De Gaulle insieme a Gramsci (?!?) e i busti del duce tenuti nascosti fino alla fine del congresso. E purtroppo non è solo a destra che si fanno operazioni di questo tipo, il maggiore partito italiano, il PD, è frutto di una mitopoiesi altrettanto artificiosa e sterile.
Ma soprattutto: cosa vuol dire “destra identitaria”? Parole che rimandano solo ad altre parole, parole magiche che non significano nulla. L'”identità” è un concetto neutro, dell’identità *di chi* stiamo parlando? L’identità di destra? Quindi la destra identitaria è la destra di destra? Sotto sotto vuol dire “fascista” (in origine pure quella era una parola senza definizione), ma senza neanche il coraggio, ma soprattutto senza neanche il *bisogno* di dirlo. In fondo ciò che distingue la Meloni da Berlusconi è che la Meloni parla più spesso delle foibe (come fa Vicky di CasaPound quando si trova in… crisi d’identità). Si allude a una identità metastorica che si definisce da sola. Sono destri di destra, con un’identità identitaria.
Una volta alcuni miei amici e conoscenti sono comparsi su Cronaca Vera. No, non avevano decapitato un alieno. Avevano aiutato una famiglia sfrattata ad occupare una piccola stazione ferroviaria abbandonata in un paesino di provincia. Quelli di Cronaca Vera hanno fatto un articolo che ne parlava, mostrando gli occupanti come dei disperati ma tutto sommato raccontando abbastanza fedelmente la vicenda; c’era una foto, con occupanti e compagni che tenevano uno striscione con scritto “Stazione Occupata”. In fondo allo striscione avevamo dipinto una falce e martello, ma quelli della rivista hanno fatto un fotomontaggio e hanno cancellato il simbolo. Vorrà dire qualcosa?
(Dicesi “commento senza capo né coda”.)
I deliri identitari della Meloni e di Alemanno sono solo la punta dell’iceberg.
Basta fare una ricerchina su qualcuno dei nomi citati nell’articolo et voilà
una bella pappetta tossica preconfezionata ad uso e consumo delle nuove generazioni.
“È incarnando il proprio mito e il proprio destino che si fa la storia” .. so che non dovrei, ma non riesco a smettere di ridere.
La colonna destra con le “gnocche” e la scritta “Fans dell’Avgvsto” fa pensare a un autentico disperato.
L’Augusto – per chi non lo sapesse – è un liceo romano (tradizionalmente di destra), e anche l’impostazione del blog che ho linkato mi fa chiaramente pensare all’opera di un pischello.
Disperato, sicuro, ma pur sempre pischello.
Il fatto che i deliri riguardo ai “miti che si incarnano” di questo Scianca finiscano nelle mani di ragazzini di 15 anni mi sembra il punto su cui focalizzare l’attenzione con più urgenza…
Eh, già. Ti ricordi la didascalia in “romanaccio” che abbiamo messo sotto il manifesto di Casapau sui due marò?
Se ne potrebbe parlare a lungo.
Ricordo una volta in cui mi è capitata sotto mano una fanzine del Blocco Studentesco – nome che, per inciso, mi ha sempre fatto pensare ad un’occlusione intestinale – che tra i vari articoli sulla mistica della giovinezza e sulla lirica di Ezra Pound presentava nelle due pagine centrali un bel cruciverba, tipo quelli grazie ai quali generazioni di italiani hanno trascorso l’intero ammontare della propria esistenza in termini di tempo libero ad anestetizzare in maniera irreversibile le proprie facoltà intellettive.
Che devi fa, sò sfigati, però una mano toccherebbe dajela, che poi questi crescono e fanno i danni…
Provo ad aggiungere carne al fuco.
Ieri ero assieme a @zeropregi, fiancheggiando Tabula Rasa, la trasmissione libresca di Radio Onda Rossa (qui il podcast http://www.ondarossa.info/node/8943/Superzelda%20e%20Limonov). Abbiamo intervistato Guido Caldiron sulla figura di Limonov, il capo dei nazionalbolscevichi russi con trascorsi nella scena sottoculturale parigina e newiyorchese protagonista del bestseller di Emmanuel Carrère. Guido ha fatto una descrizione dei nazionalbolscevichi che tira in ballo i temi jesiani: questi hanno ricostruito la storia russo-sovietica mettendo insieme, in nome della nostalgia dei bei tempi andati e del nazionalismo, Hitler e Stalin. E soprattutto aggregano i giovani delle periferie e della Russia profonda che arrivano a Mosca in cerca di identità: la trovano in questo partito carismatico che fa del cameratismo, della solidarietà maschile e del culto del capo in nome di un passato “pappa omogeneizzata”.
“Carne al fuco” :-)
Beh, dopo il *Partito della bistecca* e visto l’andazzo generale, *Carne al fuco* suona come uno slogan elettorale quasi credibile… :-)
L’articolo è piuttosto lungo e tuttavia più lo leggo più mi sorgono domande. Dev’essere un buon segno.
Provo a ricapitolarle:
1) Manera, citando Jesi, dice: “la maggior parte del patrimonio culturale […] è residuo culturale di destra”. Sguardo perso e verdoniano verso il cielo… “‘nche senso?” Io ho sempre sentito parlare di egemonia culturale della sinistra, che significato ha codesta frase? Posso supporre che “patrimonio culturale” in questo contesto sia da considerarsi in senso lato, come “il complesso delle strutture di organizzazione sociale, dei modi di vita, delle attività spirituali, delle conoscenze, delle concezioni, dei valori che si ritrovano, in forma e a livelli diversissimi, in ogni società e in ogni periodo storico” (citazione da puro lusso spirituale) e non come cultura tout court (Dante, Petrarca, Boccaccio, Bach, Mozart, Beethoven, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Big Jim ecc.). Anche se pure nella cultura tout court certe cornici intellettuali di destra sono stati attivate non poco. Mi viene in mente su tutti quel trombone di Harold Bloom.
2) Massimo Fini fa discorsi destrorsi? Non conosco la sua produzione o la sua storia politica (se ne ha una) nel dettaglio, ma ricordo alcuni suoi interventi all’epoca del guerrafondaio Bush Jr., contro l’imperialismo culturale, che mi sembrarono tutto fuorché omologanti.
3) Nella discussione viene affermato che Jesi non stigmatizza il mito per se stesso, perché permea tutta la nostra vita sociale ed è necessario, ma allo stesso tempo “non si possono (…) muovere le forze inconsce del potere simbolico e poi sperare di controllarle razionalmente”. So che voi Wu Ming avete più volte espresso la necessità di fondare nuovi miti (tornare a immaginare il futuro ecc.) per uscire dal pantano ideologico in cui ci siamo cacciati, e ci avete anche provato in passato (G8 di Genova), ma se poi questi miti sono intrinsecamente incontrollabili e inclini alla manipolazione, come se ne esce?
Manera allude a un “mito umanizzato”, ma non mi è chiaro che caratteristiche dovrebbe avere e con quali modalità dovrebbe diffondersi nella “comunità mitopoietica”. Insomma, mi sembra un equilibrio molto precario, quasi impossibile da raggiungere.
Infine, un paio di riflessioni, di cui almeno una di totale disinteresse per chiunque non sia il sottoscritto.
“…decostruito, neutralizzato e messo a distanza il mito-sacro e il mito-politica, questa sospensione della temporalità o anacronìa, la capacità di giocare tra i diversi strati del tempo, è lo specifico della produzione di immaginario e di ogni narrazione, del raccontare storie.”
Leggendo questo passaggio mi è venuta in mente una cosa che ho letto su un testo in preparazione di un esame. Analizzando e interpretando i testi medievali si nota la ricorrenza della figura retorica detta tipologia, secondo la quale un’immagine o un evento assumono non soltanto il loro significato letterale, ma anche un ulteriore significato allegorico con in più, rispetto alla tradizionale allegoria, una traslazione nel tempo. Questo permetteva ad esempio di leggere l’Antico Testamento in funzione del messaggio evangelico della venuta di Cristo o della redenzione. Siamo di fronte quindi a una tecnicizzazione mitologica in piena regola. Questa era la riflessione che non interessa a nessuno.
La seconda riguarda l’attivazione di alcuni frame attraverso le parole, in questo caso in campo politico. Sono rimasto molto colpito, e irritato, nell’apprendere il nome che Ingroia ha dato alla propria lista elettorale: Rivoluzione Civile. Non so voi, ma a me un nome del genere è sembrato quasi un insulto al buon senso. Quell’aggettivo messo lì a destra (non a caso) della parola “rivoluzione” mi sembra la solita strizzatina d’occhio ai soliti fantomatici moderati piccolo borghesi. Rivoluzione, sì, ma civile, ovvero educata, leggermente frizzante, edulcorata, pastorizzata, omogeneizzata, disinfettata, derattizzata, per piacere, per cortesia, mi scusi eh, con permesso, prima lei, non sia mai, ma si figuri. La rivoluzione è un pranzo di gala?
La risposta più semplice da dare è quella su Massimo Fini, fondatore di Movimento Zero, che si definisce “anti-illuminista, anti-modernista, anti-progressista, anti-materialista”. Un movimento dichiaratamente “né né” ma inequivocabilmente di destra, di quella destra che sta torcendo come fili bagnati i discorsi sulla “decrescita”, rivelandone le contraddizioni che sottolineava anche Giuliano nel post.
Massimo Fini e il suo movimento propongono il ritorno a una società “organica” preindustriale, rivalutano i bei tempi del feudalesimo, hanno come cavalli di battaglia la lotta al signoraggio, all’usura, alle lobby internazionali etc.
I discorsi di Massimo Fini contro “l’imperialismo culturale” sono apparentemente antiimperialisti ma in realtà improntati al “razzismo culturale differenzialista” tipico di molte estreme destre contemporanee: per Fini le culture sono ferme nel tempo, ontologicamente diverse e al fondo incomunicanti, blocchi dai confini ben definiti che dovrebbero stare ciascuno al loro posto, e quindi “ognuno a casa sua”, nella sua comunità omogenea. Da qui, per dirne una, l’apologia dei talebani e della loro difesa delle “tradizioni” (in realtà in larga parte inventate, a loro volta miti tecnicizzati). I talebani lottano per la loro comunità omogenea come dovremmo fare noi europei.
Sulla “egemonia culturale della sinistra”: in Italia non c’è mai stata. Anche prima del berlusconismo, il senso comune di massa lo hanno sempre prodotto tutt’altri agenti: la RAI democristiana, la chiesa, rotocalchi ad altissima tiratura come “Oggi” e “Gente”, la divulgazione pseudo-storica di Montanelli e Petacco… Per questi ultimi viatici è passata la strisciante riabilitazione del fascismo, come spiega molto bene Mimmo Franzinelli qui:
http://www.mimmofranzinelli.it/tool/home.php?l=it&s=0,1,55,57,102
(Grazie a Salvatore Talia per la segnalazione)
Per quanto riguarda la provocazione di Jesi sul patrimonio culturale che è “residuo culturale di destra”, ti dico come l’ho interpretata io (è una frase presa da un’intervista a un quotidiano, quindi è tagliata con l’accetta, ma in Cultura di destra viene sviluppata). Jesi intendeva dire che il modo di rapportarsi al patrimonio culturale restava improntato a una “retorica del sublime” che faceva del consumo di Cultura materia di “lusso spirituale”. In parole povere: “residuo culturale di destra” è il considerare la Cultura (borghese) come qualcosa di Alto, di Puro, “roba che fa sentire intelligenti” e “mette soggezione” e quindi porsi in modalità ossequiosa e contemplativa nei confronti di chi “fa Cultura” con la C maiuscola, il Genio di turno, l’Artista, l’Intellettuale, “come parla bene!” E’ residuo culturale di destra il culto superficiale per l’eloquio vacuo di certi scrittori, è il pendere dalle labbra dello scrittore-opinionista di turno che riempie lenzuolate di pagina di quotidiano con pensieri al vuoto pneumatico ma che fanno tanto “fico”.
Per questo viatico di sudditanza psicologica, en passant, veniva reso “rispettabile” uno come Evola, perché in fondo si muoveva in una dimensione culturale (Jesi è molto tranchant su questo tipo di atteggiamento). Il “lusso spirituale” chiaramente è illusorio, ma si cerca di evocarlo tramite immagini di “lusso materiale”, accumulazione di ciarpame kitsch come al Vittoriale di D’Annunzio (è uno degli esempi che fa Jesi) o come nei romanzi di Liala.
C’è molto “residuo culturale di destra” anche nei discorsi della sinistra. Per fare un esempio, è stata una manifestazione di residuo culturale di destra anche la Resistenza ridotta a martirologio edificante e privo di asperità, storia eroica consolatoria da chiudere in un mausoleo. Di questo parlo diffusamente nell’mp3 linkato in calce al post, “Macchine mitologiche e cultura di destra”.
Sul “fondare nuovi miti”, quello era appunto il nostro errore di impostazione del periodo 2000 – 2001, quando pensavamo che la mitopoiesi si potesse fare a tavolino, a condizione di “lasciare aperta l’officina”. Dei “tecnicizzatori” consapevoli e open source. Ci abbiamo sbattuto il grugno, e abbiamo fatto autocritica in “Spettri di Muntzer all’alba”:
http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/giap6_IXa.htm
NON C´ENTRA UN TUBO (o quasi), ma visto che mi citi il vostro articolo “revisionista” su Genova, una cosa la devo dire.
Nel 2001 avevo vent´anni: avevo letto del Chiapas e di Marcos e della Teologia della Liberazione del Brasile. Non avevo mai sentito parlare di Q, Luther Blisset…
Quando andai a Genova, per me era mitico. Era la lotta del bene (noi) contro il male (voi, gli otto, le multinazionali,…).
Questo per dire che Genova era un mito, un mito di formazione, di passaggio, epocale *INDIPENDENTEMENTE* da Q.
Non era un mito creato in laboratorio: era al 100 per cento genuino.
Abbiamo perso? Si, ma analizzare la sconfitta dicendo che si era creato un mito errato é cannare il frame. Siamo stati massacrati perché siamo andati alla guerra pensando che fosse un pic-nic. Perché le tute bianche dicevano una cosa ma ne facevano altre. Perché non c’era accordo tra pacifisti e non.
Perché non avevamo *coscienza*, o non era tanto avanzata quanto la situazione lo richiedeva.
Ma, definitivamente, il mito c’era ed era reale.
A Genova ABBIAMO FATTO degli sbagli, ma non per questo Genova E’ STATA uno sbaglio.
Un abbraccio
Mi sa che hai frainteso, eh.
Che sia stata la lettura di Q a creare il “mito di Genova” e convincere la gente ad andare a Genova non lo ha mai detto nessuno, solo un deficiente potrebbe sostenere una cosa del genere. Anche perché a Genova venne gente da tutto il mondo, da un sacco di paesi dove Q non era stato pubblicato.
Né nel nostro pezzo si sostiene che fosse sbagliato manifestare, essere contro i “potenti della terra” etc.
Uscendo con Q poco prima di Seattle noi ci ritrovammo, nell’anno successivo, pienamente dentro il grande frame dell’assedio al castello, frame scazzato come pochi. Dapprima ci ritrovammo dentro la cornice solo oggettivamente, perché le parti più ricordate del nostro romanzo evocavano quel tipo di atmosfera; poi fummo presi dalla “fotta” e ci demmo da fare non solo per confermarlo, ma per rilanciarlo.
*Questo* fu il mito tecnicizzato, e noi prendemmo parte alla sua costruzione. Non fummo certo i soli, e un sacco di gente non fu convinta da noi, nemmeno ci sentì nominare… ma noi critichiamo noi stessi, “Spettri di Muntzer all’alba” è il pezzo in cui ci assumiamo la responsabilità per quel che abbiamo fatto noi. Si chiama “autocritica” per quello. Gli altri facciano la loro, di autocritica (anche se, a dire il vero, in questi anni non ne abbiamo viste molte).
Quello che tu chiami “mito genuino” non era un mito, ma la sacrosanta spinta a manifestare. La tecnicizzazione consisté invece nel creare storie ad hoc che concentrassero tutto il focus, tutte le energie e tutte le aspettative su un’unica, grande manifestazione, senza pensare che lo Stato avrebbe fatto lo stesso, specularmente, e con più mezzi, determinato a tendere una grande trappola.
Anziché “essere dappertutto”, manifestare ovunque, fare blocchi in giro per l’Italia e l’Europa (alcuni lo proposero ma furono trattati quasi come dei vigliacchi), conservando così le energie per i mesi successivi, si andò ingenuamente e disorganizzatamente alla battaglia di Frankenhausen.
Nel nostro pezzo diciamo precisamente che l’errore di framing fu “andare alla guerra pensando fosse un picnic”, come l’hai messa giù tu.
Ne derivò un trauma che stiamo scontando ancora oggi, c’è gente che non si è più ripresa, non è più riuscita a ripartire. C’è gente in galera, c’è gente fuggiasca, c’è gente pietrificata nella ricostruzione di quel che accadde allora.
Questa è la nostra lettura di quei mesi. Si può essere d’accordo o meno, ma per favore, non se ne faccia la caricatura, dicendo che secondo noi fu Q a portare la gente a Genova. Non abbiamo mai scritto una simile cazzata.
Mi sono preso il week-end per farmi una pensata…
A scanso di equivoci, dico subito che non volevo né mettervi nella penna cose «deficenti», né sostenere «cazzate». Men che meno farti inalberare ;-)
Il succo, provo a riformulare, é tutto qui.
«Perché il problema è anche: chi è l’artefice della mitopoiesi, l’evocatore, lo sciamano, l’ostetrico? Spetta a un intero movimento, comunità o classe sociale maneggiare i miti e mantenerli vivi. Nessun gruppo separato può auto-incaricarsi di questo. Noi, invece, finimmo per diventare “funzionari” alla manipolazione delle metafore e all’evocazione dei miti. La nostra divenne una quasi-specializzazione. Eravamo una cellula agit-prop. Eravamo spin doctors.»
Ecco: secondo me l’intero movimento stava manipolando il suo mito. Non eravate un *gruppo separato*. Facevate parte di questo movimento e quindi di questo mito. Per questo ho parlato di mito genuino.
Quando dico che ai tempi di Genova non avevo mai sentito parlare di Frankenhause, non lo dico per contestare la tesi bislacca che sia stata la lettura di Q a creare il “mito di Genova” e convincere la gente ad andare a Genova. Ovviamente non lo penso. He detto questo invece per controbattere all’idea che siate stati “”funzionari” alla manipolazione delle metafore e all’evocazione dei miti”. Di nuovo, eravate dentro il movimento e, come parte di esso, eravate (eravamo) immersi nel mito.
E il mito era autentico in quanto su quel mito centinaia di persone sono andate a Genova.
Anche se evidentemente espresso malissimo, quello che volevo dire con l’intervento precedente era che la critica non dovrebbe essere sul mito, ma sulla, diciamo cosí, applicazione del mito: come si assedia un castello? Siamo in grado? Con le mani alzate? Spaccando le vetrine? Tagliando i viveri agli otto?
Non sono un prete, non do assoluzioni, ma non prendete colpe che non sono vostre.
Hai parlato di chi é finito in galera, di chi é scappato. Tutto vero. Ma quanti sono tornati da Genova e hanno iniziato / continuato nuove e vecchie lotte. Tanti. Tante. Genova ha significato, per me e per altri, radicalizzazione e coscientizzazione. Non nonostante il suo mito, ma grazie al suo mito.
L’autocritica è importante: ma facciamola sulle cose giuste, se no é tafazzismo.
Un abbraccio (e scusate l’OT)
“Come si assedia un castello?” secondo me è la domanda sbagliata.
Perchè non c’era nessun castello. Non stavamo assediando niente. Ma su questo ripeterei cose già scritte quattro anni fa.
Eravamo nel movimento, sì, ma ci siamo comportati da “specialisti del framing”, da “ufficio addetto alla manipolazione mediatica”. Producevamo testi e performances e agit-prop a getto più o meno continuo. I numeri di Giap della prima metà del 2000 sono testimonianza di quel clima. E tutta quell’attività convergeva su Genova, era un ossessivo “Andiamo a Genova”. Un errore strategico. Che abbiamo condiviso con moltissimi altri, certamente. Ma nel quale ci siamo impegnati a fondo, non senza arroganza intellettuale, quel genere di “hybris” che nella mitologia greca viene punita dagli dei. E ‘nfatti.
Le persone che dopo Genova hanno continuato o addirittura cominciato a fare qualcosa di buono, lo hanno fatto *nonostante* l’errore strategico, non grazie ad esso. E quell’errore strategico fu alimentato per mesi da una continua tecnicizzazione di mito (o “scherzare col fuoco”, per essere più prosaici).
“Tafazzismo”, per come la vediamo, sarebbe stato *non* scrivere l’autocritica. Fìdati, compagno, che lo sappiamo meglio di te cosa abbiamo e non abbiamo fatto in quei mesi.
@ dovic
L’utilizzo della lettura allegorica dell’Antico Testamento affonda le sue radici nel sostrato più antico della tradizione cristiana, e in un certo senso hai perfettamente ragione a definirla come una vera e propria tecnicizzazione del mito.
Vorrei sottolineare però che questo tipo di lettura allegorica ha avuto origine in ambiente giudaico, con Filone di Alessandria che tentava di coniugare le storie e le leggende della tradizione biblica con la grande tradizione filosofica greca, in particolare platonica.
Riflettendo su questo punto – e per tentare di ricollegarsi all’argomento principale del post – mi piacerebbe domandare ad Enrico Manera qualche informazione sui rapporti intrattenuti da Furio Jesi con la tradizione ebraica – rapporti di cui non so molto, e su cui non riesco a trovare quasi nulla.
Le similitudini tra certi aspetti del pensiero – e della biografia – di Jesi con quelli di Walter Benjamin mi continuano infatti a riportare con la mente verso Filone e il giudaismo alessandrino… magari si tratta solo di suggestioni, magari no.
Un saluto
un po’ di risposte per queste domande,
dove non rispondo si intende che Wu Ming 1 ha già risposto e condivido.
@dovic
sul “mito umanizzato” e sulla “comunità mitopoietica”.
é davvero un equilibrio precario, è qui c’è più una problematizzazione che non una soluzione.
Yves Citton ha recentemente scritto un libro, che Alegre dovrebbe tradurre in cui si affronta la questione:
http://www.fabula.org/actualites/y-citton-mythocratie-storytelling-et-imaginaire-de-gauche_35261.php
la narrazione e l’arte sono il vettore mitologico che può supportare una comunità che si stringe nei suoi simboli, in quali continuo a ribadire, sono indispensabili ma se rimandano a un fondale metafisico determinano quella cultura che Jesi chiama ‘di destra’.
Sono racconti che hanno autori, e che non si fanno da sé, in cui citazione, parodia e ironia sono le strategie per evitare di creare approccio fanatico e idolatra.
laddove parlo di
“sospensione della temporalità o anacronìa, la capacità di giocare tra i diversi strati del tempo» intendo dire che per Jesi questa caratteristica della cultura è di destra se rimanda a un essere fuori dell’uomo;
è di sinistra se rimanda all’uomo che genera miti su di sè e su di essi affida: è l’autoaffermazione dell’umano che crea cultura ed è antropologicamente determinato.
i miti sono il risultato della produzione di immaginario che l’uomo da sé fa su di sé: questa è la concezione del mito-letteratura e della mitologia poetica.
Per chi pensa metafisicamente questo significa che la vita cessa di avere senso se non è fondata sull’essere, per chi pensa in termini naturalistici e materialisti questo non fa che far risplendere la vita umana di “tragica bellezza”. Espressione di Telmo Pievani, filosofo della biologia e allievo di Gould e Cavalli Sforza, curatore del bellissimo numero di Aut Aut dedicato all’evoluzione.
@cesare
«esiste una dimensione oltre-umana a partire dalla quale comprendere il soggetto umano?»
sarò brutale: da Kant in poi è impossibile dimostrarlo e non ha alcun senso farlo. Puoi sperarlo.
In una prospettiva antropologica rigorosamente immanente questo crea più problemi di quanti ne risolva:
smette di essere scienza e diventa teologia, questo è più meno ciò che Clifford Geertz pensava di Eliade.
Platone, per come lo vedo io, è un geniale mitologo, il padre della teologia politica e della tecnicizzazione del mito. Non mi piace l’interpretazione di Reale, mi interessa quella di Vegetti.
@franzecke
Jesi è influenzato dalla tradizione ebraica filtrata da Scholem, Buber, Benjamin.
Ne ho scritto io, e più diffusamente Giulio Schiavoni su «Nuova Corrente» 2009 e Carlo Tenuta, in rete trovi un articolo.
Cosa ti posso dire io qui:
Jesi studia la cabala, che interpreta non in chiave mistica ma in chiave ‘ermeneutica’ e laica:
L’immaginazione simbolica di una comunità passa attraverso l’interpretazione dei testi perché la realtà è pensata sulla base di strutture ideative trasmesse dalla tradizione, innanzitutto scritta: il mito dunque diventa necessariamente una stratificazione complicata, inestricabile dalla sua storia esegetica. Ogni indagine sul mito è dunque interpretazione delle interpretazioni delle mitologie. Questo è chiaro nella tradizione ebraica (è la religione del libro!) ma è valido nell’ambito del mito greco e della mitologia comparata in generale.
Nota: per Benjamin l’interpretazione talmudica è paradigma della comprensione di tutta la modernità;
per Derrida e per Blumenberg il rapporto con il mito dell’ebraismo è il paradigma di ogni rapporto con il mito. Stiamo parlando di ebrei della diaspora non credenti.
Se una posizione metafisica usa l’ermeneutica per cogliere la ‘voce dell’essere’ come avviene con il romanticismo e l’idealismo viene occultata la mediazione testuale (l’umanizzazione): il mito diventa il cavallo di Troia per un approccio metafisico.
Però… la “determinatezza antropologica” dell’essere umano come andrebbe declinata secondo te? E’ il risultato de “la bava e i detriti che la semiosi precedente si trascina dietro” (per dirla con Eco) o è il frutto del suo “posto nel mondo” per come è stabilito dai processi evolutivi (naturali e culturali), dallo sviluppo dei mezzi di produzione e dei rapporti sociali che lo inviluppano, dalla divisione sociale del lavoro ecc.? Non puoi rispondermi “di entrambi”, perché le due prospettive non si muovono su terreni diversi, ma sono due paradigmi che inquadrano lo stesso terreno d’indagine ;-)
Perché – e questo secondo me è un punto fondamentale – se l’umanizzazione dello sviluppo culturale non viene condotta in riferimento alle sue *basi materiali*, si ricade solo in un’altra forma di idealismo. L’idealismo implicito nella presupposizione di un “terzo livello di realtà”, puramente simbolico-semiotico, che sta alla base di tante teorizzazioni della semiotica contemporanea e che rappresenta, a conti fatti, un tentativo di recupero in extremis (magari ibridato con Peirce e Deleuze) dello strutturalismo.
senza indugio, mi sembrava sottinteso, tu l’hai detto:
‘processi evolutivi (naturali e culturali)’, tra i quali figura lo ‘sviluppo dei mezzi di produzione e dei rapporti sociali che lo inviluppano, dalla divisione sociale del lavoro’.
i miei punti di riferimento sono nell’antropologia filosofia,
non credo alla sola ‘cultura’ che sarebbe effettivamente il mondo divenuto favola.
detto questo qualsiasi raffinata analisi del soft power non può sostituire quell’hard power: l’ideologia ccosì come la controcultura presuppongono le pratiche materiali di autorità/violenza/potere.
Quando Jesi critica Canetti (in Materiali mitologici) dice che l’alienazione e il plusvalore non possono essere sostituite da qualsivoglia spiegazione psicologica.
Quindi siamo d’accordo! Non era sottinteso, perché la semiotica “ufficiale” (a Bologna almeno, dove come filone di ricerca sopravvive anche in forma istituzionalizzata… c’è un corso di laurea specialistica dedicato, per capirci) non viene a capo di questa ambiguità. E l’ortodossia accademica, purtroppo, è una rogna ben più grossa dell’ortodossia marxista di un dato gruppo politico ;-)
Altre due cose.
Per “antropologia filosofica” si possono intendere un sacco di cose, fra loro molto diverse. Incluse le teorie di Scheler, Gehlen e Plessner, recuperate ad esempio da Galimberti e ripensate alla luce dell’esistenzialismo heideggeriano nei suoi “imperdibili” tomi… taglia&incolla (“Psiche e Techne” su tutti). Rompere con certo culturalismo retrivo (che flirta proprio con il peggiore “pensiero di destra”), secondo me vuol dire anche rompere con le vecchie etichette, laddove queste lascino margini di ambiguità così pesanti.
Poi. Le pratiche di autorità, violenza e potere restano, secondo me, formazioni sovrastrutturali. Quando parlo di “base materiale” intendo, nello specifico, proprio i buoni, vecchi rapporti di produzione e la loro evoluzione storica legata alle vicissitudini della specie umana. Autorità, violenza e potere, in altri termini, hanno come condizione la divisione della società in classi e il monopolio dei mezzi di produzione da parte di una classe; al punto che non possono sparire se non nel momento in cui la società umana diventa una società… senza classi. Ossia con il pieno e maturo raggiungimento del comunismo.
Poi, è chiaro, la sfera culturale ha una sua relativa autonomia, e a tratti evolve anche in maniera indipendente (pur seguendo, secondo me, la stessa logica di fondo dell’evoluzione biologica e materiale). Il punto essenziale per chiarire secondo me è questo: le idee diventano una “forza materiale” nel momento in cui si trasformano in strumenti al servizio delle rivendicazioni politiche di una determinata classe sociale; nel momento in cui, cioè, diventano un ingrediente dei rapporti di forza fra le classi.
A titolo di esempio, e per restare nell’ambito del “pensiero di destra”, valga l’analisi straordinaria di Mosse sulle origini culturali del nazionalsocialismo.
@ Arrigo Manera
“L’immaginazione simbolica di una comunità passa attraverso l’interpretazione dei testi perché la realtà è pensata sulla base di strutture ideative trasmesse dalla tradizione, innanzitutto scritta”
Ahia, mò ricominciamo a litigare come l’anno scorso… ;) se ben ricordi infatti sono un fervente seguace dell’oralità e della sfera rituale come chiave di interpretazione della realtà mitica, anche se non posso che essere d’accordo con te se parliamo di cultura ebraica (in particolare di tradizione talmudica), e di mitologia comparata – un po’ meno per quanto concerne il mito greco, ma lasciamo perdere…
Il rapporto tra Jesi e Benjamin mi pare strutturarsi intorno al loro essere ebrei della diaspora non credenti, senza dubbio, ma secondo me anche dal fatto di provenire entrambi da famiglie ebree assimilate: è un aspetto questo che per quanto riguarda Benjamin viene affrontato in maniera piuttosto virulenta da Scholem nel suo libro in cui ricostruisce la storia del rapporto tra lui, sionista della prima ora, e il suo più caro amico, ebreo marxista scettico. Credo sia in questo senso che mi viene in mente il giudaismo alessandrino, considerato in una prospettiva sincretistica, ma forse sbaglio.
In ogni caso, ti ringrazio molto per la risposta e per il link dell’articolo, che leggerò con molto interesse.
Un saluto
Ringrazio tutti per le ottime risposte. Dopo aver pubblicato il mio intervento mi sono defilato a causa di impegni di studio e ora anche per malattia (sigh), ma mi riprometto di approfondire gli argomenti e i link che mi avete segnalato.
Dibattito molto interessante, peccato che i tre interpreti Ming1, Manera e Santoro non facciano che ripetere la medesima tesi a voci diverse, creando così, più che una dialettica, un ben compatto coro polifonico. Quella di Jesi è una figura di studioso interessantissima che non può essere liquidata da nessuna battuta. Ma qui sembra che si cerchi di instaurare un impianto ermeneutico per il quale è giusto e necessario condannare a priori il pensiero di un Evola e di uno Schmitt, e quindi la medesima condanna non può essere perpetrata nei confronti di chi (Jesi) condannerebbe il loro pensiero. E’ una tautologia vacua, lo si vede. Più fecondo sarebbe restare filosoficamente sul pezzo, per cercare la verità: esiste una dimensione oltre-umana a partire dalla quale comprendere il soggetto umano? Le nozioni di origine, tradizione, razza, idea si fondano tutte a partire da qui. E – a ben vedere – si tratta di capire se e in che misura è valido l’impianto della filosofia platonica; ovvero, se (e soprattutto) l’ontologia che non riduce l’essere umano a “semplice presenza” (la heideggeriana Vorhandenheit) sia più vera, più valida e più bella dell’ipotesi secondo cui l’ente sia espressione di un essere trascendente. Jesi è lo strenuo paladino della prima delle due possibilità, ma a validità di questa posizione qui parrebbe celebrata, più che discussa. Anche Roger Scruton (che nell’articolo viene banalizzato non diversamente da come Scianca fa con Jesi) ha affermato recentemente che il tema Conservatorismo vs Modernismo vada affrontato a partire da una problematica ontologica di ordine platonico. A me sembra (ma posso ovviamente sbagliare) che il lungo articolo eluda la sostanza del problema, ricadendo, nei confronti della filosofia della Destra, nella medesima metodologia ermeneutica che si vorrebbe (giustamente) criticare nel suo utilizzo contro Jesi.
poiché qui più che pontificare intendo condividere e smistare argomenti segnalo un libro, con relativa recensione, del libro di Zagrebelsky che affronta il potere dei simboli politici e il discorso ‘Simbolo/diabolo’, come qualcosa che unisce/separa.
http://www.filosofia.it/recensioni/gustavo-zagrebelsky-simboli-al-potere-politica-fiducia-speranza
l’altro libro secondo importante è quello di Chiara Bottici,, scusate se mi autocito linkando una mia recensione.
http://www.doppiozero.com/materiali/contemporanea/il-mito-politico-l’immaginario-sociale-tra-ideologia-e-utopia
Ho letto Cultura di destra non molto tempo fa, proprio in seguito a un post su Giap. L’ho trovato interessantissimo ma certo non facile, anche perché conosco poco o nulla gli oggetti di studio di Jesi (non ho mai letto niente di Evola, per esempio, non tanto per ostracismo, che troverei stupido -bisogna conoscere il nemico- ma per semplice pigrizia. La stessa che mi portò ad esempio a snobbare gli inviti al “cineforum virtuale” proposto da WM1 tempo fa sui film fascisti: sono letture/visioni per me poco gradevoli e per quanto utili è difficile trovarvi anche un dilettevole.) Ora magari ci riproverò con l’aiuto di questo libro.
Prima di allora, avevo avuto un incontro direi “inconsapevole”con Furio Jesi, che tuttavia si rivelò provvidenziale: parlo dell’introduzione a “L’isola del Tonal” di Castaneda, autore che stavo divorando in ordine (avevo appena finito Viaggio a Ixtlan, che mi aveva davvero catturato) e, allora poco più che adolescente solitario, ero completamente affascinato da questo percorso esoterico-lisergico :D… Furio Jesi agì da potente anti-allucinatorio. L’isola del Tonal mi “prese” molto meno (la mia lettura di Castaneda, come avrete capito, era tutta “mistica”: non era un interesse etnografico, volevo proprio diventare un “apprendista stregone”…) e persi poi coi libri successivi la disposizione del “discepolo” e con essa anche l’interesse per Castaneda. Anche allora non capii del tutto il discorso di Furio Jesi, ma aveva efficacemente trasmesso una distanza incolmabile con quelle poche ma dense pagine di introduzione, non soltanto aveva fornito un contesto storico-sociale a qualcosa che ne sembrava ontologicamente privo, ma aveva anche spiegato la funzione di questa mancanza e i suoi portati alteranti nella “dottrina” castanediana, svelandone l’apologia del potere personale e della sua asocialità sottese al mito del Potere.
Microscopico appunto sulla citazione un pochino facilona su Sorel: il mito Soreliano è solidamente marxista, anche se nel sentito dire viene automatico associarlo al fascismo. Ma è solidamente marxista: non è una commemorazione vitalistica della violenza, ma una tattica politica atta a rimettere in moto il sistema capitalistico, il cui pieno sviluppo è precondizione del socialismo.
Credo che non sia affatto facilona, anzi
è questo il punto:
Sorel è il padre del mito politico, viene letto da Mussolini e da Lenin.
Quanto scrive le Riflessioni sulla violenza (1907) è nella fase anarco-sindacalista.
I marxisti devono credere nello sciopero generale come i cristiani all’apocalisse, da qui viene la loro forza.
Non è una chiara ipoteca escatologica e metafisica?
La storia poi non finisce bene: Sorel entra nell’Action Francaise nel 1913: la nazione deve sostituire la classe dei proletari in cui lui non crede più. Cioè entra nel primo importante movimento nazionalista europeo, di quella Terza repubblica francese che secondo Sternhell crea la destra moderna.
Mussolini fa lo stesso (sostituisci la classe con la nazione come soggetto rivoluzionario) da massimalista del Psi con lo scoppio della guerra; molti anarco-sindacalisti diventano futuristi e poi fascisti alla fine della guerra.
Non è proprio cosi…
Mussolini dichiara di aver letto Sorel (verosimile) ad un rotocalco francese, poco dopo la marcia su Roma.
Lenin cita Sorel una volta sola, e lo cita dandogli del “esprit-brouillon”, del confuso, in Materialismo ed Empirocriticismo.
“I marxisti devono credere nello sciopero generale come i cristiani all’apocalisse, da qui viene la loro forza.”
Questo dice Sorel? No, questo è il Sorel per sentito dire. Sorel riflette sull’attualità del Marxismo in tempo di contrazione capitalistica, ed arriva a suggerire che solo cercando lo scontro di classe si può riportare la borghesia al suo ruolo storico, e dunque creare le condizioni del socialismo.
Il mito Soreliano è una variante sul tema della coscienza di classe: è determinazione di una volontà collettiva, espressione della classe operaia. C’è ZERO escatologia nelle Riflessioni, e nel pensiero Soreliano in generale.
Sorel non è mai entrato nell’Action Française.
Ha scritto una recensione all’amico Péguy sul loro giornale nel 1910, ed una lettera a seguire nello stesso anno. Alcuni anni prima aveva ripubblicato in una rivista vicina ad ambienti Maurrassiani un suo vecchio articolo italiano: ‘comme ils citent continuellement mes livres, je ne pouvais leur nier une collaboration de ce genre’ scrive a Croce.
Per il resto, ci sono tentativi di riviste falliti con gente de l’AF, e qualche simpatia reciproca. Culture di destra e di sinistra che si opponevano alla III Repubblica. Nel clima avvelenato post-Dreyfus, questo ed altro era possibile.
“la nazione deve sostituire la classe dei proletari in cui lui non crede più.”
Quando sarebbe che Sorel parla di comunità nazionale come soggetto rivoluzionario? Confondi Sorel con alcuni suoi discepoli, che effettivamente tentarono quella strada, aprendo la poco fortunata rivista ‘Cahiers du Cercle Proudhon’, nella quale si tenta la sintesi di cui tu parli. Ma intellettualmente è poco più che un rancore semi-articolato contro la terza Repubblica, sul quale c’è molto da dire. Ma soprattutto, non è una strada tentata da Sorel. Che, anzi, dedica gli anni finali della sua vita ad una raccolta dei suoi scritti socialisti (il cui emblematico titolo è Materiali per una teoria del proletariato ) ed al progetto di un libro su Proudhon.
I danni che ha fatto Sternhell al povero Sorel sono grandi. Ma è un pensatore da leggere, per andare oltre la leggenda ed il sentito dire.
vediamo, le mie fonti sono H. Stuart Hughes, Coscienza e società e Sternhell, prometto di approfondire e di raddrizzare eventualmente il tiro sulla biografia di Sorel, adesso non ho strumenti precisi; è possibile anche che non conosca bene Sorel e che abbia confuso lui e suoi discepoli.
Il testo di Sorel però dice:
«noi sappiamo che lo sciopero generale è, per l’appunto, il mito in cui viene a compendiarsi il socialismo, nella sua interezza. un organismo di immagini capaci di evocare, con la forza dell’istinto, tutti i sentimenti che corrispondono alle diverse manifestazioni della guerra, impegnata nel socialismo contro la società moderna. Gli scioperi hanno fatto fiorire nel proletariato i sentimenti più nobili, più profondi, più fattivi, ch’esso possegga. Lo sciopero generale li unisce tutti, in un quadro d’insieme; dà a ciascuno di essi, riunendoli insieme, la massima intensità. (…) Noi otteniamo così quella intuizione del socialismo che il linguaggio non poteva fornirci in modo perfettamente chiaro – e l’otteniamo, in un insieme percepito istantaneamente».
ancora:
«le costruzioni di un avvenire indeterminato nel tempo possono avere una grande efficacia quando […] si tratta di miti che racchiudano le tendenze più spiccate di un popolo, di un partito o di una classe; che, con la tenacia propria degli istinti, si presentano allo spirito in tutte le circostanze della vita; che infine diano un aspetto di piena realtà alle speranze di prossima azione su cui si fonda la riforma della volontà».
G. Sorel, Le riflessioni sulla violenza, Laterza, 1974,
p. 183-184; p. 180.
Per me questa è cripto-escatologia. La mia opinione peraltro può essere irrilevante.
Per Jesi questa è cultura di destra. Scrive che una coscienza di classe degna di questo nome non si può fondare sul mito, è troppo pericoloso.
se Sorel pensava di scrivere per il socialismo e i suoi allievi diventano nazionalisti mi sembra una conferma.
Stuart Hughes è buono, Sternhell molto meno.
Il discorso è lungo e non fattibile qui.
Ci sono molti elementi da tirare in ballo, contesti filosofici, contesti politici ed anche elementi biografici. Ma non c’è nessuna escatologia in Sorel, il cui pensiero è dominato dall’idea della contingenza fondamentale del processo storico. Questo il vero Sorel, il Sorel che non ha mai pensato alla comunità nazionale come soggetto rivoluzionario, che non si è mai iscritto all’action française, e soprattutto il Sorel che ha pubblicato centinaia di testi oltre le Riflessioni.
Poi c’è il Sorel per sentito dire che resiste, anche perchè latitano gli studi seri. A questo proposito: Georges Goriely, Le Pluralisme Dramatique de Georges Sorel, Paris, 1962.
@ ldtxv,
alcune cose:
nei primi anni Novanta, incuriosito dal capitolo su Georges Sorel nel libro Il marxismo introvabile di Daniel Linderberg (capitolo intitolato “Un sole nero o l’azione”), lessi le Riflessioni sulla violenza. Pensa che le trovai in un’edizione inglese, su una bancarella.
Negli anni successivi, rimuginai sulle intuizioni di Sorel e, insieme ad altri compagni, cercai velleitariamente di “rimetterle in gioco”. Pensavo si potesse riprendere il “nocciolo” di quella proposta mitopoietica, in un diverso contesto storico, con una diversa composizione dei movimenti e, ovviamente, con alcune cautele di fondo. Il Furio Jesi di Letteratura e mito mi/ci aveva messi in guardia, dicendo che era pericoloso, ma non lo ascoltammo, o meglio: lo ascoltammo, ma pensavamo di potercela cavare. Tracce di quella lettura di Sorel si ritrova in una mia conferenza (abortita) del 2001:
Tute bianche: la prassi della mitopoiesi in tempi di catastrofe
Eravamo già (poco) dopo Genova e non credevo fino in fondo a quel che stavo dicendo, avevamo già fatto esperienza delle conseguenze nefaste della “convocazione mitica”. Ma in pubblico ero ancora restio a trarne tutte le conseguenze. Già in quel testo prendevo Sorel “con le pinze”, ma in buona sostanza pensavo (con meno convinzione di prima, ma ancora lo pensavo) che si potesse usare la sua “cassetta dei martelli” (non c’erano altri strumenti: niente viti o cacciaviti, solo chiodi e martelli, era uno che inchiodava e smartellava, non uno che smontava, oliava i pezzi, rimontava: diceva che andava prodotta UN’immagine dello scontro)
La nostra posizione del 2002 è precisamente quella che poi abbiamo criticato con durezza nel 2009. E l’abbiamo criticata anche ricordando la frase con cui Jesi, ai tempi, ci aveva messi in guardia. Non si può mobilitare qualcuno facendo affidamento sulla sola “tecnicizzazione” di un mito di lotta e poi sperare che i soggetti mobilitati siano in grado di criticare il loro movente mitico; non si possono evocare potenze irrazionali e poi sperare che il movimento sia abbastanza maturo da controllarle.
– Io credo che il mito soreliano sarebbe “di destra” anche se Sorel fosse stato il più sperticato elogiatore del marxismo, e anche senza gli ambigui pencolamenti del suo propagandista. “Ambigui”, sì, perché anche se non aderì all’AF, comunque ne frequentò gli esponenti e la pubblicistica, contribuendo a creare quella “interzona” tra estrema destra ed estrema sinistra che poi si sarebbe popolata di discorsi protofascisti, spesso fatti da suoi allievi o ammiratori. Si formò uno spazio di convergenza dove gli enunciati erano in continua, pericolosa oscillazione da un polo all’altro. Il mito soreliano sarebbe comunque di destra, perchè in nuce è manipolatorio e autoritario, è pavloviano, è uno stimolo inteso a sollecitare *una* risposta e non altre. La classe è descritta come protagonista dello scontro, ma in realtà è un ricettore di enunciati preparati altrove, sono al lavoro intellettuali tecnicizzatori, “facitori di mito”.
– Avrei un’altra cosa da dire, ma per poterla dire devo farti una richiesta di fonti: potresti citarmi il testo dove Sorel dice che il mito dello sciopero generale serve a far ripartire il capitalismo e assicurarne il pieno sviluppo? Grazie.
“Il mito soreliano sarebbe comunque di destra, perchè in nuce è manipolatorio e autoritario, è pavloviano, è uno stimolo inteso a sollecitare *una* risposta e non altre. La classe è descritta come protagonista dello scontro, ma in realtà è un ricettore di enunciati preparati altrove, sono al lavoro intellettuali tecnicizzatori, “facitori di mito”.”
No, no, no, è proprio il contrario. L’astio nei confronti di una classe intellettuale manipolatrice (‘giacobinismo’ nel vocabolario di Sorel) è un tratto fondamentale di tutti i suoi scritti socialisti. Nelle stesse Riflessioni è centrale la differenza tra mito (espressione della volontà collettiva di una realtà sociale) ed ‘utopia’ (prodotto intellettuale e modello di società). Sorel insiste lungamente sul fatto che solo l’utopia è pericolosa, precisamente in quanto contenente istruzioni precise sull’organizzazione della futura società socialista. Ma cio è 1-assurdo (perchè il futuro non è conoscibile) e 2-pericoloso, perchè svuota la specificità di classe della rivoluzione.
Sulla tua richiesta di fonti, io penso che questo sia quello che emerga da una lettura comparata delle Riflessioni e del libro che lo precede, gli “Insegnamenti sociali dell’economia contemporanea”, un testo del, se non sbaglio, 1907. Il sottotitolo del libro è: decadenza capitalista e decadenza socialista, e li argomenta che laissez-faire e marxismo sono ideologie proprie ad un sistema capitalista in espansione, mentre socialdemocrazia e protezionismo caratterizzano un sistema economico in crisi. E’ questa crisi, questa contrazione delle forze produttive, che determina la “decadenza capitalista” e la “decadenza socialista”.
PS: Il saggio di Lindenberg è scritto bene, ma nell’edizione Francese il titolo del capitolo su Sorel è “il brutto anatroccolo” (le villain petit canard). Di quale edizione parli? Di quella del 75 o del 79? Curiosa, comunque, come traduzione.
Intanto segnalo la risposta di Girolamo, che secondo me dice meglio cose che ho detto male io.
Su Lindenberg, ce l’ho qui davanti:
edizione Nuovo Politecnico 98 Einaudi 1978, traduzione dell’edizione Calmann-Lévy del 1975, capitolo secondo: “Un sole nero o l’azione: Georges Sorel”.
Sul fatto che Sorel contestasse le élites del movimento operaio e socialista e il “giacobinismo”, è vero, ma almeno nelle “Riflessioni” mi sembra alludere continuamente a un’altra élite, un’élite invisibile e informale. Sono costoro che devono impugnare il mito dello sciopero generale e sventolarlo davanti alla classe come fa il toreador col suo drappo rosso.
Può darsi, naturalmente, che la mia sia una lettura influenzata da anni di militanza nei movimenti e di innumerevoli assemblee “orizzontali”, “senza leader”, dove si diceva che l’assemblea era l’unico sovrano, si contestava la presenza di realtà organizzate, si esprimeva una critica della prassi di votare e decidere per maggioranza perché sarebbe stata una modalità autoritaria e para-parlamentare etc.,
Dentro quelle assemblee non si prendeva una sola decisione, per il semplice motivo che erano già state prese prima. L'”istituzione” sovrana era in realtà il corridoio, o una stanzetta dove si era riunito il “gruppo ristretto”. Erano in azione élites e correnti “informali” e strategie invisibili di condizionamento della discussione, tramite la disposizione delle persone nella sala, il volume della voce, gli interventi che si confermavano “a batteria”, il linguaggio del corpo, la disponibilità a rimanere più a lungo di altri che la mattina dopo dovevano alzarsi per andare a lavorare etc. etc.
Sai quante assemblee ho visto vincere in modo sottilmente autoritario da pretesi libertari?
Tutte quelle che ho visto.
E a volte, shame on me, tra quei pretesi libertari c’ero anch’io.
La condanna a parole (anche molto energica) di caste burocratiche, dirigenze codine, élites prevaricanti, autoritarismi, spesso è accompagnata dall’apologia tra-le-righe di un’élite “diversa”. Foss’anche l’élite che impedisce l’azione di altre élites, è comunque un corpo separato. E se è un corpo separato che ricombina in modo strumentale e incanala materiali mitologici che devono sollecitare nella classe una precisa risposta, è l’élite più pericolosa.
Ammazza che riflessione amara… posso solo aggiungere che te hai quello che a Sorel mancava, e cioè l’esperienza concreta della politica.
Credo che la rivista a cui fa riferimento @ldtxv sia “L’Illustration”, nel 1932. Non ho a mano quell’intervista, ma se Mussolini dice di aver letto le Riflessioni sulla violenza solo dopo la marcia su Roma mente: nel 1909 Mussolini lo recensì, subito dopo aver recensito La teoria sindacalista di Prezzolini. A mia memoria (ma non ricordo la fonte), Mussolini ha ri-letto le Considerazioni nei giorni della detenzione, assieme a Pietro Nenni, per il boicottaggio dei treni che portavano i soldati alla guerra di Libia.
Lasciando da parte le molte ambiguità del Sorel degli anni Dieci e Venti, e le letture strumentali della destra francese, che il mito di Sorel sia “solidamente marxista” è difficile da sostenere. Sorel allarga l’interpretazione dell’XI tesi su Feuerbach (influenzato certo da Bergson e Le Bon (ahi ahi ahi…), spostandone il significato tutto sul momento dell’azione che cambia il mondo, sino a negare valore alla conoscenza del mondo. Per Sorel la realtà è dominata da forze irrazionali ed è quindi inconoscibile tanto dalla scienza storica, quanto dalla scienza vera e propria: «non vi è nessun procedimento che ci permetta di prevedere l’avvenire in modo scientifico, o di discutere della superiorità che certe ipotesi possono avere rispetto ad altre» (pp. 215-16 dell’ed. UTET, cap. IV). Questo non solo non è conciliabile col materialismo scientifico di Marx, che crede che nella storia ci agiscano leggi razionali, che queste leggi siano conoscibili, e che la loro conoscenza possa migliorare l’azione di modifica dello stato di cose esistenti. Ma è molto vicina, nel suo irrazionalismo, a un filone ben preciso del pensiero reazionario italiano (e non solo) che fa dell’inconoscibilità del reale, e quindi della natura irrazionale della realtà, un canone che sfocia nell’accettazione dello stato di cose esistente, o nell’esaltazione dei pochi che sono capaci di compiere il salto nel buoi e guidare l’azione: da Guicciardini a Mussolini, per intenderci. Non per caso uno dei più raffinati intellettuali fascisti, Nello Quilici, scrive negli anni Trenta saggi anti-machiavelliani in cui esalta Guicciardini proprio sul tema dell’inconoscibilità e dell’irrazionalità della vita.
Su questo sfondo, il mito in Sorel è un mito tecnicizzato: lo stesso Sorel afferma più volte che l’unico criterio dirimente è quello funzionale, non la pretesa aderenza del mito alla realtà. Banalizzando, Sorel ritiene che non sia importante che il contenuto del mito sia vero: importante è solo che funzioni. E fa del mito una sorta di trascendentale storico, in cui non fanno differenza le condizioni materiali del mito stesso, né i diversi soggetti cui afferisce: «l’esperienza ci prova che le costruzioni di un avvenire indeterminato nel tempo possono possedere una grande efficacia presentando ben pochi inconvenienti, allorché tali costruzioni siano di una certa natura; ciò che si verifica quando si tratta di miti nei quali si ritrovano le più forti tendenze di un popolo, di un partito o di una classe (sic)» (p. 216).
Il che non toglie che ci siano aspetti di Sorel che possono essere letti “a sinistra” (la sua critica al revisionismo e alla deriva parlamentaristica, ad es.): ma che lo sfondo su cui si muove la teoria del mito possa altresì essere assimilato da una lettura reazionaria mi pare difficile da negare.
Ed invece lo nego ;)
“Questo non solo non è conciliabile col materialismo scientifico di Marx, che crede che nella storia ci agiscano leggi razionali, che queste leggi siano conoscibili, e che la loro conoscenza possa migliorare l’azione di modifica dello stato di cose esistenti. ”
E’ proprio contro ciò che si muove il Marxismo Soreliano, influenzato da fonti nostrane (Labriola, Croce e Vico).
La prassi rivoluzionaria è anche un modo conoscitivo, poichè le uniche realtà sociali che si possono conoscere sono quelle create dagli uomini stessi: verum ipsum factum.
Non c’è da stupirsi che Lenin non abbia gradito: col suo materialismo brutale, tutto questo doveva essere solo filosofumo.
Ma questa è la base idealistica del Marxismo soreliano. La stessa base idealistica di Gramsci oserei dire, che infatti stronca il Lenin di Materialismo ed Empirocriticismo.
PS: Era proprio l’illustration. E mi ero confuso fra 1932 e 1922.
@ ldtvx, WM1, Malera
Il mio commento qui sopra è riferito all’intera discussione che segue il commento di @ ldtvx delle 4:05pm. Purtroppo ho sbagliato a cliccare (in realtà non capisco come funzioni questo sistema di commenti). Gli ultimi due commenti, quello di @WM1 e l’ultimo di @ ldtvx, sono stati pubblicati mentre scrivevo, e quindi non li avevo letti.
Devi cliccare sul bottone “Reply” che sta sotto lo specifico commento al quale vuoi rispondere. Se non c’è, è perché “sono finiti i livelli”, e allora basta che risali fino al primo bottone utile, e clicchi quello.
Ok, chissà se lo imparo. Nel frattempo mi è scappato un altro commento fuori posto,vabbé…
Che facciamo, @ldtxv? Ci rivolgiamo a un trascendente oltre-umano pseudoplatonico dal cui punto di vista commisurare le nostre tesi, o ci accontentiamo di aver fornito argomenti a supporto delle rispettive tesi? ;-)
Vada per la seconda, è già una soddisfazione in se. :)
PS: Ci si può tenere in contatto?
Devo dire che, finora, questa discussione non mi sta piacendo granché.
Evidentemente dobbiamo avere sbagliato qualcosa nel post…
Pensavamo di averlo impostato in modo anche molto *politico*. Abbiamo suggerito possibili usi della “cassetta degli attrezzi” di Jesi nel presente, per leggere fenomeni (e pericoli) di adesso, e speravamo che un po’ di spunti che abbiamo gettato sulla differenza destra-sinistra e la cultura di destra che c’è “a sinistra”, il mito politico, il M5S, gli odierni neofascismi, la cultura di massa reazionaria, i miti dei “bei tempi” etc. potessero interessare, incuriosire e sollecitare risposte anche, al limite, tra quelli che Jesi non lo avevano mai sentito nominare.
Pensavamo che questa fosse la miglior introduzione possibile a Jesi, nonché il miglior omaggio. Spiegare come mai i fascisti lo odiano e spiegare perché le sue riflessioni sono utili nel presente erano per noi *la stessa cosa*.
Però dobbiamo avere sbagliato qualcosa, perché la discussione è molto, molto… “teoretica”, filosofica nell’accezione più autoaggrovigliante, con un sacco di teorie e letture date per scontate, un sacco di nomi di filosofi e semiologi (davvero un sacco di “name dropping”!).
Una discussione che rischia di far sentire inadeguati molti lettori, e dunque di essere respingente, ottenendo quindi l’effetto contrario che ci eravamo proposti. Jesi non è certo un autore facile, ma è come ha scritto Diserzione nel suo commento: anche non capendo tutto subito, quel che si capisce mette in moto sinapsi, fosse solo perché Jesi afferra cose che “stanno in cielo”, trascendenti, e le porta “a terra”, nell’immanenza, nella storia.
Scusate lo sfogo, ma volevo condividere questo disagio.
Io ne so poco ma non per questo mi sento *respinta*, anzi trovo la discussione molto interessante; certo non è che abbia granché da aggiungere ma in una discussione a volte si partecipa in modo intenso anche solo ascoltando.
Secondo me nel post non c’è niente di sbagliato, però c’è da dire che è molto lungo e denso e quindi se uno parte da zero o poco più (io so di Jesi solo quello che ho letto qua sopra anche in altre occasioni) leggere, metabolizzare, sintetizzare e sviluppare un discorso autonomo richiede un certo tempo e impegno.
“leggere, metabolizzare, sintetizzare e sviluppare un discorso autonomo richiede un certo tempo e impegno.”
E di sicuro questa configurazione a commenti nidificati non aiuta: è tutto un apri/chiudi, leggi su e leggi giù, avanti e indietro… sì, sì lo so per quelli che twittano la lettura è più semplice, ma posso per due secondi fare la conservatrice? Sogno il ritorno a quell’età dell’oro in cui su Giap i commenti erano a struttura lineare e ci si rivolgeva direttamente a Tizio o Caio usando la @.
Quando i commenti al post sono lunghi e affrontano tematiche complesse (come questo) per me è molto faticoso seguire (ma forse è un limite mio). Perdonate l’OT reazionario.
In realtà quello è un vantaggio: quando ci sono digressioni ultratecnicofilosofiche o comunque ultraspecifiche, se rimangono confinate dentro un sotto-thread è meglio. Senza la ramificazione, vedresti tutti i messaggi tutti di fila, tutti ugualmente “importanti”, e se ci sono 67 commenti di gara di piscio e solo il 68esimo è interessante, ti devi comunque seguire tutta la gara di piscio. Invece, con la ramificazione, si fa il possibile perché le nostre gare di piscio non siano visibili subito, e quindi non ingombrino lo spazio e la percezione.
Dovrebbe funzionare che uno dà prima un’occhiata al “tronco” principale della discussione, poi se “ha lo stimolo” apre le sottodiscussioni. Se vedi che un commento comincia tipo: “La scotomizzazione parziale dell’essere che gli esistenzialisti avevano frainteso a partire da Jaspers…” e vedi che gli hanno risposto in 23, per quale motivo al mondo dovresti cliccare e leggere il sotto-thread? Passi oltre e amen.
Mmmh, dipende… il fatto è che se io resto lontano dal pc per alcune ore o magari un giorno, mi viene istintivo andare a recuperare tutto, ma proprio tutto (anche le sottodiscussioni) ciò che è stato scritto in mia assenza e un po’ mi perdo, comunque è sicuramente un mio limite.
In quel caso, suggerisco di fare così:
– aprire sottodiscussione n.1
– leggerla
– richiuderla (questo è forse il punto più importante. Una sottodiscussione si richiude cliccando di nuovo sul numero dei commenti; se si lascia tutto aperto, è chiaro che poi non si capisce più niente)
– aprire sottodiscussione n.2
etc.
Lo faccio già. Comunque, come ti dicevo, è di sicuro un mio limite ed è anche giusto adattarsi ai cambiamenti. L’età dell’oro non esiste.
“interessare, incuriosire e sollecitare risposte anche, al limite, tra quelli che Jesi non lo avevano mai sentito nominare”
“spiegare come mai i fascisti lo odiano e spiegare perché le sue riflessioni sono utili nel presente”
“Una discussione che rischia di far sentire inadeguati molti lettori, e dunque di essere respingente, ottenendo quindi l’effetto contrario che ci eravamo proposti”
…ma quindi è la voce delle masse ignoranti quella che vi preme? Stai dicendo che non era tra voi, ma era per noi? E’ questo il senso della metafora della cassetta degli attrezzi?
Stento a crederlo, ma per una volta sono totalmente d’accordo con te ;) sembra una gara a chi ce l’ha più lungo.
Peccato, anche perché credo che molti degli autori che sono stati citati finora funzionino molto meglio fuori dall’accademia – Jesi in primis.
“sembra una gara a chi ce l’ha più lungo”
io invece PER UNA VOLTA ;-)) non ho avuto questa impressione. Leggo più entusiasmo che esibizionismo
Sottoscrivo. E’ una cosa che qualche volta capita, da queste parti. E’ anche uno dei motivi che mi fanno continuare a leggervi, perché meno ci capisco un cazzo più voglio capirci, ma non so se sia per tutti così. Non ho trovato da nessun’altra parte una situazione in cui gli utenti di un blog sono altrettanto, se non più, preparati degli autori, e su un’infinità di argomenti. Da un lato è una grandissima opportunità di confronto o, almeno nel mio caso, di crescita e apprendimento, ma quando succede, come in questo caso, che si prenda il volo verso paradisi interstellari della filosofia politica, il mio complesso di inferiorità mi dice che nel mio corpo non c’è più spazio per tutti e due. E io sono il primo a irritarmi quando sento molte persone dire di “non fare l’intellettuale”, come se quest’epiteto fosse ormai diventato un insulto. Però se facciamo così stiamo per primi porgendo le terga a questo genere di discorsi (da residuo culturale di destra, ma senza lusso spirituale stavolta). Peace.
“Pensavamo di averlo impostato in modo anche molto *politico*. Abbiamo suggerito possibili usi della “cassetta degli attrezzi” di Jesi nel presente, per leggere fenomeni (e pericoli) di adesso” […]
“Una discussione che rischia di far sentire inadeguati molti lettori, e dunque di essere respingente, ottenendo quindi l’effetto contrario che ci eravamo proposti”
Sebbene condivida l’opinione di alcuni giapster, ovvero che spesso trovo piacevole anche solo ascoltare, in questo caso leggere, discussioni dal livello così “alto” e che altrettanto è bello constatare come in questo blog autori e commentatori sono in tutto e per tutto allo stesso livello, il senso di inadeguatezza da me provato è evidente.
L’articolo in sé è un bel malloppo e per me non tanto semplice, tra impegni vari ci ho messo tre giorni a leggerlo per intero, ma mi sono intestardito nel farlo dal momento che la figura di Jesi è stata più volte ripresa in questo blog. Insomma desideravo farmi un’idea di questo personaggio, conoscerlo, sapere cos’ha fatto, cosa pensava.
La volontà di innescare una discussione politica attuale espressa dallo sfogo da WM1 l’ho colta, tanto che finita la lettura mi sono precipitato sui commenti alla ricerca di qualche spunto del genere, ma niente. Per quanto mi riguarda i miei possibili spunti e domande sono stati completamente annullati dallo sforzo di capire almeno un venti per cento dell’argomento =)
Al momento mi sento tanto una voce della “massa ignorante” citata da @VecioBaeordo. Ma se posso fare una piccola critica il mio senso di inadeguatezza deriva tutto dall’impostazione molto filosofica (molto evidente nei singoli termini, nelle parole usate) dell’intervento a tre. Speravo di leggere una “spiegazione per principianti”, una “semplificazione” del pensiero di Jesi, anche se da quel che ho capito questa è molto difficile, o impossibile, da fare.
@ Filippo
Speravo di leggere una “spiegazione per principianti”, una “semplificazione” del pensiero di Jesi, anche se da quel che ho capito questa è molto difficile, o impossibile, da fare.
Secondo me non è affatto impossibile, io sono privo di qualsiasi formazione filosofica eppure Jesi l’ho letto, (credo) di averci anche capito qualcosa, e lo utilizzo sempre con grandissima, direi quasi inestimabile, utilità.
In questo senso, il lavoro di *divulgazione* operato dai nostri ospiti aiuta parecchio.
Il vostro “dialogo a tre” mette sul piatto un sacco di questioni, e secondo me è anche normale che alcuni rami della discussione finiscano per impantanarsi in un dibattito più filosofico o storico-filologico. Mi dispiace aver contribuito a questa deriva “respingente”, però la tentazione in questo caso è stata troppo forte: per la prima volta mi è capitato di trovare un contesto, al di fuori della palude accademica, in cui riprendere e rimettere in gioco alcune idee e suggestioni che avevo lasciato per anni a prendere polvere in un cassetto. Se ho esagerato con il “name dropping” mi scuso; potevo sicuramente esprimerle con meno enfasi.
Poi devo anche dire che non mi sembravano troppo OT, visto che voi per primi riconoscete che un utilizzo appunto *politico* di Jesi va fatto anche rispetto ai residui culturali di destra nel pensiero di sinistra; un utilizzo che spinge certamente su un crinale difficile e pericoloso, sul quale però bisogna prima o poi incamminarsi, consapevoli del fatto che si può scivolare nel burrone da un momento all’altro e che qualche parete un po’ ostica va comunque scalata (senza un ragionamento approfondito sul significato del materialismo dialettico, ad esempio, diventa difficile secondo me valorizzare fino in fondo il potenziale critico ed emancipativo del marxismo).
Ho letto avidamente gli interventi su Sorel, del quale conosco quasi nulla, e che mi hanno invogliato ad approfondirlo, magari in futuro. E non è la prima volta che discussioni più “specialistiche” qui su Giap mi aiutano a incrociare qualcosa di nuovo. Penso che le discussioni servano anche a questo, dopo tutto :-)
Più che altro, in ogni discussione “anime” diverse e registri diversi forse possono anche convivere. Fermo restando che, laddove si genera uno squilibrio così forte, diventa necessario riequilibrare.
io abbasso subito il tiro con due cose,
una di attualità e una di riflessione, ho trovato due cose che mi incuriosiscono sul tema ‘culture di destra’:
i nazionalbolscevichi (su cui vorrei sapere di più) che mi sembrano simili agli ungheresi di Jobbik
l’uso che sul sito di casapound (che è stato linkato) si fa delle modelle tricolore,
una versione aggiornata delle copertine di fausto papetti, delle copertine di panorama o comunque dell’uso berlusconiano del corpo femminile.
machismo classico o qualcosa di più?
@ Manera
Non credo sia machismo in senso classico: secondo me è piuttosto la versione Terzo Millennio del “lusso spirituale” di cui sopra.
Evidente funzione decorativa, kitsch in senso stretto, e poco altro…..
E a proposito… visto che si parla di Jesi, e che di conseguenza l’ombra lunga di Kerényi si allunga inesorabile sulla nostra discussione, credo che un buon omaggio nei confronti di tale maestro potrebbe essere tirare un po’ in ballo quanto sta avvenendo in Ungheria… io ne so davvero poco, ma *per quel poco che ne so* sembra proprio una storiaccia.
nel frattempo ho ancora pensato che cosa mi incuriosisce: la possibilità di capire quale è lo stile estetico e visuale della cultura di destra e come muta nel tempo,
il kitsch ad esempio, lo è per noi, ma non è percepito tale da chi lo usa e piene mani e ci vince le elezioni ad esempio, o ci conquista le periferie.
iconografia, ma anche tratto grafico, editing, immaginario, stile di quel ‘kitsch spirituale’ e oggi ‘erotico’ che probabilmente vuole essere vitalista e edonista.
un sito filo-fascista lo vedi dai colori e dai font.
per quanto riguarda l’aspetto teorico del forum, molto dipende dalla mia impostazione, credo, che riflette la complessità dell’uomo-Jesi: chi conosce la letteratura sa che questo è davvero uno sforzo di ‘urbanizzare’ Jesi.
Uno sforzo di non essere esoterici o autoreferenziali, credo davvero che Giap sia una eccezionale ‘palestra dell’ardimento’ (quella del gruppo Tnt ovviamente) in cui discutere alla pari e condividere: abbiamo voluto molto, soprattutto Roberto di partire da lì per dire sull’oggi.
L’impressione che ho avuto io è che essendo tutti abbastanza d’accordo sugli esiti pratici in termini politici ci sia un forte bisogno di chiarire ed esplicitare i fondamenti di quello che si pensa, che è comunque una sana forma di riflessione.
Suona l’intervallo ed entro in classe, un abbraccio,
Non saprei, è un discorso parecchio complicato.
Di recente ho letto un libro di Hermann Broch su Hoffmannsthal, in cui il tema del kitsch, considerato come un sintomo di decadenza, era centrale.
Secondo Broch il kitsch si manifesta sempre quando la funzione decade per lasciare il posto ad una forma che si riduce a semplice apparenza: per dirla con parole mie, il kitsch è dunque quello che a Roma si definisce un’imbastita.
Ora, l’impressione che ho ogni volta che mi trovo di fronte ai manufatti dell’estrema destra italiana contemporanea – soprattutto dell’area riconducibile a Casapound – è esattamente quella di trovarmi di fronte ad un accrocco semantico totalmente privo di fondamento, una sorta di frullatone in cui elementi eterogenei vengono mischiati senza alcun nesso logico, e in cui l’elemento grafico/decorativo riveste una funzione centrale.
Se c’è una cosa che possiamo evincere dalla più recente storia politica italiana è che il kitsch sembra funzionare alla grande, e lo dimostra il fatto che come dicevi giustamente tu serve a vincere le elezioni e a conquistare le periferie; in questo senso, mi sembra che i fascisti nostrani abbiano imparato molto bene la lezione del berlusconismo, e che al di là delle loro *chiacchiere* sulla Purezza dello Spirito che si incarna nei Cuori Arditi dei Giovani Ribelli e via così, alla fin fine il loro immaginario si riduca ad una visione del mondo assai meschina, del tutto priva di sostanza, e decorata – ça va sans dire – da ritratti di bonazze messe a pecora.
Inutile aggiungere che tutto ciò mi sembra estremamente pericoloso proprio perché, come dicevo prima, sono proprio queste stronzate ad abbindolare i ragazzini al giorno d’oggi, esattamente come succedeva quaranta anni fa con la paccottiglia esoteristica alla Evola/Guénon/Eliade e ottanta anni fa col simbolismo funerario legato al culto della Bella Morte.
grazie per Broch, adesso metto da parte, mi hai fatto venire in mente che ne ha scritto Belpoliti in Crolli, che ora riprendo.
anche Kundera, se ne è occupato: il kitsch nasconde ciò che considera inaccettabile nell’esistenza ed è il risultato del sentimento in sentimentalismo,
nell’insostenibile leggerezza parla di «dittatura del cuore» e di «accordo categorico con l’essere». nel regno del kitsch totalitario le risposte sono date in precedenza ed escludono qualsiasi domanda.
cultura di destra, insomma
Kundera, eh?
Non conosco, ma quel che riporti mi sembra molto calzante.
Il kitsch è anche uno dei punti chiave per la lettura del lavoro sui Passages di Benjamin.
Tutto torna…
un saluto
Azzardo una risposta sui nazionalbolscevichi russi. Per quanto riguarda le loro imitazioni italiane c’è il sempre verde articolo di Evangelisti per Carmilla sui rossobruni:
http://www.carmillaonline.com/archives/2010/07/003561.html
Il libro di Carrere su Limonov ha dato ai nazionalbolscevichi un’improvvisa popolarità fuori dalla Russia, ma per approfondire la questione al di là delle chiacchiere alla moda basta buttare un occhio ai vecchi testi di Limonov (in inglese) su exiledonline (non lo linko, c’è Google): si tratta di una riproposizione da manuale del polpettone ideologico a là Jesi.
Tento una sintesi storica: i nazbol nascono contestualmente alla caduta dell’Unione sovietica dall’incontro fra Limonov e Aleksandr Dugin, rispettivamente “leader carismatico” e ideologo. Ne esce un partitino che si allea di volta in volta ai nazionalisti o ai comunisti.
Per farla breve, ad un certo punto Limonov e Dugin litigano.
Oggigiorno Limonov sta cercando di darsi una patente di rispettabilità: si era alleato con i liberali di Kasparov e ha dovuto cambiare nome al partito (ora si chiama “Russia unita”). Di recente ha anche affermato il carattere “antifascista” del nazionalbolscevismo. Si tratta di un’escamotage, probabilmente, ma è interessante perché il modo più efficace per sgamare i néné nostrani è proprio chieder loro cosa pensano dell’antifascismo (vedi Grillo e casaclown).
Più inquietante la parabola di Dugin: dopo la separazione da Limonov ha fondato un centro di studi “eurasiatici” con i soldi del Cremlino e sta tentando, con non molto successo, di diventare il Ras-putin di Zar Putin.
La sua corrente nazionalbolscevica pone l’accento in modo più netto sul “nazi”: Dugin vagheggia un’impero eurasiatico che unisca la Russia all’Europa e si allei con la Cina e il “mondo musulmano” (percepito ovviamente come un blocco monolitico) contro gli Usa. Nel nome de che? Ma della TTTTradizione, ovviamente.
E qui veniamo al punto: uno dei più importanti riferimenti ideologici di Dugin (forse il principale) è Julius Evola.
L’influenza del vecchio cialtrone è arrivata a farsi sentire fino in Russia, dove alle sue idee si ispira un movimento piccolo ma certo non insignificante.
Dugin a sua volta è un tipo pericoloso: in Italia è in diretto contatto con la rivista Eurasia (di cui fanno parte anche autori italiani non immediatamente riconducibili all’estrema destra, buttate un occhio).
Anche in Turchia sembra che Dugin fosse in contatto con le parti più golpiste dell’esercito, e fino a qualche tempo fa c’era anche un partitino eurasiatista a lui ispirato.
Quanto alla somiglianza dei nazionalbolscevichi con Jobbik non saprei: mi sembra che gli ungheresi abbiano un approccio più retrò. Un po’ la differenza che passa in Italia fra forza nuova e casaclown, per intenderci.
Errata corrige: il partito di Limonov si chiama “Altra Russia”, “Russia unita” è quello di Putin. (C’è l’ho fatta a ramificare!)
Dio, ce l’ho fatta, non c’è. (davvero, cosa mi succede? :))
grazie,
storia molto istruttiva, sia per il momumentalismo e il collassare della sinistra sulla destra che per le forme mutanti Virus Evola,
il già citato Norman Manea, che è un ebreo romeno che si è fatto campi nazisti e interrogatori della securitate, ha scritto alcuni buoni spunti sul nazionalsocialismo del socialismo reale in Est Europa.
Uffa, voleva essere una risposta ad Arrigo Malera ma nemmeno io riesco ad agganciare il commento ai precedenti, scusate!
Ma che vi succede a tutti all’improvviso? :-D
*Dentro* la finestrella di ogni singolo commento, in basso a destra, c’è scritto “Log in to reply” (se non si è ancora fatto il login) o semplicemente “reply”. Quello serve per rispondere al commento specifico e avviare o proseguire una sottodiscussione.
Invece, *in fondo* all’intera conversazione, in mezzo alla colonna centrale, c’è la finestrella per scrivere un commento che non risponde a nessuno in particolare, o genericamente a tutti, o propone un’osservazione ex novo. Se altri vorranno replicare, anche quella diventerà una sottodiscussione.
@ ldtxv
Certo che ci si può tenere in contatto :-)
Salve!
Seguo giap da tempo ma questa è la prima volta che commento.
Ho trovato il post interessantissimo. Tra le altre cose mi pare illuminante la definizione primaria che WM1 dà di “destra” e di “sinistra”.
Sto cercando di inserire in queste definizioni l’ideologia liberista. (Forse il termine non è usato nella maniera più corretta, spero si capisca ciò che voglio dire. Penso ai miti della mano invisibile, del self-made man, del “sogno americano”.) Mi aspetto che il liberismo rientri nella sfera della destra, ma ho delle difficoltà a far combaciare i pezzi. Mi pare che l’ideologia liberista riconosca le differenze tra le classi sociali, ma sostiene che l’ultimo degli operai può (in linea di principio, con impegno e fortuna — e magari pure la grazia di dio) diventare il più grande capitalista. Quindi si potrebbe dire che il mito del self made man finisce per nascondere le differenze di classe e che la società armoniosa e concorde sia quella narrata nel mito del buon selvaggio. Tuttavia non riesco a vedere l’elemento degli “agenti esterni da espellere”. Mi aiutate? :)
@kzm
Forse per i liberisti “l’agente esterno da espellere” è lo Stato, perturbatore del naturale e armonioso funzionamento del libero mercato. Altri agenti esterni che ostacolano la mano invisibile sono i sindacati, i diritti (se una cosa è un diritto, è gratis, e quindi il suo prezzo non è determinato sul mercato), le leggi restrittive sul reclutamento della manodopera e sulle condizioni di lavoro ecc. Questa dottrina è particolarmente esplicita nel caso degli anarco-capitalisti.
Si tratta naturalmente di una contraffazione ideologica, perché anche i più accaniti liberisti quando sono al governo non disdegnano affatto l’aiuto statale alle grande imprese private, a partire dalle banche, e in realtà non può esistere un libero mercato senza Stato.
La risposta è in realtà facilissima, basta guardare contro chi si sono scagliati quelli che si sono riempiti la bocca e ci hanno riempito le teste di narrazioni tossiche sul “libero mercato”, dalla Thatcher a Reagan e tutti i repubblicani USA, fino ai Tea Party etc.
Oggi tutto andrebbe per il meglio se il mercato fosse stato lasciato al suo andamento naturale, e vivremmo in una comunità sana, giustamente basata sulla competizione che premia i migliori, e una società che premia i migliori fa il bene di tutti quanti.
Un tempo era così, quando c’erano i “pionieri”, poi però c’è stata una frattura: la sinistra e le minoranze, i liberal statalisti e i “rossi” nutriti di false idee provenienti da fuori, hanno turbato quest’equilibrio con rivendicazioni che hanno turbato il funzionamento del mercato, aiutando gli autoproclamati “deboli”, espandendo il ruolo dello stato in settori dai quali dovrebbe stare fuori, negoziando il costo del lavoro secondo criteri che ledevano gli interessi degli imprenditori (che sono gli “eroi” della storiella).
Questo è il frame di tutta la controrivoluzione capitalista iniziata all’inizio degli anni Ottanta. Anche qui c’è un’armonia turbata da forze “esterne”, a conferma che questa narrazione è intrinsecamente di destra e una “sinistra liberista” non può esistere.
Se ci fai caso, nella propaganda dei repubblicani USA, dei Tea Party etc., il nemico è sempre riferito a un “altrove”: New York, la East Coast, l’Europa, il Canada, e ovviamente gli stati-canaglia. Quando, prima della visita in Cina, chiesero a Nixon se fosse mai stato in un paese socialista, rispose: “Sì, in Massachusetts”. Per un repubblicano, all’epoca, il New England era l’altrove.
Non esiste un nemico “interno”, cioè generato dalle contraddizioni interne del sistema; se è “all’interno”, è perché si è insinuato tra noi.
Il frame viene attivato continuamente in politica estera: ci siamo “noi” (l’occidente, le democrazie basate sul libero mercato) e ci sono i nemici di turno (“l’impero del male” dell’URSS e dei suoi satelliti, le guerriglie che agitano il “cortile di casa” latinoamericano, il terrorismo che minaccia i nostri valori etc.). Quella dello “scontro di civiltà” è la massima espressione del frame della “comunità armoniosa che si difende”.
Io e Mauro abbiamo scritto in simultanea :-)
Un altro aspetto che caratterizza il liberismo (soprattutto quello più conseguente, quello anarco-capitalista) come *pensiero di destra* è il fatto di fondarsi su di un preciso “mito d’origine”: quello dello “homesteader”, del pioniere che si insedia nel territorio vergine, stabilisce i confini della sua proprietà, li difende a mano armata e rivendica il diritto di farci quel che gli pare.
Se si storicizza questa vera e propria “robinsonata” (Robinson Crusoe è l’archetipo dichiarato di questa figura mitologica), si vede abbastanza chiaramente cosa abbia significato in realtà: nel caso degli USA e del Nuovo Mondo, il genocidio di interi popoli a colpi di fucile e malattie; nel caso dell’Europa, il processo di accumulazione originaria “scritto negli annali dell’umanità a caratteri di sangue e fuoco” (per dirla con Marx).
Questo mito fondativo, in combutta con altre narrative tossiche affini, fa anche sì che il pensiero ultraliberista escluda la storicizzazione dei processi che hanno portato alla concentrazione del capitale e all’imperialismo. Il risultato è che i liberisti non riconducono questi processi alla dinamica storica del sistema economico basato sul profitto e, quindi, alle sue *esigenze strutturali* (per capirci: la necessità di ingrandirsi sempre di più per sopravvivere alle proprie crisi ricorrenti); li riconducono invece, come sottolineano anche Mauro e WM1, a fattori “esterni” o addirittura a fattori soggettivi.
Così capita che l’apparato militare-industriale nato sotto gli auspici dell’intervento governativo venga visto come il frutto demoniaco della coercizione statale e dell’azione dei sindacati. Mentre, al contrario, le grandi fortune individuali vengono viste come il frutto dei meriti sovraumani di un’élite di spiriti liberi e creativi in perenne lotta contro il potere e la coercizione statale (Ayn Rand è stata una delle più ferventi propagandiste di questa concezione, che ha poi attecchito in modo impressionante fra i “giovani turchi” della New Economy).
Se sul versante destro di quel fronte ideologico questo si traduce in un’appassionata difesa del “big business” e dei diritti degli ultraricchi, va anche detto che persino i liberisti/libertari più a sinistra (penso ai left-libertarians americani, che si definiscono anarchici, mutualisti, volontaristi, neo-proudhoniani ecc.) restano vittime di questa assenza di storicizzazione, di questa riduzione del processo storico a miti fondativi, e finiscono per rivendicare la possibilità di “tornare” ad un modello di produzione e scambio fondato sulla piccola proprietà, che rimanda agli utopisti libertari americani dell’Ottocento (H.D. Thoreau, Benjamin Tucker, Lysander Spooner) e a un modello del tutto anacronistico di società.
In senso lato, è un po’ l’equivalente ‘mmerrecano di alcune varianti europee delle teorie della decrescita (economia kilometri zero, patto sociale fra produttori e consumatori ecc.).
Un’altra considerazione “en passant”. Il fondamentalismo liberista/libertario è un fenomeno principalmente americano, che si spiega in parte guardando alla storia di quel paese. Non è però per nulla estraneo al panorama politico e ideologico italiano.
I libertari “all’americana” dichiarati, qui in Italia sono più un fenomeno marginale, di colore politico per così dire. Alcuni bazzicano l’area radicale, altri invece sono più vicini alla destra vera e propria, non senza qualche affinità e commistione con il leghismo: penso al Movimento Libertario dell’agricoltore pordenonese Giorgio Fidenato (il cui motto è “la proprietà è un diritto naturale e le tasse sono un furto” e che ha avuto un minimo riscontro mediatico nel Nordest con le sue campagne pro-OGM) e alla casa editrice di Leonardo Facco, ex articolista della Padania.
Queste idee, però, sfruttano anche certe porosità ideologiche per insinuarsi anche nella politica più “mainstream”. Il mito del “self made man” in eroica contrapposizione allo stato e alla burocrazia è naturalmente uno dei cavalli di battaglia di Berlusconi, oltre che, secondo me, una delle fonti della convergenza ideologica fra centrodestra e Lega Nord. Ma anche a sinistra le sorprese non mancano; basti vedere la venerazione di molti giovani “liberal” di area PD o SEL nei confronti di figure come Steve Jobs. Per non parlare poi del M5S, dove le idee della destra liberista/libertaria americana trovano un terreno particolarmente fertile.
Insomma: quella mitologia è tutto salvo che un fenomeno marginale, e secondo me è interessante vedere come l’analisi di Jesi consente di smontare l’ideologia di destra (e le sue propaggini nella sinistra) ben al di là del neofascismo!
Nota a margine: i liberisti ci hanno insegnato a ritenere il fascismo una destra completamente diversa dalla loro, addirittura in odore di sinistra in quanto presuntamente antiliberista e statalista.
Dietro questo punto di vista, che è molto diffuso, c’è una buona dose di mistificazione. Usando la lente della “comunità armoniosa che viene disturbata dall’intruso” vediamo come il fascismo abbia sempre usato anche la versione liberista di questo frame. Il fascismo delle origini, e cioè lo squadrismo, giustificava sé stesso proprio come difesa armata della “mano invisibile” e dell’armonia tra le classi sociali. L’olio di ricino e le uccisioni dei “sovversivi” ripristinavano la libertà d’impresa, la libertà di commercio e il funzionamento “normale” dell’economia capitalistica. Per esempio è famoso questo poster propagandistico fascista: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fascism.jpg
Alla presa del potere, Mussolini dichiarò: “”Il governo fascista accorderà piena libertà all’impresa privata ed abbandonerà ogni intervento nell’economia privata”. Per anni i fascisti (saliti al potere in coalizione coi liberali, non sarà un caso) condussero una politica economica liberista e solo in una fase successiva cominciarono ad applicare misure keynesiane ante litteram. Nei primi anni di governo, ci furono privatizzazioni (venne privatizzata addirittura la zecca, chissà cosa ne pensano i signoraggisti!), una politica monetaria restrittiva, un allentamento del carico fiscale (in particolare della tassazione progressiva).
Quando questo non rispondeva più alle necessità economiche del grande capitale industriale, in particolare cioè attorno alla crisi del ’29, si è passati ad una politica economica diversa, e si è adeguata la fraseologia propagandistica al culto dello Stato, alla lotta contro l’individualismo borghese e tutte quelle manfrine con cui ancora ci fracassano le palle i neofascisti. Anche i neofascisti, tuttavia, qualche volta si levano la maschera e parlano da liberisti. Per esempio, Forza Nuova a Genova aveva come primo punto del suo programma politico la lotta contro la Compagnia Unica dei camalli che secondo loro strangola la città impedendo la libertà d’impresa nel porto. CasaPound ha preso posizione sull’ILVA di Taranto (facendo scrivere un dossier alla nostra vecchia conoscenza, l'”Ing.” Di Stefano) prendendosela con gli ambientalisti che in combutta con oscuri potentati europei vogliono soffocare la siderurgia italiana.
Alla fine della fiera liberismo e fascismo hanno lo stesso eroe-simbolo: il crumiro.
“Alla fine della fiera liberismo e fascismo hanno lo stesso eroe-simbolo: il crumiro.” Quoto!!! :-D
Azzardo una considerazione di carattere generale. Partiamo dalla domanda: che cos’è la cultura di destra? Dall’analisi di Jesi, e sulla base di quello che dicono oggi coloro che la riprendono, si può ricavare secondo me una definizione generale di “cultura di destra” come un insieme di artifici discorsivi che rafforzano l’ideologia delle classi dominanti. Laddove l’*ideologia* in senso stretto, ossia l’elaborazione esplicita di idee e concetti, mira a *giustificare* l’egemonia delle classi dominanti, la *cultura* mira piuttosto a *renderla accettabile* influenzando il modo di parlare e di scrivere, i costumi, le pratiche sociali, i riti collettivi ecc.
Butto lì una suggestione: il fascismo vive (ed è vissuto in passato) più di “cultura” che di “ideologia”, e questo fatto è strettamente legato al suo carattere di fenomeno di massa.
Non che siano mancate delle elaborazioni *ideologiche* fasciste relativamente originali, come la teoria dello stato corporativo, che declina il principio dell’armonia sociale ed economica fra le classi in un’ottica nazionalistica. Però, allo stesso tempo, queste elaborazioni ideologiche originali non costituiscono affatto la base del “successo politico” del fascismo. Tanto per dire; fu proprio recidendo l’ala strasseriana del NSDAP – quella che preconizzava la “terza via” fra capitalismo e socialismo – che Hitler pigliò i proverbiali due piccioni con una fava: consolidò il suo potere assoluto nel partito; gettò le basi dell’alleanza con gli Junckers e l’alta finanza tedesca.
Tutto questo si spiega abbastanza facilmente se si guarda quella che è la funzione storica e sociale del fascismo – così come, mi verrebbe da dire, di ogni iniziativa politica di massa che parte dalle destre (populismo di destra, qualunquismo, poujadismo ecc.). Si tratta di un’arma nelle mani delle classi dominanti del tipo “rompere il vetro in caso d’emergenza”. Quando le masse perdono fiducia nei confronti dei vecchi leader e delle élite screditate, il rischio concreto e temibile per le classi dominanti, è che facciano la rivoluzione; sicché la priorità diventa quella di riconquistarne i cuori e le menti. Come? Inoculando nel quotidiano – nel linguaggio, nella visione del mondo – quegli elementi culturali di facile presa che possiamo ricondurre appunto all’etichetta generale di “cultura di destra”.
Il fascismo, d’altronde, procedette alla sistematica distruzione di tutte le forme di organizzazione sviluppate autonomamente dalla classe operaia (dai sindacati ai circoli scacchistici) per sostituirle con strutture e rituali simili “calati dall’alto” (il sabato fascista ecc.).
L’ideologia “ufficiale”, in questo senso, è abbastanza ininfluente; più che altro perché, alla base, è quella delle classi dominanti. L’importante è che l’azione politico-economica si accordi con gli interessi della borghesia e del capitale (per cui liberismo e keynesismo vanno altrettanto bene, a seconda della particolare fase), e che questa stessa azione risulti giustificabile e accettabile agli occhi delle masse.
Di nuovo, per tornare alla confusione *ideologica* del grillismo… niente di nuovo sotto il sole.
Se posso chiosarti, Mauro: la dottrina economica del fascismo prevedeva una compresenza di liberismo sul mercato, e un embrione di Stato sociale per rimediare alle inevitabili conseguenze del libero mercato, che l’ex socialista Mussolini ben conosceva. Lo Stato assistenziale è, in buona misura, un’invenzione del fascismo. Il limite della seconda aprte del programma fascista fu che l’assistenzialismo, se vuole andare oltre la semplice carità, presuppone dei diritti, e l’eisstenza di diritti soggettivi è incompatibile con la dottrina fascista. Su questo i giuristi fascisti si ruppero senza costrutto la testa. L’emblema della contraddizione fu la tessera di povertà: era necessaria per ottenere sussidi (cibo, vestiti), ma il suo possesso non implicava il diritto di averli.
Nutro un certo timore reverenziale nel contraddire girolamo :-) ma stavolta non sono del tutto d’accordo.
Forse esagero, ma misurare l’ideologia fascista (termine con cui mi riferisco all’idea di stato nazionale o regionale corporativo come “terza via”) con il metro dei diritti soggettivi mi sembra un po’ una concessione (ma forse mi sbaglio) alle visioni che introducono un legame costitutivo fra teoria “organica” della società e totalitarismo; contrapponendole di solito una visione, di origine liberale, incentrata al contrario sul riconoscimento dei diritti individuali.
Continuo a pensare che gli zig-zag nella politica economica e sociale fascista e nazionalsocialista, così come la forma totalitaria che hanno assunto questi regimi, dipendano molto poco dall’ideologia, che da quel che ne so rivestì un ruolo relativamente marginale, e molto di più (1) dai particolari interessi materiali che difendevano e (2) dal modo in cui si sono trovate concretamente a difenderli sotto la pressione degli eventi storici.
Regimi totalitari, incompatibili con il riconoscimento dei diritti soggettivi, si sono sviluppati anche in assenza di un’ideologia che prevedesse una concezione “organica” della società (stalinismo, dittature populiste di destra non fasciste). Di converso, teorie “organiche” della società sono state (e in alcuni casi sono) la spina dorsale di ideologie che annunciavano la liberazione individuale, o addirittura forme di democrazia universale.
Insomma: più che frutto della dottrina, le contraddizioni delle politiche sociali fasciste secondo me rimangono una conseguenza dello sviluppo storico e materiale del sistema sociale ed economico capitalistico, momentaneamente “prestato” al fascismo, pur con tutte le “deviazioni” del caso.
No, calma, Little Commie Craig: non ho usato i diritti soggettivi per esprimere una valutazione sul fascismo, ho riportato in estrema sintesi un dibattito storico e giuridico interno al Regime, e che ha messo in luce la differenza tra ciò che il Regime si vantava di poter fare, e ciò che in concreto non ha fatto, perché non era possibile che potesse fare. In altri termini, il fascismo ha cercato di mascherare una politica economica dettata, nelle sue linee strutturali, dal capitalismo industriale (vedi i ministeri Rossi e Volpi, espressione diretta di Confindustria) con una patina di assistenzialismo e di Stato sociale (che in Italia ha i suoi albori con Nitti, a cui il ministro Corbino pretendeva di richiamarsi), che si rivelò nei fatti una finzione ideologica (lo stesso, in termini un po’ diversi, potrebbe dirsi del sindacalismo di Rossoni). Può essere utile saperlo, perché, come immagino sia noto, la vulgata fascista – non importa se del secondo o terzo millennio – continua a vendere la favola del fascismo che assisteva i poveri, i bisognosi e i pensionati, che dava casa e lavoro, ecc.
Grazie per la risposta! :-)
Questa vulgata è veramente insidiosa, fa breccia nelle fasce popolari in modo subdolo e pericoloso anche fra persone che, per il resto, non hanno nulla da condividere con il fascismo.
Distribuendo la pubblicistica di un’organizzazione marxista in un mercato popolare e discutendo che le persone che si incrociano se ne hanno continue conferme. Persone comuni, lavoratori o disoccupati incazzati con il mondo, che acquistano volentieri il materiale che gli proponi, sono in linea di principio d’accordo con te, ma poi ti piazzano di punto in bianco un bel “a volte penso ci vorrebbe Mussolini, lui si ha fatto molto per aiutare gli italiani”.
E lì l’unica cosa che puoi rispondere senza chiamare in ballo Marx, Jesi o chissà che altro, è la banale verità: il fascismo ha fatto gli interessi dei grandi industriali, ha attaccato operai e braccianti distruggendone le organizzazioni, ha mandato al massacro in guerra milioni di persone.
Smontare la favola a livello dialettico in una discussione individuale è relativamente semplice. Demolirla culturalmente – ossia rimuoverla una volta per tutte dal senso comune imbevuto di retorica reazionaria – è di una difficoltà immensa.
“In senso lato, è un po’ l’equivalente ‘mmerrecano di alcune varianti europee delle teorie della decrescita (economia kilometri zero, patto sociale fra produttori e consumatori ecc.).”
Ecco, se posso avanzare una richiesta, a me piacerebbe, prima o poi, leggere su Giap un post specifico su questo argomento a cui accenna LCC. Credo di conoscere svariate persone (orientate a sinistra) che leggono questo genere di saggistica (decrescita, etc…) senza essere minimamente coscienti del pericolo, in pratica lettori di sinistra poco consapevoli di questa ambiguità.
Se ho ben capito, stiamo parlando di un pensiero ecologista fondamentalmente destrorso.
Io l’ho un po’ buttata lì, nel senso che secondo me ci sono delle affinità. Non so fino a che punto ci sia una vera e propria filiazione. Anche perché il panorama della decrescita è abbastanza variegato.
In Francia mi sembra che le idee decrescitiste derivino principalmente dall’ecologismo di sinistra; in Italia, invece, la cosa è parecchio più ambigua, visto che i “guru” locali non si fanno scrupoli nel manifestare pubblicamente idee abbastanza reazionarie (sul ruolo sociale della famiglia, ad esempio) e nel pubblicare con case editrici rossobrune e di destra (Pallante e Cedolin che pubblicano per Arianna Editrice).
Io resto dell’idea che, soprattutto nelle loro forme più “volgarizzate”, le teorie della decrescita presentino tutti gli ingredienti che Jesi attribuirebbe alla cultura di destra. Anche quando flirtano con la sinistra. Però forse qui l’integralista sono io ;-)
@LCC: No, no, hai inteso perfettamente il mio pensiero (mi riferivo proprio a Pallante). Le persone amiche cui facevo riferimento non sono per nulla coscienti di questa impostazione saggistica rossobruna e, guarda caso, sono in procinto di appoggiare il M5S dopo aver votato, per una vita, Rifondazione prima e di poi Vendola. Non sei tu l’integralista ;-)
Grazie per le dritte, anzi mi piacerebbe sapere qualche cosa in più.
Little Commie Craig aveva scritto sul suo blog un post in proposito (ora non ho più il link) con cui ero in quasi completo disaccordo. Tempo dopo, reagendo ad un altro articolo ma avendo in mente anche il suo, avevo scritto questo.
http://viadiscorrendo.blogspot.it/2012/06/parlare-della-decrescita.html
Non è certo un discorso completo, ma qualche elemento secondo me lo porta
@robgast69
Avevamo anche iniziato a discuterne di persona, ma purtroppo il confronto era finito lì. Grazie per il link. Che secondo me permette di precisare alcuni aspetto molto importanti.
Personalmente, da marxista, mi riconosco nelle critiche del terzo tipo: quello che contesto, in particolare, è che la decrescita non ponga il problema della proprietà dei mezzi di produzione.
Tu obietti che nessuna teoria può essere “completa”. Su questo non posso che essere d’accordo. Nessun autore singolo, neppure uno prolifico, colto e geniale come Marx, può includere nella sua analisi una risposta a *tutti* i problemi, sia teorici che pratici, che si porranno nell’utilizzo pratico di quella analisi. In molti casi perché, banalmente, le circostanze storiche non pongono ancora un determinato problema “all’ordine del giorno”.
Marx quindi non poteva porsi il problema dei limiti ambientali dello sviluppo per come sono stati poi affrontati dal Club di Roma e dall’ecologismo contemporaneo. Però va anche detto che una sensibilità “ecologica” è tutto salvo che estranea agli scritti marxisti! Nell’Antidühring, ad esempio, Engels affronta in termini che non esisterei a definire “decrescitisci ante-litteram” il problema dell’inquinamento delle acque, ponendolo in relazione al rapporto fra città e campagna. Ma ci sono sicuramente molti altri esempi.
Detto questo, ci sono incompletezze e incompletezze. Ci sono quelle che derivano da una carenza, per così dire, “di dettaglio”; e quelle che derivano da carenze fondamentali. In pratica cosa significa?
Se Marx, Engels o Lenin non formulano esplicitamente delle rivendicazioni ecologiste, questo però non comporta che dall’analisi marxista non si possano dedurre considerazioni in quel senso. Né significa che l’incremento della produttività sociale che è condizione per l’instaurazione del socialismo debba per forza di cose poggiare sull’idea di uno sfruttamento selvaggio ed indiscriminato delle risorse… anzi! Nella misura in cui l’economia socialista è un’economia razionalmente pianificata che mira a rispondere ai bisogni delle persone e non alla logica del profitto, il problema dei limiti ambientali si pone in modo praticamente inevitabile!
Quindi, se si parte da una prospettiva marxista, l’incompletezza relativa all’aspetto ecologista è “di dettaglio”; la teoria fornisce delle basi abbastanza solide per ricavare conclusioni adeguate rispetto a quel problema.
Ma eludere il problema della proprietà dei mezzi di produzione, al contrario, è un’incompletezza fondamentale! Perché?
Beh, se davvero la decrescita non è semplicemente il ritorno ad una economia di sussistenza, è chiaro che anch’essa prevede la produzione su vasta scala di beni destinati al largo consumo (vestiti, alimenti, tecnologia, cultura, servizi). Ma i *mezzi* che consentono la *produzione* di questi beni possono farlo in modo ecologicamente e socialmente compatibile soltanto se la produzione è finalizzata, appunto, al soddisfacimento dei bisogni e non al profitto. Come si può garantire, allora, questo risultato? Soltanto facendo sì che la produzione stessa sia gestita e pianificata *collettivamente*; e, per rendere possibile ciò, è necessario che la *proprietà* dei mezzi di produzione sia, appunto, collettiva.
Altrimenti cosa succederebbe? Se i mezzi di produzione restassero di proprietà dei privati, il loro utilizzo sarebbe vincolato al profitto economico dei loro proprietari (come giustificare altrimenti il loro investimento in mezzi di produzione?), e il risultato sarebbero sprechi, consumismo, inquinamento, esaurimento delle risorse ecc.
Insomma: i disastri ambientali con i quali si misura l’ecologismo sono il frutto del sistema capitalistico basato sul profitto. L’unico modo per ridurne l’impatto e per riconvertire la produzione è superare il modo di produzione capitalistico. L’unico modo per superare il modo di produzione capitalistico è rendere collettiva la proprietà dei mezzi di produzione.
E quindi: se la “decroissance” non pone il problema della proprietà dei mezzi di produzione (il *primo* problema, quello fondamentale; non l’ultimo e accessorio), viene meno l’intera consequenzialità logica dei passaggi. E le rivendicazioni ecologiste si riducono alla prospettiva di una riforma morale dell’umanità, senza fornire gli strumenti per rivoluzionare la società sul piano *materiale*.
Grazie a entrambi.
@robgast69: Appena ho un attimo mi leggo il link.
Si, poi eravamo stati risucchiati da Struggles…
Mi sembra che tu abbia frainteso un passaggio (ma, a rileggermi, ho aiutato abbastanza il fraintendimento). Non ho mai voluto dire che la ‘dimensione’ delle lacune sia paragonabile, quello che volevo dire è che io vedo la decroissance non come un discorso a se stante, ma (passami il paragone informatico, deformazione professionale) come un ‘plugin’ che va innestato su un altro programma per completarlo, fornendogli ‘funzionalità’ che il programma originale non prevedeva.
Spingendo ancora oltre il paragone, ci sono plugin che *più o meno* funzionano su programmi diversi, ma ciò non toglie che con alcuni ‘giri bene’ e con altri sforzi ad ogni movimento, questo perchè il plugin è stato scritto per completare quel programma e non un altro. Io mi sento di dire (ipotesi puramente mia, per quanto ne so mai sostenuta da Latouche o altri) che la decroissance sia pensata per collegarsi al marxismo. Forse su quest’ultimo punto prendo una solenne cantonata, ma anche se fosse questo non invaliderebbe il discorso precedente: La decroissance è pensata per collegarsi ad un discorso più ampio, quindi è ovvio che non tratti alcuni (anche molti) temi, ritenendoli, a ragione, già toccati dal suddetto discorso.
Penso anch’io che la teoria della decrescita sia stata pensata per essere “inserita” nel marxismo o comunque nel pensiero di sinistra. Più che un plugin, però, mi sembra un virus.
Ci sono numerose teorie che nella storia sono state proposte da questo o quel guru per “migliorare” il socialismo inserendo una cosa che “mancava”, e che tuttavia sembrano poter esistere benissimo da sole anche in un contesto di estrema destra. Ce n’erano un bel mazzetto già ai tempi di Marx, che le confutava una dopo l’altra tipo rosario.
Non me ne volere, ma a me sembra che proprio il nucleo della teoria della decrescita, che resta lo stesso in tutte le sue continue varianti e in tutto il suo infinito ciclo di fraintendimenti e chiarimenti, abbia un contenuto reazionario. Sarà un limite mio, ma non riesco a vedere come una teoria che propone di ridurre i consumi delle masse possa conciliarsi col marxismo che propugna esattamente il contrario. Girala come la vuoi girare, ma è una teoria che vede la specie umana come un fastidioso invasore di un pianeta altrimenti armonico (“l’agente esterno”… siamo noi).
Scusami ma non è vero che “propone di ridurre i consumi delle masse”.
Latouche ha sempre detto che il suo discorso poteva essere applicato solo alle società “avanzate” (aggettivo mio e brutto, ma spero si capisca), e queste certo, guardando alla popolazaione della terra nel suo insieme, non sono certo ‘le masse’.
Secondo me gran parte della discussione deriva dall’adozione di un punto di vista troppo ‘occidental-centrico’ rispetto a quello da cui è nata quella teoria, e rispetto al quale si pone
@robgast69
Oh bella, le masse europee non sono masse?
A me sembra in realtà che proprio la decrescita sia molto eurocentrica, sembra la razionalizzazione “di sinistra” del declino del capitalismo europeo. Della serie “La volpe e l’uva”… siccome il capitalismo europeo è in declino, diciamo che il declino ci fa bene. Non mi stupisce che i fautori della “bella morte” si trovino a loro agio con la “bella miseria”.
@maurovanetti
Lo chiedo da ignorante e in buona fede: in che senso “una teoria che vede la specie umana come un fastidioso invasore di un pianeta altrimenti armonico” è di destra? E in che senso il suo contrario, e cioè che la specie umana sia un Dono del Cielo e Fine ultimo di Tutto il Creato non lo è?
(lo so, è scritto in modo provocatorio perché non so come porre la domanda in modo altrettanto netto, ma non c’è polemica).
– Secondo me, nel discorso della decrescita gli (ovest)europei sono (erano) elite. Guardando a 15 anni fa il 90% degli europei era nel 10% più ricco della popolazione mondiale. Questo sta cambiando, e infatti non sto dicendo che la decrescita sia un qualcosa adottabile oggi (sono convinto del contrario). Solo vorrei che prima di abbandonare l’idea ne estaessimo le parti buone
– La decrescita è eurocentrica nel senso che (dichiaratamente) delinea quello che dovrebbero fare gli europei (sempre in senso lato, USA, Canada, Giappone etc compresi), dicendo che per il resto del mondo si dovrà pensare qualcosa di diverso ma che non essendo noi parte di quel mondo non possiamo essere noi a dirgli cosa
– “bella miseria” è una provocazione tua, ma forzata perchè più volte esplicitamente negata da quelli a cui la attribuisci (ripeto, non stiamo parlando di Pallante). Che però il livelo di consumi medio (facciamo riferimento sempre a 10-15 anni fa) dell’europeo non possa essere esteso a tutto il mondo senza portarlo al collasso non mi sembra contestabile, quindi a chi sta meglio (noi) qualche rinuncia gli tocca. Questa consapevolezza, secondo me, è una delle cose che dalla decrescita dobbiamo assolutaemnte prendere, anche se scartiamo il resto
Però, scusate… uno dei limiti più significativi di molte prospettive ecologiste sta proprio nel concentrarsi interamente sul punto di vista del consumatore. Guardiamo la cosa dal lato della produzione, invece. Se si controlla e si gestisce *collettivamente* la produzione per soddisfare i bisogni di tutti (unica condizione per farlo: proprietà collettiva dei mezzi di produzione), non viene da sé che i consumi, più che ridursi o aumentare, semplicemente vengono “razionalizzati”? Per cui diventa possibile garantire a tutti un livello soddisfacente di vita, sia a livello materiale che a livello culturale, rimuovendo gli sprechi e l’irrazionalità della produzione capitalistica?
In teoria, quanto meno. In pratica, poi, è tutto un altro paio di maniche, visto che si pone pur sempre il problema: come arriviamo alla proprietà collettiva dei mezzi di produzione…? E anche qui, temo che le divergenze con molti sostenitori dell’ecologismo e della decrescita sarebbero di natura sostanziale ;-)
@VecioBaeordo
Non mi sembra che nessuno abbia parlato della specie umana come Dono del Creato! :-D
Forse che l’alternativa che poni tu è così inevitabile? O, piuttosto, dobbiamo semplicemente prendere la specie umana per quello che è: una specie animale dotata di una strategia di sopravvivenza sua propria che, per le sue caratteristiche, ha banalmente conferito alla storia naturale delle pazzesche accelerazioni? :-)
Approfitto della distrazione di Saint-Just, perché comincio a sentirmi off-topic… e quindi mi scuso se sarò lapidario ma non vorrei dirottare troppo il discorso.
@VecioBaeordo
Secondo me sarebbe un discorso reazionario anche quello antropocentrico del Signore del Creato. Semplicemente la Terra non è mai stato un pianeta armonioso, né prima né dopo la venuta al mondo della specie umana. Le cose si evolvono attraverso continue contraddizioni e anche passando tramite catastrofi. Invece di rimuovere col tasto Rewind la contraddizione (innegabile) costituita dal ruolo distruttivo che ha oggi la società umana *nella sua fase capitalistica*, penso che bisognerebbe far sviluppare questa contraddizione col tasto Fast Forward, e vedere cosa c’è dopo. Poi si potrebbero dire alcune cose su come in realtà l’Uomo sia stato distruttivo anche prima del capitalismo (c’è spesso un legame tra arretratezza tecnologica e inquinamento, per esempio il posto più nocivo del pianeta per il clima è il Delta del Niger), e come anzi l’ecologia stessa sia un frutto del progresso umano, inconcepibile in società precedenti.
@robgast69
In tutta franchezza, dire i disoccupati greci sono parte dell’élite mondiale e quindi devono ridurre i loro consumi mi sembra un’idea di destra.
Sul fatto che non si possa estendere all’intero pianeta il tenore di vita di un normale lavoratore europeo (mi riferisco al tenore di vita *mediano*), mi permetto di non essere assolutamente d’accordo. Tutte queste affermazioni di “impossibilità” sono quasi sempre avventate e basate su proiezioni malthusiane, che danno per scontato che non si possano fare le cose in modo diverso e migliore. Ogni singola volta che qualcuno ha fatto previsioni di questo tipo, si è sbagliato – perché dà per scontato che le cose cambino gradualmente, mentre la storia a volte cambia in modo drastico.
Ad ogni modo, se ha ragione chi crede che non si possa estendere il tenore di vita attuale degli operai e degli impiegati europei al resto del pianeta, evidentemente questo significa che il marxismo è fatalmente bacato e deve essere abbandonato. Può anche essere, ma in tal caso non sarebbe serio tenere Marx vivo come uno zombie solo perché ci siamo affezionati; se la decrescita è l’unica via, probabilmente la cosa migliore da fare è mettere una dittatura militare che obblighi gli europei a consumare di meno – più o meno quel che sta succedendo negli ultimi anni, in effetti…
“Sul fatto che non si possa estendere all’intero pianeta il tenore di vita di un normale lavoratore europeo (mi riferisco al tenore di vita *mediano*), mi permetto di non essere assolutamente d’accordo.”
Anch’io ho sempre pensato che fosse una bufala. Quanti siamo al mondo? 7 miliardi? Se ci mettiamo tutti in fila occupando un metro quadro a testa occupiamo un’area grande circa quanto la provincia di Torino. Davvero in tutto il pianeta non ci sono risorse sufficienti per far vivere in modo soddisfacente una popolazione tutto sommato così piccola?
@maurovanetti
Forse è la prima volta che non mi convinci. Mi ritiro per terrore di Saint-Just, ma dovremo rivederci a Filippi. Per una birra, ovviamente :-)
OT sulla decrescita
Lungi da me fare la vecchia zia, ma secondo me molte delle vostre divergenze derivano da incomprensioni reciproche. Mi è capitato diverse volte di affrontare questo argomento di persona con Roberto Gastaldo e qualche volta anche con Vanetti e LCC.
Gastaldo è il primo a dire che tutto il discorso della decrescita, per la fase in cui siamo (sia da un punto di vista ecologico che economico) è superato.
Per me è anche circoscritto a una fase politico-economica che almeno noi in Europa (e probabilmente sta andando in quella direzione anche il resto) non vedremo più, cioè quella della “Crescita” nell’ambito capitalistico. La decrescita, nel suo nucleo originario, era imho una proposta limitata alla razionalizzazione e alla preparazione di questo accadimento, la fine della crescita. Fine che c’è già stata: parlare di decrescita ora, semplicemente, non ha senso. La decrescita *sta già avvenendo per conto suo* e i capitalisti la stanno cercando di manovrare (con il meccanismo del debito, cioè con l’accaparramento di beni e risorse non più destinati alla produzione, e con lo smantellamento della stessa in occidente).
La decrescita era la spia che il paradigma della crescita, forse per tentare di rientrare in tema potrei dire il mito, stava per entrare in crisi. Ora è in crisi nera e sì, sono d’accordo che continuare a parlare di decrescita oggi come di una teoria politico-economica e sociale da realizzare è anche del tutto reazionario oltre che assurdo.
La “crescita”, per come se ne è parlato e per come tutt’ora si prova a fingere di parlarne, è stato quel mito socialdemocratico per cui si poteva convivere con il capitalismo e il suo modello di produzione perché grazie appunto alla crescita parte del profitto sarebbe stato redistribuito o almeno redistribuibile. Mi sembra che almeno in Europa siamo in un’altra fase, ma non è questo il punto. Il punto che pone la decrescita a sinistra secondo me è: oggi non possiamo più essere keynesiani, non possiamo essere socialdemocratici, non possiamo più convivere con questo modello di produzione, non ci sono i margini ecologici per farlo. Ora non ci sono più nemmeno quelli economici e il capitalismo stesso sta andando verso quella direzione.
La mia conclusione: essere pro-decrescita non ha senso; quello che ha senso dire è che la socialdemocrazia -cioè convivere con il capitalismo- non ha senso; la decrescita è stata una spia, secondo me poco cosciente politicamente, della fine della possibilità dell’equilibrio socialdemocratico; ovviamente si può essere anti-socialdemocratici di destra e molti decrescitengoli lo sono (stati); oggi quell’equilibrio è in crisi totale e imho irrecuperabile; da sinistra si deve pensare e agire per un superamento del capitalismo, per un abbandono delle velleità socialdemocratiche, prima che lo facciano da destra.
Spero di non aver detto troppe castronerie, e chiedo scusa per il prolungamento dell’OT.
D’accordo praticamente su tutta la linea. Per me l’OT finisce qui.
:-)
Daccordo quasi su tutto. Unico appunto, quella che stiamo avendo adesso non è decrescita nel senso di Latouche. Ma, come dicevi, quella non credo la vdremo mai, era una ricetta, secondo me buona, ma pensata per condizioni di partenza che non sono più quelli attuali
Grazie a tutt*! La soluzione in effetti era abbastanza facile: “la colpa è dei comunisti!” :)
Queste definizioni di destra e sinistra sono davvero potenti. Mi sono adesso reso conto che in base ad esse sono “di destra” le teorie complottiste e “infiltrazioniste”, dalle BR fino al 15O, passando per il Genova 2011.
Vorrei ringraziare Furio Jesi, Manera per avermelo facilitato, e i Wu Ming per avermelo fatto conoscere, in particolare tramite l’analisi del film 300: sono state le letture fondanti del mio lavoro di tesi.
Si trattava dell’analisi della mitopoiesi di Alberto da Giussano, Lega Lombarda e company negli scorsi mille anni, con particolare attenzione alla lettura (a prima vista) “padana” del pietosissimo film “Barbarossa” di Renzo Martinelli, confrontato con la sua nemesi naturale, “Baudolino” di Eco.
Se può interessare, la “tesi” principale è stata l’inadeguatezza del film, non solo dal punto di vista estetico, quanto da quello mitopoietico. Ho concluso con piacere che si trattava di una macchina mitologica irrimediabilmente “rotta”, secondo me rotta con una sorta di “miticidio” proprio da Umberto Eco. La mia idea è che questo libro sia un fantastico esempio di pallottola d’argento antimito. Per chiarire: si poteva rispondere alla mitologia dell’Età dei Comuni in due modi; creando un nuovo mito non-reazionario (e sappiamo quanto sia difficile, forse impossibile) oppure attaccando le incongruenze e falsità storiche (una ben povera risposta solo per addetti ai lavori, e comunque inefficace visto il carattere sfuggente delle “argomentazioni” mitologiche). Eco ha risposto scrivendo invece un romanzo METAmitopoietico, in cui ha messo a nudo (con una certa partecipazione umana) le stronzate del potere, le bugie dei cortigiani, in ultima analisi il suo stesso ruolo di inventore di storie. La lettura del suo libro (molti elementi indicano che ci sia stata) ha agito, secondo me, in maniera benefica sulla mente reazionaria del regista Martinelli o di chi per lui, impedendogli di creare l’opera manichea e funzionale stile braveheart che si era prefisso, e facendogli, in sostanza, creare una cacata che fa addormentare pure bossi. Secondo me vale come uno dei primi esempi di vittoria sul difficile campo della “guerra mitologica”, e credo che Eco abbia continuato con questa tattica con “la misteriosa fiamma della regina Loana” e “il cimitero di Praga”. Ma forse credo troppo nel potere della letteratura…? :D
Rapa, si può leggere questa tua tesi? L’hai messa on line da qualche parte?
Ecco qua!
http://www.scribd.com/doc/122389412/Mitopoiesi-padana-ovvero-Barbarossa-di-Renzo-Martinelli
Mi farebbe strafelice avere l’opinione vostra e dei giapsters! :D
Vorrei conoscere la vostra opinione in merito al cosiddetto “Nuovo Realismo” proposto da Maurizio Ferraris e altri (vd. qui) come reazione “di sinistra” al relativismo, derivante secondo questi autori dal successo del cosiddetto “pensiero debole” e del postmoderno in Italia, che ha permesso – se non provocato – il lungo regno berlusconiano.
Della serie: può proprio la realtà, paradossalmente, essere un mito tecnicizzato?
Mi spiego meglio: per realtà intendo quel richiamo un po’ nostalgico e un po’ retrò ad un approccio ingenuo (depurato da eccessivi filosofismi) e più diretto alla realtà che possa fondare l’azione politica e che, mi sembra, sia l’obiettivo di questo “Nuovo Realismo”.
Conosco poco la proposta di Ferraris e il dibattito in cui si inserisce; ho giusto letto, a suo tempo, alcuni articoli per farmene un idea. Da quel poco, però, mi sembra di capire che questo “new realism”* sfoci più o meno una riedizione tutt’altro che originale del pragmatismo statunitense, soprattutto per quanto riguarda le sue conseguenze politiche.
L’idea di fondo, infatti, mi sembra quella per cui, nella famosa realtà che esiste indipendentemente dal nostro discorso su di essa (e grazie al c…! :-D), la nostra azione politica guidata dalla “critica illuministica” procede necessariamente per piccoli aggiustamenti… da delegare, ovviamente, ad una “libera” comunità scientifica di esperti che al massimo si cureranno di far arrivare le loro illustri deduzioni al popolino bue e becero per il tramite della divulgazione. Ideologia liberaldemocratica, elitaria e borghese in piena regola, insomma.
Ad ogni modo, non so se sia corretto parlare di “mito tecnicizzato” in questo caso. Per come interpreto io l’analisi di Jesi (e le considerazioni di chi oggi lo riprende), il “mito” funziona come tale nella misura in cui trova espressione in un’intera “cultura” che (1) tende ad una ricezione di massa e che (2) è fatta di comportamenti, modi di parlare e scrivere, riti, liturgie; in un modo tale per cui tutto il discorso si appiattisce proprio su questa “cultura viva” (molto concreta) priva di profondità storica (omogeneizzazione del passato, miti d’origine ecc.), sottratta alla discussione e indirizzata ad un’adesione acritica e totalizzante (vedi le “idee senza parole”).
Questo “new realism” (evito *deliberatamente* di usare le maiuscole :-P), invece, oltre a non avere nulla di originale, mi sembra qualcosa spendibile *a malapena* in una discussione fra intellettuali in pausa caffè. Figuriamoci quante possibilità può avere concretamente di mettere in moto una macchina mitologica in grado di influenzare la coscienza collettiva. Se ha avuto qualche riscontro mediatico nelle pagine culturali di qualche quotidiano borghese è giusto perché il livello del dibattito filosofico in Italia è – detta come va detta – quello che è. ;-)
* E’ davvero curioso che chi critica il populismo e la degenerazione postmoderna ricorra poi all’espediente da marketing di dare un nome inglese al suo brillante e innovativo prodotto intellettuale per farlo sembrare più “fico” e attuale…
“E’ davvero curioso che chi critica il populismo e la degenerazione postmoderna ricorra poi all’espediente da marketing di dare un nome inglese al suo brillante e innovativo prodotto intellettuale per farlo sembrare più “fico” e attuale…”
cioè tipo New Italian Epic?
:) vi prego non mi picchiate, è colpa di Little Commie Craig che me l’ha veramente strappata dai denti… imploro umilmente pietà e mi rimetto alla giustizia rivoluzionaria.
@ Francioso non so bene di cosa si tratti, se però questo richiamo ad un realismo più reale del reale dovesse essere finalizzato a smuovere le masse in vista di un imminente sovvertimento dell’ordine politico-sociale nel nome del Nuovo Credo Realista ok, si potrebbe anche parlare di mito tecnicizzato, altrimenti mi sa proprio che ha ragione il compagno Craig…
Grazie ad entrambi.
Dalle vostre risposte penso anche di aver compreso meglio proprio il rapporto con la realtà del mito analizzato da Jesi ed in questo senso la differenza rispetto ad una concezione *post-strutturalista* (ad esempio quella foucaultiana del potere-sapere).
Una differenza che, mi pare di poter dire, si basa soprattutto sulle solide fondamenta marxiste del pensiero di Jesi,.
Il mito tecnicizzato resta sempre una pezza sovrastrutturale della classe egemone ed ha quindi, come dice @LCC, un carattere oppressivo, generalizzante, “totalizzante” (e totalitario??).
In questo senso, e correggetemi se sbaglio, la ‘pars construens’ del discorso di Jesi sul mito passa attraverso le modalità marxiste della lotta di classe, ecc.
Il che è un bel problema risolto: le possibili soluzioni “francesi” (Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan…) sono molto più sfumate e paradossali, perché è diversa proprio la concezione del rapporto tra linguaggio e reale (per dirla bene, del rapporto tra i “modi di veridizione”, le “forme di governamentalità” e le “tecniche di soggettivazione”).
@Francioso
Grazie a te per la sintesi brillante.
Pensa che non c’ero mai arrivato a mettere in relazione il potere-sapere di Foucault con la macchina mitologica di Jesi.
Questo perché la mia lettura di Jesi è sempre stata più “di retroguardia”, più rivolta agli studi sul mito della prima metà del novecento che all’école post-strutturalista (che, fatta eccezione per Foucault, conosco molto poco).
Quel che ti posso dire è che studiando il mito in una prospettiva socio-antropologica ti accorgi presto di quanto questo sia sempre stato legge, norma fondante e garanzia di stabilità e di coerenza sociale.
In quest’ottica, l’operato dei tecnicizzatori che utilizzano il mito per *manovrare la massa* si può leggere come il lato oscuro di tale istituzione, che considerata dal punto di vista della portata e della persistenza sul piano storico, può tranquillamente definirsi atavica.
Molto interessante quello che dici sul mito dal tuo punto di vista “socio-antropologico”.
Temo sia OT, in ogni caso ho letto ora la primissima (fantastica) diramazione dei commenti e oltre ad essermi commosso per la descrizione di WM1 dei *post-strutturalisti* francesi, mi sono reso conto di quanto in fondo eravamo anche noi vicini alla stessa questione del rapporto tra linguaggio (racconto, mito) e realtà (materialismo).
Quando dici “studiando il mito […] ti accorgi presto di quanto questo sia sempre stato legge, norma fondante e garanzia di stabilità e di coerenza sociale” penso che tu non sia affatto lontano da Foucault e mi piacerebbe approfondire il tuo concetto di “istituzione atavica” che mi sembra rinviare a molto più che “semplice” sovrastruttura :)
Sarei curioso di sapere cosa ne avrebbe detto Gramsci…
Non è che passa un gramsciano da queste parti??? Altri posti dove cercarli non ne conosco… :)))
@ Francioso
Anche io sarei molto curioso di avere una lettura dettagliata della faccenda da un punto di vista gramsciano.
Quel poco che so di Gramsci l’ho imparato seguendo a ritroso i sentieri tracciati da Foucault – e da Dick Hebdige… ma quella è tutta un’altra storia ;)
“In questo senso la ‘pars construens’ del discorso di Jesi sul mito passa attraverso le modalità marxiste della lotta di classe.”
Secondo me sì! Meglio ancora: passa attraverso l’intervento attivo e consapevole nella lotta di classe. Il che mi sembra perfettamente coerente non solo che l’analisi, ma anche con la stessa biografia di Jesi.
Sulla questione del mito/istituzione atavica in quanto “molto di più” di “semplice” sovrastruttura… bisognerebbe prima di tutto chiarire bene come intendiamo il rapporto fra struttura e sovrastruttura.
Perché il ruolo della sovrastruttura può essere inteso in modo “diminutivo” e derivato solo se fra i due piani si presuppone un rapporto meccanico e deterministico… ma non ho mai pensato che la concezione marxista vada in quella direzione. Si può quindi collocare la “macchina mitologica” al livello della sovrastruttura e, al tempo stesso, riconoscerle un ruolo essenziale nel mantenimento e nella legittimazione dei rapporti di potere che nascono dal possesso dei mezzi di produzione (ossia dalla struttura) ;-)
“cioè tipo New Italian Epic?”
Assolutamente no! WM1 è giustificato ad utilizzare l’inglese in quanto postmodernista deleuziano degenerato! :-D
A parte le battute idiote, il nome del NIE è stato introdotto in inglese semplicemente perché utilizzato per la prima volta durante una conferenza negli USA, come se non ricordo male ha spiegato lo stesso WM1.
Il “new realism”, invece, oltre a fare piuttosto evidentemente il verso al NIE (è solo una mia impressione?), è stato introdotto per la prima volta… sulle pagine culturali di Repubblica! ;-)
Si può quindi collocare la “macchina mitologica” al livello della sovrastruttura e, al tempo stesso, riconoscerle un ruolo essenziale nel mantenimento e nella legittimazione dei rapporti di potere che nascono dal possesso dei mezzi di produzione (ossia dalla struttura)
stai dicendo la stessa cosa che intendevo io ma da un punto di vista marxista, direi.
Nella mia visione la macchina mitologica garantisce il funzionamento stesso di una società attraverso un meccanismo di coercizione – basato sul sapere rituale e sulla tradizione – pressoché totalitario, più che un equilibrio dei poteri basato sul possesso dei mezzi di produzione.
Ma ripeto, mi sembrano essere due facce della stessa medaglia..
Postmodernisti e pure filoamericani, dunque! :D
Ok, fine dello scherzo.. del resto “Nuova Epica Italiana”suona abbastanza agghiacciante.
Cmq sto sistema dei reply ha qualche problema, in effetti.. per l’ultimo commento avevo loggato seguendo la procedura corretta e sono finito in un altro thread. Boh?
Mmh… Può capitare di confondersi. Meglio in ogni caso loggarsi prima, poi seguire il dibattito e decidere a cosa rispondere.
Però se non sbaglio fu Spinazzola a venir fuori con l’espressione “New Italian Realism” in contrapposizione a “New Italian Epic”. Era il 2009 e si era ancora in ambito letterario. La rivista “Allegoria” di Romano Luperini aveva già fatto il numero monografico sul presunto “Ritorno alla realtà” (2008) e De Cataldo aveva parlato su Repubblica di “neo-neorealismo”.
Poi Ferraris cominciò a parlare di “nuovo realismo” (all’inizio era in italiano), praticamente replicando in filosofia lo stesso identico dibattito che era avvenuto nel campo letterario, senza però citare niente e nessuno, come se all’improvviso si fosse svegliato lui e avesse avuto la folgorazione! Repubblica gli concesse lenzuolate su lenzuolate, gli oppose Vattimo e altri, e così è partita la rumba.
In ogni caso, già il “Ritorno alla realtà”, il “Neo-neorealismo” e (Dio ce ne scampi!) il “New Italian Realism” erano formule che non condividevo. A maggior ragione perché molti commentatori e critici iniziarono a schiacciare il mio memorandum sul NIE dentro quella prospettiva, mentre io avevo scritto tutt’altro. Ancora oggi c’è gente secondo cui io nel NIE avrei predicato un “ritorno alla realtà”, segno evidente che non capirono nulla allora e continuano a non capire niente adesso. Su questo, rimando a un mio pezzo del dicembre 2008:
REALISMO: IL GIGANTESCO MALINTESO
Invece, riguardo alle critiche fattemi all’epoca per aver usato un’espressione inglese, rimando a quest’altro mio pezzo:
NEW ITALIAN EPIC: REAZIONI DE PANZA
con particolare riferimento al paragrafo 1c, “Stratagemma del ‘Mi fingo autarchico’” :-)
“E così è partita la rumba…”
… che continua ancora oggi, con Ferraris che assurge praticamente a “filosofo ufficiale” del PD bersaniano :-)
In che senso dici che il dibattito filosofico sul “new realism” rimanda alla sua controparte in ambito letterario (che non conosco)? Non riesco a capire come le lenzuolate su Kant e la realtà materiale delle multe per divieto di sosta (sic), o i batti e ribatti con Severino e Vattimo, si incastrino, per dire, con il dibattito sulla natura di “Gomorra”…
Il frame del dibattito del 2008-2009 era, tagliando con l’accetta: è finito il postmodernismo; per troppi anni la letteratura ha scritto solo di letteratura e non si è occupata della realtà sociale esterna, dura, oggettiva; finalmente gli scrittori non fingono più che la realtà non esista o comunque sia inaffrontabile e tornano a occuparsene con romanzi che affrontano il reale, il sociale. Tutto questo era riassunto nella formula “Ritorno della realtà” (o “Ritorno alla realtà”).
Questo è, mutatis mutandis, lo stesso frame attivato da Ferraris al momento di avviare il dibattito sul nuovo realismo in filosofia.
@ Little Commie Craig
Più che di “filosofo ufficiale del PD”, io parlerei di un comitato filosofico (un modo figo per dire: una compagnia di giro) interno a “Repubblica”, di cui fanno parte, oltre a Ferraris, Esposito, Galli (che entrerà in parlamento senza passare dalle primarie, vedi mai il porcellum…) e altri. In realtà io credo che il PD degli intellettuali se ne freghi, perché non sa che farsene; mentre “Repubblica” coltiva (in concorrenza con “MicroMega”) il mito della mosca cocchiera. Se posso permettermi, quello che penso del “ritorno alla realtà” l’ho scritto su carmilla qui (più o meno a partire dall ametà), e in precedenza su minima & moralia qui.
ho trovato l’articolo di Repubblica con la recensione (di Simonetta Fiori) a Tirature 2010, il volume di Spinazzola in cui si parla di “nuovo neorealismo” (si parla per modo di dire, perché Spinazzola non è preciso nell’uso della terminologia):
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/13/il-nuovo-neorealismo-romanzi-riscoprono-il-paese.html
il neorealismo italiano (che poi tale non è, come spiega bene Girolamo De Michele su Carmilla – linkato da WM1 in Realismo: il gigantesco malinteso) è una categoria nata dal cinema, passata alla letteratura e poi approdata alla filosofia.
Anche il “nuovo neorealismo” ha fatto la stessa strada…
Con piacevole sorpresa ho letto questo articolo in proposito poco tempo fa, in cui @WM1 è citato (come collettivo… ma non credo se la prenderà a male :)), che tutto sommato mi sembra abbastanza equilibrato.
Forse avvicina troppo WM al NR, ma credo in buona fede: nel senso di una necessità di fondamento dell’azione politica.
Un punto del rapporto tra realtà e “testo” mi sembra ineludibile e fondamentale: «Non si può portare nella scrittura la cosa-in-sé, ma solo il modo in cui viene raccontata nel reale testualizzato» (da Realismo: il gigantesco malinteso, link sopra) e (anche @franzecke e @LCC) non vorrei dire una boiata, ma se fosse il concetto gramsciano di ‘egemonia’ l’anello mancante?
Chissà cosa pensava Jesi di Gramsci e cosa avrebbe pansato Gramsci di Jesi… Entrambi marxisti, entrambi *antropologi* fuori dagli schemi,…
Il pezzo di Federica Blasio è interessante dove critica Ferraris, mentre non mi convince per nulla dove cerca affinità tra NIE e New Realism. Prima inquadra il memorandum sul NIE dentro “una crescente esigenza di ritorno al realismo”, poi però cita il passaggio dove dicevo che il realismo è solo “una delle tante frecce nella faretra di un autore”. Le due cose non vanno insieme. Infatti, quel passaggio proseguiva dicendo che ogni pretesa di “realismo” è minata alla base dal fatto che la connotazione influenza la denotazione, il nostro linguaggio è *sempre* figurato, metaforico, visionario, e l’allegoria “scappa” come scappano le scuregge. Io non ho mai sentito né tantomeno espresso alcuna esigenza di “ritorno al realismo”, anzi, ho sbeffeggiato tale esigenza, perché il realismo (la denotazione) è sempre stato qui con noi, non ce ne siamo mai allontanati.
Quello che cercavo di fare io nel memorandum e quello che sta cercando di fare Ferraris in filosofia sono due cose diverse. Differenti le premesse, differenti i concetti, diverso il campo da gioco, divergenti i percorsi.
Eh già, il punto ineludibile di cui sopra.
È difficile l’equilibrio e il punto d’incontro tra realtà e linguaggio… Una lancia spezzata a favore dei nostri criptolaliaci amici francesi (@Girolamo: anche di Lacan direi… :))
Cmq più leggo i vostri commenti e più questo New Realism mi sembra qualcosa che «trova espressione in un’intera “cultura” che (1) tende ad una ricezione di massa e che (2) è fatta di comportamenti, modi di parlare e scrivere, riti, liturgie».
Hanno perfino sede virtuale a Repubblica…
@ Francioso
Certo, anche di Lacan. Ricordando però che dopo Lacan c’è stato altro, e che il solo Lacan a me non basta. Non a caso citavo, in uno dei due testi, il lavoro che Althussser ha fatto su Lacan (rispetto al quale, ma posso sbagliarmi, Zizek non ha detto altro, salvo usare un diverso linguaggio). E non si può ignorare che L’anti-Edipo nasce in opposizione alla macchina teorica lacaniana, e costringe – pur tenendo presente, come fa il lacaniano Recalcati, che con Mille plateaux alcune distanze si accorciano – a una scelta tra il modello lacaniano e quello deleuze-guattariano. Altrimenti finiamo per fare una lista acritica, sul modello “french theory”. Alla fine, tagliando cl machete, il problema è sempre se il “reale” si aqualcosa che sta per i fatti suoi “al di là” delel nostre rappresentazioni (con quel che segue: possiamo raggiungerlo? Passiamo almeno sapere che c’è? Ci impone le sue leggi, o se ne sbatte di noi?), o se è una creazione (o un’interazione tra “polo soggettivo” e “polo oggettivo”): ed è chiaro che statuto e funzione del linguaggio (e dunque dell’apparato simbolico, delle narrazioni e dei narratori, ecc.) cambiano in modo radicale se è buona l’una o l’altra opzione.
Io com’è noto, sto con Deleuze-Guattari e Foucault (ma non per questo butto via Lacan). Però è vero che se i nostri amici francesi (mica solo loro, del resto) ci avessero dato un taglio col linguaggio esoterico, ricordandosi di come Bergson riuscisse a parlare di cose complicatissime con un linguaggio accessibile a tutti, ne avremmo guadagnato tutti (ma anche mio nonno, se avesse avuto tre palle…).
Hai centrato un punto molto importante (il solito) e sono inizialmente d’accordo con te.
Lungi dal volermi considerare l’unico interprete dell’ortodossia lacaniana (ruolo che lascio volentieri a Recalcati che, non a caso, mi pare propugnatore di un “ritorno al reale” inteso come dato biologico [sic]), anche perché Lacan non credo avrebbe voluto avere un’ortodossia.
A me piace credere che dopo le giustissime critiche di DeG de L’Anti Edipo, proprio alla “mancanza” della Realtà, che si trasforma in “bisogno” (da riempire con oggetti, ad esempio), Lacan si sia accorto di essere troppo schiacciato sulla dimensione Simbolica e abbia cercato una sterzata.
Leggendo (????) i suoi ultimi seminari (xes: il XX, Ancora) si ha l’impressione che tutti i suoi contorcimenti (i disegni di nodi!!!) siano finalizzati ad una via paradossale ed intricata (almeno quanto il rizoma dei Millepiani) al Reale: una via etica in cui non a caso irrompe la corporeità ed il godimento femminile.
Poi non so cosa ne dica Zizek e non mi interessa troppo, però non so ma mi interessa cosa ne dice Althusser :)
[OTtissimo!!!!!]
Ragazzi, state di nuovo scivolando nell’impenetrabile (che come immagine è un bell’ossimoro, ma mi sembra renda l’idea).
Hai ragione, chiedo scusa per la deriva. Grazie a Girolamo per la conversazione OT :)
amici,
sono perso in un mare di stelle,
apprendo molte cose e vi ringrazio per farmi ripensare continuamente e riformulare da altri punti di vista le questioni.
su Jesi e Gramsci, velocemente.
in assenza di citazioni dirette e dato per scontato che Jesi ne conoscesse i fondamentali,
entrambi ripensano l’importanza della sovrastruttura rispetto alla struttura e attribuiscono enorme rilevanza alla cultura come elemento costitutivo di una società,
entrambi hanno grande attenzione agli aspetti antropologici del sacro nella costituzione delle identità e dei temi folklorici,
per entrambi come è stato detto si tratta di contribuire a costituire una coscienza di classe.
Per Gramsciè fondamentale conquistare l’egemonia culturale: per Jesi la controcultura è piuttosto un antidoto all’egemonia culturale della destra.
Nel dibattito della Nuova sinistra la controcultura deve disinnescare le ‘macchine mitologiche’ mosse dal potere in funzione strategica e dopo, la stessa strumentazione teorica deve servire, secondo Jesi, per non essere soggiogati dal fascino mitologico della propria ‘macchina mitologica’.
Una cosa di Fortini del 1972 che ho messo da parte e che mi sembra importante per la questione:
«Tutte le forme di ribellione di contestazione sorte nell’ambito studentesco hanno in comune negato il ruolo dell’intellettuale e promossa la sua conversione all’attivismo politico. La negazione del ruolo si è ispirata a modelli approssimativamente “cinesi” o “cubani”; mentre l’attivismo politico quasi sempre ha finito con la riscoperta di formule organizzative di tradizione leninista […]. Gli studiosi e i militanti non sono stati quasi mai capaci di superare l’atteggiamento moralistico proprio delle minoranze intellettuali del passato […]. Chi scrive si rende benissimo conto che tentare di elaborare un sistema di segni – cioè di valori – in opposizione a quello realmente diffuso dalle centrali dell’informazione neocapitalistica, può sembrare altrattanto colpevole – direbbe Brecht – quanto “voler mettere ordine in un porcile”: e che può essere soltanto l’ennesima ripresa di un errore storico […]. Nessuno è così ingenuo da credere che ci sia davvero una “cultura proletaria” o “rivoluzionaria”; ma questo non significa che accettare di riconoscere i fondamenti capitalistico-borghesi tanto della condizione intellettuale quanto degli strumenti e delle categorie con le quali l’intellettuale oggi lavora equivalga condannarsi al riformismo e alla mistificazione. È un lavoro di talpa quello che oggi si propone agli intellettuali rivoluzionari in un paese come l’Italia: nientemeno che l’ipotesi di un uso integrale degli strumenti di informazione e di comunicazione della società presente, dalle televisioni al ciclostile, dalla cattedra universitaria alla poesia».
F. Fortini, Intellettuali e Nuova Sinistra, in Id., Questioni di frontiera. Scritti di politica e letteratura, 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977 pp. 135-136; 137-138; 139-140.
Grazie per la risposta, l’approfondimento e per la splendida, splendida citazione di Fortini (secondo me, varrebbe la pena di mandarla a Ferraris…) che è di una chiarezza invidiabile!
(grazie anche per la precisione del riferimento bibliografico).
Cosa direbbe Furio Jesi se vedesse questo spot? http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HtPcA9dO4qc#!
che dire?
autentico cattivo gusto dal basso,
di un infantilismo sorprendente. animato dalla convinzione di stare contribuendo a salvare il mondo.
se è maggiorenne è imperdonabile.
questo mi sembra più inquietante.
http://www.youtube.com/watch?v=t4o6MEmD3es
1 in contrapposizione all’uso del passato come pappa omogeneizzata cosa ci mettiamo? Una storia precisa, collocata? La storia si può fare, intendere e parlare, se sappiamo che stiamo parlando di un discorso costruito, pieno di diverse prospettive che solo insieme danno il quadro della situazione. Cioè quando io mi chiedo cosa sono, mi racconto la mia storia, che è il mio passato, collocato e esibendo il punto di vista da cui lo colloco (che sono ovviamente io). Così uso il passato con un tempo e risignifico la storia e me ne riapproprio in un certo senso, o no?
Me lo chiedo, me lo rispondo ma lo condivido e chiedo pareri.
2 Sulla questione die „guerrieri“ e l’uso costante di pezzi di macchina culturale di destra anche per la militanza a „sinistra“, trovo l’analisi di Jesi davvero centrata. Non solo nei Settanta, ma anche nell’oggi. Mi chiedo, si può quindi riuscire a parlare di lotta e di militanza senza questi dispositivi? Ne siamo immersi e li vediamo funzionare. Cosa ci mettiamo contro? Ed ecco che arriviamo dove ci interessa, cioè a pensare di declinare questo sguardo possibile dall’altra parte, della produzione, dopo l’analisi, come già si diceva in pezzi di conversazioni sui nuovi miti e su wuming stess* e nell’autocritica, giusta e responsabile, del post genova.
Provo a fare un altro esempio: sia per l’uso della storia che per il combattere, tutta la grammatica zapatista può essere una mitologia „di sinistra“ davvero? E può esserlo anche se si sa che ogni mitologia è per forza fatta di rielaborazione e quindi non esiste marcos senza l’uso che se ne fa in tutto il mondo e senza quel che se ne dice? O esiste? Cioè..
Se la rielaborazione di un mito è essa stessa parte di esso, non si possono o si possono dividere i momenti? Intendo, poniamo il caso esista una mitologia „non di destra“ ma se ne faccia uso „di destra“ posso „ripulire“ (orribile termine di destra, vero? :)) un materiale originario o lo do perso per sempre? O devo aspettare che cambino le condizioni collettive di uso dello stesso? Anche per Q questa è una domanda. Io credo che la risposta possa essere esattamente nella domanda, cioè.. laddove la rielaborazione determina il mito, allora devo continuare a rielaborarlo per tenerlo vivo. Ma dall’altra parte non si può mica raccontare sempre la stessa storia.. o sì?
provo a rispondere a queste centrali questioni, che spero di aver colto correttamente.
1. la conoscenza storica come critica e la consapevolezza della distanza sono un antidoto fondamentale all’uso della storia, sia esso monumentale o antiquaria (cfr. le Considerazioni inattuali di Nietzsche).
Assmann, che è un teorico dell’identità, citando Olivers Sacks (il neurologo) considera i processi di «organizzazione narrativa della memoria» e di «autocostruzione» che riguardano il piano inviduale (life-stories) analoghi a quelli inerenti al collettivo (“miti”).
In qualche modo siamo intrecciato con la storia che ci precede e abbiamo una storia, nella misura in cui ce la raccontiamo. Ri-significazione mi sembra un buon termine, perché ogni approccio è comunque sempre anche una appropriazione. Cfr. Ricoeur che parla di un
fondo impenetrabile nei soggetti che precede ogni interpretazione, opaco, non esauribile, di interesse che pertiene alla dimensione personale, di cui lo stesso soggetto non è in grado di rendere pienamente ragione e che rinvia alla costellazione collettiva memoria-narratività-testimonianza-rappresentazione storica.
2. la seconda questione è quella più politica e riguarda l’uso del mito a sinistra ed è quello di cui parla WM1, citando il problema che hanno attraversato del rapporto mitopoiesi/movimento.
i miti che si pretendono originari sono dannosi perché fanatizzano, i materiali rielaborati e vistosamente mostrano invece la loro leggerezza e mantengono sempre desta la riflessione, non prevedono il solo momento patetico-emozionale. Qui Jesi citava il Brecht dello straniamento che produce per un’arte di idee, o il Benjamin del commento decostruttivo (e perdonatemi l’anacronismo).
Perché una narrazione non sia tossica, ci siamo detti, deve mostrare la sutura, il lavoro di rimontaggio, citazione, l’ironia e la parodia,
deve rinviare-a, essere allegorica e allusiva; pena l’adesione acritica, l’idolatria, l’ipnosi di massa.
é LA questione di ogni movimento realmente emancipativo che senza una propria mitologia non può essere tale e se appesantisce il mito tradisce il suo afflato utopico e si trasforma in chiesa.
Il libro di Yves Citton, Mythocracie. Storytelling ed imaginaire de gauche, 2010, discute questo. Alegre ne proporrà un’edizione entro l’anno. In sintesi, traduco a braccio dall’ed. francese, p. 18:
«è oggi urgente costruire insieme: non tanto un sistema di idee, coerente e totalizzante […] ma piuttosto un bricolage eteroclito d’immagine frammentarie, metafore incerte, interpretazioni da discutere, di intuizioni vaghe, di sentimenti oscuri, di speranze folli, di narrazioni sconnesse e di miti interrotti, che prendono insieme la consistenza di un immaginario».
Come esempi di uso possibile del mito Citton cita Sun Ra, sì il jazzista, che ha usato «la forza emancipatrice del mito: cambiare nome, adottare un’identità extraterrestre, guardare la società terrestre da un punto di vista interplanetario, tutto questo ha contribuito a uno sforzo di contro-scenarizzazione permettendo di denunciare e resistere all’oppressione, razziste, classiste, conformiste e anti-intellettualiste che strutturano la società americana».
Poi Citton cita il lavoro di Wu Ming (pp. 165-169) come un esempio per rinnovare l’immaginario di sinistra senza cadere nelle trappole del mito per la scelta dell’autore collettivo contro il mito dello scrittore, la transmedialità e il riferimento ai movimenti e alle moltitudini in rete;
il mito di sinistra come cantiere aperto e il New italian epic come risposta di sinistra al ‘soft power’ reazionario,
Le sue fonti sono ‘Wu Ming. La narration come tecnique de lutte’, Politique, 56, 2008 e poi NIE, versione francese, con largo spazio al sito…
Posto un passo da Critica della violenza etica di Judith Butler, spero non troppo OT e non di troppo cmq, a proposito di raccontare sé stessi.
“Se l’identità che noi diciamo di essere non può catturarci una volta per tutte, e allude immediatamente a un eccesso e a un’opacità che fuoriescono dalle categorie dell’identità stessa, allora ogni tentativo di “dar conto di sé”, dovrà necessariamente fallire per avvicinarsi a una qualche verità. Nella misura in cui chiediamo di conoscere l’altro, o chiediamo che l’altro dica, una volta per tutte e in modo definitivo, chi lui o lei sia, sarà necessario non aspettarsi una risposta che possa davvero soddisfarci. Solo non aspirando a tutti i costi a una risposta esaustiva, e lasciando che la domanda resti aperta, che addirittura continui a insistere, noi lasceremo davvero vivere l’altro, dal momento che la vita può essere intesa proprio come ciò che eccede ogni tentativo di dar conto di essa. Se lasciar vivere l’altro è parte essenziale di ogni definizione etica del riconoscimento, allora questa versione del riconoscimento si fonderà meno sulla conoscenza che sulla percezione e l’assunzione consapevole di certi limiti epistemici, di certe pretese di verità.
In un certo senso, come suggerisce Cavarero, il “vero” atteggiamento etico consiste nel porsi la domanda “Chi sei tu?” e nel continuare a domandarselo senza mai aspettarsi una risposta piena e definitiva. L’altro a cui pongo la domanda non sarà mai completamente catturato da una risposta che possa soddisfarlo del tutto. Così, se nella domanda vi è un desiderio di riconoscimento, questo desiderio sarà sempre obbligato a tenersi vivo come desiderio, a non risolversi mai in qualcosa di soddisfatto. “Oh, ora finalmente so chi sei”: nel momento stesso in cui pronuncio queste parole io cesso di rivolgermi a te, o di essere interpellata da te.”
bellissimo e in focus,
grazie, hai le coordinate esatte, metto da parte,
grazie
grazie mille e sì, hai colto entrambe le questioni.
sulla seconda leggo e penso: già! il punto non è nel cosa ma nel come e già sta in Jesi che infatti ci parla di macchina, di processo e di dinamica. Un “mito non di destra” non può esistere o se vogliamo definirlo non possiamo definirlo così. dovremmo trovare qualcosa che suoni tipo “insieme di pratiche comunicabili critiche per dire qualcosa di performativo che sia collocato nel mondo e nel tempo”
wuming è quindi un immaginario possibile perché fatto di modi e non “solo” di storie, oppure di “storie”, se come storia si può intendere insieme “prodotto”, “processo di produzione”, e “processo di fruizione/ricezione possibile di condivisione” in un certo senso.
Ho capito giusto?
@jackie.brown grazie e niente OT, se il topic è stato da me impostato siamo proprio lì a chiederci come si fa a dire, a dirsi e quindi grazie!
direi di sì,
modi e nodi, crocevia di storie afferenti a diversi momenti di storia dei movimenti di resistenza, ri-visitate e ri-abitate. i personaggi di WM sono sempre identità-dubitanti e sfumate ed è l’insieme della coralità dei punti di vista (dei personaggi) che determina un quadro. ma io non sono un buon critico, sono un lettore, e qui mi fermo…
Salve a tutti,
credevo che la discussione fosse morta e sepolta e invece vedo che il buon Malera sta ancora qui a presidiare il fortino.
Ne approfitto per raccontare una cosetta curiosa che mi è capitata stasera.
Mentre buttavo un occhio per vedere se riuscivo a rimediare da qualche parte una copia di “Mitologie intorno all’Illuminismo” di Furio Jesi mi sono imbattuto in questo
http://anonym.to/?http://totalitarismo.altervista.org/totale/calasso-si-e-fermato-a-jesi/
Dovrei dedurne che esisteva anche uno Jesi esoterista di cui noi “zecche” ignoriamo l’esistenza?
L’articolo – tra citazioni di Papini e atmosfere degne delle migliori vasche da bagno di Argentiana memoria – si commenta da solo, direi.
A quanto pare sarà anche il “più odiato dai fascisti”, ma una bella riabilitazione *decorativa* in ambienti ben più nazi rispetto a quelli dell’ AVGVSTO sembrano proprio pronti a dargliela.
Mi resta soltanto un dubbio, che probabilmente mi leverà il sonno stanotte: ma ‘sto GdC sarà l’amico immaginario?
@malera molto bello il pezzo che hai pubblicato sul tuo blog sugli scritti giovanili di Jesi, ho anche provato a commentartelo ma qualcosa nn ha funzionato, quindi ti ringrazio qui.
Sempre se ci sei ancora ;)
Un saluto
Urca che tipi! Povero Jesi, se si sentisse coinvolto in questi discorsi… Da prendere in seria considerazione l’ipotesi danbrowniana del suicidio/omicidio misterico, da farne una puntata di Mistero…
Mi sono spesso chiesto il perché della fascinazione della destra per l’esoterismo ma poi penso che ogni mito identitario è per definizione esoterico, cioé interno, chiuso nel gruppo che sancisce e “sigilla”. Sbaglio @franzecke?
TdC: Secondo me non sbagli, sei molto arguto. Mi piace la tua ipotesi.
F: Eh! Grazie, grazie. Sì non è malaccio. E l’ho tirata fuori così, en passant…
TdC: Sei er mejo.
L’esoterismo un po’ pecione di questi pseudo seguaci di Guénon, per come la vedo io, ha ben poco a che vedere con le istituzioni iniziatiche legate ai miti identitari.
Si tratta più che altro di paccottiglia identitaria, di esoterismo plastificato, di gnosticismo de noantri.
In questo senso Evola ha fatto scuola.
Il discorso può benissimo ricollegarsi con quanto si diceva sopra rispetto all’uso del kitsch come funzione decorativa: scollegate dal loro contesto sociale, le simbologie esoteriche scadono subito nel grottesco (Apuleio docet).
Riguardo al fascino che tali puttanate hanno sempre esercitato sulla destra, credo sia un discorso analogo a quello riguardante la loro ossessione per i complotti, le cospirazioni, le società segrete e via dicendo: si tratta di semplici soluzioni atte ad eludere la realtà e a nascondere la polvere sotto al tappeto, per riprendere un’espressione di WuMing1.
Correre a rifugiarsi nella solita pappetta pronta con cui la cultura di destra si nutre e si propaga, mi sembra infatti sempre di più un modo per nascondere un rimosso, e il risultato di tali operazioni, più che verso l’identità, secondo me conduce dritto alla schizofrenia.
«Riguardo al fascino che tali puttanate hanno sempre esercitato sulla destra, credo sia un discorso analogo a quello riguardante la loro ossessione per i complotti, le cospirazioni, le società segrete e via dicendo»
È proprio questo che intendevo (forse impropriamente) per esoterismo. Mi hai fatto pensare a quanto radicata sia in alcune persone di destra che conosco l’ossessione (vera e propria) per queste sciocchezze: dal libro dei sette savi alla civiltà aliena.
Del resto già il nazismo correva dietro alla sindone, la lancia di Longino, ecc.
Tu sei sicuramente più ferrato di me in questo campo, ma la spiegazione di ideologia prêt-à-porter non mi convince molto, neppure quella della fuga dalla realtà o della rimozione: c’è qualcosa che mi inquieta in questa insistenza e deve essere legata a doppio filo con la creazione dei miti di destra.
Non so: non vi sembra strano, per chi si pone come difensore dell’ordine e dell’autorità, ricercare spiagazioni oscure e nascoste?
È un tratto che la destra ha sicuramente in comune con Beppe Grillo ed il suo complottismo che ogni tanto riemerge (uuuuuh: e il signoraggio????).
In generale più che schizofrenia (a me gli schizo stanno simpatici!), dovrebbe aver a che fare con la psicosi: ne parlavamo tempo fa a proposito dell’abuso di Tolkien da parte della destra.
È la ricerca di un significato profondo, un’essenza nascosta che stabilisca una volta per tutte la verità del significante (del simbolo)?
È come se perfino i portatori di un’ideologia “totale” e “totalitaria”, si accorgessero che qualcosa sfugge, che il senso comune a disposizione non è sufficiente, che c’è un vuoto o un’eccedenza (vd. Butler) che non si sanno spiegare (in questo senso il rimosso): non potendo però accettare l’idea che un senso non esiste, lo cercano in questo modo bislacco…
Caro Francioso, direi che il commento postato qui sotto dal buon Lorevero sia una spiegazione abbastanza esaustiva di quanto stavo dicendo – molto più esaustivo di tutto quel che potrei dirti io, che sono un seguace dell’arretos e della dea pigrizia :) – nonché un bel modo, a mio parere, di chiudere questa discussione.
Nel pensiero di destra la via più facile, benché spesso travisata da passaggio attraverso la porta stretta, passa sempre in primo piano rispetto alle sterminate – e faticose – praterie del ragionamento: in questo senso, direi che lo possiamo in tutta tranquillità definire un *non pensiero*.
Un saluto e a presto
ci sono, continuo a seguire, grazie, è un piacere davvero
qualcuno può anche pensare uno Jesi esoterico, ma si tratta di un abbaglio.
dirò di più: è vero che il giovanissimo Jesi ha frequentato Galvano, un insegnante di filosofia, poeta simbolista e pittore d’avanguardia con entrature nella buona società torinese, e non è da escludere che li ci fosse poltiglia esoterica. (cfr. Ferrari, 2007)
Il giovanissimo Jesi va anche a trovare una volta il barone de Rachewiltz, egittologo traduttore del Libro egiziano dei morti e marito di Mary, figlia di Ezra Pound. Il tipo, un aristocratico con castello in tirolo e suocero poeta al seguito, aveva simpatie destrorse. Jesi ha conosciuto quindi anche il vecchio Pound, poeta che amava. Ma stiamo parlando di primissimi anni sessanta se mi ricordo bene la corrispondenza, insomma il giovane studioso mette insieme egitto e poesia e conosce uno dei suoi poeti preferiti. Me ne ha parlato Mauro Raspanti, del Centro Jesi di Bologna, centro studi su antropologia, storia delle religioni, post-coloniale, di grande impegno civile e antifascista.
La mia idea è che lì abbia cominciato a capire che il mito e la destra sono strettamente connessi e che doveva guardarsi bene dagli ambienti egittologi, rilkeiani (come dai salotti torinesi, su cui scrive cose molto divertenti) e da lì credo abbia cominciato non solo a prenderne le distanza, ma a cercare di capirne i motivi.
Ricordo che dal 1964 comincia a scrivere cose marxiste, nel 1968 scazza con il maestro Kerényi per questione politiche, lo accusa in molto garbato di cripto-fascismo, e poi nel 1969 molla la CGIL, criticandola da sinistra.
Il libro di cui si parla nel dialogo è il Mitologie intorno all’illuminismo (esce 1972 ma i saggi sono precedenti, per le edizioni di Adriano Olivetti, che dovrebbe essere una garanzia di per sé) in cui studia l’esoterismo, ma senza alcuna simpatia.
John Dee è un protoscienziato, Jakob Frank e Shabbetay Zezy trasformano la loro utopia religiosa in mito vissuto, Kierkegaard e il pietismo sono modi di vivere il mito in terra.
Studia l’approccio esoterico appunto, come fa uno studioso materialista che ne riconosce il fascino e il pericolo. (cfr. Manera, 2012).
In quel libro ci sono anche i saggi su Sade e Swift, è un libro molto sperimentale, che odora di Barthes e Starobinski per intenderci, non di Guenon.
Detto questo io ho comprato a Roma nel 2007 ‘Il linguaggio delle pietre’ Rizzoli, 1978, in una vecchia libreria del centro che sembrava di essere in Harry Potter, in categoria ‘esoterismo’. Anche lì Jesi cita Bulwer-Lytton in apertura, ma il libro è tutto Leroi-Gorhan , Caillois, Benjamin… per me il messaggio è molto chiaro: il mito promette sfondi e squarci sull’altrove ma ti può dare solo il labirinto dell’immaginario.
(cfr. Roda, in Riga’ 31)
Contesto poi che Jesi si sia suicidato o sia stato consumato da una sorta di malattia spirituale.
La morte di Jesi è stata un incidente domestico assurdo e causato dalla trascuratezza verso lo scaldabagno di un appartamento appena affittato, da parte di un uomo che lavorava tantissimo.
L’idea del suicidio rientra nel trito cliché (un brutto mito) del mitologo morto giovane, magari perché si è avvicinato a studiare l’esoterismo.
L’ultimo Jesi era secondo me attraversato dalla felicità dalla scrittura, dall’impegno politico, da una carriera che stava finalmente decollando dopo una lunga ‘traversata del deserto’, dal cambio di città, di frequentazioni e di prospettive. Posso immaginare che Jesi avesse un lato melanconico (chi non lo ha…), ma al tempo stesso era vulcanico, mercuriale, ironico, un trickster irriverente.
a presto,
vostro arrigo
Leggerti, arrigo, è un piacere tutto nostro (o almeno mio!!) :)
Sottoscrivo in pieno!
Grazie mille per le preziose informazioni :)
Credo di sapere a quale libreria ti riferivi, e mi risale su un filino di nostalgia per le belle giornate che ci ho passato dentro.. à bientôt!
Abbiamo fatto splash!
Dall’altro delle ns rarefatte altitudini meditative, troppo inebriati dallo stabilire quanto la trascendenza soreliana sia arbitrariamente di ds o ambiguamente di sn per prestare attenzione alle insidie del percorso, siamo ruzzolati nell’acquitrinio melmoso dei miasmi nazional bolscevichi. A fatica siamo riemersi aggrappandoci all”inadeguata,ma pur sempre salvifica imbragatura di Eco. Ma una volta al sicuro, invece di calibrare meglio il ns passo, abbiamo preferito abbuffarci di autocompiacenti affabulazioni. Con ben poco REALISMO e molta euforica eccitazione, ci siamo fatti venire il MAL DE PANZA.
Insomma, quella che era iniziata come una stimolante, seppur impegnativa escursione indagataria, si è trasformata in un baccanale stordente. Con tanto di incontinenze,annebbiamenti e sfarfugliamenti.Ora che la pacatezza pare tornata, io la scarpinata vorrei poterla continuare. E vorrei farla in compagnia di Tolkien.
” Distogli il viso dal verde mondo e guarda là, dove
ogni cosa sembra nuda e fredda.”
suggerisce Gandalf ad Aragorn ne IL RITORNO DEL RE.
Ecco, ritengo chee il limite intrinseco del pensiero destrorso stia tutto qui. Nella sua stizzinosa incapacità di afferrare la realtà come ambito di eventi fattuali, dialettici e contraddittori. Nell’ impossibilità di affrontare le cause ultime del profondo decadimento che investe le società secolarizzate.In quella sua costitutiva inadeguatezza a misurarsi con la contorta ed impegnativa complessità del divenire storico.Un deficit di senso espresso dal rancoroso schematismo del Mein Kampf. Connaturato all’allucinogena ricerca di una conoscenza esoterica intrapresa da Evola. Insito nel rimpianto agreste di un Pound, così come nel romantico nazionalismo dannunziano. E nemmeno riescono a compensarlo il feudale anticapitalismo di uno Strasser o il fallace corporativismo di un Bottai. Ed il minestrone non è che diventi più sostanzioso se insaporito coi diorami orientali che Renè contrappone alla materialità occidentale oppure con la vorticosa e vitale redenzione ascensionale dell’uomo caldeggiata da Bergson. Tantomeno con la catartica corsa senza scopo verso un divenire senza alcun fine propugnata da Sorel. Ma aggiungiamoci anche ingredienti più nobili come la intransigente opposizione verso ogni rivelazione metafisica e ipocrisia morale di Nietzche nonchè le rigorose speculazioni teoretiche di un Gentile e, xchè no, pure quell’indefinibile possibilità dell’umano esserci tanto cara ad Heidegger. Insaporisci, mescola e fai bollire fin che ti pare, ma alla fine servirai solo una zuppa x stomaci senza pretese, seppur di gradevole sapore. Nessuno degli elementi costitutivi che permettono di definire un apparato concettuale come tale è qui riscontrabile. Non abbiamo un corpus, se non proprio organico, quanto meno definito. Non vi è uno sviluppo costante ed unitario di pensiero . Solo un esile e stiracchiato filo che tenta di riannodare un’ipotetica tradizione e dal quale si dipanano ancor più esili sfilaccciamenti che avvalorano o giusticano. E’ come un affannosa costruzione di senso che implode e riesce a spiegarsi solo come fascinazione dell’astratto. Come assoluto tautologico. Un continuum disomogeneo e vuoto, ma evocativo quel tanto che basta per poter incontrare rabbia e frustrazione e porger loro contenitori di sacralità nei quali poter raccogliere un istintuale e differenziato bisogno di rassicurazione, appartenenza e riscatto. Paradigmi categorici di assoluto assunti come chiavi interpretative del reale. Cristallizzazioni di una storia più desiderata che accaduta. Una “superficializzazione del mondo” che sacrifica la complessa articolazione del concreto entro schematismi cognitivi fantasmatici immediatamente fruibili. Inevitabile. L’artificialità narrativa della ds è figlia di quella mancanza di tensione progettuale nell’edificare un nuovo tempo storico che si sostanzia nel suo farsi potere. La modernità tanto declamata si rivela come esaltazione e perpetuazione di fatto dei desueti meccanismi capitalistici di accumulazione, delle loro leggi e valori di riferimento. Non rompe,non supera bensì recupera,ripristina,rafforza. Non solleva problematicità, impone semplifiicazioni, dicotomie spicciole. Non contempla la certezza del costruire ex novo, ma salvaguardia l’esistente annientandone ogni residuale criticità sociale. Non arricchisce orizzontalmente l’indagine sul reale, ma si delega all’incarnazione leaderistica del verbo. Questo suo mix di disappunto da salotto aristocratico e rabbiose invettive da curva sud, mi appare frutto di un pensare privo di quella temerarietà indagatrice che vuole rompere la continuità storica del presente. E le sue elaborazioni mi risultano farciture rimasticate, volitive ingenuità o tentativi di arabescati ricami su un grezzo sudario tanto per voler seppellire ogni possibile atto conoscitivo scientifico, logico e dialettico. Non le vedo supportate da quell’ imperativo di sondare a fondo la materialità che ci circonda così da arricchire di spessore la visione di un altro mondo possibile.
” Si tolse l’Anello, forse spinto da qualche profonda
premonizione di pericolo. (…) -Meglio dare uno
sguardo al peggio – mormorò – Inutile barcollare
nella nebbia.-
Duro, crudele e selvatico era il paesaggio davanti
a lui.”
E quando il trascendente diventa storia collegandosi alle esigenze di sopravviivenza del dominio, allora l’evocativo si disvela ed il passato coincide con il racconto delle classi dominanti. L’ unico. Il pensare diventa inutile xchè il credo economico imperante non ha bisogno di intellettualità, non necessita di altre storie, ma solo di libertà d’azione. E mentre la tradizione valoriale giustifica le necessità dell’oggi, la riorganizzazione capitalistica della società impone il suo implacabile sfruttamento su uomini, risorse e territori altrui. L’ideale avvalla e divarica le differenza fino a diventare una salutare barbarie evoluzionista. E le contraddizioni sistemiche restano tutte lì, irrisolte. Ancora presenti, solo un pò in disparte. La valorizzazione del capitale, ritrovato un nuovo equilibrio momentaneo, è rimasta intatta. Dominatrice incontrastata, è ora legittimata a dispiegare il suo destino civilizzatore. Con tutto il suo carico di sofferenza, ingiustizie, barbarie ed iniquità che dall’ Olimpo dei miti ritornano rovinosamente sulla terra.
Le storie migliori da raccontare non sono le preferibili da vivere.
Ma è uno scherzo o è un ragionamento che uno dovrebbe poter seguire?
Dai ldtxv, proprio ora che Saint-Just ci lascia un po’ liberi di sfogarci! ;)
È chiaramente un volo pindarico, non privo di spunti di notevolissimo interesse.
@ LOREVERO io, in effetti, ho mal de panza da una settimana…
Farebbe bene un pochino di filosofia analitica ogni tanto.. ;)
Vi prego di perdonarmi, volentieri vorrei proseguire la riflessione rispondendo ai vs post, ma sinceramente non ne ho afferrato il senso.
ldtxv, a cosa ti riferisci quando parli di scherzo o ragionamento ? A quale contesto o individuo farebbe bene la filosofia analitica?
franzeche, a quale volo pindarico interessante fai riferimento ?
Ovviamente, lungi da me ogni intenzionalità polemica. Il mio è solo un sincero ed interessato desiderio di continuare l’ approfondimento sulle ” idee silenziosamente sedimentata” e le loro implicazioni storiche.
Ti chiedo io di perdonarmi, perchè ho usato un tono polemico. E’ che ho trovato quello che hai scritto incomprensibile, e mi chiedevo se ci stessi prendendo in giro. Per questo suggerivo la filosofia analitica, perchè è rigorosa e poco verbosa.
Non conoscevo Furio, per fortuna c’è gente come voi e posso rimediare (magari mettendolo da parte un attimo, come ha fatto Enrico), comunque grazie delle frequenti riflessioni che ci “obbligate” a fare… e concordo con Ekerot su De Turris.
Se per caso lo spettro di Jesi (cioè @arrigo :)) si dovesse aggirare ancora da queste parti…
Mi chiedevo se la possibilità teorica della “tecnicizzazione” del mito sia un’esclusiva del sistema capitalistico: se, cioè, il mito tecnicizzato sia “la voce” del capitalismo.
Spiego a cosa mi riferisco.
Nella lettura di Deleuze e Guattari dello sviluppo storico socio-economico (L’anti-Edipo, cap. III), una delle caratteristiche, se non la più vistosa, del capitalismo (il che non vuol dire necessariamente che ne sia la causa, né l’effetto…) è la perdita dei precedenti riferimenti socio-culturali (quel processo progressivo che chiamano “decodificazione”): sostanzialmente la perdita di ogni possibile “senso” linguistico e culturale della realtà.
La “codificazione” delle società pre-capitalistiche mi sembra possa accostarsi al valore “classico” del mito, come esposto ad es. da @franzecke:
«legge, norma fondante e garanzia di stabilità e di coerenza sociale».
(Noto incidentalmente che è difficile immaginare lo spazio per una contro-narrazione in una dimensione in cui il racconto del potere è tutta la realtà)
Ora, secondo DeG, l’esempio migliore di questo depauperamento del mito (come lo chiamo ora io) è il valore di “equivalente generico” attribuito al denaro: questo non ha più un senso socio-culturale (xes tasse per reggere lo stato), ma diventa l’oggetto feticcio per eccellenza che si accumula come valore in sé e che produce (apparentemente) valore di per sé.
(non vi fa venire in mente il capitalismo finanziario???)
Questo svuotamento culturale come conseguenza provocherebbe lo spazio per una apparente e superficiale libertà di racconto,”codificazione” (“tecnicizzazione”???), di mitologie contrapposte (ideologie??), che però, prima o poi, vengono disciplinate dal potere “assiologico” proprio del sistema capitalistico (attraverso “funzioni” linguistiche profonde, che mi ricordano gli “enunciati” di Foucault, ma lascio perdere perché per me è un casino…).
È una visione, credo, interessante soprattutto in quanto spiega gli apparenti spazi di libertà di cui si giova l’ideologia liberale-liberista (progresso, benessere diffuso, democrazia, diritti umani,…) e li spiega inevitabilmente come miti tecnicizzati (codificazioni superficiali).
Il problema, d’altro canto, è che non ci sarebbe spazio per miti *non* tecnicizzati…
[…] imporre l’uso di «centrodestra» e «centrosinistra» al posto di «destra» e «sinistra» è stata un’operazione di framing che ha avuto conseguenze devastanti: a destra l’eufemismo è servito a legittimare soggetti lercissimi e fascisti nemmeno ripuliti; a sinistra […]
[…] la strada, poi la sinistra ha distrutto quel mondo” (in realtà, è questa una parafrasi di Wu Ming 1, ma siamo lì); come concetto è ridicolo, eppure probabilmente anche voi conoscete persone che lo […]
ecco l’ennesimo capitolo in tema di offensiva culturale / manipolazioni / appropriazioni indebite eccetera, direttamente da Torino, visibile a chiunque sta uscendo dalla città passando dalla zona degli ospedali. che dire, sono al passo coi tempi e con la cronaca.
(non sapendo se e come è possibile caricare immagini, linko la foto presente sul mio contatto twitter; nel caso non sia la procedura corretta, chiedo scusa in anticipo)
https://twitter.com/Klingsor_/status/311541491283685376/photo/1
e poi che dire, ti vengono dei dubbi, fai due ricerche, e ti viene da vomitare.
https://www.google.com/search?q=carlo+vive&hl=it&client=firefox-a&hs=Qpz&rls=org.mozilla:it:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=93NCUf3ZKsTA7Ab7pIDADA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=611#imgrc=_NIEG1hnWgv7pM%3A%3BoYuyykOVkjTD4M%3Bhttp%253A%252F%252Fimg44.imageshack.us%252Fimg44%252F227%252F16338291.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.termometropolitico.it%252Fforum%252Fmovimenti-e-cultura-politica%252Fdestra-radicale%252F14903-foto-corteo-carlo-falvella-7-luglio-1972-7-luglio-2009-a.html%3B640%3B480
[…] richiamati all’ordine economico e la paura del diverso, dell’altro spinge verso una destra che manipola «materiali mitologici» per fondare un “noi” inesistente (ma rassicurante) da […]