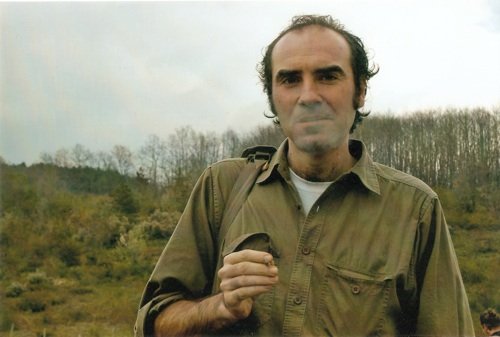
Alberto Prunetti (fotografia di Stefano Pacini)
[Dopo le bestemmie col groppo in gola, il commento viscerale e la “decantazione” del libro, ecco la chiacchierata col Prunetti. Partecipa il collega Girolamo De Michele. La particolarità del terzetto di scrittori è questa: si è tutti e tre figlioli della classe operaia (famiglie piene di braccianti, metalmeccanici e quant’altro) e tutti e tre si viene da zone di nocività e alta mortalità operaia: la Taranto dell’Italsider/Ilva, la Maremma maiala avvelenata fino al midollo, la Ferrara del polo petrolchimico (le morti causate a Ferrara dalla Solvay sono raccontate nel romanzo breve di Girolamo Con la faccia di cera, Edizioni Ambiente, Milano 2008).
Come sempre, vi ricordiamo che in calce al post ci sono due link molto utili: uno apre la versione ottimizzata per stampa/pdf, l’altro permette di salvare il post in formato ePub. Buona lettura.]
–
Wu Ming 1
Quando si suicidò il compagno Riccardo Bonavita – vicenda che mi dilania ancora, per motivi personali legati al mio rapporto/non-rapporto con lui, e ormai parliamo di più di sette anni fa: andai al funerale con mia figlia neonata in braccio e oggi mi arriva allo sterno – tu scrivesti una riflessione breve ma molto incisiva sulla precarietà intellettuale, che apparve su Carmilla. Incisiva perché molto materiale, concreta, e perché diceva una cosa che spesso non è chiara ai commentatori: il “precario intellettuale” di oggi non fa solo “lavoro intellettuale”; c’è un continuo rimpasto di “manuale” e “intellettuale”, si rimbalza da un cantiere a una pizzeria a una traduzione o che altro. Quelli che una volta erano i “lavoretti” che uno faceva in gioventù prima di trovare “la propria strada”, oggi li fai per anni e anni e anni, ti ritrovi quarantenne, anche cinquantenne, e sei ancora lì che fai i “lavoretti”, e ti accorgi con orrore che sono proprio i “lavoretti”… la tua strada. Al fondo si è tutti “trasfertisti”, in una maniera diversa da quella che conobbe il tubista Renato, che pure fece in tempo a vedere l’alba di questa precarietà, addirittura poté far parte del grande popolo delle “finte partite IVA”, nominalmente lavoratori autonomi ma nel concreto lavoratori subordinati, per giunta con meno diritti dei lavoratori ufficialmente dipendenti. Oggi si è “trasfertisti” nel senso che non si lavora mai “in sede”, perché la “sede” non c’è. Un tempo si associava lo sradicamento alla libertà di muoversi, si sognava la “flessibilità” come nomadismo, ma lo sradicamento si è realizzato come schiavitù, oggi si è sradicati in una maniera scombinata, aleatoria e deprimente. Ed è successo nel giro di una generazione. Tempo fa, su Giap, mi ha colpito molto un tuo commento, che poi hai sviluppato in Amianto ma vale la pena riportare anche nella forma “compatta” del commento:
«Quello che è sconvolgente (e riguarda la volontà del capitale di sfruttare la manodopera rappresentata dalla nostra generazione) è anche un elemento generazionale. Mio padre era un discreto saldatore e un tubista con la terza media: ha sempre fatto solo quello e gli è bastato per comprarsi la casa e farci campare e studiare fino all’università; io conosco 4 lingue, sono un fotografo passabile, ho scritto e tradotto libri (quasi 25) senza parlare di cose come il ghost writing, ho vissuto, studiato e lavorato in tre continenti, dove ho insegnato italiano, so fare qualcosa in ambito di idraulica, avicultura e di equitazione, in agricoltura sono in grado da solo (e lo faccio ogni anno) di fare olio, vino, passata di pomodoro, ortaggi… tutto questo e ancora non riesco a camparci oltre il livello di povertà! Vi rendete conto che razza di impoverimento hanno realizzato in una generazione? Altro che continuare a formarci, a studiare, come dicono gli alfieri di questa capitalismo morto e risorto vampiro… altro che debito pubblico: è la società che alla nostra generazione deve qualcosa, ed è arrivato il momento di riprendercelo.»
Ecco, io diffido sempre di chi adotta un approccio “generazionale”, perché in questi tempi di false dicotomie «vecchi vs. giovani», «gerontocrazia vs. rottamatori», «garantiti di mezz’età vs. precari under 30» etc., la “generazione” è un concetto funzionale alla guerra tra poveri. Ma tu qui – e nel libro – lo declini in modo totalmente diverso, qui il nemico non è la generazione precedente, ma il capitale. Anzi, la generazione proletaria precedente (rappresentata da tuo padre) risulta sconfitta insieme alla successiva: i padri speravano che i figli, studiando, si sarebbero emancipati dalla condizione subalterna, e invece non è andata così. Qui il discorso generazionale è teso non alla rivalità ma alla solidarietà ed empatia tra gli sfruttati di qualunque fascia anagrafica. Quello che mi piacerebbe facessi, a partire da questo, è raccontarci le tue esperienze nel mondo del lavoro in parallelo a quelle di tuo padre: entrambi “nomadi”, lavoratori-viaggiatori, ma che differenza tra un percorso e l’altro!
Alberto Prunetti
Per fare un parallelo tra la carriera professionale di mio padre e la mia, si potrebbe ipotizzare un confronto tra i due rispettivi curricula professionali. Io ho tre curricula distinti, a seconda dei profili, e in media ognuno va dalle 5 alle 7 pagine. Mio padre non aveva il curriculum ma il libretto di lavoro (e non era lunghissimo). Sostanzialmente ha avuto 4-5 diversi datori di lavoro e per un certo periodo è stato un artigiano con partita iva (come carpentiere in ferro-installatore industriale). Però attenzione: lavorava per ditte che lo mandavano in cantieri sempre diversi e il nomadismo l’ha conosciuto anche lui. Inoltre il sistema delle ditte in appalto e in subappalto cominciava a farsi strada anche nella grande industria, quindi – come adesso – c’erano negli impianti gli operai assunti dalla proprietà e gli esterni (che a volte stavano tre mesi, a volte ci stavano per anni in quell’impianto, e questa era una finta assunzione per conto terzi che permetteva di abbassare i costi del lavoro). Quindi di fatto anche il curriculum di mio padre era lungo pagine e pagine e infatti la difficoltà che ho avuto io ai fini del riconoscimento dell’esposizione all’amianto è stata quella di ricostruire il suo curriculum tra una raffineria e un’altra, tra un’acciaieria e un’altra. D’altro canto lui aveva orari fissi, tabella degli straordinari e della malattia, i pagamenti supplementari della diaria del trasfertista, il vitto e l’alloggio pagato, la formazione professionale e le ore di assemblea sindacale pagate, il diritto di sciopero e la possibilità di rivolgersi al sindacato per ogni problema contrattuale o per gli abusi padronali. Il risultato di un secolo di lotte sociali a partire dalla prima Internazionale. Soprattutto aveva un contratto collettivo, quello dei metalmeccanici, che fissava per la categoria tutti questi elementi contrattuali. I “lavoretti” li ha fatti da ragazzino, a quattordici anni (bagnino, cameriere…) e ha continuato fino ai venticinque anni saltuariamente: il Cardellino era un posto alla moda (era la discoteca beat migliore del posto) e lui con la paga da operaio non avrebbe mai potuto permettersi il biglietto d’entrata: così si è fatto assumere come cameriere.

Renato e Alberto, 1974.
Quando avevo diciott’anni, Renato mi ha proposto di andare con lui a pulire delle cisterne in una fabbrica del nord ma poi ci ha ripensato (io avevo accettato) e mi ha detto: «Lascia perdere, è l’ultimo pane». Così, da studente all’università, d’estate facevo il barista e poi ho imparato a fare il pizzaiolo (ci ho scritto un racconto rimasto ancora inedito su carta ma pubblicato su Carmilla, la prima puntata è qui). Poi ai tempi dell’università ho cominciato a lavorare anche d’inverno (ero tornato in Maremma) e ho fatto il boscaiolo (avevo letto Il taglio del bosco di Cassola ma non pensavo che la pratica fosse tanto più dura della teoria). Dopo la laurea mi sono cimentato in qualche lavoretto per alcune agenzie di formazione e ho fatto anche del ghostwriting. Di seguito sono andato in Inghilterra. Mi avevano detto che si trovava lavoro facilmente, io avevo un inglese di merda, non ce la facevo più a fare lavoracci stagionali in nero in Maremma (tipo svegliarsi alle sei del mattino per aprire gli ombrelloni nei bagni sulla spiaggia in cambio di due lire) e così sono partito: era il mio primo volo aereo, a ventotto anni. Sono entrato in un’agenzia interinale di Bristol, avevo i soldi per una settimana di albergo, mi hanno mandato a pulire i tavolini in un centro commerciale e a pulire i cessi. L’ho fatto. In seguito sono stato promosso a magazziniere. Dopo sei mesi mi sono trasferito sulla costa del Dorset e sono andato in un centro-vacanze scolastiche e ho fatto il kitchen assistant, cioè lavoravo in una mensa somministrando il cibo agli studenti (e aiutando in cucina). Ci sono rimasto un altro anno, lavoravo anche in una finta pizzeria italiana come pizzaiolo il sabato sera (il proprietario era un turco che si spacciava per italiano). Tornato in Italia mi sono rimesso a studiare e ho fatto un inutile corso professionale post laurea con tirocinio fotografico non pagato. Intanto ho cominciato a lavorare saltuariamente (l’ho fatto per due anni, forse tre, a periodi) in un centro ippico come manovale-tuttofare. Portavo fuori i cavalli dai box, ripulivo le stalle e li rimettevo dentro. Li governavo e li spazzolavo. Tagliavo l’erba, verniciavo le palizzate, preparavo i campi per i concorsi ippici. Stavo per ripartire per lavorare in Inghilterra quando mio padre si è ammalato. Così, per stargli vicino, sono tornato in Maremma e mi sono cercato un lavoro. Ho trovato un posto come pizzaiolo in un parco naturalistico sopra le miniere di Gavorrano, era un posto tranquillo. In quel periodo quasi per caso ho pubblicato Potassa (scritto negli anni precedenti) e ho conosciuto dei lavoratori dell’editoria: così mi sono arrivate delle traduzioni. Mi sono trasferito a Siena e poi sono partito con la mia compagna per l’Argentina, dove lei era andata a insegnare italiano. Ho fatto alcuni reportage per il Manifesto ma non potevano pagarmi. Ho fatto qualche lezione di italiano a Buenos Aires come volontario, sono tornato, mi sono specializzato per insegnare italiano agli stranieri (si alternano sempre lavori manuali, lavori intellettuali precari e cicli di formazione a pagamento sperando di ottenere più lavori meno di merda, questo nonostante il fatto che nessuna azienda abbia mai speso una lira nella mia formazione professionale, anche quelle per cui ho lavorato in maniera più continuativa). Per anni ho insegnato italiano a lavoratori migranti stranieri, ho fatto formazione (nella fotografia e nella storia dell’arte) e ho anche aiutato alcuni amici in lavori fotografici (foto di cerimonia) saltando da un posto all’altro del centro nord. Ho avuto altre traduzioni (di recente ho tradotto Debito di David Graeber) e ho anche fatto lavori manuali per integrare (ad esempio le vendemmie). Sono anche andato a lavorare in India, ho insegnato italiano là per periodi alterni per un bel po’. Avevo anche la tessera blu da lavoratore immigrato in India, ero registrato nell’ufficio immigrati della questura di Mumbai. Quando sono tornato nel 2010 le tariffe di insegnamento sono diventate da 24 euro orari prima 15, poi 12. Poi (mi dicono) sette ma ormai me n’ero già andato. Ho fatto di recente parecchia disoccupazione non retribuita, dal momento che qui in Italia non c’è un reddito minimo garantito.
Negli ultimi tempi faccio agricoltura di sussistenza in un circuito amicale in Toscana. Ci scambiamo competenze, tempo, forza fisica. Adesso mi sto prendendo cura dei pollai di alcuni amici che sono in viaggio. Presto andrò a aiutare un mio amico a potare la vigna che ha rilevato dalla vedova di un contadino, mi autoproduco molto cibo, quando ho bisogno di un tecnico in casa lo ripago con l’olio che faccio io, ad altri do la mia passata di pomodoro e in cambio mi regalano della carne di cinghiale o della legna da ardere per la stufa. Poi ogni tanto arriva qualche traduzione e mi rimetto alla tastiera. Oppure mi offrono un corso di formazione e insegno qualcosa di storia del territorio, per esempio. Si va avanti ma senza vedere vie d’uscita. Anche le traduzioni si sono ridotte e molti editori pagano sempre più tardi (prima 30, poi 60, poi 90 giorni) e alcuni ti trattano con un’arroganza… Sto anche pensando di affittare un terreno e iscrivermi come coltivatore diretto (non come imprenditore agricolo), però devo farmi due conti in tasca. Quando mi chiedono che lavoro faccio, non so bene come rispondere. Quando vado al sindacato, non sanno cosa dirmi.
Rispetto a mio padre, io lavoro anche quando cerco lavoro, lui conosceva i suoi ritmi e sapeva quando poteva fermarsi. Non credo neanche che si annoiasse, nel cantiere (aveva i suoi compagni con cui univa il lavoro e il piacere di stare assieme). Io non riesco a collegarmi con altri lavoratori, siamo sempre posti gli uni contro gli altri, il gioco del potere è quello. Non c’è un contratto collettivo (per i formatori, o i traduttori, o gli insegnanti assunti da associazioni o scuole private) né un ente che ci rappresenti davvero, nonostante alcuni timidi tentativi in questa direzione. Al contrario di Renato, non posso chiedere la malattia né ho diritto a straordinari né a ferie pagate né a corsi di formazione pagati. Non posso neanche fare sciopero né ho diritto a ore di assemblea sindacale. Con la legge Biagi e le assunzioni occasionali hanno rimosso lustri di lotte sociali. Bisogna ripartire dagli IWW, che sindacalizzavano gli insindacalizzabili (come gli immigrati italiani).

La lapide di Anna Lo Pizzo (che forse si chiamava Anna Lo Monaco) a Lawrence, Massachusetts. Per approfondire, cliccare la foto.
Quanto a me, anche il nomadismo ormai mi è venuto un po’ a noia, ho quasi quarant’anni e sento il bisogno di provare a mettere qualche radice. Per non parlare degli acciacchi lavorativi (mal di schiena, male alle ginocchia, tendinite cronica da tastiera). Da un punto di vista fisico, alla mia età, Renato cominciò a dare i primi segni di disagio. Anch’io spesso mi ingrippo. Il capitale, nel nome della produttività, della flessibilità, ci sta disumanizzando lentamente e le malattie sono il segno di questa sconfitta del nostro corpo: un’uscita orbitale del nostro organismo verso una degenerazione scheletrica, psicologica e cellulare (come i tumori). In ultima analisi, mentre faccio lavori intellettuali mi prendo acciacchi fisici concreti e mentre faccio lavori manuali cerco ormai sempre di più di valorizzare certi saperi contadini per non avvilirmi troppo e dare dignità alla fatica corporale. Ma non ci riesco sempre. E se anche mangio biologico, aiuto un po’ il mio stomaco ma non faccio niente per aiutare la categoria di quelli che si trovano nella mia situazione.
Girolamo De Michele
A me, in fondo, è andata meglio: ho avuto culo, più di Alberto. Ho attraversato la crisi strisciante della fine degli anni Ottanta (che c’era, ma veniva mascherata con l’esaltazione della flessibilità, le cooperative e altri strumenti che servivano a “tastare il terreno” e a inoculare il virus della precarietà) e quella, violentissima, della prima metà degli anni Novanta rimbalzando da un lavoro all’altro. Alla metà dei ’90 ero sposato, padre, disoccupato, e potevi incontrarmi sulla vespa a fare il pony express, o a fare il bidello. Poi, un paio di decisioni prese quasi per caso mi hanno portato a insegnare, e alla fine ad un contratto “a tempo indeterminato” come insegnante. Un mio amico, che ha iniziato più o meno con me e ha solo due anni meno di me, è ancora precario, e non è neanche messo bene. È una storia che ho raccontato all’inizio di La scuola è di tutti, non sto a ritornarci. Però mi è stata utile, sarà che, mi dicono, sono uno che riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno: attraversando la precarietà, e al tempo stesso facendone uno dei miei argomenti di studio quando era di moda esaltare la globalizzazione (lì, invece, le casette di marzapane e le porte di cioccolato fondente proprio non riuscivo a vederle, alla faccia dei bicchieri mezzi pieni) ho focalizzato non solo che, come diceva Roberto, il nemico non è la generazione precedente, ma il Capitale: ma, soprattutto, che gli strumenti di cui si serve il Capitale per esercitare il proprio dominio ruotano attorno alla precarizzazione dell’esistenza. Precarizzazione che non è solo una condizione lavorativa – sei un precario, ti sbatti tra un contratto a progetto e un lavoretto in nero, e anche se il tuo contratto dice “a tempo indeterminato” ci sono mille sottigliezze che ti fanno capire che il vero significato di quella frasetta giuridica è: «non credere di essere arrivato»; la precarizzazione è una condizione esistenziale, ma non per un qualche destino o una qualche fatalità. C’è una precarietà emotiva, relazionale, che si riverbera in una miriade di manifestazioni di insicurezza, di incapacità di stabilità passionale – il mio filosofo, Spinoza, le chiama “passioni tristi”. Non so se avete presente il film di Anna Negri Riprendimi, che uscì, se non ricordo male, più o meno in contemporanea con Tutta la vita davanti di Virzì, altro film sulla precarietà, sui call center, di cui, grazie al cast, si è parlato molto di più. Quello che Riprendimi cercava, secondo me riuscendoci, di comunicare è come la precarizzazione ci è entrata nell’anima e l’ha colonizzata. Abbiamo un’anima precaria, insomma: e quello che dovremmo fare tutti quanti (in parte alcuni di noi lo fanno, lo facciamo) è capire con quali strumenti è stata creata quest’anima precaria. Questa precarietà dell’anima è stata raccontata in molti film (ad esempio gli ultimi di Silvio Soldini), in molti romanzi mainstream (mi vengono in mente sono Caos calmo, Come dio comanda, La solitudine dei numeri primi): ma non basta mostrare le espressioni di queste cattive passioni, bisogna svelare i meccanismi che le generano. E secondo me la vita di Renato Prunetti lo fa: ci mostra un operaio “old style” – un labronico working class hero che non ha nulla di eroico – nel momento in cui quella generazione di operai, di proletari muoveva i primi passi, forse senza saperlo, in quella zona grigia della precarietà. E mentre lo fa la vediamo crescere, questa zona grigia, nella quale il semplice fatto di vivere non è né scontato né banale, perché la stessa pericolosità del lavoro, il suo rapporto con la morte – altro che l’essere-per-la-morte di cui cianciavano gli accademici dalle loro cattedre – è una forma di questa condizione.

Distruzione del corpo proletario. Renato Prunetti nel luglio 1970 (a 25 anni) e dopo trent’anni di lavoro salariato e nocività.
Wu Ming 1
Mi collego a quel che ha appena detto Giro. In un saggio intitolato «Narrativa del precariato e transmedialità: il caso di Scrittori Precari» (apparso nella sezione “New Italian Epic” dell’ultimo numero di Bollettino ‘900) Claudia Boscolo riflette materialisticamente sul rapporto tra condizioni di lavoro e raccontabilità del lavoro, e scrive:
«I genitori della generazione precaria erano votati a obiettivi “a lungo termine”, e la linearità esistenziale ne compensava i sacrifici. Ciò significa che, volgendosi indietro oppure guardando avanti, la vita assumeva un senso narrativo compiuto. Oggi è ancora possibile una narrativa che rappresenti il tema del lavoro, quando il suo protagonista, il precario, ha come carattere distintivo la sua irrappresentabilità? Questo tratto restituisce nel narrato la frammentazione esperita dagli autori nel loro personale vissuto […] L’assenza di tutele nel mondo del lavoro, disciplinato da una legislazione che da venti anni a questa parte ha indebolito la posizione dei lavoratori a esclusivo vantaggio di quella dei datori di lavoro, ha avuto come effetto secondario l’introduzione pervasiva nella narrativa italiana contemporanea di temi legati al raggiungimento di certezze qui e ora, contrariamente a quelli legati alla progettazione del futuro, in relazione al fatto che la realtà è spezzettata e che il presente sembra essere divenuto eterno […] Nelle narrazioni a tema che hanno per oggetto la precarietà lavorativa si riscontra per lo più un’intensificazione del presente, il racconto di episodi spiccioli e quotidiani come unico orizzonte temporale possibile.»
Amianto sfugge a questa trappola storicizzando la precarizzazione, mostrando che la precarizzazione ha un divenire e un passato, non soltanto un inspiegabile “esserci” e un incontestabile presente. Alberto ottiene questo narrando la vicenda famigliare e il passaggio di testimone tra padre e figlio. Passaggio reso in modo letterariamente fortissimo quando Renato appare in sogno ad Alberto e gli dà certosine istruzioni… sulla manutenzione dell’auto! Anche in Amianto ci sono gli «episodi spiccioli e quotidiani», e sono parecchio divertenti, ma sono contestualizzati, inseriti in una prospettiva storica. Quel che manca in molte narrazioni del precariato è, azzardo, la buona vecchia coscienza di classe. E’ la coscienza di un “lignaggio” proletario che permette ad Alberto di confrontare due storie lavorative (la sua e quella del su’ babbo) senza mettere una generazione contro l’altra. Certo, Alberto conosce bene la storia del movimento operaio (in particolare della sua componente anarchica), ma prima di essere un sapere studiato e imparato, il suo è un sapere respirato in famiglia (il nonno che gli raccontava di Pietro Gori etc.) Su Giap mi sembra che ci abbia preso in pieno il compagno Mastacchi quando in un suo commento ha parlato di
«operai che hanno fatto studia’ i bimbi, ma che son riusciti a tirarli su in modo da non fargli mai scordare d’esse’ figlioli d’operai, e con la coscienza di riconoscersi anch’essi come operai, seppure d’un tipo nuovo e diverso, ma con meccanismi di sfruttamento che si ripropongono.»
E allora continuo con l’azzardo: la situazione descritta dalla compagna Boscolo non deriverà proprio dal fatto che molti dei precari che scrivono e si raccontano non hanno una storia famigliare proletaria, ma appartengono a un ceto medio che si è “proletarizzato” solo di recente, quindi non “ereditano” alcun passato, nessuna consapevolezza pregressa sulla condizione dello sfruttato e sull’inconciliabilità del punto di vista operaio con quello padronale, e gli tocca partire da zero? Magari i loro genitori erano quel genere di piccoli borghesi che mugugnavano contro gli operai che “stanno sempre a scioperare”, e adesso i loro figli non fanno mugugnare nessuno, perché di scioperare non hanno nemmeno il diritto. Ci vorrebbero più opere come Amianto, che mettano in collegamento i precari di oggi con la classe operaia di ieri (e di oggi, ça va sans dire). O Prunetti, che te ne pare di quest’analisi?
Alberto Prunetti
Spero di ‘un piscià troppo fóri dal vaso (going off topic): la prendo un po’ lunga ma comincio dal lavoro. Anzi: ho cominciato dal lavoro. Ho scritto il mio primo racconto attingendo alla mia esperienza come lavoratore in una pizzeria. Volevo raccontare il lavoro vivo perché non avevo altro da cui cominciare. Di che dovevo parlare, di musica classica? Quello era il mio mondo. E all’inizio volevo scrivere per vendicarmi dei miei datori di lavoro. La scrittura doveva essere un modo per colpire i padroni. Col tempo (e qui vengo a chi su Giap ha sollevato analogie con Timira) ho capito che si poteva scrivere “non per vendetta ma per mettere radici”. Perché mettere radici è un modo per picchiare più duro.
Come fare per raccontare questo mondo, quello evanescente di mio padre e quello marcescente che abbiamo trovato infestato dalla miseria del Capitale? I ricordi bisogna stimolarli, bisogna riattivarli. Mi ha aiutato la convivialità con i miei amici, molti sono figli di operai, alcuni colleghi di mio padre (che lavoravano in altri reparti alle acciaierie di Piombino o al Casone di Scarlino, oppure erano emigrati per andare alla BMW in Germania e poi sono tornati, sono amico sia dei figli miei coetanei che dei padri…). Parlavo con loro, tra una cosa e l’altra… chi si lamentava della silicosi del nonno, chi del respiro corto del babbo, delle pensioni Inail sempre più magre… non c’è solo il mio di padre in Amianto, ci sono i babbi di tanti altri amici miei riassunti nella figura di Renato.

Renato Prunetti (a sinistra) con un collega in una raffineria, primi anni Ottanta.
Un altro elemento metodologico importante: non bastano i ricordi, che sono ingannatori. Le storie che si vuole raccontare bisogna andarsele a cercare. Andarci coi piedi e imparare con gli occhi. In campagna si dice: il mestiere si ruba cogli occhi e s’impara col cuore. Certa gente non ti da istruzioni, se vuoi conoscere le storie, vai a lavorare con loro. Vai in campagna, vai nell’orto dell’emigrato tornato dalla Rhur e fatti raccontare, mentre spacchiamo la legna, la sua vita. Ma ovviamente i calli non bastano. Non basta sudare assieme a qualcuno per saper raccontare la sua storia in maniera avvincente, me ne rendo conto.
Infatti in Amianto non c’è solo “spontaneismo operaio”, c’è anche mestiere. C’è la ricerca nei documenti, anche quelli privati (buste paga, certificati medici e pensionistici). C’è la facilità di scrittura elaborata in anni di correzione di bozze e di traduzione. C’è la capacità di muoversi sul crinale della storia e della storiografia e su quello dei tribunali. C’è la testardaggine di smontare le dichiarazioni del potere e ribaltarle producendo nuova documentazione, elaborando una controinchiesta rispetto a quella ufficiale. C’è mestiere, certo, ma come “entra” il mestiere? Da piccolo quando agonizzavo su un campo di calcio per qualche colpo, c’era sempre un grande, un “mister” (di solito un operaio che si improvvisava allenatore) che mi diceva placido: «Tranquillo, passa: è tutto mestiere che entra». Il mestiere entra con le cicatrici e il dolore. E il libro è gonfio di entrambe, anzi: è una cicatrice, una cicatrice che si è rimarginata col filo di sutura della scrittura.
Ritornando all’intervento di Claudia Boscolo, condivido quel che dice lei ma anche e soprattutto quello che tu aggiungi alla sua osservazione. La precarietà si esprime in forme non lineari, ma l’appiattimento sul presente io proprio non lo percepisco, perché ragiono molto su base stagionale, questo è un retaggio più contadino, che ritrovo in mia nonna materna… il mio nonno materno non l’ho mai conosciuto perché è morto prima della mia nascita ma ci sono alberi, dei mandorli, che lui ha piantato lungo la ferrovia: esistono ancora e quasi mi parlano quando parcheggio sotto l’ombra della loro chioma la vecchia Audi di mio padre, che ha quasi 25 anni. Se hai questa comprensione della durata, quasi biologica, e vedi cicli e stagioni che si accavallano, allora il presente non è altro che la somma delle forze del passato e delle potenzialità del futuro… bisogna prepararsi in tempo, limare i ferri del mestiere, armare la propria potenzialità per le stagioni calde… gettare semi e poi aspettare il fango e il sole. Un seme che io lancio oggi porterà refrigerio a chi porterà innanzi la mia lotta tra trent’anni. Non credo che i ceti medi, che hanno sviluppato più facilmente la logica consumista e il divertimento individualista, coltivino questa forma di memoria storica che si espande come gli anelli di un albero, succhiando linfa dalle radici per alimentare il verde delle foglie.
Con questo non voglio dire che se non hai il padre operaio e la nonna coltivatrice diretta non capisci il libro. Io non ho avuto nessun indottrinamento politico in famiglia. Era la convivialità a darti certi valori, era l’ironia tagliente livornese, il gusto grossetano per l’improperio, il fatto di fare i lavori assieme, di dare una mano, di fare le vendemmie e le olive assieme, di «passami una chiave del quindici che devo sbullonà st’affare», di «sentì se c’hanno un cavolo nell’orto e intanto regalagli sei coppie d’ova», era chiedere a babbo: «Perché a Rosignano al cimitero invece che la croce c’è la falce e il martello sulle tombe?» che ti cambiava la vita. Più di un comizio o di una festa de L’Unità. Senza tutte quelle storie, quei lavoretti fatti assieme agli operai in pensione, quei cancelletti e quei balconi spazzolati e riverniciati a tempo perso assieme a Renato, senza tutto questo non avrei mai scritto in quel modo il libro. Per questo Renato non è neanche il Renato storico ma una somma dei tanti Renati che ho incontrato, inclusi quelli ancora vivi con cui condivido ogni tanto un bicchierino. Se sei passato attraverso queste cose, in Amianto ti ci ritrovi anche di più, con orgoglio. E soprattutto dici a te stesso: cazzo, ma non è tutta da buttar via la nostra storia dal basso. Perché io credo che a un certo punto ci hanno fatto quasi vergognare delle nostre origini, negli anni ottanta-novanta. Rimanevano gli operai, sempre meno eppure tanti, ma veniva meno la classe operaia. Scompariva la lotta di classe perché ormai la facevano solo i padroni e usavano gli operai leghizzandoli, berlusconizzandoli, trasformandoli – come suggerisce Evangelisti nell’introduzione a Amianto – in ombre servili. Io volevo affermare la voglia di riscatto e il senso di solidarietà che c’era e che c’è in certi posti e che è una forma di comunismo latente (David Graeber scrive che il comunismo è già attivo nelle società dentro alle strutture capitaliste, si tratta di tirarlo fuori, portarlo in atto, a partire dalle forme quotidiane di solidarietà).

Padre Ernesto Balducci
Quanto all’impoverimento dei ceti intellettuali, di recente ho sentito una delle tante conferenze sul precariato. Ero d’accordo su tutto. Quando l’oratore ha parlato di ceti medi impoveriti, lì ho accennato a un sorriso. Quando io sono arrivato “al piano di sopra”, ci ho trovato solo macerie. Io ho preso una fregatura ma non comprendo quelli che si strappano i capelli. Sono d’accordo, sono miei amici e miei compagni e miei colleghi i ceti medi impoveriti, però non è la miseria quella che mi fa paura. La miseria bisognava combatterla anche prima che riguardasse i ceti medi. Quel che mi offende è la subordinazione, è essere divisi, è non potere nemmeno fare sciopero assieme. Quel che mi offende nella precarietà moderna è piuttosto non aver mai fatto sciopero (non essendo assunto) nonostante mio padre fosse delegato nella rsu. Vivo questa cosa con un senso di colpa tremendo. Lo stesso senso di colpa di Ernesto Balducci (ne ho parlato sull’Amiata con una compagna e proprio lei mi ha raccontato questa storia): figlio di minatori, racconta di essere andato a fare il prete mentre i suoi compagni di classe continuarono il lavoro dei padri. Quei suoi compagni di classe, il suo stesso compagno di banco, morirono nell’eccidio nazifascista dei minatori di Niccioleta e lui rimase vivo solo perché per farlo studiare l’avevano mandato dai preti invece che in miniera. Questo gli dette un senso di colpa tremendo ma perlomeno la sua risposta a quello che lui viveva come un tradimento verso i suoi compagni e la loro classe, quella del proletariato di miniera, fu una spinta a lottare contro ogni fascismo. Questi meccanismi di colpevolizzazione esistono, è inutile ignorarli. In Argentina i familiari dei desaparecidos si chiedono perché loro sono sopravvissuti. E lo stesso è capitato a chi è tornato dai campi di concentramento nazisti: si sentivano in colpa per essere sopravvissuti. Anche i figli delle vittime del lavoro (me ne sono reso conto di recente, facendo brutti sogni dopo aver incontrato operai ammalati) si sentono in colpa. C’è un rimosso che torna, nella morte così sacrificale del padre. Perché con il martirio del padre hai vissuto, hai studiato, hai mangiato. Ma non bisogna colpevolizzarsi e fare il gioco del potere ma bisogna rivoltare la nostra rabbia e determinazione verso i mandanti di quelle morti, verso il capitale, che su quelle morti si è arricchito. Quindi non bisogna cadere nel tranello del senso di colpa ma bisogna reagire. Scrivere questo libro era un modo per salutare la memoria di chi si è ammalato o è morto a causa del lavoro, senza celebrare per forza il lavoro come in un romanzo socialista. Più che celebrare il lavoro volevo ricordare quel senso di condivisione e di solidarietà che c’era in quel mondo e quale miseria ha creato il capitale e i suoi armigeri, che hanno vinto lasciando la terra desolata e sciapa, perché il sale della terra eravamo noi, loro sono solo gli utilizzatori finali di un mondo al collasso.
Riassumendo, credo di poter dire che sono d’accordo con la tua analisi e che il fatto di aver nutrito la mia coscienza politica non solo di libri ma anche di convivialità, di tempo passato con contadini e operai ─ mio padre, i suoi amici, i genitori dei miei amici, che son quasi tutti operai, che ormai sono essi stessi miei amici, tanto che negli ultimi tempi quando esco la sera a Follonica frequento un vecchio minatore in pensione reduce da un’emigrazione in Francia e un pensionato dell’Italsider ─ tutto questo insomma ha alimentato la mia consapevolezza (e credo anche la mia scrittura) di una capacità e di uno sguardo verso il mondo operaio che non è esterno, non è funzionale, non è furbetto. Io non ho scritto un libro sull’Amianto perché il tema è scottante e serviva un instant book visto che l’apice dei casi di morti per amianto sarà tra il 2015 e il 2025… è perché quest’apice si sta avvicinando che statisticamente era probabile che mio padre morisse qualche anno fa ed è proprio perché lui è morto che io ho scritto il libro.
Girolamo De Michele

Giacomo Leopardi
Mi colpisce molto la tua (di Alberto) riflessione sui ceti medi e la dimensione temporale, e il modo in cui tu e Roberto riprendete quell’intervento di Claudia Boscolo. Perché è una riflessione che si colloca all’interno di un quadro concettuale che è stato definito, e secondo me una volta per tutte (in modo “strutturale”, si sarebbe detto una volta) nientemeno che da Giacomo Leopardi, in un testo che scrisse negli anni Venti dell’Ottocento, e poi non pubblicò: il Discorso sopra lo stato presente dei costumi morali degl’italiani. Lì il conte Giacomo prendeva una strada che con facilità poteva sfociare in una distinzione caratteriale tra italiani e francesi motivata con degli universali immodificabili: gli italiani cazzeggioni e sarcastici, i francesi ragionatori e illuministi. Quante volte lo abbiamo sentito dire, questo ritornello dei “soliti italiani”, della “nazione femmina”, del “solo da noi succede questo o quello”? Una forma di autoassoluzione, un po’ come una collettiva visione di un film di Alberto Sordi, dove ridi dei tuoi vizi “da italiano”, e ridendo ti autoassolvi, e dopo la catarsi de noantri non fai nulla per cambiare te e il tuo mondo, e tutto resta uguale. Non a caso il massimo cantore (qui ci vorrebbero delle faccine) dell’eroicità italiota di Alberto Sordi è stato Walter Veltroni: perché il correlato dell’italiano medio come eterno Alberto Sordi (o, se preferite, dell’albertosordità come categoria dello Spirito) è il “quindi lascia fare a me, che ci so fare”. E invece Leopardi collegava la dimensione dell’eterno presente, contrapposta a quella della proiezione nel futuro – e dunque l’alternativa tra quale dimensione temporale sia prevalente nella propria visione del mondo – al posto occupato nella società, al genere di attività svolta, alla dimensione economica come struttura che genera valori morali, caratteri, modi di dire e di fare: persino la differenza tra la risata demistificatoria e la battuta arguta ha un fondamento sociale. L’ho presa, come faccio spesso, alla lontana, ma per dire che i comportamenti del ceto medio al tempo della crisi sono tutti interni a quella fenomenologia dell’italiano senza coscienza, senza lingua, senza teatro, senza letteratura nazionali fotografati dal Recanatese. Il rischio – che Boscolo individua, e fa bene – delle narrazioni della precarietà è quella di fare del precario una variante dell’uomo del ceto medio, cioè dell’impiegato. Non a caso per Leopardi l’uomo della “società stretta” era un produttore, uno che progettava e costruiva il proprio futuro. In realtà io nelle figure della precarizzazione – che non sono solo quelle della precarietà lavorativa: basta pensare alle figure femminili, e al tema della femminilizzazione del lavoro e della messa a lavoro e a profitto di passioni, affetti, sentimenti (penso, in Italia, alle ricerche di Cristina Morini, soprattutto) – è una sorta di temporalità schizofrenica, all’interno della quale si rimbalza da un tempo all’altro – presentificazione dell’esistenza, nostalgia e rimpianto, ansia e panico, senza riuscire ad andare oltre i confini di questa dimensione.
In questo senso libri come Amianto sono importanti per ricordare, un po’ come gli alberi piantati dai nonni di Alberto, che un altro modo di rapportarsi al mondo attraverso un’altra percezione del tempo è stata possibile, e se lo è stata la questione fondamentale è come, in quali forme sia possibile riproporla: come sia possibile oggi pensare come possibile e realizzabile un mondo diverso, come progettarlo, in base a quali percezioni confliggere con l’esistente.
Altra cosa: quando Alberto dice che non è indispensabile avere il padre operaio e la nonna coltivatrice, ha al tempo stesso torto e ragione. Quello che ci accomuna, in questa discussione, è, tra le tante cose, di venire da famiglie di lavoratori (nella mia, prima che divenisse prevalente il mestiere di insegnante, ci sono stati operai metalmeccanici, ferrovieri, carpentieri, ostricultori, e l’immancabile nonno contadino); ora, io cosa sia la coscienza operaia l’ho imparato dal mio zio operaio che ha sempre votato DC, che era cattolico e conservatore: ma che non è mai entrato in fabbrica in un giorno di sciopero, anche se non andava alle manifestazioni. Io credo che quello che ci si diceva in casa, magari a tavola, a cena, ha condizionato (in positivo) la mia e la nostra coscienza. Quella convivialità aveva uno spessore diverso da altre forme di convivialità. Però è anche vero che una coscienza non solo te la formi, ma devi anche curartela, e nel curartela la orienti: c’è tutto un lavoro, lungo una vita, che ti porta a ritenere ancora importante quel mondo operaio e contadino che intorno a te non esiste più, o esiste in forme molto diverse da quelle di un tempo. È per questo che non abbiamo alcuna vergogna da provare per le nostre origini, sia familiari che sociali e politiche: io sono fiero della faccia che mi guarda dallo specchio quando rientro a casa.
 C’è un altro tema su cui credo valga la pena spendere qualche parola, ed è in fondo il tema principale del libro: la nocività del lavoro. Qui si racconta di una nocività che viene sempre venduta come frutto del caso, come un rischio in fondo accettabile – chi prende in mano il libro capisce di primo acchito che in qualche modo si parlerà di tumore. Quello che ancora non si è fatta strada nell’opinione pubblica, nella coscienza generale, è che non solo certe sostanze e certe lavorazioni possono essere nocive – a questo forse si sta arrivando -, ma che la nocività è un dato intrinseco, consustanziale del lavoro industriale come lo abbiamo conosciuto e accettato: perché “non c’è acciaio senza amianto”. Quando ho pubblicato su Carmilla uno dei pezzi che ho scritto sull’ILVA di Taranto, con Alberto ci siamo scambiati una mail su una foto, uno striscione tarentino che diceva: «Non moriremo “a norma di legge». Io da quello striscione ho tratto il titolo del pezzo, senza sapere (il libro non era ancora uscito) che la stessa frase è in Amianto, a pag. 132. È uno dei tanti fili che lega questo libro, e la storia di Renato, alla storia dell’ILVA di Taranto, una fabbrica che ha preteso, come un minotauro metallurgico, il suo tributo di vittime da divorare (e la mia famiglia non ha fatto eccezione, purtroppo). E Taranto ha pagato, mentre i sindacati dicevano che non si può sputare nel piatto in cui si mangia («Pompieri, pompieri», cantava Piero Ciampi). Pochi giorni fa Adriano Sofri ha raccontato su “Repubblica” della scuola elementare “Grazia Deledda”, al rione tamburi, dove i livelli di diossina nelle aiuole sono il doppio del “consentito”: beh, quella scuola l’ha inaugurata e diretta al suo nascere mio padre. Leggendo il libro di Alberto provavo la stessa rabbia che provo leggendo ogni giorno le cronache di Taranto: la rabbia di chi è consapevole del fatto che la direzione capitalistica del lavoro si basa sulla necessità che, in nome e a garanzia del profitto, qualcuno debba “morire a norma di legge”.
C’è un altro tema su cui credo valga la pena spendere qualche parola, ed è in fondo il tema principale del libro: la nocività del lavoro. Qui si racconta di una nocività che viene sempre venduta come frutto del caso, come un rischio in fondo accettabile – chi prende in mano il libro capisce di primo acchito che in qualche modo si parlerà di tumore. Quello che ancora non si è fatta strada nell’opinione pubblica, nella coscienza generale, è che non solo certe sostanze e certe lavorazioni possono essere nocive – a questo forse si sta arrivando -, ma che la nocività è un dato intrinseco, consustanziale del lavoro industriale come lo abbiamo conosciuto e accettato: perché “non c’è acciaio senza amianto”. Quando ho pubblicato su Carmilla uno dei pezzi che ho scritto sull’ILVA di Taranto, con Alberto ci siamo scambiati una mail su una foto, uno striscione tarentino che diceva: «Non moriremo “a norma di legge». Io da quello striscione ho tratto il titolo del pezzo, senza sapere (il libro non era ancora uscito) che la stessa frase è in Amianto, a pag. 132. È uno dei tanti fili che lega questo libro, e la storia di Renato, alla storia dell’ILVA di Taranto, una fabbrica che ha preteso, come un minotauro metallurgico, il suo tributo di vittime da divorare (e la mia famiglia non ha fatto eccezione, purtroppo). E Taranto ha pagato, mentre i sindacati dicevano che non si può sputare nel piatto in cui si mangia («Pompieri, pompieri», cantava Piero Ciampi). Pochi giorni fa Adriano Sofri ha raccontato su “Repubblica” della scuola elementare “Grazia Deledda”, al rione tamburi, dove i livelli di diossina nelle aiuole sono il doppio del “consentito”: beh, quella scuola l’ha inaugurata e diretta al suo nascere mio padre. Leggendo il libro di Alberto provavo la stessa rabbia che provo leggendo ogni giorno le cronache di Taranto: la rabbia di chi è consapevole del fatto che la direzione capitalistica del lavoro si basa sulla necessità che, in nome e a garanzia del profitto, qualcuno debba “morire a norma di legge”.
Alberto Prunetti
Girolamo, è proprio così che la legge, che la vecchia talpa vuole a garanzia degli interessi del capitale, si esprime. E le parole non sono neutrali. «Esposto a norma di legge» è stato Renato insieme a quelli come lui che, cito ancora l’idioletto legale, «godono dei benefici» di tale esposizione. Benefici INPS conteggiabili, immagino, sui cento euro al mese, mentre le dinastie dei padroni dell’acciaio e del petrolio godono di accumulazioni di capitali che sfuggono alla mia limitata immaginazione economica. «Esposto» è un bel verbo, è un participio passato in forma passiva, non implica un’azione attiva, una responsabilità. «Gli operai sono esposti»… Bella frase. Suona più pulita di «I padroni hanno ammazzato degli operai…»: il modo indicativo implica una responsabilità che i tribunali faticano a riconoscere. E invece bisogna cominciare a usare l’indicativo, a indicare i responsabili con i loro nomi. Perché qui siamo tornati a Germinal di Zola, a Taranto e altrove. Nell’ottocento era la tubercolosi, poi la silicosi, ora l’asbestosi e i tumori. Si muore, si muore, altro che il pane. Sarebbe ingiusto morire per sfamare la propria famiglia, ma morire per arricchire i padroni (chiamarli imprenditori mi sembra un eufemismo)… che non vivono a Tamburi, ma ci vanno in culo e portano cinque, come si dice a Livorno, e se ne stanno in ben altre magioni… che senso ha? Io non credo che esista un capitalismo pulito, sai? Credo che il concetto di nocività sia fondamentale per descrivere nella sua sostanza il capitalismo: dove arrivano i procacciatori d’affari delle multinazionali, non cresce più l’erba. Dai campi del Paraguay alle scuole italiane. Credo che un’immagine del capitalismo dell’acciaio adeguata sia quella della fucina malefica che nel Signore degli Anelli distrugge le foreste per forgiare metalli per le corazze e le armi di un esercito di mostri che dovrà andare a distruggere le città. È questo il sogno del capitale. Forgiare metallo per distruggere il pianeta e le vite che lo abitano, espandendosi fino all’utilizzazione finale dell’ultimo albero e dell’ultimo operaio. Quest’impresa economica, o con parole più adeguate questo modo neoschiavistico di gestire il pianeta è talmente disumano da risultare fallimentare (infatti è in crisi dichiarata su tutti i fronti) e si alimenta ormai, vampirescamente, solo del sangue e della carne dei propri sudditi, ridotti a zombie. E non vengano a dirmi che si ammalano anche gli “imprenditori” (ora va di moda parlare di “suicidi di imprenditori,” in televisione, da Santoro in avanti, giusto?) Qualcuno conosce i nomi dei tre operai che anche oggi sono morti in qualche cantiere edile o industriale, dei tre che muoiono ogni giorno?
Girolamo De Michele
Qualcuno ricorda che il giorno in cui fu assassinato Marco Biagi a Bologna ci fu un secondo omicidio, un operaio extracomunitario morto sul lavoro in cantiere?
Alberto Prunetti
Dopo questa, «Il Giornale» griderà ai terroristi.
Wu Ming 1
Capirai che novità… Faccio notare una coincidenza curiosa: sempre quel giorno e sempre a Bologna, gli ex-padroni della Menarini furono rinviati a giudizio per omicidio colposo, cioè per l’esposizione degli operai all’amianto nel periodo 1977 – 1987. Le testimonianze raccolte dalla FIOM su quel che avveniva in fabbrica erano raggelanti, sinistramente simili a quelle degli ex-operai Solvay di Ferrara. Ebbene, i Menarini furono assolti poco più di un anno dopo, con la motivazione che il fatto «non sussisteva».
Alberto Prunetti
Ora si parla dei suicidi degli imprenditori. Se noi ci ammazziamo (e penso a Bonavita) è per l’urgenza di una vita che ci hanno rubato. Se i padroni si ammazzano (quanti sono poi, uno ogni due mesi?) è perché sono vicini al fallimento, cioè non possono più giocare a fare i padroni… sai che non mi commuovono tanto quanto quei tre operai che ogni giorno muoiono ammazzati in Italia, costretti a un lavoro nocivo e pericoloso? I sedicenti imprenditori sono stati i rappresentanti mandatari del capitalismo e ora che la loro impresa assassina si dimostra per quel che è (una campagna armata, una guerra di classe contro la vita e la terra….) ora che non c’è più né terra né sangue da succhiare, ora vorrebbero anche la mia compassione? Vengano a vivere al Cotone di Piombino o a Tamburi, vengano a viverci alla paga di un tubista di quarto livello e i soldi che risparmiamo sui loro stipendi vadano a bonificare totalmente i loro veleni… forza padroni, sveglia, al lavoro, otto ore ogni giorno a ripulire la cokeria, con la pala e il muletto, mentre noi, operai e operaie, figli e figlie di operai, lavoratori precari della conoscenza e commesse, disoccupati e cassaintegrati, professori sotto concorso a sessant’anni e casalinghe, immigrati e traduttori con la tendinite, pisceremo negli altiforni e spengeremo quel fuoco che ci ha devastato la vita.
Wu Ming 1
L’ultima riflessione tocca a me? Bene. Negli studi di mitologia esiste un concetto proposto da Károly Kerényi: “mitologema”. Un mitologema è un nucleo narrativo minimo dal quale si sviluppano leggende, miti, favole. I miti sono spesso storie molto ramificate e complesse, ma possono essere riassunti in poche parole, e quel riassunto è, appunto, il mitologema.
«Un eroe scende agli inferi, incontra uno o più morti, supera prove e ritorna in superficie» è un mitologema. Certe volte, anziché tornare, muore all’ultimo momento perché fa una cazzata.
«Un bambino viene perso o abbandonato ma sopravvive e da grande compie imprese importanti, fondative» è un altro mitologema. A volte il protagonista incontra di nuovo i suoi genitori e insieme combattono un nemico, in altre storie li incontra ma non li riconosce, e si ingenera un equivoco fatale.
Ai tempi del “memorandum” sul New Italian Epic, lo ricorderete, io proposi di cercare quello che chiamavo l’allegoritmo comune a molti libri scritti in Italia più o meno a partire dal ’93, dall’inizio della cosiddetta “Seconda repubblica”. Quel termine un po’ bislacco e non utilissimo, “allegoritmo”, lo avevo preso dagli studi sui videogame, anche se il mio uso era diverso. Quel che intendevo dire era: cerchiamo l’algoritmo delle allegorie, le allegorie profonde che stanno alla base di questi libri. Mi sembrava che al fondo, pur nella diversità apparente delle forme o delle ambientazioni, quei romanzi raccontassero una stessa storia di base, mettendo in atto una sequenza di “istruzioni” (appunto, una sorta di algoritmo) che ricevevano dall’ambiente e dalla fase storica. Lo facevano ciascuno a modo suo e senza che i loro autori fossero consapevoli della parentela, della strana “aria di famiglia” che trasmettevano i loro libri. Provvisoriamente, proposi di indicare quell’insieme di libri con l’espressione “New Italian Epic”. Scelta infelice, perché la maggior parte dei critici si fermò lì, spernacchiandomi per la scelta “esterofila” etc.
A un certo punto mi è sembrato che l’allegoritmo del New Italian Epic avesse a che fare, come ha scritto Wu Ming 2, con «la difficoltà di ereditare il mondo». Ho ipotizzato che il mitologema su cui si costruivano le allegorie del NIE, e forse di buona parte della letteratura italiana coeva, fosse quello della “morte del Vecchio”: «un fondatore / capostipite / capofamiglia muore, la sua morte coincide con la crisi terminale di un mondo e i figli / eredi / successori devono decidere come andare avanti in uno scenario radicalmente mutato».
Questo mitologema, questo nucleo narrativo, lo vedevo in libri in apparenza diversissimi tra loro, da Medium e Italia De Profundis di Genna a Nelle mani giuste di De Cataldo, dal nostro Manituana a L’uomo che volle essere Perón di Bellu.
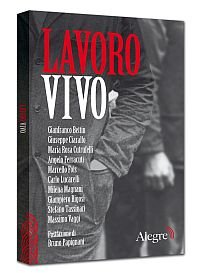 Le proposte critiche abbozzate nel “memorandum” furono descritte in modi caricaturali e poi rigettate in blocco, così anche il discorso sulla “morte del Vecchio” cadde nel vuoto e non se n’è più fatto nulla. «Pazienza», mi son detto.
Le proposte critiche abbozzate nel “memorandum” furono descritte in modi caricaturali e poi rigettate in blocco, così anche il discorso sulla “morte del Vecchio” cadde nel vuoto e non se n’è più fatto nulla. «Pazienza», mi son detto.
Solo che negli anni successivi altre voci, fuori del campo letterario, si sono espresse – in modo ben più strutturato e meno episodico del mio – sul tema del vuoto lasciato dal genitore, riprendendo il discorso lacaniano della «evaporazione del nome del padre» etc. Penso soprattutto agli ultimi libri di Massimo Recalcati. Anche in narrativa continuo a imbattermi in questa storia: nel giro di poco tempo ho letto il racconto Eqquessaè di Giuseppe Ciarallo (dall’antologia Lavoro vivo, Alegre 2012, anche lì ci sono i documenti che spuntano dalle cose del padre operaio morto) e Amianto (che infatti Ciarallo ha subito recensito), e nel frattempo ho visto che sia Edoardo Albinati sia Valerio Magrelli hanno pubblicato libri dove raccontano le morti dei loro padri (rispettivamente: Vita e morte di un ingegnere e Geologia di un padre). Anche Le meccaniche dell’infelicità di Pino Loperfido si svolge dopo “la morte del Vecchio”, e questi sono solo i titoli che mi vengono in mente adesso, su due piedi. Ecco, a me pare evidente il collegamento tra “morte del Vecchio” e “anima precaria”. Insomma, forse non avevo scritto una cazzata…
Naturalmente, un mitologema può essere sviluppato in modi diversissimi, e un’allegoria può avere interpretazioni liberatorie o incatenanti, rivoluzionarie o reazionarie. La “morte del Vecchio” può generare nostalgismi mefitici, tipo «Quando c’era Lui», aridàtece er puzzone… Pensiamo al “mussolinismo trascendentale” che condiziona la vita politica italiana, perfettamente descritto da Mimmo Franzinelli nel suo saggio “Mussolini, revisionato e pronto per l’uso”. E solo pochi giorni fa abbiamo assistito a una manifestazione raccapricciante e bisunta di “nostalgia del puzzone”, con destra e “sinistra” unite a commemorare in modo acritico un personaggio nefasto, Gianni Agnelli. Un libro come Amianto, per tutti i motivi che abbiamo appena esposto, mi sembra un piccolo antidoto a questi sviluppi del mitologema. Insomma, io credo che abbiamo bisogno di narrazioni della “morte del Vecchio” che siano sfide, che rilancino il conflitto, che raccontino la lotta per divenire genitori di noi stessi, e perciò stesso si oppongano alle puerili nostalgie del puzzone, del porcone, del padrone di turno.
Proprio oggi, mentre chiudiamo questa conversazione via email durata un paio di settimane, su «La lettura» – settimanale culturale del padronalissimo «Corriere della Sera» – trova spazio un’inattesa, quasi impeccabile recensione di Amianto scritta da Matteo Giancotti. Dico «quasi» solo per via di una piccola sbavatura: mi sembra molto impreciso dire che Alberto «rimpiange il cantiere»; non è certo la “retrospezione rosea” la cifra del libro, ma il passaggio di testimone del conflitto. Appunto, il divenire «genitori di noi stessi».
Di questa recensione vorrei citare un passaggio significativo:
«Uno dei punti di forza di Amianto è che non ha un genere di riferimento. Non è inchiesta, non è biografia, non è romanzo, non è saggio, ma ha ognuna di queste componenti in piccole dosi.»
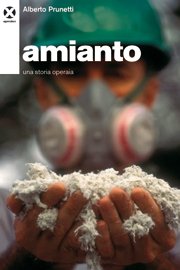 Più o meno nel 2005, dentro Wu Ming cominciammo a riflettere su opere letterarie ibride, indefinibili, che vedevamo spuntare tutt’intorno. Le definimmo “oggetti narrativi non-identificati” (UNO, Unidentified Narrative Objects). Ipotizzammo che, negli anni a venire, sempre più autori avrebbero battuto quelle piste, e gli UNO avrebbero acquisito rilievo e centralità, a parziale scapito dei “romanzi-romanzi”, dei romanzi facilmente definibili come tali.
Più o meno nel 2005, dentro Wu Ming cominciammo a riflettere su opere letterarie ibride, indefinibili, che vedevamo spuntare tutt’intorno. Le definimmo “oggetti narrativi non-identificati” (UNO, Unidentified Narrative Objects). Ipotizzammo che, negli anni a venire, sempre più autori avrebbero battuto quelle piste, e gli UNO avrebbero acquisito rilievo e centralità, a parziale scapito dei “romanzi-romanzi”, dei romanzi facilmente definibili come tali.
Tra quelle opere ibride posizionammo Gomorra, cosa che suscitò reazioni sproporzionatamente ostili, perché all’epoca alcuni critici erano convinti che Gomorra non contenesse fiction, fosse un reportage integralmente e strettamente autobiografico, e rappresentasse un ritorno al realismo “puro” e referenziale. Oggi, se nel mondo degli studi letterari (almeno quelli seri) sostieni una cosa del genere, ti ridono dietro e ne hanno ben donde.
Apro un inciso: quest’equivoco – che l’autore stesso scelse di mantenere – contribuì non poco ad avviare la macchina mitologica che tramutò Saviano in un martire, poi in un trombone, infine in una sorta di presidente-ombra dell’Italia “buona”. Un Napolitano più giovane ma altrettanto insopportabile. Se Saviano avesse «mostrato la sutura», cioè fosse stato più trasparente sulle strategie testuali che aveva utilizzato per comporre Gomorra, forse sulla sua figura ci sarebbe stato meno investimento emotivo, e lui non si sarebbe calato così profondamente nella parte di quello-che-rischia-la-vita. Intendiamoci: l’ha rischiata e la rischia davvero, ma questo non può funzionare da ricatto morale ed eterna scusante per tutte le sue scelte e i suoi comportamenti. Chiuso l’inciso.
Nel 2008 ripresi il concetto di UNO nel “memorandum”, e anche in quell’occasione non ebbe maggiore fortuna. Ora siamo nel 2013, e se facciamo caso ai libri (non solo italiani) che diventano “casi” e producono vera discussione, sono quasi tutti UNO, sono scritti da autori che se ne fottono altamente della frontiera tra narrativa e saggistica, non si pongono nemmeno il problema, passano di qua e di là quando vogliono, sfuggendo ai doganieri senza alcuno sforzo. Pensiamo, ad esempio, ai cerchi nell’acqua che sta producendo Limonov di Emmanuel Carrère… Pensiamo a HHhH di Laurence Binet… E pensiamo ad Amianto.
Dopodiché, avrei altre cose da dire e da chiedere, partendo da Potassa, da certe cose che Alberto scrive sui maremmani di ieri e di oggi e “risuonano” anche a me che sono nato, cresciuto e abitante in Emilia, ma l’abbiamo già fatta fin troppo lunga, fermiamoci qui. La parola alle altre e agli altri giapster.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

parto dal fondo perché studi(av)o la letteratura e quindi comincio dall’ultima notazione di WM1, che poi è una delle cose che mi sono venute in mente leggendo “Amianto” (anche se “leggere” non è il verbo adatto per descrivere l’esperienza di attraversamento che la tua narrazione suscita, Alberto).
Negli ultimi tempi mi è capitato di leggere alcuni libri, che ho scelto casualmente ma poi si sono in un certo senso “messi in ordine”, e cioè Storia di un corpo di Daniel Pennac, Diario d’inverno di Paul Auster e Quel che resta della vita di Zeruya Shalev. Tre libri che raccontano di un corpo anziano in disfacimento. Tre autori lontani per ambiente culturale, lingua, esperienze. Due uomini e una donna. Poi, si è aggiunto il libro di Alberto (che è “anche” la storia di un corpo in disfacimento), il libro di Magrelli (di cui ho letto ma che non ho letto).
Non può essere un caso, concordo con WM1, e credo che sia un addio a un Vecchio a un tempo molto intimo e molto collettivo. A un Vecchio individuale, sociale, culturale.
Ma mentre gli altri mi sembrano rassegnati spettatori di un ciclo ineludibile, il passo ulteriore che leggo in “Amianto” (forse perché l’autore è il più giovane?) è la lotta per non abbandonarsi all’inevitabilità dei cicli naturali (quelli reali e quelli spacciati come tali). Ed è in questa rabbia, in questo amore, il nucleo caldo del tuo libro, Alberto. Ancora non ho “decantato”, quindi spero mi siano permesse lacrime di commozione.
(notazione autobiografica: sono passata anch’io per il dip. di archeologia di Siena, e il tuo commercio di trowel mi ha fatto ridere un bel po’!!!!)
Nel primo intervento di Alberto si vede tutta la realtà che oggi si vive in maremma. Io ho ventisette anni, e vengo da Gavorrano, ma la mia esperienza è diversa. Io lavoro, certo come migrante e asservito al sistema di totale precarietà. Ma accanto a me (pur se in questo momento in modo solo sentimentale) ho molti amici che vengono da Follonica, Gavorrano, Scarlino, e che rimbalzano tra stage su e giu per l’Italia (o meglio solo su perche giu la situzione è drammatica). E’ tutto così assurdo, perchè vada per la flessibilità, vada per la necessità di muoversi, qui il vero problema è un altro. Questi ragazzi hanno competenze acquisite in anni di università, pagati coi soldi di tanti babbi come quello di Alberto, che tra miniere ed acciaierie per 40 anni si sono repsirati merda…e il loro solo punto di sfogo erano quei quindici giorni di festa dell’unita’ in paese…Ad ogni modo sono andato fuori tema, il discorso che facevo era sui giovani: Questi ragazzi hanno competenze, che non sono sfruttate perchè fanno stage sottopagati (ovvero gratis) e i più su cose per nulla attinenti agli studi. Ora io il problema lo vedo molto molto più complesso. Si è vera la tesi del mercato globale del lavoro, ma anche gli ammistratori locali si sono fregati di questo problema. I giovani che restano fanno ancora i bagnini e i baristi, per il resto in provincia non c’è nulla, zero possibilità per un laureato. Poi certo che c’è un problema a livello globale, il capitale ci risucchia l’anima, ci sfrutta, ci istiga e ci sputa via. Ma io propongo pure un terzo problema che è quello delle competenze che si danno ai giovani studenti: Sono dav vero utili? Abbiamo veramente bisogno di 5000 psicologi l’anno? Di migliaia di giornalisti? PErchè tanti di questi ragazzi scelgono queste facoltà, snobbando le scienze. C’è pure un problema di indirizzamento dei giov ani studenti, di creare la passione per lo studio, c’è dell’abbandono in giro. Io dal canto mio non mi lamento, lavoro giro il mondo, attualmente sono in Francia, presto partiro per gli stati uniti. Certo l’Italia e la Maremma mi mancano, ma dobbiamo anche un po’ sbatterci e guardare oltre. Di occasioni ce ne sono, ma il discorso è complesso. Dal mio punto di vista tutti hanno un po’ di colpe in questa situazione, Io per primo forse…
Pete85, io penso che il problema più che avere a che fare con la provincia o le generazioni sia strutturale. Ricordi quando Luciano Bianciardi diceva che in provincia (ora cito a memoria e trasformo a mio modo i termini di quel ragionamento) i fenomeni si vedono in maniera più evidente perché in certa maniera c’è meno rumore? Quel che accade in provincia non è altro che quello che accade globalmente: impoverimento di prospettive e di tasche, disoccupazione, esodi migratori imposti. E’ il capitale che si sta incattivendo e non è colpa dei giovani o dei vecchi. (PS: se a Gavorrano dieci anni fa sei passato a mangiare la pizza, il pizzaiolo ero io).
Siamo in perfetto accordo sul fatto che esista un problema globale, ma se vogliamo anche un po’ uscire dall’ambito ridotto del lavoro, la provincia (la maremma ad esempio) è una zona che paga sempre un prezzo un po’ più caro. Perchè si è lontano da tutto, dalle camere dei tg, dai salotti dei politicanti. Il sistema la uccide, ma la politica della provincia (dei politici provinciali) è completamente asservità al sistema. Zero lavoro, zero cultura. Avrei tante storie su questo, perchè venticinque qnni q Gavorrano, con gli occhi un po’ aperti si vede tanto. Ad ogni modo non è questo il luogo per dilungarsi. Comunque, alla pizzeria ci son passato almeno 3-4 volte all’anno per tutti gli anni della mia vita, avrò sicuramente approfittato anche del tuo savoir-faire culinario…Se è come quello letterario, posso esser certo di aver mangiato una buona pizza…
Danae, mi sa che dovrò rimettermi a trasformare cazzuole da muratore in trawl da archeologi, per come vanno le mie economie…
Invece concordo sul fatto che la morte del padre è un sentimento che può dare sensi di colpa o trasformarsi in una riflessione politica… bisogna arrivare al bivio e scegliere la strada giusta… la mia è stata quella di andare oltre l’individualismo piagnone(“capitano tutte a me”) e vedere in tutti gli operai ammalati il mio padre da difendere (e potenzialmente in tutti gli oppressi i propri compagni).
Fatemi capire bene visto che non ho ancora letto il libro (però mi è capitato di usare la trowel all’università, nel corso di una campagna di scavo archelogico)… Prunetti quindi modificava le cazzuole da manovale e le trasformava in cazzuole da scavo? Ma poi Alberto le vendevi agli archeologi?! No, ma tu sei un genio!!
Propongo di aggiornare l’elenco degli strumenti che compongo il kit del perfetto archeologo. Alla lista va aggiunta *la Prunetti* (trowel di origine proletaria potenzialmente adatta anche alla lotta di classe).
http://www.archeojobs.com/blog/detail/gli-attrezzi-da-lavoro-dellarcheologo
esattamente così! geniale, vero?
anche e non solo per questo (ti) consiglio, (ti) invito, (ti) spingo a leggere “Amianto”. E’ un libro di una bellezza sfolgorante: ridi, piangi, ricordi, scopri, conosci… e arrivata alla fine, ti viene voglia di ricominciare subito a leggerlo…
(ancora non ho decantato, mi sa)
Il lavoro geniale lo faceva mio padre: era lui che ritagliava le cazzuole per farne delle trawl. Io poi le vendevo agli archeologi (ma ne avrò vendute una decina, mica tante). Nel libro c’è un annesso fotografico: c’è anche la foto dell’unica di queste finte trawl che mi è rimasta in casa.
@ Danae e Alberto: grazie per i dettagli aggiunti a questo aneddoto che, pur mescolato a resoconti inevitabilmente tristi, mi ha fatto davvero sorridere.
Per enfatizzare la mia ‘critica’ vi consiglio di legger questo link (http://www.nature.com/ngeo/journal/v5/n12/full/ngeo1670.html) … Si ribadisce il fatto che il problema vero è la ‘distribuzione delle comeptenze’…Insomma magari non ve ne frega nulla… In tal caso smetto …
http://www.claudiogiunta.it/2011/10/alcune-considerazioni-sulle-facolta-umanistiche/
forse ti può interessare questo.
A proposito dell’analisi di WM1 sull’inconsapevolezza dei precari di oggi, una situazione del genere l’ho trovata nel documentario di Celestini, che ha seguito il collettivo dei precari dell call center dell’Atesia. Il doc si chiama Parole sante.
Ci sono due questioni speculari nella tua critica. Una accettabile, e una che io ritengo assolutamente fallace.
Quella accettabile è il proporre opportunità lavorative scoperte, mostrare le opportunità e sollecitare a coglierle.
Aprire strade in una situazione che sembra disperata.
Ma questa è la superficie: che se poi vai a vedere si tratta spesso di lavori usuranti (il classico caso dell’autotrasportatore o del panettiere che cerca un apprendista e non lo trova – grazie al cazzo, direi) o pochi posti d’elite.
Però ci sono critiche più profonde: l’articolo che posti fa un po’ sorridere: sinceramente che un fisico o un chimico inorganico non possano occuparsi di ricerca nell’ambito delle geoscienze è ridicolo per chiunque conosca la ricerca nel campo. L’idea che un corso di laurea debba essere tagliato sulle specifiche esigenze del mercato – magari di un programma di ricerca ben preciso – non solo è sostenibile solo se non si ha idea di cosa voglia dire fare ricerca, ma risulta controproducente sul lungo periodo, perché una volta passato il tiro economico sul settore specifico ci si trova con un corso talmente settoriale da essere inutile.
Ma soprattutto, la questione del primato delle scienze è interamente politica, e (mi permetto di dirlo, essendo scienziato) una beata vaccata. Vatti a leggere il primo post sulla vicenda dei due marò: nella discussione WM1 e WM4 smontano l’uso delle fonti fatto nella “perizia scientifica” dell'”ing.” Di Stefano con metodo storiografico: quante perizie sono falsate dall’incapacità dei tecnici di valutare l’attendibilità delle fonti, che è data in una formazione umanistica, e non in quella scientifica? Eppure a fare le perizie in tribunale e in commissione parlamentare si chiamano gli ingegneri senza manco porsi il problema.
Mai avuto a che fare con un ufficio marketing? Tipicamente il personale di formazione economica non riesce a mettere in fila tre righe in italiano, un laureato in lettere sì (banalizzo, ma spero si capisca). E la differenza di efficacia delle campagne marketing si vede.
Però ci si continua a chiedere se “abbiamo bisogno di tremila laureati in lettere all’anno”.
Sì, ne abbiamo bisogno, e parecchio…
Perché il problema non è quasi mai la mancanza di capacità del dipendente, è il sistema produttivo che se non ha l’etichetta a posto non riesce a valorizzare il lavoratore. Scaricare sempre la colpa sul dipendente (con la laurea sbagliata, poca disponibilità alle trasferte, poca voglia di fare il turno domenicale, di notte, scegli tu) è comodo, però è un inganno bello e buono.
@rockit…
ti quoto ‘l’articolo che posti fa un po’ sorridere: sinceramente che un fisico o un chimico inorganico non possano occuparsi di ricerca nell’ambito delle geoscienze è ridicolo per chiunque conosca la ricerca nel campo’…Penso tu ti riferisca a questo passaggio: ‘Compared with other science subjects — physics, chemistry and biology — there are only a small number of Earth-science graduates…’. Qua il concetto è comparativo, e non tende ne a sminuire, ne a escludere certe categorie. Che la trasversalià sia una risorsa lo sanno tutti, scienziati in primis. Nelle scienze della Terra arrivano contributi da ogni lato, paradossale è il recente sviluppo che vede la grande partecipazione di matematici, che apportano un fortissimo background alle scienze della Terra. Quindi sono in perfetto accordo con te, che la troppa settorializzazione del percorso di studi sia nociva. A tal proposito, ricordo quanto ancora oggi gli studenti italiani siano ben accetti ovunque, proprio per la loro trasversalità e la loro forte conoscienza teorica. Questi uitimi due aspetti sono qusi completamente assenti nell’università del nord europa, dove si tende a creare della macchine da produzione più che cervelli pensanti. Quest’ultimo è un merito da riconoscere all’università italiana (uno dei pochi ma meglio di nulla…). E con questa considerazione mi ricollego alla tua seconda parte. Pesno che il nostro senso di trasversalià ci derivi dal nostro lato ‘umanistico’. Abbiamo avuto molti ‘galilei’ nella storia scientifico-umanistico-culturale. Persone che di pari passo svilupavano concetti, teorie, e le esprimevano in modo chiaro e dettagliato (con rigore letterario e scientifico). Oggi, paradossalmente questo si perde anche nelle facoltà letterarie, dove si ‘ammassano’ orde si studenti che dopo 5 anni (o molti di più) saranno offerti ad un mercto del lavoro non pronto a recepirli. 5000 letterati all’anno non sono necessari, sminuiscono il senso della lettereatura. Ben vengano 200 persone motivate, che sappiamo produrre sapere, non 5000, delle quali 4800 saranno costrette a lavorare in banca, in assicuarazione o a fare i bagnini. La colpa non è degli studenti a mio avviso, ma di un sistema (la scuola secondaria) che non sviluppa passione…C’è da rivedere il conetto di scuola, mettendosi intorno qd un tavolo e parlando come stiamo facendo noi. Infatti, trovo assurdo che questo si faccia qui in un blog tra persone pseudo-nascoste-sconosciute. Una discussione così la vedo bene ad un ministero della pubblica istruzione, della ricerca…Ecco che qui riemerge il problema che esiste un sistema che non funziona…
Mi spiace ma, se la premessa la condivido fino all’ultimo, la conclusione in fondo la trovo rivoltante (non per come la esprimi tu: per il suo significato).
Col cavolo che sono meglio 200 persone motivate: le altre 4800 finiranno ugualmente a fare i bagnini, i bancari o gli assicuratori, in compenso saranno più ignoranti (senso etimologico), meno preparati e tendenzialmente più rassegnati. Già siamo messi male, togli pure il minimo di formazione superiore e altro che non leggersi un contratto nazionale, manco sapranno che cos’è un contratto (no, non sto esagerando, purtroppo…casi di dimissioni in bianco, mancate denunce di infortunio, straordinari aggratis fatti come se fossero cose assolutamente normali, nel senso di “conformi alla legge”, te ne posso portare finché vuoi).
E questo non nuoce solo ai dipendenti nuoce pure al sistema produttivo, sia nell’immediato che sul lungo periodo, perché c’è poco da fare, lo stagista a seicento euro se è laureato riesce meglio nel suo lavoro di quello con il diploma, e anche se a lui non torna in tasca una lira nel complesso si perde competitività. Insomma l’idea dei 200 motivati è perdente pure se uno abbraccia in pieno l’ottica capitalista.
Insomma, si studia pure per imparare qualcosa, non solo per trovarsi un lavoro, se no tanto vale introdurre le cabine per suicidi, lo troverei più dignitoso.
In questa conversazione mi sento a casa. E come sempre quando si tratta di cose familiari, c’è tanta ilarità quanto dolore, tanta passione quanta rabbia, tanta impotenza quanta soddisfazione. Un solo post non può mettere in gioco tutto quello che avete smosso, che già stava in circolo, e che ha trovato affinità, connessioni, nuova intensità.
Alcune cose sparse: mi sembra che lo dica bene Alberto, e che altrettanto bene l’abbiate fatto voi tre: le storie bisogna andare a cercarsele e poi condividerle, senza solidarietà e memoria collettiva il Capitale vince fino alla fine dei tempi.
Il Capitale è il nemico, ma spesso non sa parlare alla gente: gli serve chi ti faccia sentire “sbagliat*”, “indegno”, “choosy”, per fiaccarti e farti piegare sotto l’infamia del senso di colpa. Questa gente è altrettanto pericolosa quanto il Capitale, tutti gli Agnelli di questo mondo come tutti i Monti/Fornero/Passera di questo mondo.
Hannah Arendt, nel suo “Vita Activa”, parla di 3 stadi antropologici: animal laborans, homo faber, e zoon politikon. Si procede come i gamberi, da noi, purtroppo. Ci stanno togliendo spazi politici, ci tolgono il lavoro dignitoso, ci lasciano volentieri l’animalità ripetitiva e meramente riproduttiva: ringrazia, Alberto, che sai usare le mani, sennò ti rimanevano solo le ginestre del già citato Leopardi, e non credo siano saporitissime…
Il mitologema qua per me è: delle storie vengono condivise, toccano molte persone, si trasformano e con esse trasformano il mondo. Una narrazione alla volta.
Un post davvero interessante. Vorrei esprimermi solo sulla questione dell’amianto, dato che ho lavorato per il processo a Torino (dalla parte giusta, ovviamente).
Per interi mesi ho dovuto esaminare le costituzioni di parte civile, e per ognuna di quelle a me passate dovevo redigere una sintesi biografica. In soldoni, mi passavano le cartelle divise per tipo (stabilimento di provenienza, ancora vivo, già morto, morto prima degli anni ’80, morto mentre lavorava ancora, morto già in pensione, morto che non c’entrava nulla, etc.) e io per ognuna redigevo vita morte e miracoli dell’individuo e dei suoi rapporti con “l’esposizione a fibre di asbesto” o al “rischio mesotelioma”.
Ovviamente era una minima parte del mega-processo imbastito a Torino.
Vorrei sapere se Prunetti (e nel caso, chiunque altro abbia lavorato su documenti simili) ha avuto come me l’impressione di scoperchiare un vaso di merda tossica, ma di una qualità umana straordinaria. Alcune testimonianze mi hanno colpito come un pugno, ma nel complesso, erano tutte prove inconfutabili di un concetto che fino a che non lo incontri in quel modo lì non puoi dire di sapere cosa sia: la nocività del lavoro. Certo, ogni lavoro da un certo punto di vista è “nocivo”, ma quelle testimonianze particolari (esempio a caso: una donna che racconta come all’Eternit di Casale ogni mattina lei e il suo gruppo dovessero correre per arrivare alla loro postazione. Non era questione di ritardi. L’aria nei corridoi che le separavano dal loro settore era talmente densa di fibre di amianto che era meglio darsi una mossa. Tutti i giorni. Per vent’anni.) rendono un concetto estremamente denso di nocività. Colpisce ai polmoni.
@maxmagnus, molto interessante quel che ci dici. Mi sembra di capire che tu abbia affrontato e sistematizzato in maniera sintetica una miriade di storie operaie. Io ho lavorato su una sola cercando di renderla emblematica (con la difficoltà di averla vissuta e di “metterci mano” da dentro assieme a chi l’aveva condivisa). In parte le prospettive sono diverse, rispetto ai casi del processo Eternit: Renato lavorava in contesti in cui non si trattava direttamente amianto bensì acciaio, ghisa oppure idrocarburi e loro derivati. L’amianto se lo ritrovava addosso, nelle tute, nei guanti, e attorno, nei manufatti, perlopiù tubi, che doveva tagliare col flessibile e giuntare o rimuovere. Infatti legalmente si parla per essere precisi solo di esposizione nel suo caso, il suo processo è stato solo civile e il suo statuto itinerante di trasfertista già lo rimuoveva da un collettivo stabile e rende complessa una class action sul fronte penale come quella di Casale Monferrato. (A Casale Monferrato c’è stato anche lui e c’ero anch’io, ma questo è un po’ uno spoiler e si capisce leggendo il libro, non voglio anticiparlo).
Detto questo, il libro e la storia che racconto sono colme di nocività tossiche (immaginati uno che si infilava nelle cisterne svuotate di idrocarburi) ma purtroppo, dopo averle sentite in casa per quasi quarant’anni, queste storie risultano alle mie orecchie quasi ordinarie. Perché ci ho fatto un po’ il callo, racconto nel libro che a sette anni un mio compagno di banco lasciò la nostra scuola perché suo padre fu ammazzato da un getto di vapore uscito a potenza formidabile da un impianto industriale. Credo che più che la straordinarietà di questa vicenda, quel che colpisce è la sua banalità, il fatto che sia stato normale vedere compromessi udito, denti e vista a quarant’anni, avere la tessera Anmil, l’associazione degli invalidi e mutilati del lavoro a cinquanta e ammalarsi dubito dopo la pensione senza arrivare ai sessanta. E non è una storia ordinaria perché come questa ne ho sentite tante.
@maxmagnus (e @tutti), mi piacerebbe chiederti, visto che siamo alle soglie del processo di appello del processo Eternit, che se non erro dovrebbe ripartire il prossimo 14 febbraio, che sensazioni hai al riguardo di questa nuova vicenda. A me sembra che l’opinione pubblica abbia il sentore che l’amianto sia un pericolo ma l’informazione è ancora molto fluttuante: c’è chi pensa che l’amianto sia un metallo pesante che avveleni come il piombo e non un minerale che fa un’azione meccanica; c’è chi se la prende con le lastre di eternit del vicino e non vede la pagliuzza che ha negli occhi… intanto in Lombardia è stato fatto un censimento con autodichiarazioni che è una sorta di evento in questo senso (e anche la Puglia ha fatto un piano regionale, probabilmente sulla spinta del disastro di Taranto e con cifre che andrebbero verificate e disaggregate, in mancanza di un censimento, ma intanto è già un passo avanti). E una commissione nel parlamento europeo lancia il progetto, tutto da leggere e poi da approvare, per una rimozione totale dell’amianto. Ti sembra che gli scenari siano modificati rispetto a prima della sentenza Eternit? Questa sentenza può aver inciso su questi nuovi sviluppi? Lo chiedo non solo a te ma a tutti quelli che ci leggono, e quindi apro al riguardo un nuovo thread.
Che la rimozione dell’amianto vada fatta, è certo cosa giusta. Ma, e parlo della Lombardia, il pericolo ora è lo smaltimento. La corruttissima Regione Lombardia (carta canta) è stata molto “liberale” nella concessione di permessi per discariche, in zone vicinissime agli abitati: al mio paesello, per esempio, avevano concesso ad uso discarica una ex-cava ormai popolata da flora e fauna e dunque protetta dalle stesse leggi regionali. Per fortuna l’amministrazione ha fatto ricorso e sembra che la cosa sia stata bloccata. Ma il problema dello smaltimento rimane.
Sì, Vito, si aprirà il verminaio del tema dei rifiuti e delle nocività che abbiamo prodotto in secolo di civiltà industriale. Quando gli archeologi del futuro verranno a scavare i resti della nostra civiltà (speriamo con trawl vere e proprie, non come quelle che spacciavo io) troveranno sostanze contaminanti e nocive, perché questo è il vero volto della nostra produzione industriale. Non c’è da rallegrarsene. Quanto all’amianto, bisognerà pensare come renderlo non pericoloso, perché così com’è è già dappertutto, sotto i nasi di chiunque.
Non esageriamo, non mi considero un esperto nè ho affrontato una “miriade” di storie operaie. Molte, si, ma comunque all’interno di un compito marginale e spesso ripetitivo come può essere quello legato ad un processo enorme, con mille compartimenti.
Per quanto riguarda il maxi processo, in Piemonte (dove vivo anche se ora sono all’estero) ha avuto una risonanza non banale, e secondo me ha contribuito a formare un’immagine piuttosto cruda della nocività dell’indotto produttivo legato all’Eternit e più in generale all’amianto. Anche perché oggettivamente è una strage: c’è ancora gente che muore a 40 km dagli stabilimenti di Cavagnolo o Casale, a fabbrica chiusa da ormai vent’anni, e se Torino non è avvolta in una coltre di tumori lo si deve solo ai venti favorevoli.
Ha inciso anche perché il processo è stato un lavoro lunghissimo, inziato più di trent’anni fa e costruitosi negli anni grazie ad un solido lavoro dal basso delle associazioni, di pezzi di sindacato, di avvocati appassionati; un lavoraccio che ha coinvolto migliaia di persone in mille parti d’Italia (e all’estero), ma che è partito con un piccolo ed agguerrito gruppo di operai e sindacalisti che da Casale Monferrato ha cominciato a dichiarare l’amianto sostanza nociva. La costruzione del processo meriterebbe un libro a parte. Erano gli anni ’80, mica tempi antichi… da allora penso che molte cose siano cambiate, almeno nella percezione che le persone hanno di questo problema. Per fare un esempio, i ritratti degli imputati del processo Eternti de La Stampa, un giornale tutt’altro che attento a queste problematiche, sono lampanti: questi baroni e padroni ne escono come dei mostri assetati di sangue. Poi, certo, c’è attorno una cascata di sciovinismo che nasconde realtà altrettanto gravi – tipo che l’amianto c’era anche in FIAT, per dire.
Un’ultima cosa sul processo che secondo me è importante è l’effetto che ha avuto all’estero. L’Eternit è una tra le multinazionali del settore più importanti del globo, e ha ancora mille stabilimenti nelle zone del mondo dove del problema amianto non frega niente a nessuno. In Belgio, Svizzera e Francia è considerata parte della storia nazionale dei rispettivi paesi, un bersaglio tanto intoccabile quanto potente. Grazie al maxi processo, si è costituita una rete internazionale di avvocati che ora sta provando a muoversi per avviare iniziative simile anche in quei paesi (non senza rischi, visto che uno degli avvocati francesi è stato querelato per diffamazione http://www.journaldelenvironnement.net/article/amiante-jean-paul-teissonniere-mis-en-examen,30591).
A me i processi in generale non piacciono molto, ma è interessante come la battaglia per una verità giuridica sia stata, in questo caso, anche battaglia per una verità storica, che per di più parla di chi normalmente è dimenticato dalla Storia. E che a distanza di anni riesce ancora a produrre effetti sulla “opinione pubblica”, parlando di cose molto concrete e altrettanto importanti, risultando convincente (almeno, secondo me), negli anni di Ruby Rubacuori e cazzeggi vari.
Anche a me non piacciono i processi e sono scettico su quanto sia giusta la Giustizia con la bilancia in mano. Ho iniziato a seguire quella che era una semplice pratica patronale nel campo civile, sezione lavoro, solo perché mia madre non ce la faceva più e non riusciva a rielabortare il lutto anche a causa del fatto di dover riaprire le ferite della memoria. Sono stato a lungo scettico poi di colpo mi sono infervorato. Possibile che i medici curanti non volessero neanche pensare al ruolo che le nocività industriali avevano in quella malattia? Assolutamente no: nessun tentativo di un inquadramento epidemiologico. E noi parenti, e il malato, sudditi di un sapere disciplinare che non ci spiegava nulla e ci umiliava con la sua tecnica. Sai che, nonostante il mio scetticismo verso i tribunali, vedere almeno riconosciuta l’esposizione all’amianto è stato un sollievo, per me e mia madre (certo non si potrà parlare di un vantaggio economico, la sua pensione sarà riconteggiata nella reversibilità di un centinaio di euro al mese). Ma la sentenza ha dato tranquillità a mia madre, e questo libro l’ha data a me (anche se poi andare alle presentazione e aprirmi come una cozza davanti a un pubblico, non è che sia proprio semplice, ma questo è un altro discorso).
Forse mi sono espresso male. Era più corretto dire “non mi piacciono molto i *tribunali* “. In ogni caso, trovo le tue parole molto condivisibili, anche se non ho avuto esperienze personali come quelle che ti hanno guidato nella stesura del testo.
Rimando ogni commento a quando avrò letto il libro!
A me sta succedendo questo.
La mia casa, vecchia (e bella proprio per questo), in un centro storico dell’Etruria meridionale, lentamente ha cominciato a mostrare cenni di cedimento, e una cosa tira l’altra, sono praticamente sfollata da un anno. Tra i vari interventi da fare, c’è anche lo smaltimento di una parte del tetto, che è in Eternit. Il Comune non ha fondi per questi interventi privati, quindi, va bene, ci penso io (insomma, in qualche modo si farà). Mi mandano un tecnico della ditta che si occupa degli smaltimenti comunali “pubblici” (= smaltire le lastre che la gente toglie dai tetti di casa e butta nei prati), fa il preventivo, e parte la macchina burocratica. Eh sì, perché essendo in un centro storico la mia normalissima, umilissima casa è vincolata, e la Soprintendenza deve dare il permesso. Un geometra deve fare il progetto, il Comune lo deve approvare e passare alla Soprintendenza che deve dare parere favorevole. E io aspetto, con molta calma, perché quelle lastre devono essere smaltite in completa sicurezza, e voglio fare le cose per bene. Ma quanti dei miei vicini, con metri quadri di amianto sulla testa, fanno lo stesso?
Aggiungo la questione dell’arsenico (parzialmente OT: nella bibliografia di Amianto sono segnalati volumi sull’argomento). Non so se sapete che dal 1° gennaio l’Etruria laziale è di fatto senza acqua potabile in casa. SENZA ACQUA POTABILE, ci rendiamo conto? Da anni i Comuni erano avvisati che le ingenti quantità di arsenico nell’acqua non sarebbero state più tollerate, ma non hanno fatto granché. E ora non hanno più soldi, logico, e poi “i nostri vecchi hanno sempre bevuto quest’acqua, che male gli ha mai fatto?”.
Da qualsiasi parte la prendiamo, si arriva sempre a questo lavoro continuamente da fare, senza stancarsi: sciogliere il deposito calcareo dell’inevitabilità di una storia raccontata sempre nello stesso modo, di padre in figlio…
La recensione appena uscita di Girolamo De Michele su L’Indice: Il mastice della scrittura http://www.lindiceonline.com/index.php/56-l-indice/febbraio-2013/375-il-mastice-della-scrittura
Linkato in un post scriptum, grazie!
Il link al mio pezzo sul rinvio a giudizio dei dirigenti Solvay merita un post-scriptum: quei dirigenti sono poi stati assolti. Giusto per ricordare che va benissimo tentare anche la via giudiziaria, ma se non c’è un procuratore del calibro di Guariniello (parlo di competenza tecnico-giuridica), o una procura che sui temi del diritto alla salute dei lavoratori ha idee chiare e determinate, i processi si possono anche perdere.
Ciao a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per la strepitosa discussione e per l’opportunità di sviluppare ulteriori elaborazioni delle tematiche trattate nel mio articolo citato qui. Mi scuso in anticipo perché questo commento più che altro è una splafonata, e richiederà una certa pazienza a chi abbia voglia di leggerlo.
Quella parte introduttiva aveva la funzione di aprire un discorso più ampio su strategie discorsive di risposta alla narrazione del precariato imposta dai media – in particolare dall’editoria, che chiede agli autori proprio storie frammentarie, possibilmente leggere, incentrate sulla perdita di identità del ceto medio impoverito e indirizzate al target tipico della narrativa del precariato, ovvero il precario “overqualified”, con laurea, specializzazioni, esperienze nel terziario avanzato, perfetto rappresentante di quel cognitariato precario che i libri li legge e magari contribuisce anche a farli. Parto dalla prima considerazione di WM1: “Amianto sfugge a questa trappola storicizzando la precarizzazione, mostrando che la precarizzazione ha un divenire e un passato, non soltanto un inspiegabile “esserci” e un incontestabile presente. Alberto ottiene questo narrando la vicenda famigliare e il passaggio di testimone tra padre e figlio”. In questo senso, Amianto si inserisce perfettamente nel quadro di quelle strategie discorsive che costituiscono una forma di resistenza a questa narrazione del precariato e che, anzi, vanno in senso opposto: il loro obiettivo (di queste strategie) è boicottare la frammentazione e ripristinare la linearità narrativa, perduta per imitazione della realtà. Questo era il punto di arrivo dell’articolo, che ruota attorno al case-study dell’esperienza del blog collettivo Scrittori Precari in quanto rappresenta un caso esemplare di questa pratica, il cui approccio alla precarietà è determinato anche dal “fare comunità” attraverso tematiche condivise. Così, quando Prunetti parla di “convivialità” con la comunità di appartenenza che gli ha permesso di stimolare e riattivare la memoria, sta a tutti gli effetti confermando il fatto che la comunità che si attiva attorno a tematiche condivise ha una funzione fondamentale nell’operazione di ripristino della linearità narrativa, un’operazione che è principalmente di scavo nella memoria, di recupero di un sostrato la cui perdita è solo apparente, ed è di fatto il frutto di una violenza esercitata sul singolo attraverso la dispersione della comunità proprio in base alla negazione del diritto di sciopero e di altri diritti fondamentali introdotti dalla L. 30 e dalla successiva normativa che disciplina il lavoro precario. In questo senso, è fondamentale l’osservazione di Prunetti sull’importanza del contratto nazionale: niente di più del ccnl unisce una categoria, che sia quella degli operai, degli insegnanti o degli impiegati, non ha molta importanza. La coscienza di avere accesso a diritti specifici per una una comunità di lavoratori ha la funzione di rendere quella comunità forte di un senso di appartenenza nell’affrontare insieme le forze disgreganti che derivano da altre strategie del capitalismo, per lo più sono mediatiche. Interessante il riferimento al suicidio degli imprenditori, fenomeno che imperversa in Veneto, e che ha a che fare con la perdita del ruolo sociale e non certo con quella dei beni mobili e immobili. È una caporetto a livello simbolico, non materiale: è il simbolico che ha agito sulla psiche dell’imprenditore suicida. Personalmente non sottovaluterei questo fenomeno, nel senso che se il simbolico ha il potere di agire in maniera così distruttiva sul detentore del capitale, ma non altrettanto sul lavoratore precario – vedasi l’esperienza incredibilmente ricca descritta qui da Prunetti, che è molto lontana dal trasmettere una sensazione di sconfitta: di fatto questa potentissima capacità di adattamento rappresenta esattamente il punto di forza del lavoratore precario oggi – il precariato ha già vinto, in quanto il nucleo di coscienza marmoreo che impedisce all’universo simbolico della sconfitta (la perdita di ruolo sociale) di penetrare e agire in maniera distruttiva nell’individuo costituisce di fatto l’anticorpo principale contro ogni forma di distruzione attuata dall’esterno e dall’interno dell’individuo, ovvero rispettivamente da un lato dal capitale e dalla psiche. Interessante anche il fatto che il capitale distrugga il suo proprio detentore agendo sulla sua stessa psiche: una forma di entropia che varrebbe la pena di esplorare.
Ma per tornare alla linearità, come sottolinea WM1, le autorappresentazioni identificate come narrativa del precariato e improntate alla rottura della linearità narrativa raccontano un eterno presente rompendo con la memoria storica, ed è il punto di vista di una classe media impoverita e precarizzata che non si ritrova nella narrazione lineare della vita dei genitori e che con essi entra in contrasto, dando vita a questa “guerra generazionale” di cui leggiamo ogni giorno. Le esperienze narrative che intendono invece recuperare la linearità partono proprio dalla coscienza di appartenere a un sostrato molto più ampio rispetto alla situazione attuale, mettendo in atto una conseguente operazione di recupero della memoria. Per citare WM1 “quel che manca in molte narrazioni del precariato è, azzardo, la buona vecchia coscienza di classe. E’ la coscienza di un “lignaggio” proletario che permette ad Alberto di confrontare due storie lavorative (la sua e quella del su’ babbo) senza mettere una generazione contro l’altra.” Questa è la chiave di lettura decisiva nel processo di ripristino della linearità, che si ritrova per esempio anche nell’ultimo romanzo di uno dei fondatori del collettivo Scrittori Precari, Simone Ghelli, Voi, onesti farabutti. Il romanzo di Ghelli sviluppa una variante del mitologema della morte del Vecchio, cioè quello della conversazione o dialogo incompiuto col Vecchio, il nonno, conversazione che coincide con la necessità di ricostruire una memoria che sia personale e di classe al contempo. Credo che l’attuale orientamento della narrativa del precariato sia proprio quello di creare opere “che mettano in collegamento i precari di oggi con la classe operaia di ieri” (WM1), non solo operaia a dire il vero, ma in genere con la categoria dei lavoratori salariati di ieri e oggi, nella coscienza che non giova a nessuno fare un discorso di classe. Questo aspetto lo avevo indagato un paio di anni fa in un articolo su PrecarieMenti che partiva proprio da un commento di WM1 su Giap!, in cui si leggeva “Manca la narrazione che accomuni, perché per decenni si è portata avanti solo la narrazione che divideva”. In quell’articolo tentavo di contestualizzare quella affermazione, che rimane valida oggi più che mai. Quello che la narrativa del precariato è chiamata a fare e sta facendo è allargare il discorso sul recupero della memoria in netta antitesi al discorso dominante della guerra fra generazioni e fra classi, una tendenza peraltro cavalcata dai media e da certi movimenti (penso a TQ, il cui fallimento risiede proprio nel non avere saputo creare un ponte narrativo fra generazioni, ma nell’insistere in un corpo a corpo che non giova a nessuno e che in ultima analisi non è altro che una lotta intestina al mondo intellettuale per il passaggio del testimone, cosa che col tema del lavoro precario ha poco a che fare, mentre molto ha a che fare col tema del potere).
Ringrazio tutti per la splendida opportunità di ampliare il discorso, un abbraccio. Claudia B.
Purtroppo non è apparso il link all’articolo che richiamava il discorso sulla narrazione che accomuni, lo posto qui: http://precariementi.wordpress.com/2010/11/22/appunti-per-una-narrazione-che-accomuni-3/
Vorrei che a rispondere fossero anche i giapster, oltre che me, però devo riprendere un paio di cose del commento densissimo di Claudia. Lo faccio davvero velocemente, primo perché mi duole un po’ il polso e secondo perché vorrei che anche altri lettori estendessero i cerchi dei sassi lanciati nello stagno.
__mi sembra interessante quel che scrivi sul suicidio degli imprenditori. Siccome sono un sanguinario senza cuore il mio primo pensiero è stato al capitale che si estingue in nuove impensate vie, ma poi ho pensato al fatto che il capitalismo, come nocività, è un cancro che mangia (anche) se stesso. Su questo punto dobbiamo riflettere. La narrazione moderna di questo fenomeno ci offre nei talkshow il pietismo verso i ricchi, invece questi suicidi vanno raccontati come un atto di antropofagia o una forma di entropia o una morte cellulare del capitale.
_l’ancoraggio storico della narrazione è sicuramente lo scarto che mi motivava rispetto alle tante offerte narrative che raccontano il precariato sotto l’ombrello di un “pensiero debole”. Ma non era una cosa poi davvero pensata: era vissuta (per questo parlavo di alberi e semi), era introiettata. In certo modo aveva basi quasi biologiche, più che teoriche. Poi a livello più consapevole va detto che anche come lettore non amo affatto il minimalismo di tanti racconti brevi americani e sono critico di certo postmodernismo. Anche per questo che dici tu non ho mai pensato di far circolare i miei racconti sui vari lavori precari che ho fatto (se ne trovano alcuni comunque su Carmilla, altri stanno nel cassetto). Sento il bisogno di incorniciarli in una cornice critica forte, piuttosto che darli in pasto al primo editor di passaggio. Quindi mi sono astenuto dal pubblicarli, perché il trend è quello di convertire il racconto del precariato in raccontini minimali e le indagini sociali in un noir con i poliziotti scomodi. A volte si è visto qualcosa di buono, ma poi alla lunga il gioco stanca (e Amianto non è un noir, maremma sgarganata… “se fosse un noir”, scrivo, “sarebbe uno di quelli in cui si capisce subito il nome dell’assassino…”).
Poi commento di Claudia merita ben più attenzione di queste mie poche righe… intanto passo il testimone a chi voglia raccoglierlo.
Rispondono, stai tranquillo :-) La conversazione è una bella sleppa, e se ci metti i relativi link, per leggerla e metabolizzarla ci vuole tempo. Infatti in diversi da ieri sera hanno aperto la versione stampabile o fatto il download in ePub. Aggiungi che molti non hanno ancora potuto leggere il libro e, prima di intervenire, giustamente vorranno farlo.
Ci sono delle cose che non mi sono chiare. Prima si afferma che il simbolico ha un valore disgregante sul detentore del capitale e molto meno sul lavoratore precario, ma poi si aggiunge che il precariato ha vinto… su chi? Il capitalista? Il lavoratore? Se si parla di simbolico riferendosi alla sicurezza identitaria che il capitale fornisce e infine sottrae al suo detentore, trovo che anche i lavoratori subiscano questa perdita di identità a causa della precarizzazione, e in misura maggiore dei capitalisti. Tant’è vero che si è parlato di precariato dell’esistenza nell’articolo e che il disagio di cui si lamentano maggiormente i precari non è solo quello economico, ma è proprio la perdita di identità collegata alla perdita di uno scopo e di un futuro.
C’è talmente tanta roba in questa bellissima conversazione che secondo me potrebbe uscirci un secondo memorandum… :-)
Quanto alla narrazione del precariato, penso che siano serviti anche i frammenti (un po’ come i bozzetti per il pittore) per mettere a fuoco un universo disgregato come è stato quello degli ultimi vent’anni… Reiterare il gesto sarebbe puro manierismo, ma per fortuna ci sono scrittori come Alberto che hanno iniziato a fare il lavoro grosso – da questo punto di vista rimango dell’opinione che “La dismissione” di Ermanno Rea sia un libro capitale all’interno di questo processo di scavo, che è anche un mettere in connessione piani diversi (e qui mi sembra molto pertinente e interessante il discorso di Claudia intorno al “fare comunità”).
Leggendo questa conversazione ho provato sentimenti contrastanti.
Da un lato mi sono identificato moltissimo nella prima parte, nella minuziosa descrizione delle esperienze di vita, dei disagi e soprattutto della condizione esistenziale di chi si ritrova precario, senza un futuro, in un eterno presente e, talvolta, orfano di un passato (perlomeno politico). Da qui la voglia di bestemmiare, come diceva Guccini, ma anche quella di condividere quella parte di sè che raramente si riesce a tirar fuori, ma che preme per un confronto, un rispecchiarsi nell’altro, una ricerca di stimoli e dritte per andare avanti. Ma dopotutto qui mica stiamo al bar, né sul lettino dello psicanalista, quindi mi rimangio tutto e sto zitto.
Dall’altro lato però questa voglia di condividere è evaporata quando sono arrivato al punto sui suicidi degli imprenditori, che mi è sembrato uno scivolone evitabile. Considerazioni di questo tipo mi aspetto di trovarle sui siti di gossip, dove fra i commenti degli utenti sono all’ordine del giorno. La frase tipo è: “Vorrei vederlo/la andare a lavorare in fabbrica 8 ore al giorno, da precario a 500 euro al mese, e poi vediamo se si lamenta ancora tanto! (sèguito di insulti che variano in base al sesso del VIP di turno).” Questo accade sempre a prescindere del contenuto dell’articolo e dall’identità del personaggio ed è solitamente motivato dalla frustrazione sociale di chi scrive e vede nella celebrità un colpevole in quanto tale e un’ottima valvola di sfogo per la propria rabbia repressa. Non sto dicendo che le considerazioni fatte qui su Giap siano esattamente la stessa cosa, ma di sicuro ci ho ritrovato la stessa marca di demagogia, che non mi aspettavo visto che nel resto dell’articolo e del blog il profilo è molto più alto. Sminuire la morte di un imprenditore solo perché ne parlano i giornali “del Capitale”, mentre degli operai no (in realtà negli ultimi anni nei media si parla di morti sul lavoro in maniera decisamente maggiore rispetto a prima), come se questo fatto fosse imputabile al suicida stesso, mi sembra piuttosto avvilente. Addirittura mettersi a fare la contabilità dei morti (“quanti sono poi, uno ogni due mesi?”), come quelli che fanno a gara fra chi ha ammazzato più gente, il fascismo o il comunismo… come se un morto ogni tre per due contasse di meno, tanto era un imprenditore, uno che stava dalla parte dei kattivi. Soffriamo di pietà selettiva?
Allora fatemi chiarire una cosa, tanto per prevenire le obiezioni. Non si tratta di facile pietismo, di mettere tutto sullo stesso piano, si tratta di saper scindere i piani di osservazione. Non sto dicendo che un operaio e un imprenditore siano la stessa cosa sul piano sociale. Sono ben consapevole che i loro interessi sono contrapposti all’interno del capitalismo. Quel che non accetto è l’uso manicheo della lotta di classe per disumanizzare l’avversario politico e svalutare il valore della sua vita per renderla sacrificabile, principio che, tra l’altro, sta alla base dell’agire di certe devianze politiche come il brigatismo. Non credo sia necessario arrivare a questo per conservare la consapevolezza delle differenze sociali. Conosco sulla mia schiena di precario l’ottusità, l’ignoranza, l’arroganza, i soprusi, l’avidità e la tendenza allo schiavismo di certi piccoli imprenditori del glorioso e operoso nord-est in cui vivo. Ma allo stesso tempo non trovo sia molto di sinistra annullare le differenze, tanto che nessuno riuscirà mai a convincermi che sia la stessa cosa parlare di un Agnelli, un Benetton, un De Benedetti, e di un imprenditore con la terza media che, senza neanche sapere un cazzo di cosa sia la lotta di classe, abbia deciso di aprire un’attività assumendo una manciata di persone per lo spirito di creare e produrre qualcosa (magari ingenuamente, senza sapere le dinamiche sociali che questo comportava, ma anche senza molte alternative, dato che chi vive nel sistema capitalista è costretto a piegarsi alle sue regole) e un giorno si sia trovato a buttarsi dal quarto piano o a piantarsi una pallottola in testa perché una banca, insomma uno squalo vero, gli ha pignorato anche la casa e gli piangeva il cuore di disperazione perché aveva perso tutto ed era stato costretto a lasciare senza reddito anche quella manciata di dipendenti, con cui magari nel frattempo aveva stabilito addirittura un rapporto umano (non perché non può più gocare a fare il padrone…). Vi assicuro che dalle mie parti gli esemplari del secondo tipo sono molto più frequenti degli Agnelli e dei Benetton e, anche se stanno dalla stessa parte della barricata, in buona o cattiva fede, per me non saranno mai la stessa cosa.
Forse parlo così perché sono uno di quelli che non hanno avuto il padre operaio o contadino, ma solo mediocre impiegato piccolo borghese senza coscienza politica. Questo è sicuramente un handicap, lo dico senza ironia, ma forse mi permette anche di avere una prospettiva meno legata a certi pregiudizi da “razzismo di classe” e di vedere anche l’essere umano dietro l’avversario politico. Poi possiamo parlare quanto volete di autodistruzione del capitale e teorie varie, che poi sono discorsi che risalgono a “i capitalisti ci venderanno la corda per impiccarli” e altre profezie che tardano ad avverarsi.
Chiuso il pistolotto, per il resto ho apprezzato l’aver corretto il tiro su Saviano (no pun intended), visto che le posizioni assunte da Wu Ming in precedenza mi avevano lasciato alquanto perplesso (ma risalevano anche a diverso tempo fa, in tempi meno sospetti).
Mi interessa molto anche il discorso sulla morte del Vecchio e, soprattutto, mi preoccupa, perché come è stato detto nella discussione per motivi diversi, è ormai riduttivo parlare di generazione. Se voi vi sentite orfani, i miei coetanei e quelli più giovani di me si sentono come i sopravvissuti a un olocausto nuclear-politico-sociale. Non dico che potrei essere vostro figlio (forse dei Wu Ming più “anziani” sì) ma sicuramente un vostro fratello molto minore sì, e mio fratello che ha sette anni in meno di me non si trova certo in una situazione diversa o migliore della mia. Quello che voglio dire è che il mio timore è che il lutto sia diventato cronico, che il futuro e il passato siano scomparsi per benino, che lo rimarranno chissà per quanto e che il famoso atto fondativo non si sa se e quando arriverà. Insomma, è una fase o un mutamento antropologico?
Dovic, una curiosità: nel nord-est è distribuito “Il Vernacoliere”? Lo chiedo perché ho il sospetto che ci sia stato un piccolo clash culturale… Ad ogni modo, hai fatto benissimo ad esprimere e spiegare il tuo disagio. Io credo che sui suicidi degli imprenditori abbia scritto cose molto interessanti Claudia Boscolo nel suo commento.
Faccio solo una precisazione su Saviano: già quattro anni fa, nel mio testo “Wu Ming / Tiziano Scarpa: Face Off” (che a dispetto del titolo era in larga parte dedicato all’analisi del caso Gomorra/Saviano), io separai completamente i destini di “Gomorra” (che va ritenuta a tutti gli effetti un’opera collettiva) da quelli dell’individuo Saviano, e in polemica con Scarpa e Benedetti che secondo me su di lui continuavano ad avere le traveggole, iniziai a descrivere il funzionamento della macchina mitologica che stava trasformando uno scrittore in un simbolo congelato.
Due anni fa la redazione di Carmilla scrisse:
«il fatto che Saviano abbia preso posizione contro l’uso della forza (della “violenza”) da parte del movimento mentre il suo libro andava allo scontro con la polizia, è una contraddizione interessante. Contraddizione che ha avuto almeno una ricaduta positiva: ha chiarito a molti che non si possono – non si devono mai – confondere autore e opera, opera e chiacchiera mediatica, scrittore e “io narrante”, scrittore e simbolo. Cosa che da queste parti ci siamo sempre sforzati di spiegare, contro le pseudo-analisi e gli scatti rabbiosi di chi “butta tutto nel mucchio”. “Desavianizzare Gomorra” è uno slogan che risale addirittura al 2006.»
Zì, zì, so bene che voi non avete mai condiviso Saviano su tutta la linea, nel commento precedente non avevo approfondito non era il tema principale dell’articolo. Quello a cui mi riferisco è che mentre nel 2006 Saviano era visto da voi soprattutto come vittima, strumentalizzato, impossibilitato ad agire diversamente, adesso mi sembra che finalmente si dia una certa rilevaza anche alla responsabilità individuale, ai tornaconti personali, alla possibilità di sfruttare a proprio vantaggio quel meccanismo per fare il VIP e il “santo laico”. Il che, lo sottolineo, non cancella le strumentalizzazioni, le minacce, la scorta ecc., ma nemmeno esclude tutto il resto.
Comunque ti ringrazio per il primo dei due link perché mi porge il destro per esprimere meglio la questione sugli imprenditori. Mi ha colpito molto la citazione di Dinoi riguardo alla Shoah:
“…invece che veicolare la singolarità della vittima, la specificità dello spazio e delle torture e dell’evento, le immagini dai campi assunsero nella grande maggioranza dei casi il valore di testimonianza dell’orrore universale.”
“Il simbolo allontana l’esperienza, contiene la dirompenza dell’evento. Il simbolo, anche quando non sembra, è consolatorio. Quei capannelli o ammassi di corpi scheletrici non generano empatia, perché nell’ammasso (…) svaniscono le storie singole.”
Fatte le dovute distinzioni e proporzioni, credo ci sia una forte analogia fra queste considerazioni e il modo di trattare i suicidi degli imprenditori. Anche in questo caso la storia letta sul giornale diventa simbolo, ma non più di una delle tante vittime, dell’orrore universale, come nel caso degli ebrei, ma al rovescio del capitalismo padronale, di uno dei tanti padroni uguale a tutti gli altri, la cui vita si perde fra le pieghe della statistica. Anche qui si annullano le differenze, si svalutano le storie singole, si finisce per disumanizzare.
Per quanto riguarda il Vernacoliere, non ho idea se arrivi fino a qui… a quale clash culturale ti riferisci?
Mi riferisco al fatto che sul “Vernacoliere” di Cardinali si leggono spesso cose ben più “violente” di quella che ha scritto il Prunetti. E’ una cifra di umorismo acido, amaro e molto nero fortemente presente nella cultura popolare livornese e in generale toscana. E poi, la fantasticheria chiliastica di rovesciamento sociale (il “mondo alla rovescia” coi padroni che lavorano e i poveri di ieri che gli pisciano addosso) è da sempre presente nella cultura delle classi subalterne, tant’è che è all’origine del carnevale. Se agli spossessati togli anche quello, non gli lasci davvero un cazzo, ecco.
Nulla da eccepire sull’umorismo popolare, anche quando violento. Ci mancherebbe. Le mie considerazioni però vertevano su qualcosa che non credo avesse connotati umoristici né alcun intento di rovesciamento (mi riferivo in particolare all’ultimo intervento nella discussione da parte di Prunetti). Se poi ampliamo il discorso fino a includere anche la satira popolare mi sa che rischiamo di cacciarci inutilmente in un ginepraio.
“Amianto” finisce proprio con un’immagine del “mondo alla rovescia” mediato da una citazione di Luciano Bianciardi, un topos ben affermato già nel medioevo (assieme a quello della danza macabra) e che arriva per rivoli millenaristi fino agli orgasmi di un mondo nuovo sviluppatisi nella seconda metà del novecento (penso al libro di Galeano). Rovesciare il mondo e cambiare l’ordine della vita e della morte. Dalle eresie millenariste alle rivolte contadine fino agli spasmi anticapitalisti del presente. Son storie e cornici narrative che chi frequenta Giap dovrebbe conoscere bene, mi sorprende che qualcuno se ne scandalizzi.
Eheh, vabbè, adesso ci facciamo depositari della tradizione che tutto giustifica e tutto nobilita ;-) Sono studente di lettere, figurarsi se mi sorprendo o mi scandalizzo di fronte a questo genere di cose.
Ma come ho già detto a Wu Ming, tutto il commento era principalmente una risposta a questo:
“Ora si parla dei suicidi degli imprenditori. Se noi ci ammazziamo (e penso a Bonavita) è per l’urgenza di una vita che ci hanno rubato. Se i padroni si ammazzano (quanti sono poi, uno ogni due mesi?) è perché sono vicini al fallimento, cioè non possono più giocare a fare i padroni… sai che non mi commuovono tanto quanto quei tre operai che ogni giorno muoiono ammazzati in Italia, costretti a un lavoro nocivo e pericoloso? I sedicenti imprenditori sono stati i rappresentanti mandatari del capitalismo e ora che la loro impresa assassina si dimostra per quel che è (una campagna armata, una guerra di classe contro la vita e la terra….) ora che non c’è più né terra né sangue da succhiare, ora vorrebbero anche la mia compassione?”
Qui non mi sembra c’entri Bianciardi, danze macabre o mandragole, mi è sembrata una semplice sparata da bar, ma forse mi mancheranno gli strumenti per cogliervi il sublime. Perché l’ho giudicata una visione facile e manichea poi credo di averlo già spiegato ampiamente. O mi state dicendo “eh, ma io stavo scherzando!”, “sono stato frainteso!”, “non l’ho detto io, era citazionismo!” o altre menate postmoderne? Per quanto riguarda il resto, se volete far spalare la merda ai padroni e pisciare negli altiforni, ditemelo che porto le bottiglie, per farne in copiosa quantità.
Ah, ti riferivi a questa orrenda pagina sanguinaria.. la riscriverei cento volte e anche sotto la sede della Confindustria. Se ti basta la possiamo chiudere qui.
Dovic, lo sai anche tu che quel passaggio lo stai citando monco, perché poi proseguiva con una classica, bachtiniana immagine da “mondo alla rovescia”, questa:
“Vengano a vivere al Cotone di Piombino o a Tamburi, vengano a viverci alla paga di un tubista di quarto livello e i soldi che risparmiamo sui loro stipendi vadano a bonificare totalmente i loro veleni… forza padroni, sveglia, al lavoro, otto ore ogni giorno a ripulire la cokeria, con la pala e il muletto, mentre noi, operai e operaie, figli e figlie di operai, lavoratori precari della conoscenza e commesse, disoccupati e cassaintegrati, professori sotto concorso a sessant’anni e casalinghe, immigrati e traduttori con la tendinite, pisceremo negli altiforni e spengeremo quel fuoco che ci ha devastato la vita.”
I traduttori con la tendinite che pisciano nell’altoforno è puro carnevalesco. E ce ne fossero di più, di fantasticherie utopiche come questa! Sono il sale dell’azione rivoluzionaria.
Se continuiamo così non caviamo più un ragno dal buco, sblocchiamoci, dài.
@Wu Ming 1
Beh, l’ho citato monco perché quella era la parte che contestavo, al resto ho fatto riferimento alla fine dicendomi peraltro d’accordo. Posso distinguere o anche qui devo prendere tutto in blocco?
Prunetti rivendica pure quindi mi sa che resteremo ognuno con le nostre opinioni. Se quel pezzo lo leggesse un parente di uno di quei padroni che si sono ammazzati, vorrei vedere se lo prenderebbe per una boutade satirica o per un attacco di chi valuta il suo lutto come un sicario del capitalismo in meno da mantenere. Perché qui stiamo parlando di persone che neanche conosciamo ma che sono morte davvero, non di Rockefeller o di qualche entità politica astratta che esiste solo sui giornali.
Comunque accolgo l’appello che fai più sotto, adesso piacerebbe anche a me sentir parlare d’altro.
Solo per la precisione: io non ho mai usato il concetto di “satira”, che secondo me è abusato e deresponsabilizzante. Semmai ho parlato di humour nero (negramaro!), e di carnevale (che è, letteralmente, una “rivolta”, un capovolgimento).
Che tra i piccoli imprenditori che si suicidano vi siano anche persone a loro volta strangolate da un capitalismo che li ha prima illusi col credito facile poi si è rivelato un sistema vampiro e cravattaro (cosa che i lavoratori già sapevano) è un aspetto tragico che però si pone *a latere* del discorso di Prunetti, perché Prunetti è portatore di un altro punto di vista, scrive da un altro punto d’osservazione, calato in un’altra condizione. Sono due piani diversi.
Inoltre, quello del “parente dell’industriale suicida che leggendo ci rimarrebbe male” è, oltre che un’ovvietà che poco aggiunge, anche un non-argomento che odora un po’ di ricatto morale, e mi sembra pericoloso ricorrervi, perché è troppo facile estenderlo per interdire qualunque cosa. Pure la mamma di Marchionne probabilmente ci rimane male quando dai cortei partono insulti diretti al suo figliolo.
Davvero, non caviamo un ragno dal buco, forse perché hai cercato di argomentare razionalmente un passaggio che ti ha urtato emotivamente, e non sempre è possibile (o giusto) farlo.
Quello del parente è stato un esempio sbagliato, che voleva intendere qualcuno che quelle persone le conoscesse davvero e fosse in grado di giudicarle in base al loro operato, alla loro vita, non solo in base alla posizione sociale. Amen.
Dovic, in tutta franchezza questa citazione da Lo sguardo e l’evento è fatta un po’ a cazzo di cane.
In quel passaggio, Marco Dinoi si riferisce alla presunta trasparenza delle immagini mediali, riprendendo una problematica già affrontata dalla Sontag in Davanti al dolore degli altri: un’immagine per essere significativa ha sempre bisogno di una didascalia.
Alberto di didascalie te ne ha offerte molte. Tu puoi scegliere di non leggerle.
(quasi un off topic) quella di Marco Dinoi è una morte che mi ha fatto piangere. Tra l’altro rideva come pochi alle cazzate che io sparo a iosa appena mi siedo a tavola col vino. Basta perché non voglio tirar su altri ricordi tristi… ma cosa darei per averlo con noi a discettare di queste faccende… basta così, non portiamola più avanti…
Dimitri, la citazione l’ho presa dal testo che mi ha linkato Wu Ming, non conosco il libro originario e mi è servita solo come spunto per precisare la mia opinione. Non c’era nessuna intenzione di fedeltà al testo, solo di servirsene per precisare il mio ragionamento, il che non credo ne pregiudichi la validità.
Con Prunetti poi ci stiamo già chiarendo per benino, quindi don’t worry.
@Dovic, mettiamola così… io potevo scrivere questo libro dicendo “o povero me, m’hanno ammazzato il babbo in fabbrica”… ora, c’è anche una sentenza che dice qualcosa al riguardo, ma non l’ho fatto, non volevo buttarla sul piagnone e prendere scorciatoie emotive come hai fatto subito tu… però sappi che è controproducente che tu parli a me di lutti capitalisti perché io non ho voluto buttarla sul lacrimoso neanche per il mio lutto, che era un lutto operaio.. per questo non mi commuovo neanche per gli imprenditori. Sarebbe facile farti presente che l’ultima persona a cui dovresti fare un ragionamento sul “lutto offeso” sono io, dal momento che io non so se tu hai parenti/amici/conoscenti imprenditori suicidati, ma io ho di sicuro avuto un babbo operaio iscritto all’associazione mutilati e vittime del lavoro, esposto da padroni (imprenditori) all’amianto per 15 anni, 9 mesi e 21 giorni secondo il Tribunale del lavoro di Firenze e i padroni lo sapevano e se ne fregavano. Non si è ammazzato da solo, per la crisi, lo capisci? E i babbi di molti miei amici sono ammalati per malattie professionali riconosciute dall’Inail e sono tutti molto mal disposti con i padroni. Ora, io non voglio cascare in questa struttura retorica così lacrimosa, strapparmi i capelli in pubblico e dire povero me, che cosa mi hanno fatto… però sono qui su Giap per parlare di un libro che parla di operai ammalati e morti sul lavoro…. io di imprenditori morti suicidi non ne ho mai conosciuti perché non li frequento neanche da vivi, non ho contatti in quei ceti e quando mi ci avvicino è solo nei panni di lavoratore e non si aprono granché con me sui loro problemi personali. Se ti va leggiti il mio libro così parli a proposito, se non l’hai letto e non vuoi farlo lascia stare perché perdi tempo tu e io. Se il tema degli imprenditori in crisi per qualche ragione lo conosci da vicino e ti affascina più di quello degli operai ammalati, dacci dentro e scrivici sopra, la Boscolo ha dato delle idee di base interessanti su cui lavorare. Però continuare così è una perdita di tempo e non porta a niente, né per te, né per me, né per gli altri giapster. Spero di essere stato chiaro.
Ogni tanto qualcuno si lamenta per i commenti “nidificati”, e invece servono, altroché se servono. Perché quando si prolunga uno scambio tra due o tre persone, e capita di accanirsi, comunque resta un sottodibattito a latere, ben distinto dal resto. Chi non è interessato può scorrersi il troncone principale del thread senza dover per forza seguire la digressione.
Chiarissimo. Comunque io non ho nessun parente, amico o conoscente che sia riconducibile a un imprenditore che si sia ucciso, parlo esclusivamente in base ai miei convincimenti personali e non ho nessun coinvolgimento emotivo né partiti presi da difendere. Tanto perché sia chiaro anche questo.
Anche a me il passaggio sui suicidi degli imprenditori non è piaciuto. Lo dico da persona che sa di non avere coscienza di classe e da perfetto ( magari idiota ) beneficiario del “sistema” attuale. Però non si è solo criticato l’uso che si fa dei suicidi a livello mediatico. Si è parlato in maniera se non disumanizzante, comunque non precisa. Si è parlato indistintamente di padroni, al di là dello sfogo satirico. Si è risposto all’uso sbagliato dei media con un modo altrettanto sbagliato di porre la questione.
@Dovic, la questione delle morti sul lavoro è un tema fondamentale di cui non si parla come e quanto si dovrebbe. E’ un genocidio che ha tinte selettive di classe da decenni e le cose peggiorano statisticamente quando il pil sale e migliorano quando c’è più disoccupazione (a indicare dove sta il problema e chi ci guadagna su queste morti). In genere si dice che muoiono almeno tre persone al giorno (di solito lavoratori stranieri assunti in nero, e questo ormai da lustri), ma sono dati che vanno riletti al rialzo (i contadini che muoiono sotto il trattore rovesciati sono contabilizzati come incidenti automobilistici). Io sto solo dicendo che non casco nella macchina emotiva messa in moto dai media per darci l’immagine di una crisi pagata dagli imprenditori. Mi spiace. Il capitale è la crisi e la crisi c’era anche nel 1983, solo che la pagavano solo quelli che erano in disoccupazione perché chiudevano le raffinerie. Il fatto che io non mi commuova per gli imprenditori è perché le mie lacrime le ho già piante quasi tutte e quelle rimaste me le conservo per i fatti miei e per i compagni e non abbocco ai servizi del tg. Non disumanizzo l’imprenditore. Non bisogna farmi dire qualcosa che non ho detto per poi avere una scusa per criticarmi. Tu piangi tutti quelli che muoiono? Il mio compianto va alle ceneri dei compagni e dei subalterni: a questo alludevo, se devo metterlo in forma più nobile e meno ‘gnorante (leggiamolo il Vernacoliere, come dice Wu Ming1). Gli imprenditori si disumanizzano da soli quando abbandonano in un campo i manovali feriti o li assumono solo dopo che si si fanno male come se fosse il primo giorno di lavoro. Inoltre, e l’ho ribadito rispondendo a Claudia Boscolo, io stavo parlando di una disumanizzazione creata dal Capitale che ci spinge oltre la nostra umanità nel nome del profitto, creando ferite fisiche e psicologiche, anche negli imprenditori (che però intanto ci hanno guadagnato genuflettendosi all’altare del mercato, mica stanno nel quartiere Tamburi loro, ma nelle villettine sui colli). Il riferimento qui era a J. Camatte, per chi voleva coglierlo (un teorico francese che lega la critica al capitalismo con elementi quasi biologici dell’evoluzione umana). E’ un discorso umanissimo il mio (ora non cominciamo a fare il gioco retorico di dire.. .”ah, ma così disumanizzate il nemico… il prossimo passo è la giustificazione degli assassini…”. Ohimmena: basta riparlare di classe e capitale che si alzano questi scudi retorici, che palle). Quanto poi alle piccole imprese italiane a conduzione familiare, io ci vedo poco di idilliaco: a me risulta che siano quelle in cui compare anche statisticamente il massimo di lavoro nero e quindi di infortuni sul lavoro non risarciti. Peggio dell’Ilva di Taranto? Forse. Bisognerebbe dare uno sguardo a “Lavorare uccide” di Marco Rovelli, uscito pochi anni fa. Ne parla di ‘sta roba.
Il fatto è che per me sminuire la morte di qualcuno identificandolo totalmente con il proprio ruolo sociale è disumanizzante, che lo si dica esplicitamente o meno, non serve mettere in bocca le parole perché ciò sia vero. Allo stesso modo credo sia possibile non buttare tutto nel mucchio e allo stesso tempo evitare di credere che “la crisi la stanno pagando tutta gli imprenditori”. Io non difendo affatto la classe imprenditoriale in quanto tale, ma: tutti gli imprenditori che si ammazzano hanno abbandonato i loro dipendenti agonizzanti sul margine di una strada? Cercare le differenze significa per forza stare dalla parte dei padroni? Significa automaticamente ignorare o mettere sullo stesso piano sociale le sofferenze subite dai lavoratori? O significa soltanto cercare di restituire a ogni storia la propria perculiarità, positiva o negativa che sia? Ma questo purtroppo sembra essere un vizio ricorrente in questa parte politica, quando si tratta di lotta di classe si taglia sempre tutto in due con la mannaia e o sei pro o sei contro. Se per te cercare di andare oltre questa logica e trovare piani alternativi significa solo alzare scudi retorici non ci posso fare niente, a me invece sembra doveroso.
@Dovic Ma infatti ne intendo l’importanza e la Boscolo ne ha sollevato un’interpretazione. Io non ho esultato per la morte degli imprenditori: ho detto che non voglio abboccare ai meccanismi retorici e narrativi dei media che stanno risemantizzando in chiave patemica quelle morti inducendo una commozione funzionale alla tesi per cui la crisi la pagano tutti allo stesso modo (quindi non fate casino perché anche i padroni di questi tempi se la vedono brutta e non lamentatevi). Non abboccare è un modo per restituire alle morti dei cosiddetti imprenditori il loro significato più proprio. Ho anche tentato di fornirne un’interpretazione, parlando di uscita dall’orbita umana indotta dal capitale, e meglio di me ha fatto la Boscolo. Non sono io a disumanizzare gli imprenditori: è il profitto (che appunto disumanizza anche gli operai e i precari, prima con lo stress, poi con le malattie e la morte). E quando un impr.. un padrone si trova davanti allo specchio e si rende conto che venti-trenta anni di profitto e individualismo lo hanno reso senza amici, senza relazioni di solidarietà, senza compagni (che a noi non mancano), che la sua famiglia altro non era che una piccola azienda e che per giunta sta fallendo… è un casino.
PS: mi suona male usare il termine “imprenditori”, io preferisco chiamarli padroni, quando lavoravo in una simpatica ditta a conduzione familiare il mio “imprenditore” si faceva chiamare padrone dagli “amici” che aveva assunto in nero.
Ma infatti sulla strumentalizzazione di queste storie da parte dei media sono pienamente d’accordo, chi consapevolmente e sano di mente valuterebbe più di un soldo bucato l’affidabilità di giornali e telegiornali? Diciamo che per evitare questi tranelli tu ti sei concentrato sul riconsiderare queste morti in contesto di lotta fra classi, io invece sulla differenziazione fra storia e storia, per restituir loro una dimensione umana e più “empatica”. Ma alla fine i due approcci si possono conciliare.
Fammi leggere meglio sto scambio con la Boscolo…
Ci sono delle cose che non mi sono chiare. Prima si afferma che il simbolico ha un valore disgregante sul detentore del capitale e molto meno sul lavoratore precario, ma poi si aggiunge che il precariato ha vinto… su chi? Il capitalista? Il lavoratore? Se si parla di simbolico riferendosi alla sicurezza identitaria che il capitale fornisce e infine sottrae al suo detentore, trovo che anche i lavoratori subiscano questa perdita di identità a causa della precarizzazione, e in misura maggiore dei capitalisti. Tant’è vero che si è parlato di precariato dell’esistenza nell’articolo e che il disagio di cui si lamentano maggiormente i precari non è solo quello economico, ma è proprio la perdita di identità collegata alla perdita di uno scopo e di un futuro.
Non so, provo a copiare questa parte anche sotto il commento della Boscolo e vediamo se può chiarirmi le idee.
Per quanto riguarda il termine “imprenditori”, ha sicuramente un’accezione pro-capitalista (l’impresa è eroica per antonomasia). D’altro canto “padroni” ha un suono decisamente vetero, ma l’importante è intendersi sul significato :)
Proviamo a far “decantare” quest’aspetto specifico e a tornarci sopra a mente fredda? A me, e immagino non solo a me, piacerebbe vedere il dibattito muoversi anche in altre direzioni.
Ad esempio, in fondo al suo primo commento Dovic ha parlato dell’impossibilità di immaginare atti fondativi, e della “cronicità” di questa condizione. Ecco, questo stato d’animo generale è un’incubatrice di mostri, perché un orfano che sia orfano di tutto e in primis della fiducia nella possibilità di fondare è potenzialmente disponibile a ogni avventurismo reazionario, a gettarsi tra le braccia del primo Lui che si travesta da fondatore e finga di colmare il vuoto, di curare i traumi dell’anima precaria maltrattata e disperata. E’ quello che ha scritto poco tempo fa Giuliano Santoro su Dinamo Press a proposito del grillismo:
«Tornano dalle trincee della grande guerra che il capitale ha dichiarato al lavoro i soldati dell’esercito precario. E molti di loro si sono messi, disciplinati e ipnotizzati, in fila ad applaudire i comizi-spettacolo di Beppe Grillo. Sono abituati all’orrore dello sfruttamento flessibile e dell’impossibilità di progettare il futuro. Abituati a farsi maltrattare, tanto da trovarsi a loro agio nel grillismo proprio per il fatto che chi tira le fila e possiede il logo dei 5 Stelle (il famigerato “Staff”, termine che non a caso viene dall’universo aziendale) maltratta, mobbizza, espone al pubblico ludibrio, mette in concorrenza tra di loro i militanti.»
Io non lo so com’è la realtà statisticamente, io vedo solo la realtà che conosco, ad esempio quella di mio padre che aveva un’aziendina in cui lavorava lui, mia madre e mio fratello e zero dipendenti. E zero villettine soprattutto, solo la casa che si era comprato indebitandosi e che gli hanno pignorato quando poi l’azienda è fallita. E io lo so che i miei ci hanno pensato di farla finita, e so anche (perché io c’ero e posso dirlo, a differenza di Claudia Boscolo che pare abbia psicanalizzato a distanza tutti gli imprenditori suicidi) che ci hanno pensato perché erano disperati, e non sapevano se avrebbero avuto ancora un tetto tra una settimana o un mese per loro e per me che ero minorenne. Altro che disagio a livello simbolico… E mo’ scopro che in quanto imprenditore, mio padre era un *padrone* (di che? di una casa ipotecata?) e quindi gli sta bene. Ok. Però c’è una cosa che mi sfugge: la scelta possibile quindi è solo tra lavoratori sfruttati e padroni sfruttatori? Uno non può cercare di avviare un’attività, e diventare quindi per la legge imprenditore, senza passare dalla parte dei cattivi? (a parte che pure te se diventi coltivatore diretto, il codice civile ti definisce piccolo imprenditore, quindi – secondo i tuoi canoni eh – sempre un pezzo di merda saresti, per quanto piccolo). Penso anche a una mia amica che ha fatto la segretaria sottopagata per dieci anni e ora ha rilevato un bar con una socia e è diventata imprenditrice pure lei; ha fatto un sacco di debiti e l’inizio è faticoso. Se le va male se lo merita perché è passata dalla parte dei padroni? Doveva restare a fare la schiava? Cercare di migliorare la propria personale condizione, non solo in termini economici ma anche di soddisfazione, lavorando per se stessi e non per gli altri, è antitetico alla coscienza di classe? Al di là di quanto possa sembrare acida (scusami, ma hai risvegliato un mostro di rabbia e senso di ingiustizia che dormiva da una decina d’anni) sono interrogativi che mi pongo seriamente.
Bisognerebbe fare una riflessione sui processi che hanno obbligato i traduttori precari a aprire partita iva e a “diventare imprenditori” (quando invece sono cottimisti della parola) o i piccoli artigiani che magari hanno una officina e che sono “diventati imprenditori” (e ora sono in crisi e si sentono rovinati). O i pastori e contadini che vengono descritti come “imprenditori agricoli”. Non pensate che il problema in questi suicidi sia proprio quello di esser usciti da una dimensione di solidarietà e coscienza di classe, in cui questo vuoto di solidarietà si tinge di rabbia personale e si rivolge contro di sé senza trovare la spinta a una condivisione dei problemi problemi economici? Guardate cosa si faceva quando gli operai provavano i morsi della crisi più di cento anni fa, non oggi: http://danielebarbieri.wordpress.com/2012/12/25/i-figli-dei-serrati-una-storia-di-solidarieta-operaia/ I figli degli operai in sciopero erano allevati da altri operai che lavoravano. E senza guardare in passato, in Argentina le imprese fallimentari sono state trasformate in cooperative di lavoratori, che hanno anche mense e forni autogestiti: ma lì c’è coscienza di classe e l’individualismo è rimasto fuori dalla porta. Oggi che tutti gli artigiani si sono trasformati, anche loro malgrado, in impenditori ed è venuto meno il senso della contrattazione collettiva, qualcosa del genere sarebbe possibile in Italia? Io me lo auguro ma la vedo dura. Perché sennò rimane quella rabbia che, come diceva prima Wu Ming 1 citando Santoro, può spingere i precari a forme autoritarie. Io voglio resistere a diventare imprenditore, perché non voglio “farcela” da solo ma vorrei campare assieme a quelli che fanno il mio lavoro, siano contadini o traduttori. Dico contadini, dovrei dire coltivatori diretti. Ho anche detto che non voglio fare l’imprenditore agricolo. Lo vedi l’errore che fai? Essere coltivatore diretto non è essere imprenditore agricolo. Sono due cose diverse, non facciamo giochi delle tre carte: basta andare in una associazione di categoria e vi spiegano la differenza. Però attenzione: ormai anche se vai al CAI o alla Coldiretti, per una consulenza, ti invitano a diventare più volentieri “imprenditore agricolo”. Ma magari sei un pastore o un contadino che fa olio e un po’ di vino. E ti indebiti per le macchine agricole e poi fallisci. Però ti hanno consigliato di diventare imprenditore e ci si crede, perché il capitale sembra vincente, finché non ci porta in una trappola. Perché invece le cooperative agricole erano roba da comunisti o da paesi del terzo mondo o da morti di fame. Questo ci fanno credere. Pensa che invece conosco comuni agricole di fricchettoni libertari che in tempi di crisi vanno meglio delle imprese agricole: guadagnano poco ma hanno l’asilo comunitario, allevano tutti i bambini assieme, si sono risolti con poco ilproblema abitativo, mangiano tutti assieme e se qualcuno ha difficoltà conta sugli altri. E fanno vini molto buoni. Penso a Urupia, sono anarchici salentini, o alla Bagnaia senese. Sai che quelli non si ammazzano ma resistono collettivamente alla crisi? No, rispondo francamente: se non voglio fare l’imprenditore è perché non credo nel sogno del capitale e ne vedo ovunque i fallimenti, nel passato, e nel presente. Perché il capitale ormai è agli ultimi colpi di coda, ammazza da sempre gli operai e ormai anche gli imprenditori (no, non si parla dei grandi capitalisti ma di chi è caduto nel miraggio ingannevole del capitale ed è “diventato imprenditore”). Bisogna ripensare il modo di vivere e di lavorare, sfruttado gli altri si finisce per sfruttare le proprie famiglie e i lavoratori stranieri e se stessi e non c’è piacere in tutto questo. Ripartiamo da Fourier, non dalle partite iva, per favore. E infine, e lo ribadisco per l’ultima volta perché mi sono stancato di ripeterlo, né io né la Boscolo abbiamo irriso i suicidi. Parlo da parte mia, ma l’inumanità che affermavo era quella del Capitale che ci spinge oltre e fuori la nostra natura generando stress e malattia, se non lo si capisce e perché non lo si vuole capire ma si vuole provocare e rovinare questo dibattito.
Scusate gli errori di ortografia, mi sono alzato per pisciare e ho visto alcuni commenti e ho risposto ma dormivo e ho sonno: continuo domani.
Ho scritto anch’io su questo chiamare tutti “imprenditori”, ma l’ho fatto nel thread principale, in forma di chiarimento per ripartire e di “mozione d’ordine”.
Aver risvegliato il senso di ingiustizia può essere una cosa buona ma bisogna guardare la luna e non il dito che la indica. Io quando parlo di imprenditori mi riferisco a piccoli Marchionne e tu mi parli di contadini o bariste ex- segretarie sfruttate che hanno rilevato un baretto. Mi sa che non ci stiamo capendo. Oppure il nodo scoperto del discorso è proprio questo. Anche tra i miei compagni d’infanzia, cresciuti tutti in un dormitoio operaio, c’è chi adesso fa il barista o ha una piccola ditta personale d’idraulica o fa il falegname o l’affittacamere. Ce l’hanno detto i babbi, non andate in fabbrica che v’ammalate, e comunque non c’era posto. Hanno (abbiamo) fatto tutti altre cose ma attenzione: non hanno creduto ai pifferai magici del capitale. Loro non parlano di sé come “imprenditori”. Perché il problema è proprio qui, che si è ormai assunta per osmosi la logica del capitale e si vede l’imprenditore nel contadino, nel barista, nell’oste e nel falegname, che da sempre fanno parte dei ceti popoalri. Lo scrivi tu perfettamente. Questi imprenditori sono stati indebitati, gli hanno fatto credere che erano tutti dei piccoli padroncini. Sono cresciuti col mito dell’azienda familiare. E le loro famiglie sono diventate aziende e i loro amici gli impiegati, e le loro case, se non sono diventate ville, sono diventate delle nicchie in cui o si lavorava o ci si riposava. Se si parlasse dopo aver letto il libro, si saprebbe che la stessa cosa è stata proposta a mio padre, ma era una prova generale di precariato. Lui diceva: “Maremma serpe, m’hanno fatto diventa un artigiano”. Diceva artigiano perché il termine imprenditore lui giustamente lo riferiva a Agnelli. Ma si sentiva operaio e aveva bisogno d’un contratto nazionale e delle riunioni sindacali. Quando ha capito che lo stavano fregando, mettendo a un operaio i panni dei padroni, si è rifatto assumere. Allora era possibile, ora forse no e lo capisco. Ma credimi, non basta la partita iva per fare un imprenditore. E’ una cosa di testa, ideologica: devi condividere il sogno del capitale, desiderare il tuo successo liberale. E qui arriviamo alla crisi di fiducia e ai suicidi. Perché quei miei amici che sono stati obbligati, come tutti del resto, a prendere parita iva, mica si sentono imprenditori. Io come traduttore mi definisco un cottimista di parole, mica un artista o un imprenditore editoriale. Chi ha coscienza del fatto di essere cresciuto nei ceti subalterni non si trova a suo agio nei meccanismi individualizzanti dell’imprenditore, con la logica della divisione, della parcellizzazione, del successo economico personale. Lo ridico, se si fosse letto Amianto, si troverebbe nelle forme di “comunismo latente” di cui parla l’antropologo David Graeber una risposta alla crisi, e soprattutto alla crisi di fiducia personale di quelli che tu definisci piccoli imprenditori o di quel ceto medio impoverito che è diventato precario. Perché i figli degli operai non si ammazzano come i piccoli imprenditori e non patiscono troppo il precariato come i figli dei ceti medi? (questa domanda è stata posta mi sembra dalla Boscolo o da Wu Ming). Provo a azzardare tre risposte ma solo l’ultima è quella più calzante: primo perché sanno comunque sopravvivere con le proprie mani; secondo perché sono abituati da sempre a stringere la corda, usano auto vecchie di venticinque anni e cellulari trovati nella spazzatura; e soprattutto
perché sono ancora inseriti (e questa è la chiave di tutto e risponde a certe domande che Wu Ming 1 continua a porre sul precariato mentre gli si risponde a minchia buttandola sul frignone) in un contesto sociale che ha RESISTITO alla frammentazione sociale che è la base del capitalismo. Il capitale deve aprire mercati, indebitare la gente e distruggere le loro società informali (leggetevi “Debito” di David Graeber) Così si insedia al potere, spezzando le società solidali (siano i piccoli gruppi di raccoglitori cacciatori del deserto del kalahari o i villaggi minerari a nord dell’Inghilterra). Se resistiamo tenendo in piedi (nelle vie o nei condomini o nelle campagne) quel senso di mutuo aiuto tanto elogiato da Kropotkin, forse non ci si ammazza e poi soprattutto non ci si incazza con chi come me sta indicando il problema (il dito), ma ci si incazza con il capitale e con i suoi mangiafuoco che hanno portato gli operai e i ceti medi nel paese dei balocchi del consumismo, spacciando per miracolo economico un cumulo di rovine (la luna). Ti faccio un esempio concreto: se tu avessi letto il libro, sapresti chi è Alvaro. Era un tipo strambo che si mascherava continuamente, una sorta di “matto del villaggio” che viveva in una fabbrica Ilva dismessa quando io ero piccolo. Credevo fosse morto a metà anni ottanta e ne ho parlato in Amianto. Ho scoperto presentando il libro sul Monte Amiata che invece era tornato in un paese di minatori e che i vecchi minatori e i contadini del posto lo avevano aiutato a invecchiare bene. Mi hanno detto: “Fino all’ultimo dei suoi giorni, un piatto di minestra, un tetto, magari in una cantina o in un garage se non in casa con noi, e mezzo litro di vino, a Alvaro qui in paese non gliel’ha fatto mancare nessuno”. Cosa sarebbe successo a Alvaro se fosse stato un imprenditore e avesse vissuto invece che tra gli operai maremmani, i contadini e i minatori, dove la povertà non è una colpa, fra i piccoli imprenditori di cui mi parli tu? Forse una spiegazione per quei suicidi adesso ce l’abbiamo.
(Ho appena visto che WM1 ha pubblicato un commento in cui scrive cose molto simili a queste che ho scritto adesso io, in sintonia totale).
Visto che si è parlato di baristi come se fossero imprenditori, riporto un breve aneddoto dal libro (si riferisce a quando io e mio padre torniamo da un viaggio a Siena dove io dovevo iscrivermi per fare l’università). Tanto per far capire come le logiche di massimizzazione del profitto mancassero in baristi che non si percepivano come uomini d’affari ma pensavano di guadagnare quanto dovuto alla loro sopravvivenza facendo un servizio alla comunità in cui vivevano:
“Riprendemmo a respirare solo dopo esserci fermati al bar di Frosini, dove
il tempo e i prezzi erano rimasti quelli del dopoguerra.
Due enormi fette di pane con il buristo bastarono a consolarci
degli insulsi tramezzini senesi e ci dettero il tempo di ascoltare una conversazione paradossale. Un gruppo di fiorentini si accostarono alla cassa e dichiararono quattro
panini, otto bicchieri di vino e quattro grappe. Si sentirono
dire dal Papero, il vecchio gestore del bar: ‘Cinquemila lire’. ‘Come cinquemila lire?’, replicarono i fiorentini allibiti per un prezzo tanto economico. ‘Maremma cane,
se vi sembra troppo facciamo tremila e chiudiamo la faccenda
qui!’, rispose il vecchio, che non cedeva alle regole
dell’economia.”
Ci riprovo qui, fuori dal thread “nidificato”:
In fondo al suo primo commento Dovic, partendo da quel che ho scritto io sulla “morte del Vecchio” ha parlato dell’impossibilità di immaginare atti fondativi, e della “cronicità” di questa condizione. Ecco, questo stato d’animo generale (diffusissimo tra i più giovani ma non solo) è un’incubatrice di mostri, perché un orfano che sia orfano di tutto e in primis della fiducia nella possibilità di fondare è potenzialmente disponibile a ogni avventurismo reazionario, a gettarsi tra le braccia del primo “Lui” che si travesta da fondatore e finga di colmare il vuoto, di curare i traumi dell’anima precaria maltrattata e disperata. E’ quello che ha scritto poco tempo fa Giuliano Santoro su Dinamo Press a proposito del grillismo:
«Tornano dalle trincee della grande guerra che il capitale ha dichiarato al lavoro i soldati dell’esercito precario. E molti di loro si sono messi, disciplinati e ipnotizzati, in fila ad applaudire i comizi-spettacolo di Beppe Grillo. Sono abituati all’orrore dello sfruttamento flessibile e dell’impossibilità di progettare il futuro. Abituati a farsi maltrattare, tanto da trovarsi a loro agio nel grillismo proprio per il fatto che chi tira le fila e possiede il logo dei 5 Stelle (il famigerato “Staff”, termine che non a caso viene dall’universo aziendale) maltratta, mobbizza, espone al pubblico ludibrio, mette in concorrenza tra di loro i militanti.»
Alcune questioni di poetica e politica affrontate in questo post mi fanno frizzare la testa. Le prendo, le faccio mie e le rimesto con quelle degli autori.
Scrive Prunetti:
“Come fare per raccontare questo mondo, quello evanescente di mio padre e quello marcescente che abbiamo trovato infestato dalla miseria del Capitale? I ricordi bisogna stimolarli, bisogna riattivarli”.
Vale a dire, come mettere in moto un esercizio di memoria capace di regolare il nostro legame con il passato e con i significati in esso trattenuti? Come percorrere le tracce se esse sono ormai sottratte alla storia viva degli eventi? Come convertire una traccia in un tracciato?
La memoria non basta, sembra suggerire Prunetti. Per funzionare da spessore del presente, essa deve compiersi in modo produttivo, farsi processo rammemorante. Il ricordo deve essere “a futura memoria”, prolungarsi in ogni sguardo che a esso si appoggia. Solo in questa apertura, il passato sembra pensabile come “scarto” che può essere riattivato.
E continua poco dopo:
“Non bastano i ricordi, che sono ingannatori. Le storie che si vuole raccontare bisogna andarsele a cercare. Andarci coi piedi e imparare con gli occhi. […] Ma ovviamente i calli non bastano. Non basta sudare assieme a qualcuno per saper raccontare la sua storia in maniera avvincente, me ne rendo conto. Infatti in Amianto non c’è solo “spontaneismo operaio”, c’è anche mestiere. C’è la ricerca nei documenti, anche quelli privati (buste paga, certificati medici e pensionistici). C’è la facilità di scrittura elaborata in anni di correzione di bozze e di traduzione. C’è la capacità di muoversi sul crinale della storia e della storiografia e su quello dei tribunali. C’è la testardaggine di smontare le dichiarazioni del potere e ribaltarle producendo nuova documentazione, elaborando una controinchiesta rispetto a quella ufficiale.”
Amianto è attraversato da ciò che una volta WM1 ha definito “un desiderio feroce che ogni volta porta agli archivi, o per strada, o dove archivi e strada coincidono”.
La strada e gli archivi, vale a dire un occhio all’emergere del presente e un occhio alle forme della convenzione attraverso le quali tendiamo a rappresentare e comprendere la contemporaneità degli eventi. Ed è qui che Amianto incontra Timira. In entrambi i casi, il lavoro di scrittura opera una “diagnosi della civilizzazione”, mettendo in forma uno sguardo testimoniale che, anziché posarsi sul “nudo fatto”, rintraccia nel passato le stratificazioni che lo ricoprono per esibirne il potere falsificante e la capacità di indirizzare il presente. Se questi romanzi producono una testimonianza attraverso il racconto, lo fanno mostrando al lettore le modalità attraverso cui il significato dei fatti è stato amputato, veicolato e infine promosso a strumento del consenso attraverso cui rendere accettabile come “realtà” uno stato di cose inaccettabile. Archivio e memoria si incontrano per fondersi nelle forme di un discorso letterario che esplicita nel presente ciò che il passato contiene per aprirlo al futuro.
La connessione che queste opere stabiliscono con il mondo non si lascia quindi riassumere in una semplice aderenza alla superficie delle cose, in cui basti nominare l’esistente: è la narrazione che si pone, essa stessa, come luogo di rielaborazione dei codici culturali e linguistici che strutturano la nostra esperienza delle cose. Una differenza non da poco perché permette al lettore di raggiungere il reale extratestuale non come una datità semantica, ed in quanto tale definita in partenza, ma come un “risultato”, come un percorso praticabile del mondo.
E’ la storia che ritorna all’elemento dal quale proviene, al linguaggio. Ed è grazie al ritorno al linguaggio che la storia accaduta può essere rielaborata e fatta procedere come storia che avviene, realizzando una congiunzione tra la libertà trattenuta nelle possibilità del presente e la forza del passato che preme su di esso.
innanzi tutto, grazie. Perchè le esperienze raccontate in questa discussione, le emozioni, le *storie* che ho letto, mi hanno fatto sentire meno solo.
ho quasi 26 anni, laurea in giurisprudenza con lode. dopo un anno di pratica legale a 200 euro al mese e interminabili giornate di moderato mobbing provo a sganciarmi, tentando l’esame di dottorato, nel quale vengo trombato malamente a causa delle solite raccomandazioni. poiché sono dell’idea che a 25 anni suonati si debba cercare di uscire dal proprio nido ,inizio a lavorare in un noto supermercato, che per le feste ha bisogno di più manodopera. somministrazione, agenzia interinale, sai il giorno prima della scadenza se sarai rinnovato o meno. a settembre ritenterò il dottorato, a dicembre l’esame di stato di avvocatura, settore al collasso dove gli ultimi arrivati altro non sono se non segretarie non pagate, esposti alle bizze del dominus come le foglie al vento; altro che *liberi professionisti*.
non sono figlio di operai: mia mamma, arrivata dalla sardegna con la valigia di cartone, ha fatto prima la donna di servizio e poi l’operaia in una fabbrica di bibite prima di diventare infermiera e poi tecnica di radiologia. arrivava da una famiglia *povera* per gli standard dell’epoca, contadini e pastori, ma dignitosa e ricca del sapere della tradizione, di quella cultura rurale che sta andando irrimediabilmente perdendosi. mio padre lavora in banca da quando aveva più o meno la mia età, figlio unico di una famiglia piccolo borghese, zia industriale alla quale *i partigiani hanno rubato le coperte dalla fabbrica!* e padre (mio nonno) tra quei quarantamila che marciarono in città nel 1980. di quanto ristretto fosse l’orizzionte nel quale era cresciuto, mio padre si è reso conto con il passare degli anni, mobbizzato da un sistema che credeva infallibile, ma che in realtà gli ha tolto più di quanto gli abbia dato. tutti e due hanno avuto i loro bei problemi di salute, mia madre a causa delle radiazioni cui è stata esposta per anni e mio padre a causa di quel sistema che tanto ostinatamente aveva difeso.
io e mia sorella (neo-tecnica di radiologia) siamo figli abbastanza fortunati della borghesia: abbiamo un buon tenore di vita, non ci è mai stato fatto mancare niente; ma senza i nostri genitori, non avremmo di che vivere. probabilmente sopravviveremmo, dandoci da fare per raccimolare uno stipendio minimo come fanno molti miei colleghi e coetanei, stritolati da un meccanismo sempre più evanescente, un fantasma di sistema che assume le fattezze ora dell’agenzia di lavoro interinale, ora del concorso pilotato, domani chissà.
forse non ho alcun titolo per sentirmi vicino, o anche lontanamente simile, ai miei colleghi, figli di operai fiat, che con me passano i prodotti alla cassa e caricano la merce sugli scaffali; nel caso, siate clementi e non mandatemi a quel paese, dopo esservi letti la storia non richiesta della mia vita. ma credetemi, la precarietà di cui avete parlato è una realtà che sento davvero sulla mia pelle, un sentimento angoscioso che mi assale e dal quale non riesco a liberarmi. forse senza titolo, ma stasera sicuramente meno solo.
un’ultima riflessione: sono fuori strada se dico di udire degli echi benjaminiani (considerazioni sull’opera di n. Leskov) nelle parole di Claudia Boscolo sulla crisi della narrazione?
Grazie a te, Klingsor, è molto toccante la storia che condividi… non ti rispondo nello specifico, spero che lo facciano anche altri…
Ho avuto tempo per leggere con calma testi e commenti, e mi spiace di non avere con me la mia copia de “La prima radice” di S. Weil (non a caso, una che le condizioni operaie volle provarle, prima di mettersi a descriverle), che lessi troppo tempo fa, perché mi pare particolarmente ad hoc, in questa discussione. Ma c’è questa bella recensione
http://www.filosofiprecari.it/wordpress/?p=2367
di Elisa Redaelli che dà ottimi riferimenti, e sottolinea proprio le cose che mi ricordavo (vagamente). Personalmente, mi riservo di andare a rileggermelo presto.
Quando Alberto parla di “mettere radici” è proprio alla Weil che penso (alla sua vita come alla sua morte), soprattutto allo sradicamento che lei nota nella classe operaia, a casa in nessun luogo, anche se questo mi pare più vero oggi che non negli anni in cui lo scrive lei.
Della precarietà emotiva e relazionale ho fatto bandiera, dato che — come dicono gli americani qui, e per loro vale sia affettivamente che professionalmente, quando rompi col tuo partner o quando cerchi lavoro — sto da cinque anni on the market (eufemismo per dire che nessun* mi assume per più di un anno alla volta). In questi cinque anni ho speso più tempo a cercar lavoro che imparare, e quando ho letto Alberto dire che lavora anche quando cerca lavoro mi sono detto che no, non era il caso mio. Ma, ripensandoci, mi devo ricredere, dato che non mi pagano un cazzo e spesso non porta a nulla o a pochissimo: hell yeah, è di certo l’ultima frontiera del lavoro, senza se e senza ma.
Davvero, ci è stata tolta la ciclicità governata da Demetra per darci quella “di questo capitalismo morto e risorto vampiro” (Alberto).
A proposito della polemica sui “suicidi degli imprenditori”
“Imprenditore” è una parola che inganna, carica di ideologia. L’azione inquinante della propaganda liberista ha portato a usarla in un’accezione estesa che prima – almeno a sinistra – non si riscontrava. Una volta si diceva che uno era un “lavoratore autonomo”, che aveva un negozio, che faceva il salumiere, che aveva un’aziendina a conduzione famigliare etc.
Fino agli anni Ottanta inoltrati, la parola “imprenditore” era usata con molta più circospezione rispetto a oggi. Era ritenuta un eufemismo pericoloso, che serviva a indorare la pillola dello sfruttamento. “Imprenditore” era un modo truffaldino di chiamare il padrone. Non solo: era un modo di appiattire le differenze, perché una simile categoria metteva sullo stesso piano Agnelli e tuo zio che mandava avanti una falegnameria.
A sinistra, la parola “imprenditore” non si usava, oppure si usava per definire il padrone, non quello che aveva l’aziendina a zero dipendenti.
Poi l’ideologia del capitale ha trionfato, e molti si sono sentiti dire: – Anche tu sei un imprenditore! – e hanno cominciato a usare la parola. Parola che attiva tutto un frame: l’imprenditore è il protagonista della favoletta liberista, è l’eroe che compie l’impresa, appunto, di saper stare sul mercato etc.
Mentre la parola “padrone” ha sempre un suo correlato -che nella terminologia dialettica tradizionale è “servo” ma oggi ha tanti “quasi-sinonimi” (dipendente, operaio, manodopera, maestranze, sfruttati etc.) – la parola “imprenditore” non ce l’ha, è presentata come autosufficiente. Questo perché è frutto di una di quelle operazioni di framing borghese che Marx chiamava “robinsonate”, da Robinson Crusoe. Vale a dire: si prende un singolo individuo, un singolo soggetto sociale, e lo si definisce prescindendo dalle relazioni che ha e intrattiene. Invece sono proprio le relazioni sociali a definirci.
A me sembra addirittura OVVIO che chi ha un’aziendina a conduzione familiare e con *zero* dipendenti non sia un “padrone”. “Padrone di chi?”, si chiede Francesca, e non si rende conto che si è già data la risposta in partenza. Se uno non sfrutta la forza-lavoro altrui non è dentro un rapporto di produzione tra padrone e operaio, e quindi non estorce plusvalore, e l’unico pluslavoro è il suo. E’ al massimo sfruttatore di se stesso. Non c’è altro da dire su questo.
Prunetti ha usato la parola “imprenditore” come la si usava una volta, quando non includeva tutta questa gente che oggi si definisce tale e che fino a venti-venticinque anni fa non lo avrebbe mai fatto.
Da qui l’equivoco che nel sotto-thread più in alto continua a ripercuotersi nonostante precisazioni etc.
Abbiamo sbagliato noi tre – io, Alberto e Giro – a dare per scontato un comune sentire che invece va ricostruito.
Chiedo veramente a tutti di andare oltre il sentirsi offesi, oltre il giocare il proprio dolore e la propria rabbia contro il dolore e la rabbia che Alberto ha elaborato ed espresso.
(La rincollo qui fuori dalla nidificazione dei commenti) A.P.
Aver risvegliato il senso di ingiustizia può essere una cosa buona ma bisogna guardare la luna e non il dito che la indica. Io quando parlo di imprenditori mi riferisco a piccoli Marchionne e tu mi parli di contadini o bariste ex- segretarie sfruttate che hanno rilevato un baretto. Mi sa che non ci stiamo capendo. Oppure il nodo scoperto del discorso è proprio questo. Anche tra i miei compagni d’infanzia, cresciuti tutti in un dormitoio operaio, c’è chi adesso fa il barista o ha una piccola ditta personale d’idraulica o fa il falegname o l’affittacamere. Ce l’hanno detto i babbi, non andate in fabbrica che v’ammalate, e comunque non c’era posto. Hanno (abbiamo) fatto tutti altre cose ma attenzione: non hanno creduto ai pifferai magici del capitale. Loro non parlano di sé come “imprenditori”. Perché il problema è proprio qui, che si è ormai assunta per osmosi la logica del capitale e si vede l’imprenditore nel contadino, nel barista, nell’oste e nel falegname, che da sempre fanno parte dei ceti popoalri. Lo scrivi tu perfettamente. Questi imprenditori sono stati indebitati, gli hanno fatto credere che erano tutti dei piccoli padroncini. Sono cresciuti col mito dell’azienda familiare. E le loro famiglie sono diventate aziende e i loro amici gli impiegati, e le loro case, se non sono diventate ville, sono diventate delle nicchie in cui o si lavorava o ci si riposava. Se si parlasse dopo aver letto il libro, si saprebbe che la stessa cosa è stata proposta a mio padre, ma era una prova generale di precariato. Lui diceva: “Maremma serpe, m’hanno fatto diventa un artigiano”. Diceva artigiano perché il termine imprenditore lui giustamente lo riferiva a Agnelli. Ma si sentiva operaio e aveva bisogno d’un contratto nazionale e delle riunioni sindacali. Quando ha capito che lo stavano fregando, mettendo a un operaio i panni dei padroni, si è rifatto assumere. Allora era possibile, ora forse no e lo capisco. Ma credimi, non basta la partita iva per fare un imprenditore. E’ una cosa di testa, ideologica: devi condividere il sogno del capitale, desiderare il tuo successo liberale. E qui arriviamo alla crisi di fiducia e ai suicidi. Perché quei miei amici che sono stati obbligati, come tutti del resto, a prendere parita iva, mica si sentono imprenditori. Io come traduttore mi definisco un cottimista di parole, mica un artista o un imprenditore editoriale. Chi ha coscienza del fatto di essere cresciuto nei ceti subalterni non si trova a suo agio nei meccanismi individualizzanti dell’imprenditore, con la logica della divisione, della parcellizzazione, del successo economico personale. Lo ridico, se si fosse letto Amianto, si troverebbe nelle forme di “comunismo latente” di cui parla l’antropologo David Graeber una risposta alla crisi, e soprattutto alla crisi di fiducia personale di quelli che tu definisci piccoli imprenditori o di quel ceto medio impoverito che è diventato precario. Perché i figli degli operai non si ammazzano come i piccoli imprenditori e non patiscono troppo il precariato come i figli dei ceti medi? (questa domanda è stata posta mi sembra dalla Boscolo o da Wu Ming). Provo a azzardare tre risposte ma solo l’ultima è quella più calzante: primo perché sanno comunque sopravvivere con le proprie mani; secondo perché sono abituati da sempre a stringere la corda, usano auto vecchie di venticinque anni e cellulari trovati nella spazzatura; e soprattutto
perché sono ancora inseriti (e questa è la chiave di tutto e risponde a certe domande che Wu Ming 1 continua a porre sul precariato mentre gli si risponde a minchia buttandola sul frignone) in un contesto sociale che ha RESISTITO alla frammentazione sociale che è la base del capitalismo. Il capitale deve aprire mercati, indebitare la gente e distruggere le loro società informali (leggetevi “Debito” di David Graeber) Così si insedia al potere, spezzando le società solidali (siano i piccoli gruppi di raccoglitori cacciatori del deserto del kalahari o i villaggi minerari a nord dell’Inghilterra). Se resistiamo tenendo in piedi (nelle vie o nei condomini o nelle campagne) quel senso di mutuo aiuto tanto elogiato da Kropotkin, forse non ci si ammazza e poi soprattutto non ci si incazza con chi come me sta indicando il problema (il dito), ma ci si incazza con il capitale e con i suoi mangiafuoco che hanno portato gli operai e i ceti medi nel paese dei balocchi del consumismo, spacciando per miracolo economico un cumulo di rovine (la luna). Ti faccio un esempio concreto: se tu avessi letto il libro, sapresti chi è Alvaro. Era un tipo strambo che si mascherava continuamente, una sorta di “matto del villaggio” che viveva in una fabbrica Ilva dismessa quando io ero piccolo. Credevo fosse morto a metà anni ottanta e ne ho parlato in Amianto. Ho scoperto presentando il libro sul Monte Amiata che invece era tornato in un paese di minatori e che i vecchi minatori e i contadini del posto lo avevano aiutato a invecchiare bene. Mi hanno detto: “Fino all’ultimo dei suoi giorni, un piatto di minestra, un tetto, magari in una cantina o in un garage se non in casa con noi, e mezzo litro di vino, a Alvaro qui in paese non gliel’ha fatto mancare nessuno”. Cosa sarebbe successo a Alvaro se fosse stato un imprenditore e avesse vissuto invece che tra gli operai maremmani, i contadini e i minatori, dove la povertà non è una colpa, fra i piccoli imprenditori di cui mi parli tu? Forse una spiegazione per quei suicidi adesso ce l’abbiamo.
(Ho appena visto che WM1 ha pubblicato un commento in cui scrive cose molto simili a queste che ho scritto adesso io, in sintonia totale).
Cerco di dire una cosa, perché non capisco dove sia il problema se qualcuno esprime disappunto, tanto più che ci sono i commenti nidificati. In più ci sta anche che qualcuno sia in disaccordo senza per che per forza sia spinto da volontà provocatorie o da reazioni emotive. Io nell’analisi trovo degli errori. Fare una differenza tra imprenditori\padroni e proletari in merito al suicidio lo trovo azzardato e perlomeno vorrei che fosse argomentato a dovere, oltretutto quando si è detto di non conoscere quel mondo e quelle persone. Negli ultimi vent’anni il tasso di suicidi è calato in tutta Europa. A suicidarsi sono soprattutto uomini di oltre 45 anni e con basso titolo di studio. Parlare di suicidio inquadrandolo in una prospettiva di coscienza di classe mi pare un azzardo. Perché non si ammazzano solo gli imprenditori\padroni e non si ammazzano tutti quelli che falliscono e quindi entra in gioco la personalità e l’analisi psicologica. Per cui c’entra di più il rapporto che si ha con il lavoro e con gli affetti e con le relazioni che appartengono a tutti e non c’entrano molto con il Capitale, senza che questo sminuisca tutto quello che è stato detto sulle conseguenze disumanizzanti che comporta la logica capitalistica.
Certo che non si ammazzano solo gli imprenditori/padroni, anzi.
Il punto è che Prunetti non ha affatto proposto un’analisi su “quelli che si ammazzano”, sul tasso di suicidi in Europa etc.
Prunetti ha fatto una semplice, terra-terra, viscerale considerazione sui padroni-che-si-ammazzano e sul fatto che, di volta in volta, a quel caso individuale è data più rilevanza che ai tre omicidi “bianchi” commessi in Italia ogni giorno che Iddìo manda in terra.
L’occasionale padrone che si ammazza è un “caso umano”.
Invece i tre operai ammazzati ogni giorno dal padrone (perché è il padrone che li ammazza, non è il caso né il fulmine di Zeus) sono abitudine, sono statistica, sono trafiletti.
Non è Prunetti a “disumanizzare”. A disumanizzare le morti di operai e precari sono i media impregnati di ideologia padronale, che si adoperano a suscitare la lacrimuccia soltanto sullo squaletto che magari ha sfruttato, avvelenato, evaso le tasse e votato razzista fino a due mesi prima, poi gli è arrivata la cartella di Equitalia e si è buttato nel fiume.
Il suo diventa un caso umano, è l’imprenditore-eroe caduto in battaglia contro i “lacci e lacciuoli” etc. etc. Gli altri, invece, gli operai, sono numeri.
Ripeto: si parla di una tipologia ristretta, quella dei padroni-che-si-ammazzano. Chi si ammazza e non è un padrone, non rientra nell’insieme (che lui per primo ha posto come molto ristretto) delle persone di cui parlava Prunetti.
Guardate che sono pochi quelli che possono essere definiti “padroni”. Il trucco di definire tutti quanti “imprenditori” serve proprio a farti identificare coi padroni anche se tu non lo sei.
Mi colpisce molto questo scambio, da un lato all’altro del fiume, perché lo vedo tale e quale in mille situazioni in cui sono coinvolta in questo periodo.
E’ indicativo che ancora una volta si comincia parlando di operai, si propone una narrazione collettiva, comunitaria, si nominano morti sul lavoro, e subito si va a finire a parlare degli imprenditori che si suicidano. Non è, questa, l’evidente incessante attività del Capitale?
E’ indicativo, ancora, quanto i nostri neuroni siano sensibili all’emotività e respingano la riflessione critica sugli eventi. A quei neuroni “intossicati” viene più facile dire “poverino!”, e quando invece devono confrontarsi con narrazioni forti, critiche, strafottenti persino, si tirano indietro.
Non ne facevo una questione di distinguo fra imprenditori illusi e vittime a loro volta e padroni fatti e finiti. Né volevo proporre un’analisi del suicidio tanto più che non ne sarei capace. Quello che ho notato, nel post e nei commenti successivi è che dato che sono d’accordo con l’uso strumentale e in vari casi magari in malafede, il modo con cui si è parlato della questione mi è sembrato sbagliato. Sbagliato nel voler piegare un fenomeno così particolare, il suicidio, a una questione più generale. Proprio perché non esiste un fenomeno degli imprenditori che si suicidano, nonostante sia proprio la cagnara mediatica a creare effetti d’emulazione veri. Capisco anche che non è piacevole stare a disquisire sulle singole parole altrui.
“Abbiamo sbagliato noi tre – io, Alberto e Giro – a dare per scontato un comune sentire che invece va ricostruito.”
vi siete comportati come una casta di figlioli d’operai, razza di privilegiati che non siete altro!
ora lasciate un po’ di spazio ai figlioli del ceto medio.
in fondo hanno solo decine di giornali, televisioni e fogli parrocchiali dove esprimere i propri punti di vista.
Bòno, Mastacchi, nonticimetteranchetè, dio bonino…
Ciao
Maremmano anche io come il Prunetti. Quelle frasi sui piccoli padroni, o imprenditori che dirsivoglia, le senti spessissimo da queste parti. Porto l’esempio di un mio amico elettricista, al quale rinnovavano il contratto ogni tre mesi, e che per due giorni di malattia in un trimestre venne licenziato (era apprendista, mi pare). Disse una cosa tipo : ” se lo trovo per strada e c’ha un infarto (riferito al padrone), di sicuro non lo carico in macchina per portallo all’ospedale”.
Non capisco cosa ci sia di scandaloso in queste reazioni umoristiche ultraspontanee. Nel senso, quando raccogli la frutta a 3 euro all’ora o ti assumono solo quando c’hanno più lavoro per scaricarti subito dopo, è chiaro che ti becchi gli accidenti della gente.
Rispondo qui a entrambi, chiarendo innanzitutto che non avevo intenzione né di provocare né di rovinare la discussione.
– Quando mi si dice “Imprenditore è una parola che inganna” o “Loro non parlano di sé come “imprenditori””, capisco che c’è un grosso equivoco di fondo. Non si tratta affatto di un problema di linguaggio o di comune sentire; mi faccio chiamare imprenditore così mi sento figo o non mi faccio chiamare imprenditore e resto un puro. Invece è una parola che non inganna affatto perché è descritta perfettamente dalla nostra legislazione, e NON comprende lavoratori autonomi con partita IVA, traduttori e giornalisti free lance, artigiani (che sono PICCOLI imprenditori, come i coltivatori diretti di cui sopra, soggetti a uno statuto diverso) e neanche dentisti, medici, avvocati per quanto dotati, loro sì, di villette, Rolex e quant’altro. E’ una figura ben specifica: SONO imprenditore per la legge e, anche se a mio malgrado, anche se non “mi ci sento”, sono soggetto a fallimento (tranne se sono imprenditore agricolo che invece non è soggetto fallibile, sempre che riesca a dimostrare di esserlo) e non mi servirebbe a niente dire all’ufficiale giudiziario “no vabbè ma io mi sento proletario dentro”.
– Quando un imprenditore o una società a responsabilità illimitata falliscono, i soci non solo perdono tutto in senso materiale, ma diventano degli interdetti legali, praticamente dei paria a livello sociale; fino al 2006 ti toglievano anche il diritto di voto, per dire. Moltissimi bar, ristoranti, negozi sono Snc e hanno questo rischio; a differenza di free lance, professionisti ecc., che quindi non possono essere messi sullo stesso piano e non sono certo stata io a metterceli (!?)
– Questa noiosa premessa è solo per dire che quando si fa la conta dei fallimenti delle imprese, ci troviamo dentro sia il tizio con la villona e venti schiavi a cucire borse nel seminterrato, sia il barista ex sfruttato. Oserei dire che è molto più facile che a fallire sia il secondo.
– Quindi secondo voi sarà pure OVVIO che parlavate solo dei piccoli e grandi Marchionne, a me non sembrava ovvio affatto anche perché ho letto ribadire più volte che TUTTI questi che falliscono e si suicidano sono padroni e sfruttatori. Che poi fino al primo intervento in cui Alberto parlava dei suicidi e diceva sostanzialmente che queste notizie hanno molta più eco che non i tre morti sul lavoro al giorno, io ero pure d’accordo, per forza. Forse il discorso avrebbe dovuto chiudersi lì.
Spero di poter leggere presto il libro, passo e chiudo.
Un momento solo: un conto è quel che dice la “norma di legge” (che, per inciso, non è affatto neutra perché il diritto è una cristallizzazione ex post dei rapporti di forza), altro conto è l’autopercezione dei soggetti sociali e il loro rappresentarsi di fronte al prossimo. Le SNC esistevano anche prima, ma un barista quando gli chiedevi che lavoro faceva ti rispondeva “barista”, non “imprenditore” come capita adesso. Un oste non diceva: – Sono un imprenditore nel campo della ristorazione. (ma mi faccia il piacere!)
Io stavo parlando di quest’autopercezione, che non necessariamente deve aderire a quel che dice la “norma di legge”, anzi. A norma di legge, un sacco di precari che fanno la fame sono “lavoratori autonomi”, ma se gli chiedi di descrivere la loro condizione, ti dicono “precari” e riga.
[Un mio collega che da anni regolarmente tiene un corso in un’importante istituzione parauniversitaria, e fa gli esami, fa il relatore alle tesi, a norma di legge fa “collaborazioni occasionali”. La norma di legge non dice la verità sulla società.]
E comunque, a riprova che la parola “imprenditore” è sovrapposta ideologicamente alla realtà, faccio notare che nemmeno la “norma di legge” la usa. Questi sono gli articoli del codice civile che regolamentano le “società di persone”, tra cui le SNC:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36501
Con una ricerchina si vedrà che le parole “imprenditore” e “impresa” non compaiono mai. Nemmeno a norma di legge ci sarebbe bisogno di definirsi “imprenditori”, pensa un po’… :-D
P.S. Non mi sembra si sia detto che tutti quelli che falliscono e si suicidano sono sfruttatori.
Sì ma è la norma di legge che decide il tuo destino quando ti capita una tegola tra capo e collo e hai lo statuto legale dell’imprenditore o della Snc, non certo la tua autopercezione o l’odio per il Capitale…
e comunque giusto per info la figura dell’imprenditore è descritta dall’art. 2082 del CC da un pacco di anni, e anche se il barista (nel senso del gestore dell’attività commerciale) prima si faceva chiamare barista e ora imprenditore, era imprenditore pure prima e poteva fallire pure prima indipendentemente da come si percepiva rispetto al mondo
vabbè comunque mi sembra che si giochi a non capirsi…
PS: a me pare che si sia anche detto tipo che più son piccoli e più son stronzi, ma sicuramente era umorismo livornese
Non è questione di “giocare” a non capirsi, qui è proprio questione di non capirsi, tout court, perché stiamo parlando di due cose completamente diverse, che stanno su due piani.
Su un piano c’è la normativa sul lavoro in tema di responsabilità di chi svolge un’attività economica. Importantissimo ragionarci sopra, perché condiziona le esistenze di innumerevoli persone, ok.
Sull’altro, però – quello di cui stavo parlando io – c’è la valenza *ideologica* che l’uso di una parola (in questo caso “imprenditore”) ha o non ha nel discorso pubblico. Non sono un giuslavorista né un commercialista: sono uno scrittore che ha fatto studi storici; rifletto sulla lingua che parliamo e *dalla quale siamo parlati*, e sulle trasformazioni che ha avuto e continua ad avere nel tempo e nel contesto sociale.
E’ un dato di fatto che la parola “imprenditore” abbia subito una supervalutazione, venga usata molto più spesso di vent’anni fa e su di essa si sia fatto un investimento pazzesco. E’ stata brandita come un’arma, e quell’arma ha ferito un sacco di gente.
Faccio notare che, in base alla definizione del codice civile, *quasi chiunque* è un imprenditore
[“E’ imprenditore colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.]
ma questo non vuol dire che la sua identità sociale sia quella.
Fra, provo a fare un altro esempio di neolingua, di parola divenuta mostruosa: “risparmiatore”. Già a cavallo tra anni Novanta e anni Zero Crozza colse bene quel che era successo. Qualcuno ricorda la sua imitazione del divulgatore di economia e finanza Alan Friedman, con la parola “risparmiatore” (pronunciata con accento americano, of course) messa alla fine di ogni frase?
Una volta era definito “risparmiatore” chi metteva soldi da parte in previsione di tempi più difficili, o comunque gestiva con oculatezza le sue finanze. A essere risparmiatore era la formica, contrapposta a quello scialacquatore che era la cicala.
Ebbene, oggi “risparmiatore” molte volte vuol dire… scialacquatore. In che senso sarebbe “risparmiatore” chi affida i propri soldi a un estraneo (broker o banca) perché li giochi d’azzardo in fondi di investimento composti dalle azioni di aziende che non conosce e forse non sentirà mai nominare e/o in prodotti derivati del cui funzionamento non sa né può sapere nulla? Ci sono prodotti derivati talmente complicati che nemmeno la maggior parte degli analisti finanziari ha la più pallida idea di come funzionino. Un sacco di singoli e di istituzioni (es. molte amministrazioni comunali) ci hanno messo i soldi fidandosi di loschi mediatori, andando sul lastrico e trascinando sul lastrico i cittadini, eppure noi questi singoli e comuni li chiamiamo… “risparmiatori”.
Lo so bene, *tecnicamente* sono risparmiatori. Sono definiti così anche dal codice civile. Ma non ci si può appellare al codice civile per rimuovere le contraddizioni e tensioni ideologiche che orientano l’utilizzo di una parola. Dire che chi, alla cieca, affida i propri soldi all’infiammabile irrazionalità della macchina finanzcapitalistica sta… “risparmiando” significa occultare la follia di quel sistema. Facciamo un esperimento: prendiamo un articolo del “Sole 24 Ore” sugli investimenti nei derivati e ogni volta che c’è la parola “risparmiatore” sostituiamola con “scialacquatore”: all’improvviso le pareti si fanno trasparenti, e dall’altra parte ci appare una verità.
Non è operazione che questo sistema possa tollerare. Per questo si fa in modo che non riflettiamo mai sulle accezioni delle parole che usiamo.
Sì ma ho capito cosa vuoi dire, son d’accordo sullo stravolgimento del significato delle parole. Solo che hai ragione, stavamo parlando di due cose diverse.
Mi riaggancio solo ora, e quindi evito di dire cose già dette e superate, e mi limito a una sola considerazione sul “si suicidano anche gli imprenditori”. È vero che dal mio punto di vista (ma ha ragione WM1: sbagliato crederlo condiviso) non c’è nulla di scandaloso, è quasi un dato empirico, sociologico. Perché una delle conseguenze rilevanti della crisi attuale (come quella del primo dopoguerra, soprattutto in Germania, per capirci) è la friabilità degli argini sociali. Non solo dei grandi bastioni tra “borghesia”, “ceto medio” e “proletariato”, come si legge nei classici e nei manuali: ma di quei canali, fossati, parapetti che creano ulteriori suddivisioni all’interno dei grandi insiemi sociali. Gli argini vengono giù, e chi era in una certa casella si trova in uno spazio sociale aperto, non delimitato, assieme ad altri più avvezzi alla precarietà e alla crisi: e non regge questa dimensione, perché ha una storia sociale, familiare, ecc. che non lo ha preparato a questo. E guardate che non è una cosa recentissima: il più bel romanzo di J.-C. Izzo, Il sole dei morenti, accomuna un ragazzo algerino fuggito dalla guerra civile a uno yuppie rampante ch enel giro di poche settimane perde lavoro, famiglia e status sociale, e si ritrova ad essere un “barbone” (come quelli che una volta infilavo nei miei romanzi, perché li frequentavo davvero, a Bologna). Com’è che succede questo? Perché un aspetto poco noto (anche se studiato da almeno vent’anni) del turbocapitalismo globale è stata la precarizzazione delle figure imprenditoriali: quei soggetti che hanno l avilla, il BMW, i nani da giardino sul cancello e la fabbrichetta lì accanto, e dunque appartengono alla fascia “borghese”. Ma al tempo stesso sono legati da una serie di vincoli – il franchising, ad esempio; la sub-produzione per conto terzi; l’aleatorietà dei mercati – che rendono la loro esistenza precaria e incerta: e se domani la grande ditta che mi subappalta la tessitura delle sue maglie delocalizza? Da cui, ad esempio, la paura dei “foresti”, non di quelli che vengono a rubarti in casa, a spacciare droga e a violentarti la figlia, ma di quelli – ad es. i cinesi – che vengono a rubarti il lavoro: e non importa se è vero o no, se in realtà i “cinesi” sono integrati e non concorrenti, sfruttati e non sfruttatori, importa che li percepiscano sotto forma di paura e rancore. Paura e rancore sono passioni tristi che si rovesciano nel panico, fino al suicidio in caso di crisi, in soggetti sociali che un tempo avrebbero chiuso la ditta e ne avrebbero riaperta un’altra ricominciando da capo (o almeno, credendo di poter ricominciare da capo): questo è il dato di cui si voleva parlare.
Discussione di quelle da ricordarsi (a parte la “deviazione”, che ho trovato assolutamente gratuita).
Vi racconto un’altra “deviazione”: sul forum di alelivorno (forum di pseudo tifosi del Livorno, in realtà molto più ricco e variegato), dopo il messaggio su Amianto, ho avuto un ritorno che ci terrei a condividere, magari ci aiuta a fare delle riflessioni. Vi offro quindi le due risposte di un compagno – non esito a chiamarlo così -, il compagno “Orso”:
“C’ho mi padre, in casa, coi polmoni pieni d’amianto.
Se tu avessi potuto seguire l’odissea che ha passato per farselo riconoscere, altro che libro ci sarebbe da scrivere.
Di quelli che lavoravano con lui all’Italso ne è rimasto in vita uno e chi non era morto nello scoppio e’ morto di tumore…già questo avrebbe dovuto far riflettere….non è riuscito nemmeno a portare una persona a testimoniare all’udienza.
Una volta vinto il primo grado, l’Inail s’è anche appellata, cioè ha fatto il cane addosso a mi padre, coi polmoni pieni (…)
Al mi babbo gli dissero:”E a noi chi ce lo dice che l’ha preso proprio a lavorare all’Italso”…98% di morti…
C’è da ridere ma ci sarebbe da piangere.”
All’Italso nell’87 uno scoppio uccise sul colpo tre operai, un quarto morì poco dopo. Io all’epoca abitavo ancora a Livorno, a Sciangai, proprio accanto alla zona industriale. Il messaggio del compagno m’ha rammentato le fiamme di quella mattina, l’angoscia, il puzzo, il dolore.
Ma rendiamoci conto che di quel tragico episodio non c’è più nulla: è più dolorosa la dimenticanza che le fiamme sul corpo vivo, è il segno d’una morte collettiva, sociale.
Tornata su come i peperoni, dopo Amianto.
Mi pareva di ricordare che l’intervento di uno degli operai morti in quella tragedia avesse salvato la fabbrica da danni ancora maggiori. E sentite la risposta di Orso:
“No, Mastacchi, quella è una leggenda metropolitana.
In realtà i tre uomini che morirono li, più uno che morì qualche giorno dopo, nemmeno se ne accorsero.
Scoppio’ tutto, punto.
Il residuo dei semi passati alla spremitura andava al reparto “estrazione”, dove venivano lavati con vapore ed esano, per recuperare il poco olio rimasto nei semi.
L’esano e’ un composto altamente infiammabile,simile alla benzina.
Questa miscela esano/vapore passava attraverso dei raffreddatori che la riportavano allo stato liquido.
La notte dell’incidente i raffreddatori erano sfondati nella parte superiore; la miscela uscì da li ma, a causa della bassa pressione che c’era quella sera, vennero spinti nei locali caldaie dove poi è avvenuta l’esplosione,causando l’incendio immediato sia delle caldaie che del reparto estrazione.
La morte e’ stata istantanea.
Successe alle 4 circa e il mi babbo montava 6/14, spetto’ a lui riconoscere i corpi dagli oggetti che avevano addosso tipo orologi o braccialetti. ”
Racconto esemplare di cultura operaia trasmessa: la tecnica, l’orgoglio per il proprio lavoro, la conoscenza, la partecipazione, il dolore.
Un altro dei tanti “Amianto” nascosti nei meandri delle nostre memorie.
Un grazie a voi, per aver stimolato i nostri scoraggiati neuroni.
Che storia tremenda. Ce ne sono a centinaia, capitano ogni giorno e non se ne parla mai. Che giramento di coglioni.
Alberto
PS: O Mastacchi, prima o poi un poncino alla livornese dal Civili e un cinque e cinque bisognerà fasselo…
Beh, son contento di fare un commento dopo due anni che seguo giap anche troppo fideisticamente, proprio su questo post che, come a tanti qui, riguarda personalmente. Figliuolo d’operaio pure io.
Confermo come il problema del Padre sia un problema diffuso. Tengo un blog che ha come unico tema (o quasi) proprio questo, e proprio sulla sua morte, sul mio ruolo e la mia colpa, ho scritto spesso lì. E correlato a questo tema ci sono le radici, manco a farlo apposta. Non la faccio lunga. Credo di aver capito la “positività” di queste radici, e anche le problematiche che la loro assenza provoca, (pure su questo scrissi, è bello quando le idee sono nell’aria e le ritrovi ovunque, anche questo crea un appartenere :) ), ma la parola stessa radici mi crea un cortocircuito interno. Ho imparato a diffidare di tante radici “di quelle profonde che non gelano” etc. Cosa rende queste nostre radici “più sane”? Che forse il discorso che faceva più sopra Dovic è anche legato a questo rischio di ipostatizzare le (posso dirlo) nostre radici? Ho vissuto nella piccola provincia e amici miei erano poveri spiantati, figli di ricconi, di padroni etc. etc. Molto variegata come compagnia, e per quanto mi rendessi conto di essere in un’altra situazione sociale, mi sono anche reso conto delle loro “radici”. Perché mi sembra una figurina semplificata quella del padrone solo e isolato che si suicida. Non è così semplice. Ci sono ragioni e “radici” pure lì. Spero si capiscano le domande. Spero di sfoltire un poco la nebbia che ho in testa.
Credo che “radici” sia un concetto pericoloso e difficilissimo da maneggiare, infatti cerco di non usarlo. Se non erro, la parola è apparsa nel post quando Prunetti ha detto: “Vorrei provare a mettere qualche radice”. La radice è quella che lui non riesce a mettere, e intende dire: smetterla di essere sballottato di qua e di là dalla precarietà. Più che di “radici”, abbiamo parlato di tradizioni, termine che è molto importante mantenere al plurale e rigorosamente con la t minuscola, e riportare al suo significato di “consegne”, “passaggi di mano”, “atti con cui si affida qualcosa alla generazione successiva”. Quel qualcosa, in questo caso, è una certa convivialità, una certa consapevolezza che la società è divisa, che gli interessi dello sfruttato non sono gli stessi dello sfruttatore, che è importante aiutarsi reciprocamente, lottare insieme… Tra “radici” e “tradizioni” non è una questione solo terminologica, sono due concetti diversi. Le tradizioni sono mobili, si evolvono perché tu ti evolvi, con le tradizioni puoi comunque viaggiare, allontanarti, e quando le trasmetti agli altri non sono più esattamente come le avevi prese in consegna tu. Con salde radici, invece, un albero può crescere alto e forte, ma… rimane fermo nello stesso posto. Certo, la faccenda si complica perché molti dicono “radici” e intendono tradizioni… Sono temi enormi, non sarà una discussione su Giap a dirimere le eventuali controversie :-)
La frase del Prunetti sulle radici partiva da una citazione di Ousmane Sembène, grande cineasta senegalese, che sta in esergo a Timira: “non fai una storia per avere vendetta, ma per mettere radici”. E le radici che puoi mettere in una storia, sono radici da cultura idroponica, o come quando fai radicare in acqua una talea d’edera: ogni volta che vuoi, puoi prendere la pianta e metterla in un altro contenitore. Tra l’altro, annaffiatura dopo annaffiatura, presto la pianta si ritrova a bagno in un’acqua diversa da quella iniziale. E’ pur sempre acqua, la composizione chimica è quella, ma non è *la stessa acqua* (come la nave di Teseo, restaurata pezzo a pezzo, che alla fine non contiene più nessuna parte originale, eppure è ancora “la nave di Teseo”). Inoltre, nella frase originale in francese, Sembène usa proprio il verbo “faire”: non *fai* una storia, ecc.. Quindi l’accento è sulla poiesis, sul farsi del racconto e della memoria, sulla sua dimensione produttiva e cangiante. Se *fai* una storia e ci metti radici, molto difficilmente crescerai forte e immobile come una quercia. Sarai piuttosto un ramo spezzato di oleandro che si rifà una vita in una boccia d’acqua. E in questo senso “radici” mi pare un termine accettabile.
Ecco, appunto, le radici “idroponiche” che uno/a mette “facendo una storia” sono tradizioni, azioni del trasmettere. In questo caso, l’immagine è suggestiva e al tempo stesso – come si diceva sopra citando Marco Dinoi – fornisce la propria didascalia (il riferimento al fare e alle storie). La faccenda resta complicata, e l’uso della parola dev’essere attento, consapevole e mai banale.
Rispondo in merito ai quesiti che mi sono stati posti, qui nel thread principale, non amando particolarmente i commenti nidificati.
@dovic chiederei innanzitutto perché inserisce quella avversativa (“Prima si afferma che il simbolico ha un valore disgregante sul detentore del capitale e molto meno sul lavoratore precario, MA poi si aggiunge che il precariato ha vinto”): io ho considerato le due cose consequenziali e non in contrapposizione fra di loro. Siccome il simbolico lavora in maniera distruttiva laddove la consapevolezza è debole, cioè dove non vi è cooperazione fra coscienza e inconscio (e non lo affermo certo io), sostenevo che al contrario la resilienza del precario che si fonda nell’abitudine ad affrontare il cambiamento (e nella conseguente consapevolezza delle dinamiche interiori del cambiamento, fra l’altro questo è stato espresso in maniera esaustiva da Prunetti nel suo ultimo commento qui sopra) funziona da antidoto al simbolico distruttivo. Dato che per perdere un ruolo sociale bisogna prima averlo avuto, è chi l’ha effettivamente avuto e lo perde che si trova ad affrontare il lutto. Così nel rapporto di forza fra detentore del capitale (l’equivoco sull’utilizzo improprio del termine “imprenditore” è già stato sciolto ampiamente da WM1 nel suo commento qui sopra) e lavoratore salariato, chi perde il ruolo una volta perso il capitale è il primo e non certo il secondo. Nel settore del lavoro salariato, può perdere il ruolo anche ad esempio il quadro di un’azienda che a cinquant’anni viene lasciato a casa ed è costretto a riqualificarsi, anche questo è un lutto, ma noi parlavamo dei precari, per cui mi sembra un po’ ozioso dilungarsi su tutte le possibili casistiche di lutti derivanti dalla perdita del ruolo, nel mondo del lavoro e fuori. Il precario questo lutto non lo vive, perché per definizione non ha un ruoli. Il precariato esistenziale confluito in narrativa di cui mi occupo e a cui fai riferimento ha un’origine molto diversa e delle conseguenze a livello psichico e quindi narrativo (la narrazione in origine è psiche) molto diverse. Non si tratta di una perdita, di un lutto, che il precario è costretto ad elaborare. Si tratta di un desiderio non soddisfatto, cioè una condizione psichica di natura completamente differente dal lutto; si tratta di uno stato di tensione verso un obiettivo che non si realizza, qualcosa che non si ottiene mai, che porta il precario a sublimare il proprio desiderio e a concentrarsi sul presente, perché il futuro semplicemente non è programmabile. Il desiderio sublimato alla lunga crea patologia, è una perdita di identità non nel senso di un lutto, ma dello svanire della possibilità di concretizzare un’identità in primo luogo. La strada che ha imboccato di recente la narrativa del precariato è proprio quella del recupero della memoria, di cui ha parlato ampiamente Alberto, nel senso di ricostruzione di un passato identitario, in funzione del superamento di questa impasse emotiva sul presente, proprio per tornare a pensare l’atto fondativo come una via praticabile.
@klingsor che chiedeva se vi sono degli echi benjaminiani nella questione della crisi della narrazione. Può essere che echi di letture che fanno parte della mia formazione riverberino in quello che scrivo, ma non è intenzionale. I riferimenti teorici del discorso che elaboro in quell’articolo sono esplicitati in nota (c’è un riferimento a Ceserani, ad esempio). È più facile che nell’economia del mio discorso si rintraccino echi foucaultiani sulle strategie di risposta ai discorsi imposti dai media, specie per quanto riguarda l’aspetto transmediale della narrazione del precariato e attraverso soprattutto le riflessioni di Mario Galzigna sulla rete. Tutto ciò comunque è citato in nota.
@punto_fra l’equivoco per cui si confonde la categoria dei commercianti e degli artigiani con quella degli imprenditori è già stato risolto in maniera esaustiva sia da Prunetti che da WM1. Posso solo aggiungere che il mio discorso riguarda un fenomeno che sta avvenendo qui e ora, che ho chiamato entropia forse usando un termine improprio di cui comunque non mi pento perché penso renda l’idea (da non confondere col discorso marxiano sul capitale che divora se stesso), e che interessa i rapporti fra capitale reale e finanza, per cui il capitale è evanescente. Neppure io vedo come chi conduce un’attività a gestione famigliare, non impiega forza lavoro, non ricava plusvalore, possa sentirsi chiamato in causa da un discorso del genere.
cboscolo scrive:
”
Non si tratta di una perdita, di un lutto, che il precario è costretto ad elaborare.
Si tratta di un desiderio non soddisfatto, cioè una condizione psichica di natura
completamente differente dal lutto; si tratta di uno stato di tensione verso un
obiettivo che non si realizza, qualcosa che non si ottiene mai,
che porta il precario a sublimare il proprio desiderio e a concentrarsi sul presente,
perché il futuro semplicemente non è programmabile.
”
ti ringrazio per aver sintetizzato (e ripreso) così bene un tema che
traspare nel post e che mi permette di fare un commento/richiesta
che prima avrei fatto fatica a formulare.
come altri qui, vengo da una famiglia operaia, cresciuto in un contesto provinciale.
ho studiato (parecchio), ho fatto anni di precariato
ed ora sono “arrivato”. ho il mio bel contratto a tempo indeterminato,
con CCNL ed annessa categoria di “forte identità” (FIOM).
però, io, questa “inquietudine del precario” ce l’ho ancora addosso.
in tutto il post ed anche in alcuni dei commenti c’é questo continuo richiamo al CCNL,
si sottolinea sempre la sua funzione aggregatrice e positiva per la lotta di classe.
mi trovate d’accordo, però mi sembra che così facendo si cada nell’equivoco
secondo cui l’identità di un individuo è data dal suo mestiere.
forse è un problema mio, ma da quando ho un contratto a tempo indeterminato
più che un senso di sicurezza, provo un senso di ineluttabilità.
la tradizione operaia non mi ha insegnato a rispettare il lavoro, ma a disprezzarlo.
ed a leggere le storie riportate nei commenti qui sopra trovo solo conferme.
tutto questo per dire cosa?
boh… la mia sensazione é che CCNL, scioperio, etc. non siano una soluzione
allo “stato di tensione” del precario che cboscolo ha egregiamente tratteggiato.
Su questa questione posso solo dire che al netto delle categorizzazioni, delle schematizzazioni e regole generali alle quali è per forza di cose soggetta la critica letteraria, ogni individuo percepisce la propria esperienza in relazione ai propri desideri. Le storie si leggono di solito perché avviene un processo di identificazione, ma anche questo è uno schema, in realtà si possono leggere anche solo per contestarle o per quanto possa apparire stravagante, persino per disprezzarle. Sul precariato si è detto e si continua a dire tutto e il contrario di tutto; quel che è necessario è scindere fra la caratterizzazione in narrativa, che è per necessità improntata ad alcune regole fisse, e la vita vera, in cui dominano altri fattori, ad esempio quello che citi tu. Grazie per la riflessione.
Grazie Claudia, ora mi è chiaro. L’equivoco era nato dal fatto che mi sembrava strano dire che il detentore del capitale subiva un danno dal precariato, visto che ho sempre pensato che il precariato fosse un’arma del capitale. Ma se colleghiamo questo fatto al discorso sulla tendenza del capitale ad autodistruggersi allora tutto si spiega.
Aggiungo una cosa, che esula da Claudia e da questo discorso. Io quel che avevo da dire sul fatto degli imprenditori/padroni l’ho detto, quindi lascio che, se vogliono, siano gli altri a proseguire la discussione. Però ho notato che, se c’è qualcuno che per qualche motivo dissente, arrivan sempre quelli bravi che, solo per questo, appiccicano etichette da “ceto medio” viziato, piccolo borghese, emotivo, bottana industriale, parlano di neuroni intossicati, menti obnubilate dal pensiero capitalista e mazzi e stracazzi vari. Se poi aggiungiamo che io sono pure permaloso, girano le balle. Non mi sembra di aver mai insinuato niente del genere su nessuno da parte mia, quindi cerchiamo di rimanere sulla pura discussione, grazie.
Senza appiccicarti nessuna etichetta, Dovic, mi permetto di consigliarti una cura per la permalosità: prova la fabbrica. Ma non un giorno, un mese, un anno. Provala con quel piacevole pensierino nella nuca che come un serpentello paradisiaco ti dice “se ti licenziano son cazzi” perché a casa il pane in tavola bisogna metterlo, e devi starci il più possibile, in questo posto di merda, dove i padroni fanno i padroni (ogni tanto bisogna chiamare le cose con il loro nome), 48 settimane all’anno, 5 giorni alla settimana, e quel pensierino sempre lì (nonni, genitori, io stesso, 12 anni in fabbrica). Provalo, come donna, che trema appena le si avvicina il capo perché sa già cosa vuole da lei, nel buio di un angolo del reparto, e non sa se riuscirà di nuovo a mandarlo via (storie vere, raccontatemi da chi le ha viste, mia mamma). Poi, impermalosisciti, se ti va.
Sì, bravo, lo sappiamo tutti che hai lavorato solo tu a sto mondo, gli altri se ne stanno a casa in panciolle. Uno può anche aver lavorato e aver conosciuto lo schifo dei padroni, senza per questo arrivare a generalizzare su tutti, ma per alcuni mi rendo conto sia difficile da comprendere. E dopo sono io quello che la butta sul lacrimoso. Ma va, va… se si arriva a certi livelli allora sì che la discussione è diventata inutile.
Ah, siete in tanti lì dentro? Beh, almeno vi fate compagnia. Baci e abbracci.
Però, @vito66: c’è stata una discussione su una frase, alla fine ci siamo capiti tutti (non che ci fossero buoni e cattivi, eh: c’erano dei fraintendimenti, ed era bene chiarirsi). C’era bisogno di tornarci su e andare in modo pesante sul personale, tra l’altro senza sapere se è poi così? Tra i tuoi commenti di quassù e quello, molto interessante, delle 4:00 c’è un abisso. Cerchiamo di non far scattare le dinamiche da blog che finiscono col mandare in caciara la discussione, io sto imparando molto da tutti quelli che stanno intervenendo (intervengo poco perché sto leggendo molto, serve anche questo), sia da te che da @dovic, qualunque lavoro facciate (che tanto il vostro intelletto, come il mio, è messo al lavoro 24/7/31, e dunque…)
Evidentemente, ho anch’io miei difetti. Ho appena letto una cosa scritta 4 secoli fa, in cui si dice che spesso ce la prendiamo per le cose da poco (una nostra frase mal interpretata, mi pareva e pare un esempio calzante) e spesso trascuriamo le cose di più grande importanza. Quelo che volevo dire era esattamente questo: fraintenderci su un passaggio e “deviare” un’intera discussione assai promettente su questo mi pareva troppo. Non si finiva più, ho finito coll’allungarla pure io. Mi spiace. Ma le esperienze personali, qua, mi sembrano più rilevanti che il sapere libresco. E volevo solo brevemente ribadirlo. Per me è finita lì.
Ma guarda te se tra un cambio di pannolino e l’altro devo intervenire a riprendervi… Bona lé tutti e due! Dibattete civilmente, please, oppure lasciate questi lidi, fatevi una camomilla, e ritornate quando sarete più sereni. Scusate, ma non ha senso rovinare il thread con dei bisticci.
Arrivo soltanto adesso, ma vedo che la cosa si è già sistemata, a Maurizio era un po’ partita la scheggia :-)
Dovic, andiamo, tu intervieni su Giap da tanto tempo, dimmi quante volte sei stato offeso o qualcosa del genere… Lo sai che qui facciamo tutto l’umanamente possibile perché si riesca a discutere bene, e sai anche com’è l’atmosfera su altri blog e forum… Adesso ti metti in ginocchio sui ceci e ti baci i gomiti, ok? :-D
“Qui si vive con esempi, non con ragione” per dirla con Paolo Sarpi/Corrado Pin. Non sempre va bene. :-)
Non vorrei che la discussione si trasformasse in un elenco di autobiografie e che ciò deviasse l’attenzione dal libro, che ho letto, e che ritengo straordinario, non solo dal punto di vista del contenuto della sua esperienza ma per come Alberto l’ha raccontata, dalla ricostruzione storica dei passaggi cruciali del nostro Paese, al taglio realistico e tecnico di alcune descrizioni, dall’ironia livornese e maremmana che ritrovo in tante persone che ho conosciuto, ai significati riferiti al mito che WM1 ha evidenziato nel suo intervento.
Il post di Klingsor però mi induce a fare alcune considerazioni autobiografiche, spero mi si perdonino, ché non c’è alcun intento egocentrico ma solo il tentativo di mettere in comune delle esperienze vissute.
Io, come Klingsor, sono laureato in giurisprudenza, ho una trentacinquina d’anni e per necessità, oltre che per una personale mancanza di vocazione alle professioni legali, ho intrapreso strade diverse dai miei studi. In questo non vedrei niente di male, il problema ovviamente è il tipo di strada e la prospettiva che ti si pone mentre la intraprendi.
Ho fatto il distributore di giornali pubblicitari con la ritenuta d’acconto, ho lavorato in una radio come tirocinante, in un call center di recupero crediti a progetto. A tre anni dalla laurea una piccola svolta: un contratto di somministrazione per una multinazionale come addetto alla contabilità, una porta che difficilmente si apre a chi non è ragioniere o laureato in economia. Non che sia una gran fortuna il lavoro impiegatizio dell’amministrativo ma almeno è una professione che ha un mercato che passa da contratti “regolari”, per quanto interinali o a tempo determinato, cioè dai tanto sospirati CCNL, che venivano citati anche in interventi precedenti in questa discussione.
In seguito, passando rigorosamente da un contratto a termine all’altro ho lavorato nello stesso settore in un paio di aziende di proprietà di piccoli imprenditori “arricchiti da strapazzo” cresciuti a credito facile, operazioni più o meno truffaldine con banche conniventi, fino ad arrivare in una grande azienda ex parastatale che mi prometteva una stabilizzazione dopo un periodo di trenta mesi come interinale. Va da sé che la stabilizzazione non c’è stata e adesso mi ritrovo senza lavoro, anche se per qualche mese con un’indennità di disoccupazione più che dignitosa, tenuto conto degli stipendi che ci sono a giro. Questo è un il bilancio a quasi otto anni dalla laurea, direi abbastanza in linea con molte esperienze che la generazione dei nati dagli anni settanta in poi (ma perché mettere questi limiti temporali, abbiamo detto…). Il tutto, va detto, nella totale assenza dei sindacati, che mi sono sembrati intenzionalmente consapevoli nel non voler essere un punto di riferimento per un precario, se non al momento della stipula del contratto nell’agenzia interinale quando diventano una voce opzionale di destinazione di una percentuale della tua busta paga.
Quello che mi interessa di più però è mettere in luce i contrasti che sono apparsi anche su questo post e che riguardano l’appartenenza di classe di ciascuno di noi. Per me è stata una presa di coscienza non semplice, che ha richiesto una verifica quotidiana delle mie origini e delle mie relazioni presenti e passate, le amicizie, le persone con cui ho studiato, i colleghi delle aziende in cui ho lavorato. Per Alberto Prunetti è fondamentale, così come per WM1, la dichiarata origine proletaria. Per alcuni, è questa origine che costituisce un’ancora di salvezza nel momento attuale, nell’attacco distruttivo portato dal Capitale. Con la consapevolezza di essere dalla parte degli sfruttati (semplifico), i figli dei proletari avevano già un’idea di cosa gli potesse capitare e se la sanno cavare, mentre tanti figli del ceto medio ora proletarizzato e impoverito che si nutrivano di “grandi speranze” si ritrovano depressi e senza strumenti per comprendere il “precariato” che gli è caduto in testa così per caso. Penso che in buona parte, questa analisi sia corretta. Certo non vale per tutti, ma per molti sì.
Per quanto mi riguarda, mi dichiaro appartenente al ceto medio, figlio di un’insegnante e di un impiegato del settore privato, entrambi laureati, entrambi andati in pensione senza un giorno di disoccupazione. Una famiglia di sinistra con amicizie mediamente di sinistra. Per molto tempo le mie relazioni si sono svolte entro i limiti del ceto medio urbano, dei figli di insegnanti e di chi aveva un lavoro d’ufficio stabilissimo. Non erano certo cerchie ristrette, in quegli anni sembrava fosse così (quasi) per tutti. A partire dal periodo universitario, quando la cerchia delle mie conoscenze si è ampliata, mi sono reso conto che continuare gli studi non aveva a che fare solo con la voglia o meno di studiare, ma c’era il problema del reddito dei genitori per le tasse universitarie che iniziavano a lievitare, che c’erano studenti fuorisede del sud che avevano esigenza di fare presto per non pesare sulla famiglia, studenti pendolari che si facevano ore di treno per andare a lezione perché non potevano permettersi l’affitto di una camera vicino alla facoltà. Negli anni ho avuto tempo per capire e per riflettere a lungo sulla botta che il neoliberismo ci stava preparando, su come molti dei miei coetanei, molti colleghi che ho avuto, fossero totalmente impreparati a capire e consapevolmente sfuggissero dalla ricerca di una comprensione. Per me il comprendere la mia condizione di “proletarizzato” e “impoverito” è stato il frutto di una riflessione individuale e collettiva filtrata dalla partecipazione politica, dai libri, dall’esperienza sul lavoro. Di certo questa riflessione non ha riguardato la maggioranza dei miei conoscenti, che molto spesso si erano abituati a recitare ruoli di millantatori di improbabili successi nello studio, nel lavoro, in pseudocarriere artistiche per coprire la propria condizione di disagio e di frustrazione. Ho studiato e poi lavorato con molte persone e sono arrivato alla conclusione che il ceto medio abbia una grandissima responsabilità nel declino di questo Paese, soprattutto per aver introiettato il concetto base del liberismo e del capitalismo: l’individualismo a tutti i costi. E oggi tutto questo gli si sta rivolgendo contro senza fargli vedere la luce dopo il tunnel, o al massimo qualche vaga e impalpabile “speranza” dai contorni indefiniti e indimostrabili. Tutto questo per semplificare, anche se ci sarebbe bisogno di un grosso approfondimento e mi rendo conto di averla fatta anche troppo lunga…
Grazie ancora per il libro e per questa discussione, veramente necessaria.
Qui si apre un’altra finestra importante. La critica del lavoro. A me, visto che siamo ospiti dei Wu Ming, viene in mente “Lavorare con lentezza”. E’ un po’ un passare dalla padella del precariato alla brace del posto fisso (è questo, se non ho frainteso, che mi dici?). Io ero molto uno con l’ideologia del non lavoro, da studente universitario, ma mi è durata poco, perché tendenzialmente sono uno che suda, che si sbatte, a cui piace alzarsi presto la mattina per fare delle cose quando l’aria è frizzante. Ricordo allora gli scazzi con mio padre, che era molto stalinista come punta d’orgoglio dell’importanza di lavorare “con dignità”. Però poi, ripensando a tante cose, osservando lui e i suoi colleghi che ho conosciuto, diciamo i babbi dei miei amici, a modo loro avevano tante piccole strategie per lavorare con lentezza, per inceppare la macchina, per ritardare i tempi della produzione. Queste strategie le ritrovo in amici che lavorano con i posti fissi, mentre chi è precario non riesce proprio a togliersi di dosso il ritmo imposto, di pieni e di vuoti, del controllo gestionale dei padroni. Comunque – e chiudo perché stanchissimo – il mondo perfetto non c’è, bisogna tenere alta la guardia da precari e da assunti a tempo indeterminato, e se possibile bisognerebbe farlo assieme.
Credo che però sia una capacità più legata al tipo di lavoro (oltre che ad una parte di attitudine personale) che non al tipo di contrattualizzazione. Io per esempio, informatico, ho il posto fisso ma la gestione dei tempi e modi di lavoro sostanzialmente la subisco.
@Alberto Prunetti
Anch’io mi sono sempre sentito lontano da una concezione “stalinista-stakanovista” del lavoro. Poi però non posso fare a meno di sbattermi e impegnarmi in un qualche “processo produttivo”, sia esso retribuito o non. Purtroppo, finché esisterà un sistema capitalista la maggior parte delle attività di produzione resterà caratterizzata da una logica commerciale e di sfruttamento. Ed è a quel punto che la maggior parte dei lavoratori alza bandiera bianca, entra nel gioco perché deve pur vivere e inizia a credere di essere nel migliore dei mondi possibili. Oggi quasi tutto si gioca sulla forma contrattuale (tirocinio, progetto, tempo determinato etc), la questione del salario è persa anche perché c’è da competere con la Cina, la critica del lavoro sembra addirittura un lusso da società in piena occupazione, stabile e coi salari alti…
@mr mill
Lungi da me attribuire un valore “aristocratico” alle dichiarazioni di origine proletaria. Anzi, mi premeva semmai sottolineare come in senso generale la “classe operaia” sia quella classe che più di altre faccia la “ricchezza” in un sistema capitalistico. E i padroni sanno bene che produce la ricchezza deve essere sottoposto a un controllo e uno sfruttamento ben maggiore di altre categorie lavorative.
Provo ad agganciarmi qui, nel tentativo di dire la mia su una questiona che mi pare emergere nel commento di @pallinov ma che mi sembra sia presente anche in altri commenti. @pallinov scrive che “per Alberto Prunetti è fondamentale, così come per WM1, la dichiarata origine proletaria”. Io aggiungerei non solo per loro; ma soprattutto aggiungerei che coloro che hanno affermato con orgoglio questa origine in questa discussione l’hanno fatto senza accenti “aristocratici” (che fa ridere scrivere aristocratico parlando di “origine proletaria”, ma è per dire, semplicemente, senza senso di superiorità). Non è questa una excusatio non petita, ma mi pare una precisazione importante da fare: per me non ha senso vantare una discendenza proletaria, di per sé non vuol dire nulla. Conosco anche figli di operai – magari pure nipoti di metalmezzadri – che sono rimasti vittime della retorica individualistica del Capitale, addirittura chi trova nella propria storia famigliare una ragione in più per colpevolizzarsi, vivendo un senso d’inferiorità rispetto a “chi ce l’ha fatta” (sarà anche che non tutti gli operai avevano forte coscienza di classe, io vengo da un posto in cui negli anni Settanta tutti lavoravano in fabbrica, ma in cui governava la DC che era votata anche dagli operai). Qui il punto è riuscire a fare emergere come – allora e oggi – la società è il risultato dei rapporti di forza fra Capitale e Lavoro, che c’è un noi e che la prima necessità è affermare questo noi.
Per chi ha una storia famigliare intrecciata con la storia del movimento operaio, per chi ha passato la sua infanzia fra tute blu sporche di grasso (i toni), per chi ha conosciuto il dolore di una perdita di/in fabbrica, ecco per questi penso sia importante riconoscersi in quel filo rosso che unisce le diverse generazioni famigliari, un filo rosso segnato dallo sfruttamento ma, al contempo, in cui allo sfruttamento si è opposta anche l’insubordinazione, in cui all’imposizione violenta dell’unilaterale narrazione capitalistica del mondo si sono contrapposte una miriade di storie marcate dal tentativo di ribaltare il segno di questa narrazione che dir tossica è dir poco. Ed è importante perché c’è un sacco da imparare.
Fatto salvo il rispetto per le tragedie personali, che non vanno ovviamente messe in ordine di classifica, mi pare di poter dire che con tutto quello che la classe operaia ha subito, ci tocca sempre anche fare quelli che vanno ai funerali del capo. Anyway, è perché noi siamo quelli che “dove si mangia in 10 si mangia in 11” come dicevano le nonne quando aggiungevano posti a tavola al poveraccio di passaggio, amico del figlio o capitato per caso, che abbiamo ‘ste supplementi d’anima. Tutta cosa buona, a mio avviso.
Mi scuso subito, ho scritto questo commento dopo aver con calma letto l’intervista a tre, ancora invece non ho letto con la necessaria calma i commenti che ne sono seguiti. Mi pare comunque di non essere andato lontano da quel che altri hanno scritto…
La lettura di Amianto inevitabilmente, per chi è nato e cresciuto in una famiglia operaia, porta a fare un raffronto fra le esperienze della generazione del padre e la propria. Ciò in seconda battuta, perché durante la lettura il raffronto immediato è dentro la cornice della “storia operaia”, cioè il confronto fra le diverse storie operaie, dove emergono con forza i punti di contatto, a prescindere dalle differenze legate ai contesti. Se trovare punti di comunanza fra le “storie operaie” è un fattore che veicola una lettura che vivifica e rafforza la consapevolezza di una storia comune che comprende anche le biografie dei figli (almeno fino a un certo punto) ed è quindi positiva, confrontare le storie lavorative dei padri con quelle dei figli è deprimente. Non ce n’è, la nostra (dei figli) condizione lavorativa è segnata dall’intermittenza o comunque da livelli di reddito infimi, che certo non ci permettono di progettare e investire per una condizione di stabilità; l’insoddisfazione per il proprio impiego, o non-impiego, è un segno ricorrente in cui riconoscersi (che per assurdo si materializza spesso in forme di auto-sfruttamento e vittimizzazione anziché in rivendicazione e rivolta), un’insoddisfazione che si riflette – rubando a Bifo ciò che scrive della forma presente di alienazione digitale (http://www.uninomade.org/aaron-e-bartleby/) – in uno stato di irrealizzazione perenne e di solitudine, depressione e tendenza suicidogena in crescita (mettiamoci anche il ritorno dell’eroina in questo, per non farci mancare nulla). I nostri padri si poterono permettere qualcosa in più (la macchina, la casa, ecc.) ma chi l’ha fatto passando quaranta ore alla settimana in una fabbrica l’ha fatto anche sacrificando molto: vivere la fabbrica era un battaglia quotidiana per l’incolumibilità fisica, non era solo il corpo come spugna che si caricava di sostanze nocive (con conseguenze non immediatamente misurabili) ma anche il corpo come ceppo, colpito e segnato – questo è un ricordo vivissimo della mia infanzia nei racconti quotidiani di infortuni – da ustioni, schiacciamenti e fratture, con le schegge di metallo infilzate negli occhi (cosa così abituale che venivano tolte reciprocamente fra compagni di lavoro con l’ausilio di uno stuzzicadenti). E gli incidenti mortali. Dagli anni Ottanta, quando si è diffusa l’idea (a colpi di cassaintegrazione e dismissioni di interi impianti) che avere un lavoro fosse un lusso, l’impresa era arrivare alla pensione e sperare che essersi sbattuti tanto per far studiare i figli potesse garantire a loro di vivere una condizione di vita dignitosa. E qui sono stati fregati, la seconda volta. O forse la terza, visto che per quanto riguarda la mia conoscenza tantissimi – come per Renato – hanno appena fatto a tempo a dargli un’annusata alla pensione, certo non a goderla.
Trovo interessante la riflessione affrontata nell’intervista a tre su come la letteratura stia rappresentando la precarietà e il lavoro, anche perché se di narrazioni stiamo parlando forse riflettere criticamente su quelle adottate dalla letteratura fornirà degli strumenti per comprendere e poter agire sulla narrazione individualistica e competitivistica diffusa largamente fra i lavoratori, quel frame che ci vuole tutti “sulla stessa barca” mentre al limite siamo tutti nello stesso mare, qualcuno su uno yacht inaffondabile, altri sulla barchetta e chi a forza di braccia si regge fin quando ce la fa. Sti cazzi la stessa barca. Non so voi, ma spesso a me capita nelle discussioni in cui ci si confronta sulle questioni inerenti il lavoro, di trovarmi di fronte a un muro di incomunicabilità, mi pare di dover ridiscendere al grado zero del linguaggio politico per scansare – come dice WM1 – le “false dicotomie”, mentre sembra ci si arrampichi sugli specchi pur di negare il potere del Capitale nel determinare le nostre esistenze. Raccontare storie come quella di Renato, raccontarle così come lo fa Alberto, sono un primo passo per plasmare una narrazione emancipatoria: se non ci si salva tutti, insieme, nessuno sarà salvo e sicuro. Visto che Alberto cita gli IWW, rilancio con uno dei loro motti più popolari: An injury to one is an injury to all. Oggi non è così, perché l’uno rimane uno e non si riconosce in quel tutti.
Un’ultima cosa: la storia del trawl autocostruito, oltre a essere divertente – e allo stesso tempo tragica – mi ha messo di fronte a un’altra constatazione: come nel volgere di poche generazioni sia stata sacrificata un’immensa conoscenza “pratica”, tutta la cultura materiale che permetteva di procurarsi cibo senza passare dal cibo-merce, di fare e costruire e smontare con le proprie mani. Già per questo mi girano, che visti i tempi che corrono non è così assurdo pensare che queste conoscenze che ci siamo giocati potrebbero in futuro tornarci più che utili; metteteci che in queste conoscenze pratiche c’era anche la familiarità con il repertorio d’azione del movimento operaio, questo è un grave danno.
No, cosa m’hai ricordato! Questo è un aneddoto che doveva andare nel libro, me l’hai ricordato proprio tu (a dimostrazione che un libro lo finiscono sempre i lettori). Questa storia dei frammenti di ferro che si piantano negli occhi…. sai che da piccolo mi rimase un pezzo di legno o di ferro nell’occhio e il mio allenatore di calcio (erano quasi tutto o operai in pensione o in cassaintegrazione gli allenatori) prese un pezzo di legno dalla siepe, mi si avvicinò tenendomi la testa con una mano e avvicinandomi questo stecco con l’altra (io quasi mi caài sotto) e mi tolse con un colpo di polso la scheggia. Quando tornai a casa la sera telefonò il mi babbo dal cantiere e glielo raccontai tutto orgoglioso e lui mi disse che lo sapeva fare anche lui e che i suoi colleghi lo facevano a lui, se magari smerigliando o tagliando con la mola qualche frammento di metallo gli si piantava nell’occhio. Poi dopo tanti anni un giorno – ricordo era l’ultimo dell’anno, facevo l’università a Siena – mi si piantò una scheggia nell’occhio, chissà come, magari passando sotto il ponteggio di un palazzo in restauro. Pensavo che se ne sarebbe andata via da sola e invece non andava via. Per farla breve mi feci l’ultimo dell’anno al pronto soccorso con la mia fidanzatina di allora, e dovemmo far tornare il medico che era in allerta e dovette saltare il cenone: ci mise anche un po’, armeggiando con delle pinzette, per toglierla. E quando il giorno dopo chiamai casa per raccontare cos’era successo, il mi babbo infierì: “povero brodo, lo vedi se venivi a casa te la levavo io con un legnetto, fava”.
la prima cosa che ho fatto ieri, dopo aver letto la conversazione, è stata ordinare il libro.
come molti di quelli che hanno lasciato un commento, come molti di quelli che hanno letto la conversazione, ho anche io la mia storia di precarietà. una precarietà che fino ad oggi aveva una sua stabilità.
non sono figlio della classe operaia, ma figlio della piccola borghesia (tra l’altro della piccola borghesia napoletana di periferia, che in qualche misura è un mondo a parte già di suo).università, praticantato, iscrizione ad albo professionale, piccola attività libero professionale (molta della quale per mia fortuna “morale” passata a cercare di dare una mano a chi era ai margini). 10 anni fa mi trovo ad entrare in una pubblica amministrazione come interinale. poi co.co.co., poi co.co.co stabilizzando con finanziaria prodi, poi tempo determinato per chiudere il percorso della stabilizzazione, poi ancora solo tempo determinato perchè i nuovi padroni decidono che la nostra stabilizzazione non vale e i primi 9 lavoratori con contratto in scadenza vengono buttati fuori.ora sarei un lavoratore a tempo determinato prorogato fino a luglio dalla montiana legge di stabilità (tra l’altro prima della legge di sta bilità stavamo per ottenere una proroga fino a dicembre).
terminata qui la mia non avvincente storia personale quello che fa più male è che nonsotante 20 anni di attività politica, iniziata con le manifestazione contro le installazioni dei missili nella base nato di Comiso (giusto per dire che non sono più un giovanotto), mi sono ritrovato fuori da qualsiasi “contesto sociale che ha RESISTITO alla frammentazione sociale che è la base del capitalismo.”
e continua a girarmi in testa la domanda “Che Fare?” per metterre insieme tutte le singolarità per “tenendo in piedi (nelle vie o nei condomini o nelle campagne) quel senso di mutuo aiuto tanto elogiato da Kropotkin”.
Anche queste storie è giusto condividerle, la tua come altre che ho letto in questi commenti. E intendiamoci: non è che tutti i miei amici sono nati con la tutina blu cucita addosso. Ho carissimi amici figli di professionisti che stanno nella merda fino al collo e mica tutti possono farsi aiutare dai genitori. E per giunta con le mani sono disastrosi più di me (che anch’io non sono eccezionale, agli occhi del mi’ babbo faccio proprio caà, ma un fanalino rotto nell’automobile lo cambio da me senza andare dal carrozziere). Senza considerare che a volte questi amici (architetti senza studio, avvocati che fanno le trafile nei tribunali… tra l’altro di una di queste parlo molto bene in Amianto perché mi ha aiutato a rintracciare la sentenza di mio padre) si vivono di brutto dei contrasti in famiglia che io non ho, perché le aspettative che c’erano sul mio futuro si sono subito raffreddate, mentre altri hanno famiglie che non comprendono quello che sta capitando ai propri figli.
Riprendo questo ultimo commento perché si lega un po’ con quello che voglio aggiungere (perdonatemi se userò un linguaggio un po’ sempliciotto). Quando si parla di macro-categorie come la classe, il proletariato etc. sorrido un po’ a volte. Vengo anch’io da lì, intendiamoci, e ne sono fiera. Ma, più che fiera di essere figlia di operaio e sarta, sono fiera dei valori che mi son stati trasmessi: onestà, solidarietà, rispetto, ascolto, per dirne alcuni. Faccio fatica a dare sempre per scontati questi valori, se penso a “quelli” della mia stessa classe sociale. Citerò un esempio per capirsi meglio. Nell’associazione di cui facevo parte, promotrice di solidarietà, cooperativismo, partecipazione, si creavano meccanismi bizzarri. Ci ho ritrovato una strana dominazione del maschio sulla femmina: noi ragazze, spesso inconsapevoli, eravamo usate come merce di scambio tra i ragazzi “intellettualoidi” del gruppo. Se non condividi lo stesso spirito, ti escludono anche un po’ a dire il vero. Dopo averci sbattuto i denti me ne sono andata, e senza sensi di colpa. Perché se per realizzare il mio sogno di uguaglianza e giustizia sociale devo farmi incastrare in meccanismi così sordidi…non c’è storia. Ci sono valori che vanno un po’ oltre l’appartenenza ad una classe, o che quantomeno l’appartenenza ad una classe non danno per scontati. Mi sento di andare un po’ oltre i determinismi e considerare di più la persona. Preferisco persone che sono posizionate in vari strati della società ma sono oneste, sincere e rispettose piuttosto che l’ipocrisia di tanti gruppi votati a ideali di solidarietà e cooperazione in cui, invece, sono presenti altre dinamiche di “dominazione” o di “sfruttamento”. Pardon se sono finita off topic….e grazie per questo splendido spazio di dialogo :)
Riporto la cosa solo perché fa ridere: Giap secondo blog italiano dietro beppegrillo
http://labs.ebuzzing.it/top-blogs/cultura
‘Ste classifiche contano quello che contano, ma è comunque divertente posizionarsi alle spalle di Casaleggio e ogni tanto dargli un coppino.
Io Giap lo vedo primo, altroché secondo.
Al secondo posto vedo il blog di byoblu, volevo dire, quel posto pieno di pubblicità e “informazione libera” gestito da uno che ha scelto il nick “byoblu” e non è per niente condizionato da Grillo, nono… =P
Era ora, finalmente si possono scoprire le carte, si fa il partitone! Altro che precari e operai, tutti i giapsters in Parlamento. Evvai di rimborsi elettorali e trenini e feste in costume.
Proposta: seratona manituana, tutti vestiti da mohawk e squaw, al billionaire?
L.
P.s.
Mi raccomando, non state a litigare che questo è un post meraviglioso.
P.p.s.
Avete visto che zu silvio i mille euro li ha offerti per davvero? Eehh….
Se li dava anticipati ci facevo un pensierino.
Scrivo queste righe dopo aver passato una giornata a Bhopal a parlare con le “vittime” (parola che non mi piace, sinceramente, ma che uso per ora in mancanza di altre più precise) della Union Carbide. Sono antropologo, vivo in India da quasi un anno, in un piccolo villaggio del Madhya Pradesh. Ho preso qualche giorno di “ferie” con la mia compagna, fotografa, per venire a Bhopal a cercare, credo, parole, più di ogni altra cosa, e la loro matericità, la necessità di vederle incarnate nei corpi di chi racconta, per “dar corpo” a una narrazione, per intravedere qualcosa oltre il velo di ciò che già si sa.
Ho letto il libro di Alberto qui in India, che mi è arrivato fresco fresco dall’Italia con una dedica dell’autore. Ho aspettato, leggendo nel frattempo tutto il dibattito qui su Giap. Ho aspettato fino a stasera. E ora che ho aspettato abbastanza vorrei provare a tirar fuori qualche riflessione a partire da quello che ho ascoltato e visto oggi. È un tentativo, qualcuno dirà maldestro, di spostare un momento lo sguardo per rimettere a fuoco un oggetto sul quale abbiamo fissato la nostra attenzione troppo a lungo. Sono appunti sconclusionati, impressioni buttate giù di getto, rabbia sotto forma di pelle d’oca che si riversa grezza in parole per non trasformarsi in impotenza.
A Bhopal la morte è l’orizzonte. Mi si dirà: lo è per tutti, ovunque. Qui però, dove l’unico punto in cui lo sguardo può correre libero è sui trecento metri di parco attorno alle macerie della Union Carbide, l’orizzonte è la casa alla fine del proprio vicolo. (E quei trecento metri non si possono neanche percorrere liberamente, perché la polizia li controlla con attenzione certosina, dal momento che la gente che circonda il perimetro della fabbrica, quella più colpita dal MIC, il gas fatale, ci torna a rubare pezzi di ferro coperti, guarda caso, d’amianto. Abbiamo sperimentato l’efficienza della polizia di persona. “Arrestati” per una buona mezz’ora per aver provato a raggiungere lo scheletro della UC, 350 rupie, 2 sigarette e il numero di telefono di un ministro dello stato ci hanno aperto i cancelli della “cella”, e della fabbrica. Vivendo in India si imparano i trucchi del mestiere, non poi tanto diversi da quelli del nostro paese…)
La morte è l’orizzonte perché qui non si combatte per non morire, ma si combatte mentre si muore. Sono passati 28 anni dall’incidente, ma la prima sensazione che mi ha attraversato i polsi stamattina è che la tragedia è avvenuta ieri. Non c’è soluzione di continuità tra l’evento scatenante e il suo “futuro”. Non ci sono genealogie da ricostruire con fatica, archivi da spolverare e su cui rompersi la schiena per tirare fuori un senso. Qui il legame tra capitale, nocività e precarizzazione dell’esistenza è così palese che non serve ragionarci troppo. L’assassino lo si conosce bene fin dalla prima pagina, e non perché uno scrittore si è fatto il culo per anni e, con mestiere, può presentarcelo al primo paragrafo. Il colpevole ti fissa dritto negli occhi, impunito, con strafottenza, e tu non puoi non guardarlo, col sangue che ti sale alla testa. Quindi, l’unica cosa che si può fare è ascoltare le voci che si alzano, dapprima come sussurri, da dietro le sue spalle. E allora ecco che dal fiato delle voci si solidificano poco alla volta, come gocce che ghiacciano all’abbassarsi della temperatura, dei corpi. I corpi di chi ha respirato il MIC, di chi ha bevuto l’acqua contaminata della zona, di chi è nato da questi stessi corpi. I corpi parlano, e raccontano. E dicono che hanno mal di testa, e vomito, e che per fare 500 metri devono fermarsi tre volte, e hanno fibrosi polmonari, disturbi neurologici e tumori, che hanno i reni rovinati, o sette dita dei piedi e deformazioni di ogni genere, le gambe doloranti, gli occhi che bruciano e che non vedono più, che gli hanno tolto vene, che perdono i capelli, che hanno acidità continua e gli si gonfia il ventre. Tu ascolti questi corpi parlanti, pieni di cicatrici, e non capisci davvero cosa hai davanti, in quale mondo sei finito. Un mondo in cui la malattia è la cifra stessa dell’esistenza, la condizione di normalità. Quando poi parlano dell’incidente e di quello che è avvenuto dopo, le storie sono, come molte narrazioni di persone che hanno avuto un trauma (o attraversato grandi eventi collettivi), racconti del proprio racconto, di quella struttura narrativa che negli anni, a forza di provare a raccontare ciò che è impossibile dire davvero a parole, si è cristallizzata in una forma precisa, fatta non solo di parole, ma di pause, gesti, sguardi. Eppure, sotto o oltre questa struttura “stereotipica”, questi corpi essi stessi campi di battaglia, c’è qualcos’altro, come una forza strana che spinge queste storie di sofferenza e ingiustizia verso il futuro: un futuro allo stesso tempo di redenzione e di dannazione. Ecco il paradosso, qualcosa che, senza capirlo subito, ho trovato anche nel libro di Alberto. Qui, se vogliamo parlare di mitologemi, più che della morte del padre si parla della morte dei figli. Della morte della capacità di generare o, piuttosto, di generare un destino. Ecco. La chiusura dell’orizzonte, la prospettiva di combattere per ottenere giustizia sapendo che essa non ci permetterà di non morire, e di non vedere i nostri figli morire. Amida Bi, un’operazione al cuore e il fiato grosso, batte palmo a palmo la città vecchia, va a trovare vecchie compagne di lotta che non possono più alzarsi dal letto (nocività vuol dire anche questo: coloro che colpisci non avranno le energie e tempo a sufficienza per risponderti), e dice ad ognuna che combatterà fino a che morte non la separi dal corpo, devastato dal gas. La gente a Bhopal combatte, e lo fa perché sa che è giusto farlo. E lotta perché vuole vincere, ottenere giustizia, e medicine, e sostegno per sé e le proprie famiglie. Allo stesso tempo, però, il futuro è un muro da scavalcare, e i propri figli avranno anche loro il fiato grosso, e poco tempo ed energie per arrampicarsi.
Mia madre, insegnante elementare, dice sempre che se i bambini a cui insegni non fanno parte di un tuo sogno di insegnante (sogno di un mondo migliore, di giustizia, di futuri immaginati), allora ha poco senso insegnare. Qui, dove sognare vuol dire sperare di avere un figlio sano e di non svegliarsi al mattino con un nuovo sintomo, il punto è proprio questo: come immaginarsi un futuro di giustizia quando quella dannata è la prossima generazione?
Ecco la forza terrificante di questo (neo)capitalismo devastante: ci fa credere di aver ucciso i nostri avi, quando in realtà sta già seppellendo i nostri discendenti.
Scusate la lunghezza del post. Mi fermo qui, più per stanchezza che per aver finito le parole. Solo una precisazione ancora: quando dico Bhopal, intendo la Bhopal vecchia che dalla ex Union Carbide sale verso la stazione dei treni e quella dei pullman, e tocca circa 36 “circoscrizioni” colpite dal gas. La Bhopal nuova, quella è un’altra storia, di un capitalismo “cosmopolita” che della strage della UC se ne fotte con 6 T (e, come dice Alberto, porta pure 5).
Sbriccoli!
Buffo incontrarti qui. Non sapevo tu fossi a Bophal. E’ su questo che stai lavorando adesso?
Oh Dimitri! Sono a Bhopal di passaggio. In realtà lavoro su altro qui in India, ma visto che in termini di distanze indiane Bhopal e’ a due passi da dove sto (200 Km) stiamo provando con Daniela a raccogliere un po’ di storie e immagini.
Posso pubblicare il tuo post su http://illavorodebilita.wordpress.com/ ?
[Spero che il libro a breve mi arrivi tra le mani, sto provando una quantità esorbitante di emozioni nel leggervi, non sono sicuro di reggere].
Aggiungo solo:
La tragedia del precariato esistenziale (lavorativo, economico, dei rapporti umani) è intrecciata tantissimo con la precarietà politica. Intendo dire che il contesto politico, almeno da Genova 2001 in poi, ci ha costretti ad una doppia sofferenza. Molti di noi hanno tentato in questi ultimi 15 anni da diverse sponde di raddrizzare questo vascello alla deriva che è la condizione italiana, e (quasi) sempre siamo stati sconfitti. Di regola non c’è stata emancipazione politica – nei movimenti, nei partiti – nè per i singoli nè per i gruppi organizzati. Molti di noi hanno provato a risollevare la propria e altrui (simile) condizione a partire dall’esperienza e dal conflitto politico sul campo. Ma col passare degli anni, il cerchio si è stretto sempre di più: non è bastato il dominio ideologico neoliberista a renderci la strada una strettoia senza luci al fondo; nel frattempo è arrivato anche un certo “ricambio” giovanile a sostituire chi non ce la faceva più e, deluso o semplicemente alla ricerca spasmodica di stabilità lavorativa, si stava allontanando dal campo del conflitto. Il problema è che tale ricambio nasce cresce e si trova definitivamente all’interno del frame più totalmente *individualista* e ne ha introiettato in maniera spesso involontaria i caratteri più antitetici ad un uscita *collettiva* dai problemi. Per questo mi sento molto d’accordo con chi sottolinea che, oltre alle famigerate condizioni occupazionali, esiste questa fragilità nei rapporti sociali tra i singoli, che personalmente ho vissuto e subito soprattutto nella militanza. Questa non è una sparata antigiovanilista, anzi, per quanto mi riguarda l’età non è un fattore determinante per la riuscita di una lotta o di una campagna politica; semplicemente mi sembra un dato di fatto: qualcosa di molto virale che ha creato vittime nella società intera, necessariamente si è fatto strada anche nei movimenti/partiti. A quel punto, alle difficoltà oggettive nel competere contro le manifestazioni plurali del Capitale, si sono aggiunte anche le “fatiche” nel trovarsi a comunicare, all’interno del “tuo” schieramento, con linguaggi spesso reciprocamente incomprensibili. E’ per questo che tutte le asce che vengono dissotterrate – Amianto è tra queste – sono un reale antidoto contro la sparizione e la depressione delle istanze di chiunque: sia esso cittadino, studente, lavoratore, precaria. Perchè rimettono in sesto qualcosa che non si può completamente nascondere o far finta di non vedere, anche se non appartieni “direttamente” a certe storie. Questo qualcosa sono le origini, i contesti nei quali le cose hanno cominciato ad evolversi, che sono molto più pregnanti e concrete dell’ideologia da eterno presente dove oltre all’assenza di futuro è maturato anche un disinteresse per le cause che ci han portato fin qua. E’ importante. E’ importante che qualche persona molto giovane che viene a conoscenza del problema-amianto (mettiamo anche dal luogo peggiore, la televisione) sappia che le cose non nascono di colpo a Casale Monferrato oppure ai Tamburi di Taranto nel 2012, ma che le origini (parola che forse aggira l’ambiguità di “radici”) stanno molto indietro e stanno in una storia, che è carne viva dei lavoratori e dei nuclei sociali ad essi afferenti, è facce/pance/gambe/braccia, per dirla con una citazione da un testo musicale. Chissà che la conoscenza delle dinamiche che state raccontando non faccia sentire il “bruciaulo” ai dormienti.
Non so, forse ho detto cose banali, e di sicuro non risollevanti. D’altronde, “nei tempi bui bisogna parlare dei tempi bui”.
Questa discussione rimarrà nella storia.
D.
“nei tempi bui bisogna parlare dei tempi bui”
Sai quante volte me l’han fatta questa battuta? :-)
Io almeno due, ma come ci dicemmo a suo tempo, affinchè sia corretta, mancano addirittura tre virgole :-)
Concordo con la difficoltà a comunicare all’interno del “mio-tuo-nostro” schieramento.
Resta da risolvere il problema di mettere insieme i risvegliati.
Mi piace pensare a Amianto come a un’altra ascia di guerra, come dici tu… è un concetto semplice e potentissimo, ma che spiega qual è il senso di queste narrazioni (e l’avrebbe capito anche mio padre, che nutriva il suo immaginario di cinema spaghetti-western). Scrivevo di recente a WM1 che Asce di guerra è forse il libro del collettivo che più ho apprezzato. E’ stato scritto mentre io scrivevo Potassa (nell’ignoranza reciproca) e trovo tantissime somiglianze tra le due opere, entrambe oggetti narrativi non identificati. Strappare dal terreno quest’ascia ha implicato tante operazioni narrative e emotive. Come restituire nel processo della scrittura e poi riattualizzare nella lettura il riso, la maledizione, la rabbia e la commozione? Credo che sia importante mettere assieme tutti questi stati d’animo per impugnare l’ascia senza essere soltanto dei “guerrieri del proletariato”. L’ascia può anche avere un potere negativo, può mangiarsi colui che la impugna. Se avessi scritto un libro in cui davo delle merde ai padroni ogni due righe (ora non mi si accusi di averlo fatto, come già in altri passi critici del dibattito… e poi non mi si accusi di non averlo fatto, eh?), probabilmente avrei scritto un bollettino di guerra, muscolare e identitario. Quello che volevo fare io invece, era anche raccontare quanto faccia male tirare fuori quest’ascia dal terreno calpestato della memoria popolare e operaia… (e mi fa male talvolta anche parlarne in pubblico, cosa che faccio e farò, ma a piccole dose, e mi scuso con tutti quelli che in questi giorni mi stanno invitando perché ogni tanto devo rifiutare gli inviti: ho visto che dopo aver presentato il libro e esibito i meccanismi di genealogia della narrazione, non è che poi dormo proprio un bel sonno… un conto è parlare di antifascisti maremmani degli anni venti, un conto di una cosa tanto personale, che ha a che fare con una memoria quasi “fetale” – e riprendo un’espressione di WM1).
Punkow, Compagno,
passa a prenderti una birra che se non lo trovi a breve te lo presto io il libro. Poi te lo compri però, che vale la pena avercelo.
Ciao, Vorrei brevemente parlare di un altro tipo di precarietà che ho vissuto idirettamente sulla mia pelle a e che credo diventerá sempre piú centrale se il capitalismo continueráa a sopravvivere nei prossimi 200 (e passa) anni. Mi riferisco a una precarietá d itipo biologico, che nel mio caso é stata ció che ha prodotto la precarietá esistenziale, e anche lavorrativa di cui si sta parlando parecchio in questo post. Essendo nato con una malformazione cardiaca di quelle abbastanza gravi ho subito un’operazione appena nato, con annessa trasfusione. Questo tipo di operazione, che nel mio caso ha avuto successo, determina una condizione di paziente sotto controllo permanente, con una prospettiva di vita sconosciuta visto che si sconosce la capacita’ nel tempo di resistete di un cuore che ha subito questo tipo di trattamento chirurgico. Ad aggiungersi a questo primo “layer” di precarietá biologica se ne aggiunge un altro. Stiamo parlando dell’italia degli anni 80, di Poggiolini e De lorenzo. Stiamo parlando di commercio di sangue infetto. Nel mio caso, le trasfusioni necessarie all’ operazioni che mi hanno salvato la vita mi hanno reglato un’epatite C, diagnosticata all’ etá di 15 anni e riconosciuta da quello stesso stato che mi ha contagiato. Tale situazione ha prodotto un forte senso diprecarietá biologica permamente che nel tempo ho coscientemente trasformato in precarietá spaziale e psicologica e quindi anche lavorativa. In questo quadro le offete del capitale hann iniziato a perdere senso; quelle di una vita alla ricerca di un minimo “garantito” (che in realtà non esiste per nessuno), e di una qualitá di vita capitalista media dove acquistare una macchina, una casa, avere un lavoro e magari un cane è il”dovere di tutte”. Tale condizione ha invece rafforzato in me un rifiuto verso le logiche capitalistiche e la voglia di ribaltare la precarietá biologica in una nomadismo spazio-temporale in cui essere capace di vivere il piu’ possibile (e nei limiti del reale) fuori dalle logiche capitaliste di sfruttamento degli altri e di me stesso. Per chi pensasse che questo é un caso isolato si sbaglia. Condivido questa condizione con moltissime persone che purtroppo, spesso, non fanno la “quaadratua del cerchio” e non collegano il risultato della propria condizione alle logiche di funzionamento del capitale. Quello che lo stato ha fatto sui nostri corpi, attraverso i suoi agenti De Lorenzo e Poggiolini, non é solo una triste e sfortunata casualià’ da collegarsi all’ attegiamento criminale di persone che teoricamente dovevano lavorare per la salvaguardia della salute delle persone. Quello che é successo é tutto dentro le logiche del capitale e ne rappresenta perfettameente le strutture profonde di funzionamento: in qualche modo ne rappresenta un perfetto modus operandi. Come il caso delle mafie, che manifestano la quinta essenza del capitalisto (NOTA: questa é uno dei limiti che imputo alla lettura di Saviano delle attivitá mafiose), commerciare con il sangue e i corpi delle persone esprime uno stadio avanzato di sfruttamente dell’ uomo sull’ uomo che questo stato liberista inculca, professa, riproduce. Credo che nei prossimi anni, a partire dala manipolazione dei geni e dei corpi, dei cibi trangenici e dalle nanotecnologie, questo sará un campo di crescente sperimentzione da parte del capitale. Ovvero di estensione del dominio della lotta del capitale sulla vita, attraverso la progressiva precarizzazione dei corpi e dell’esistente.
Saluti e grazie per giap!
rajoul-al-mashi
purtroppo nella desertificazione delle librerie indipendenti milanesi non sono ancora riuscito a trovare amianto, lo ho ordinato 2 settimane fa’ e ancora nulla, buon segno per alberto spero.
io vorrei ricollegarmi al tema del linguaggio che spesso e’ emerso nel dibattito e nel testo originale. Ci sono 2 espressioni tossiche ormai utilizzate in qualsiasi discorso che riguardi futuri possibili o marketing *virali* di ogni tipo e sono start up e green economy, ho provato a fare una lettura sintomale di queste espressioni e sono arrivato a conclusioni simili a quelle della discussione. START UP e’ la svendita di un illusione di essere tutti dei piccoli steve jobs e’ la declinazione del mito tecnicizzato della net economy, la propaganda politica parla addirittura dell’ italia come una gigantesca start up, ma cosa vuol dire ? e’ retorica crudele che va’ a pescare nell’esercito dei sognatori bombardati dalle cazzate delle televisioni , ma la realta’ e’ sempre la stessa, le start up ci sono da sempre ma serve sempre e solo il capitale per farle partire. l’ altra espressione e’ GREEN ECONOMY , questa fa’ molta piu’ rabbia, perche’ brandisce il simbolismo affascinante dell’ ecologia in un immaginario collettivo che sogna verde ma e’ intrappolato in un reale che e’ l’ilva e la tav, in un reale nel quale l’ assoggettamento della vita umana al capitale e’ ancora cosi’ forte da far barattare la vita di una citta’ con il proseguimento di un’ attivita’ industriale, questi infami che parlano di green economy dovrebbero parlare solo di black economy o blood economy, giornali, pubblicitari, imprenditori e politici che mettono arcobaleni nei simboli e poi lasciano sprofondare citta’ millenarie nei gas tossici. E ripenso all’intervista di DFW citata da wuming1 in NIE, la metafora del party selvaggio che finisce e lo scoramento di quelli che aspettano i genitori che rimettano le cose a posto ma i genitori non tornano piu’ , beh io mi sono sentito veramente cosi’ per molto tempo prima di capire che la casa la dovevo sistemare io.
ringrazio girolamo per quello che scrive su taranto che e’ anche la mia citta’ di origine e dove i suoi pezzi sono apprezzatissimi e stanno circolando in case dove non sarebbero mai arrivati.
Raffaele, ti rispondo di fatto solo sulla questione tecnica delle copie (ma aggiungo che sottoscrivo tutto quel che dici sullo “start up” d’impresa e di personalità sociale… quanto alla green economy, ha spinto al suicidio migliaia di contadini indiani indebitati, costretti a comprare sementi industriali e concimi chimici…).
La situazione delle copie di Amianto è molto problematica, non per miei “successi di vendita” ma per difficoltà strutturali che una piccola editrice incontra nel momento in cui supere le capacità di circolazione del circuito indie e la catena promozione/distribuzione/librerie si ingolfa da qualche parte con strozzature e colli di bottiglia. Prima ancora che cominciasse questa discussione Amianto è scomparso dalle maggiori librerie on line e non c’è versi di rivedere il libro disponibile, nonostante il fatto che qualche copia l’editore nel magazzino ce l’abbia e da giorni stia facendo solleciti. Noi ne parliamo ma la gente ha difficoltà a trovarlo, e quindi a leggerlo e di seguito a parlarne. In tanti mi hanno scritto e io consiglio di rivolgersi direttamente al magazzino di Agenzia x, o per ordinare direttamente da loro o per chiedere informazioni. Ecco la mail: ordini@agenziax.it. Ripeto, Agenzia x è una piccola editrice e le difficoltà sono tante. Io pensavo che i problemi esistessero solo quando un libro vende poco; in realtà è problematico diffondere il libro in ogni libreria quando le richieste aumentano. Anche per questo bisogna sostenere il catalogo dei compagni di Agenzia X.
In ogni caso si può ordinare in molte librerie fisiche, piccole o mainstream. E’ forse più semplice.
Anch’io cerco Amianto da un bel po’ senza successo, e davvero mi dispiace che un testo così ben accolto e così discusso (da La Lettura a Giap a L’Indice, siamo al -argh- “caso letterario”) non sia facilmente reperibile.
Questa mattina l’ho infine trovato disponibile su IBS e ordinato (scusate la pubblicità, ma dato che molti sono nella mia stessa situazione segnalo un luogo dove lo si può acquistare). Speriamo arrivi…
Con AgenziaX ho un pesante debito per lo scarico gratuito di decine di testi digitali in CC (in formato pdf). E molto volentieri avrei pagato per l’ebook di Amianto. Non mi permetto di dare consigli ma una pubblicazione in edizione digitale sarebbe certo gradita ai lettori che preferiscono questo tipo di fruizione (anche per ragioni economiche, dato che non raramente gli ebook sono offerti a un prezzo più basso) e a quelli che pur di leggere l’introvabile libro sarebbero disposti a rinunciare agli amati alberi morti:)
Io e qualche altro, verso la fine del dicembre scorso, via twitter avevamo suggerito/spinto su Agenzia X per un’edizione in e-book di Amianto (che già scerseggiava nelle librerie), la risposta era stata “e-book coming soon”. Alberto certo ne saprà di più…
[Ho sbagliato, rispondendo a mr mill fuori dalla catena. Incollo qui il commento e aggiungo che ho segnalato a Agenzia x, chiedendo un loro intervento su Giap. Dal momento che non lavorano solo in casa editrice (il libro precario “non furbetto” ha anche l’editore precario), bisognerà attendere quando saranno disponibili.] A.P.
Io pensavo all’ebook come alla ristampa tascabile dopo la prima edizione hardcover. Nel caso dello scambio via twitter, l’editore credo facesse riferimento a un progetto di trasformare il sito di Agenzia x inserendo una piattaforma ebook. Al momento non credo che sia ancora disponibile, però forse è possibile per l’editore distribuire l’ebook di Amianto su altre piattaforme. Probabilmente un editore commerciale avrebbe inondato di copie il mercato. Questo non è possibile per un piccolo editore, militante e “precario”, che deve pagare in tempi brevi il tipografo e poi vede i rientri arrivare in tempi sempre più lunghi dal distributore. O che incontracolli di bottiglia nella distribuzione per il suo statuto di “piccolo” e “militante”. Adesso vado a comprare i giornali in edicola e poi invito Agenzia X a discutere la questione ebook su Giap.
Alberto, ecco i miei tentativi, libreria utopia lo avrebbe avuto sicuro ma purtroppo ha dovuto chiudere, quindi ho provato hoepli ma nn avevano idea della data di consegna, alla fine sono andato su *evazon* che lo dava disponibile (paraculi) ma ancora non si e’ visto.
Guarda, Raffaele, ne ricevo di storie così. Poi magari Amazon lo mette nei topo 100 del venduto per due giorni e risulta terzo dietro a Steve Jobs e Lapo Elkan (e il mi’ babbo con la roncola in mano dietro). Ho già chiesto chiarimenti a Agenzia X che mi ha parlato di colli di bottiglia che stanno a valle di loro. Per esempio, adesso Amazon non lo ricarica, al contrario di altri come Libreria universitaria. Forse perché devono prima “evadere” le copie già vendute? Boh. Intanto però lo puoi trovare in qualche edicola e c’è anche chi l’ha rimediato in Francia. Io non sono un conoscitore dei meccanismi della distribuzione. Ovviamente i libri che raccontano la provincia in maniera furbetta (aggirando la fabbrica dopo averla messa nel titolo) poi te li ritrovi nel supermercato o dal benzinaio. Attendiamo Agenzia x, ma se qualcuno vuol farsi avanti per capire meglio la situazione è il benvenuto. Di certo quando si innesca un dibattito del genere, e il libro inizia a circolare nei commenti e nelle revisioni, bisogna andare oltre la logica dell’autore che fa tante presentazioni portandosi la scatola del libro dietro. Quello va bene, l’ho sempre fatto e lo farò, ma bisogna pensare a alternative. Forse l’ebook è la soluzione? Io non ne vedo in effetti altre. Aspettiamo anche Agenzia X, di solito sono più liberi per commentare nel pomeriggio.
io l’ho preso 2 settimane fa alla feltrinelli di milano a (NON IN) piazza duomo, non so dirvi però quante copie ne avessero perchè me l’ha preso il commesso.
hai provato da Les Mots?
due settimane fa c’era.
ciao Raffaele, non abbiamo chiuso…
ci siamo trasferiti! riapriamo il 13 febbraio in via Vallazze, 34
Non ricordo se avevamo Amianto, ma credo di sì, i libri di Agenzia X non li perdiamo.
Domani controllo il magazzino per vedere se c’è ancora una copia disponibile, e se non c’è vedrò di procurarla…
Una domanda: Ma comprare il cartaceo direttamente online sul sito di agenzia X?
In fondo è quello che abbiamo invitato a fare nel post, e che Alberto ha ri-invitato a fare nei commenti.
Ciao a tutti, bellissima conversazione (tutte e due, quella sopra e quella sotto) anche se sono in difficoltà e non ce la faccio a stare al passo e seguire tutto tutto quindi fatico anche a lasciare un commento. Qui non resisto perchè l’ambito di questo sotto-thread continuo a pensare che sia centrale: la circolazione delle idee, il costo dei libri e la loro reperibilità. Ero io su twitter (@massi_goodthing) quello che insieme a mr mill ha cercato di sollecitare prima Alberto Prunetti e poi, di rimbalzo e ovviamente, Agenzia X per un’edizione elettronica. L’uovo di colombo, probabilmente. I miei complimenti a jumpinshark che, come è suo costume e armato di garbato fioretto, ha introdotto l’argomento in maniera elegante ed efficace. A me (maremmano come Alberto Prunetti, ma del sud dunque depresso :)) è capitato in altri ambiti di indirizzare nella medesima direzione in modo, mi rendo conto, un po’ brusco ingenerando l’equivoco dispiacevole del “…tu vieni a dire a noi…”. Ma il mio cuore è puro: l’edizione elettronica di un libro come questo è tutta salute. Nel mio piccolo ho cercato di spingere il più possibile la lettura di “Amianto” (la mia copia è attualmente in prestito a un amico) perchè credo che della diffusione di storie come questa ci sia un enorme bisogno. Bellissimo il commento di Claudia Boscolo, e di primaria rilevanza: combattere la frammentazione, ripristinare la linearità della prospettiva del racconto pubblico significa mettere in atto una necessaria e sana resistenza del discorso. Segnalo, a proposito, gli articoli su slogan e discorso pubblico apparsi su “il lavoro culturale” (http://www.lavoroculturale.org/spip.php?page=recherche&recherche=slogan+discorso+pubblico). Tutta moneta corrente qui, ça va sans dire :) Mi taccio, allora, e chiudo (a mo’ di omaggio) come ebbe a chiudere il dottor Prunetti il nostro scambio di tweet a tema electronics: http://youtu.be/DF42fhtEhTM
Non sapevo, Sir Robin, che dietro un nomigliolo tanto aristocratico si nascondesse, come dicono nel senese, uno di quelli “che non son buoni né da bestie né da gristiani” (i maremmani, ndr).
Non avevo colto tempo fa l’importanza del vostro suggerimento perché sono molto legato al libro cartaceo. Ma adesso mi sembra che l’ebook sia una soluzione, e anche molto “democratica”: permette l’accesso ovunque, senza distribuzione, e una piccola “limosina” di sostegno per l’editore (che con un libro che tira di più sostiene i titoli in catalogo che tirano di meno) e per l’autore, che mentre discetta di precariato su Giap si vede rifilare dal tecnico della Ariston alle mie spalle una ricevuta di 120 euro (ho provato a rifirargli il cinghiale congelato nel frezer, dicendo che era rotto e si è scongelato, così si faceva pari… ma questo viene dalla città e non accetta; l’altra ipotesi e stringergli la mano alla Totò e far finta di aver pagato mettendolo alla porta, ma è anche grosso… vediamo).
O Prunetti, se guardi l’avatar su Twitter del sedicente “Sir Robin” vedrai che ha il villo in mostra sotto la camicia aperta :-)
E’ vero, @Wu Ming1, anche Sir Robin ha l’attaccatura arbitraria del pelo sul petto come me. Ovvero che d’estate mi rado (e di conseguenza “stacco”per simulare una faccia umana) più basso e d’estate alzo la linea per farmi la sciarpina invernale. Sul tema si potrebbe aprire una nuova catena di discussione… ho resistito da sempre a ignobili tentativi depilatori della mia compagna, che è pugliese e che, a quel che mi dice, dalle sue parti il mio pelo sarebbe sconveniente. Per come la vedo io, senza il pelo a girocollo si rimane meramente bipedi implumi.
Terza ipotesi: se il tecnico è grosso, usa la trowel modificata!
La sintassi si è un po’ persa nel mio commento sul “pelo” (e questo la dice lunga su quanto l’argomento mi stia a cuore). Però da che pulpito…anche il basettone di WM1, così working class inglese, eh? Ora smetto perché stiamo andando off topic.
Cercando di postare il brevissimo commento
“Ciao, grazie per la segnalazione”
è uscito un messaggio che mi dice “Uhm… il tuo commento è troppo breve. C’è un’alta probabilità che sia totalmente privo di senso. Sforzati un poco di più, grazie.” Allora mi sforzo e dico a Sir Robin che il petto villoso non passa mai di moda :)
Miracolo! Una serie di portentose bestemmie ha restituito tra ieri sera e mezzogiorno la disponibilità di Amianto sulle principali librerie on line. “Speriamo duri”, disse quella che andava col torello (leggetevi il libro e capirete a che mi riferisco).
Attenzione, la tremenda serie di bestemmie non paga. Dopo cinque giorni Amianto rispunta su Amazon ma l’acquisto mattutino di Jampinshark e il suo rilancio on line compromettono la disponibilità di IBS. Adesso è scomparso di nuovo da IBS: ha retto 8 ore il semaforo verde rilanciato da Jumpinshark (su sette giorni). Amazon non lo dava disponibile da domenica. Il problema è serio: in casa editrice mi dicono che di recente si vendono pochi libri, però se basta Jumpinshark (senza offesa per lui, anzi) a mettere indisponibile Amianto su IBS (e ogni volta ci vuole cinque giorni perché il titolo torni disponibile, il problema c’è e come e ovviamente non permette la circolazione del titolo). Dobbiamo capire come uscirne. (Oh, se non volete Amazon, lo danno disponibile su Libreria Universitaria, vediamo quanto ci vuole per affondarla).
grazie trovato a via ripamonti alla sede di agenzia x bastava sforzarsi :-p
Raffaele, dalla Calabria non possono salire in via Ripamonti per il libro d’un biscchero grossetano. E se trovano chiuso? Io vedo due vie d’uscita, che non si escludono:
_ristampa corposa e/o;
_ebook, o su piattaforma di Agenzia x (che ancora non c’è ma è in progettazione, e ci spiegheranno spero nel pomeriggio dalla casa editrice in che tempi;) o se possibile su altra piattaforma, via un file editato da Agenzia x (ma su queste cose ci capisco poco). Mi rivolgo a chi è più “sgamato” di me. Può Agenzia x distribuire l’ebook di Amianto facendo un accordo con un ente terzo, una sorta di distributore, e fissando garanzie sul prezzo, di modo che rimanga popolare? Che so, tipo Bookrepublic o roba simile? Può anche guadagnarci qualcosa? Di modo che qualche spicciolo in cassa di Agenzia x permetta magari di stampare nuovi titoli più di nicchia che girano poi nel circuito dei centri sociali (e magari l’autore riesce a pagare il tecnico che gli cambia le resistenze nell’elettrodomestico senza assassinarlo con la trowel modificata, come ci suggerisce la dolce Anna Maria?). Delucidatemi… ovvero datemi delucidazioni.
Anna Luisa, volevo dire Anna Luisa… non Anna Maria (oddio ora mi ammazza). Sorry, A.
Eeeh tranquillo… al mio nome modificato (come la trowel) oramai ho fatto il callo, Luca (wm3) può testimoniarlo… ;-)
Io pensavo all’ebook come alla ristampa tascabile dopo la prima edizione hardcover. Nel caso dello scambio via twitter, l’editore credo facesse riferimento a un progetto di trasformare il sito di Agenzia x inserendo una piattaforma ebook. Al momento non credo che sia ancora disponibile, però forse è possibile per l’editore distribuire l’ebook di Amianto su altre piattaforme. Probabilmente un editore commerciale avrebbe inondato di copie il mercato. Questo non è possibile per un piccolo editore, militante e “precario”, che deve pagare in tempi brevi il tipografo e poi vede i rientri arrivare in tempi sempre più lunghi dal distributore. O che incontracolli di bottiglia nella distribuzione per il suo statuto di “piccolo” e “militante”. Adesso vado a comprare i giornali in edicola e poi invito Agenzia X a discutere la questione ebook su Giap.
Ho sbagliato, dovevo mettere questo commento nella catena sulla reperibilità del titolo e sull’ebook. Scusate, ora incollo il commento dentro alla catena. A.
Se qualcuno è nei paraggi oggi alle 18 si terrà una marcia a Casale Monferrato “per non morire d’amianto” in vista dell’inizio del processo d’appello Eternit, il 14 febbraio. http://www.globalproject.info/it/in_movimento/casale-monferrato-di-nuovo-in-marcia-per-non-morire-damianto/13482
Ho letto il libro fra un viaggio in treno (da pendolare to-mi, obbligato ai frecciarossa di merda in ritardo perenne da un titolare che non vuole darti mezz’ora di ritardo manco a morì e ti obbliga a trecento carte di spesa e a viaggiare su un tav dimmerda) e una notte insonne. Il prunetti ha pubblicato a puntate su carmilla la storia di suo padre, e adesso amianto. Pensando che su queste pagine digitali scrissi che la classe operaia non è molto attuale, strido un po’ ma riconosco che quel che dico era un pezzo del discorso. Seppure non è successo a voi tre, che lavorate con la testa, il resto del mondo nato da famiglie non blasonate si è dimenticato assolutamente la provenienza: inoltre i nostri genitori magari non erano lettori incalliti, e fare i conti con un mondo di lettere un po’ ti imborgesisce, trovo.
Io sono figlio di un progettista meccanico che ha fatto le superiori alle serali mentre vendeva patatine porta a porta, macchine da cucire, oppure faceva l’operaio in nero in una delle tante officine illegali di torino, quelle nelle cantine e nei cortili di san salvario. Sono nipote di un camionista, partigiano, che ha obbligato mio padre a fare le serali per paura (paura vera) che finisse a fare lo stesso lavoro di merda che faceva lui, che portava in giro i camion, avanti e indietro da casale (giarda un po’), poi si è rotto i coglioni e si è messo a fare il commerciante, quello al mercato, a fottersi il culo di freddo, che torino non è miami e qui al mercato si applaude con il culo, talmente che fa freddo.
Mio nonno è morto a settanta anni, devastato da un tumore ai polmoni. Io avevo 12 anni e pure se fumava, il medico a mio padre gli aveva detto che non c’entrava un cazzo, che era morto per la merda che aveva respirato.
Se ho studiato, è per lo stesso motivo.
Arrivo da un quartiere di merda della torino operaia, i miei amici d’infanzia fanno gli operai, o magari i caministi, o magari puliscono le cisterne delle pompe di benzina. Io faccio il redattore precario, con la sindrome da tunnel carpale che mi devasta il polso destro, ogni giorno sempre di più, e le ginocchia in pappa o quasi. Ogni tanto facco ripetizioni di inglese, ogni tanto il commesso, il barista, quel cazzo che capita per campare.
Ma la domanda, detto che il romanzo è una bomba vera, è: come si passa il turno? Come si esce dalla precarizzazione dell’esistente? Io ve la butto lì, ci penso da un po’: ma lo sciopero condiviso? Se tu non puoi scioperare per situazioni oggettive, io vengo a scioperare sul tuo luogo di lavoro, e viceversa. Se tu lavori per una ditta che ti subappalta, io che non li conosco vengo a scioperare da te. Loro globalizzano e ci espropriano, noi occupiamo le fabbriche degli altri. A me la globalizzazione non piace, io vogliio la prima internazionale precaria.
ribadisco quanto ho detto più su (un bel po’ più su, ormai): è bello sentirsi meno soli.
non so se la proposta di sciopero di Giorgio sia attuabile, ma non posso negare che sia un pensiero che anche a me è spesso balenato in mente, nei periodi più duri della pratica. ad esempio, l’eventuale sciopero dei praticanti avvocati (chiaramente io parto dalla realtà con la quale mi confronto ogni giorno, ma non voglio per questo limitare il discorso) secondo me potrebbe anche far collassare il sistema giustizia, che sullo sfruttamento dei neolaureati si regge stabilmente. solo che per organizzare una mobilitazione efficace servono apparati forti, capaci, coraggiosi, che non solo i praticanti, ma tutti i precari in generale, non hanno.
per me quindi la domanda è: come creare le condizioni perchè lo sciopero possa essere indetto? come creare (vi prego, non saltatemi alla gola, sono per certi versi ancora uno sbarbatello che ci crede) un sindacato competitivo, che veramente *sorvegli*, come vorrebbe il suo etimo? o smuovere la coscienza (se l’hanno) e rendere effettive le strategie sul punto (che hanno per modo di dire) di quelli già esistenti? qualunque sia la soluzione credo che discussioni, e prima ancora libri come quello di Prunetti (che mi sono attivato per reperire) servano a formare una visione comune, un sostrato condiviso, base necessaria per qualsiasi discussione successiva.
Ma a me di “competere” non mi va proprio. Io voglio collaborare. Io voglio farmi insegnare dai sindacalisti veri (quelli della Fiom, che gli altri li conosco e tranne piccole eccezioni sono dei fottimondo) come si fa. La Fiom ha il comitato centrale, pura organizzazione comunista, altroché se funziona certa roba.
Un sindacato sindaca, rompe i coglioni ai padroni e chiede che vengano rispettati gli esseri umani, i lavoratori, che le aziende le fanno andare avanti. Io voglio lavorare con loro, voglio imparare a occupare luoghi di lavoro, fare vertenze, rompere i coglioni. Anni che si prova a organizzare qualcosa a torino, ma senza i contratti è difficile, e poi, a dirla tutta, i prendinculo contenti sono parecchi, e quelli son peggio del padrone.
Non ho ben chiaro cosa intendi con “sciopero condiviso” : una sorta di occupazione del luogo di lavoro da parte di lavoratori esterni ? Fattibile (basta essere consci che poi ti becchi una denuncia, ma non è poi così grave).
Alla fine degli anni ’90 a Bologna ci sono state delle esperienze di scambio fra gruppi di precari. Per esempio i precari della Ducati e della Telecom facevano i volantinaggi incrociati. In questo modo la Ducati e la Telecom si ritrovavano periodicamente davanti alla sede della gente che distribuiva materiali denunciando le merdate che succedevano là dentro, ma non era conosciuta e licenziabile (i capi letteralmente strippavano).
Per lo sfruttamento nei pubblici esercizi ricorrevamo invece al boicottaggio. Per esempio per un licenziamento + pestaggio + insulti razzisti a un pizzaiolo marocchino abbiamo sputtanato la pizzeria con manifesti in tutto il quartiere.
Altri esempi simili – anni prima – ci furono per una catena di profumerie che faceva firmare alle donne il licenziamento con data in bianco, da usare se rimanevano incinta. Le compagne dell’epoca organizzarono volantinaggi davanti ai negozi e il boicottaggio .
Le occupazioni invece le abbiamo riservate alle agenzie di lavoro interinale e, più recentemente (organizzata dalla USB), alla Confcommercio di Bologna , contro un accordo che permetteva i licenziamenti all’hotel Royal Cartlon.
Tranne l’ultima (a cui il sindacato di base è riuscito a dare uno sbocco positivo). la maggior parte di queste azioni hanno avuto prevalentemente un valore di controinformazione, o di giustizia postuma rispetto a torti subiti. Non sono riuscite a incidere veramente sulle condizioni di lavoro perchè hanno mancato di continuità, di un’organizzazione più estesa.
ciao, qui andrea di Agenzia X. intervengo velocemente per dare alcune indicazioni per così dire tecniche su libro, reperibilità e ebook.
dunque: è vero che Amianto è risultato per qualche giorno esaurito, ma ora i magazzini ne hanno copie disponibili.
La distribuzione è nazionale, il che ovviamente non significa che siano presenti copie fisiche in ogni libreria della penisola, ma che è sufficiente ordinarlo in una qualsiasi libreria, di catena (feltrinelli, mondadori, etc) o meno, per averlo in 24h.
per quanto riguarda gli eshop, questi operano con metodi del tutto autonomi e non ci sono grandi canali di comunicazione. ergo, se su amazon risulta esaurito, questo è perché spesso non ritengano valga la pena ricaricare un titolo di un editore indipendente, e il nostro promotore può farci poco o niente – e quel poco lo stiamo tentando. in ogni caso, anche loro attingono allo stesso distributore di cui sopra, che come dicevo ha copie per evadere eventuali richieste.
la visibilità ottenuta con le recensioni purtroppo non si traduce in immediato interesse per le librerie che, ormai, sono più che altro dei centri commerciali dove i libri sono uno degli articoli meno rilevanti al fine del fatturato. il vero problema parte proprio dalle librerie di catena e dal monopolio di pochi distributori che hanno centralizzato i rifornimenti, e che stanno metodicamente affossando l’editoria indipendente.
Agenzia X è una realtà piccola, questo è vero, ma non piccolissima: pubblichiamo circa 12 novità all’anno, siamo distribuiti in tutta Italia da Pde, ed è insomma paradossale che si verifichino disservizi di questo tipo.
quindi, RIASSUMENDO, la buona notizia è che non è vero che Amianto sia introvabile: se gli eshop fanno i capricci, ci si può rivolgere a una libreria fisica. non basta purtroppo guardare nel banco novità (riservato all’80% alle pubblicazioni delle “quattro sorelle”, ovvero gruppo Mondadori, Rcs, Gems e Feltrinelli), bisogna proprio sincerarsi che il titolo ci sia chiedendolo al librario. e, in caso negativo, ordinarlo.
se il libraio accampa scuse e sostiene che il titolo non sia reperibile, mente. questo può accadere per due motivi: 1) non ha voglia di richiedere un titolo per venderne una copia, e nemmeno di richiederne un numero più consistente perché teme di non venderle; 2) non sa quello che dice, cosa facilissima in una grande libreria di catena, perché si tratta in molti casi purtroppo di personale che lavora tramite agenzie interinali (per tornare in tema di precarietà…), spesso senza nessuna esperienza, chiamata a svolgere quel ruolo per una manciata di mesi appena, prima di trovarsi a fare altro.
in extrema ratio, potete segnalare a ordini@agenziax.it eventuali problemi incontrati e provvederemo a sbloccare la situazione tramite i promotori. alla stessa mail potete anche ordinare il libro direttamente da noi, se preferite.
ci rendiamo conto che si richieda una partecipazione attiva, quasi militante, e che abbiamo tutti poco tempo etc, ma la situazione è questa per qualsiasi editore con dimensioni simili alle nostre. per sostenere le varie realtà (non solo Agenzia X of course) che faticosamente cercano di sfuggire all’omologazione, occorre farlo.
questione EBOOK: al momento stiamo facendo delle modifiche al nostro sito, e sarà più agevole per noi venderlo tra circa un mese. quindi, c’è ancora un poco da aspettare.
per intanto, date la caccia al cartaceo, e leggete con doppia soddisfazione ;)
love,
X
Qua pare ce ne siano 15 copie disponibili:
http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=prunetti&sts=t&tn=amianto
Ciao Andrea, grazie per il lavoro che fai con Agenzia X. Nella mia esperienza, il libro di Prunetti è più facilmente reperibile su libreria universitaria che su ibs, o per lo meno io non ho avuto alcuna difficoltà a trovarlo lì.
Vorrei cogliere l’occasione di questo tuo intervento per segnalare anche un altro piccolo grande libro che che hai curato sempre per Agenzia X, “Erravamo giovani stranieri”, una raccolta di vari testi di Alberto Dubito, lettura fondamentale per chi voglia completare il quadro sulla questione precaria con il punto di vista di un giovanissimo che ci ha tristemente lasciati proprio quando aveva molto da dire.
Questi libri di Agenzia X sono dei veri gioiellini, mi auguro che riusciate a continuare il vostro lavoro nonostante le difficoltà. Un abbraccio, C.
ciao Claudia,
grazie davvero per i complimenti…
per correttezza Erravamo giovani stranieri non l’ho curato io ma Lorenzo Fe, fratello di Alberto. io ho contribuito, insieme a Philopat e dopo una prima selezione di Lello Voce, a dare una forma possibile a quella che era una vera e propria nebulosa di materiale stratificato, la testimonianza di un talento straordinario, con squarci davvero illuminanti. sarebbe molto interessante aprire un discorso più ampio sull’opera di Alberto Dubito, sia da un punto di vista critico – se ne è scritto per esempio qui, qui e qui – sia sotto la chiave di lettura che proponi tu. perché il percorso umano e poetico di Dubito sono saldati in modo indissolubile, ed entrambi fanno i conti con la precarietà riportando questa parola abusata al suo massimo di potenziale espressivo.
precarietà interiore addirittura ricercata nel tentativo di non dare nulla per scontato, per non spegnersi sulla strada dell’omologazione; precarietà come barriera insormontabile, pragmatica, contro cui si disfano tutti i propositi e gli sguardi che cercano un orizzonte.
Da quanto mi è stato detto da alcuni suoi amici forse Wu Ming 1 aveva conosciuto Dubito, forse erano stati presentati proprio da Lello Voce, per cui ovviamente se si volesse parlarne ancora un po’ ne saremmo felicissimi.
Per quanto riguarda Amianto intervengo ancora, più sotto. abbracci,
andrea
Sì, incontrai – “conobbi” sarebbe dire troppo… purtroppo – Alberto Dubito grazie a Lello, a Treviso, qualche anno fa. Quasi quattro anni fa, ho appena ritrovato la data: 5 giugno 2009, una serata al liceo artistico statale. Ci trascorsi insieme una serata. Io, lui, Lello e altri andammo in non so più quale posto a cenare e chiacchierare. All’epoca credo fosse ancora studente medio o avesse appena finito il liceo, non doveva avere più di 19 anni. Ricordo che parlammo principalmente di jazz, non capita spesso di incontrare persone che a quell’età ne abbiano già una conoscenza non banale. Aveva letto il mio “New Thing” e aveva colto un sacco di riferimenti che erano sfuggiti ai più. Mi diede un cd di “Disturbati dalla CUiete”, progetto che all’epoca era forse appena agli inizi… O mi chiese l’indirizzo e poi me lo spedì per posta? Ci sono dettagli che non ricordo. Che fosse morto sono venuto a saperlo solo mesi dopo il suo volo dalla finestra. Il giorno in cui morì, Stefano Tassinari entrava all’hospice di Bentivoglio e nelle settimane che seguirono la mia attenzione rimase focalizzata su quella perdita, quella mancanza. E’ una gran cosa che Agenzia X abbia raccolto e curato le cose scritte da Alberto. Il libro ammetto di non averlo ancora visto, ma me lo procurerò senz’altro. Su questa cosa sono “arrivato lungo”, come suol dirsi. Mi spiace non averlo conosciuto davvero.
2009, Alberto era ancora al liceo di sicuro, per quanto riguarda i Disturbati il loro percorso è iniziato a 12 anni (!) ed è stato pubblicato ora il “disco ufficiale”, prodotto da Bonnot degli Assalti Frontali. Ricordo di Tassinari, a inizio giugno partecipai a una serata in piazza Verdi in memoria di Abe e Tas… (Roberto, ti mando per mail libro e disco.)
noto che si è perso un link, devo aver scritto male, era questo:
http://www.rollingstonemagazine.it/cultura/news-cultura/alberto-dubito-barman-metti-lamaro-in-conto-al-mondo/
Quando, sotto la prefazione, ho letto questa frase:
“Mon frère, ti invito a resistere”
ho pensato: stiamo perdendo troppi fratelli e sorelle. E non riusciamo ad aiutarli. Non ci riusciamo. E non troviamo il modo non stronzo di dire che non riusciamo.
“Mon frère, ti invito a resistere”
Grazie “per” Alberto Dubito, ordino subito il libro.
però che dolore
Ciao a tutt*, sto seguendo la bella e ricca discussione ma ancora non ho potuto leggere il libro. Che arriverà.
Oggi durante il mio lavoro per le strade di Torino ho trovato un foglio affisso sul muro esterno di un palazzo, data 28/01/2013. Trascrivo:
Alla c/a dei
VICINI CONFINANTI E DI TUTTI GLI INTERESSATI
Oggetto: Comunicazione INIZIO LAVORI.
Con la presente, in riferimento alle opere di rimozione lastre in eternit adibite a copertura di un tetto Garage interno cortile situato in p.zza Vette D’Italia 15 Torino.
SI INFORMA QUANTO SEGUE
In data 30 gennaio 2013 dalle h. 8,00 verranno eseguiti i lavori di bonifica amianto. E’ assolutamente vietato l’accesso nell’area di lavoro e si consiglia di tenere chiuse porte e finestre e di non stendere biancheria sui lati prospicienti verso l’area di lavoro durante le opere di bonifica.
Fogli e avvisi di questo tipo ne ho visti diversi negli ultimi due anni. Per non parlare della quantità di manufatti in eternit abbandonati nelle cantine, che ho sempre e inutilmente segnalato. Ogni volta ho provato un brivido per l’inutilità delle raccomandazioni.
Arrivo tardi, e vedo che il dibattito si è dipanato in più direzioni, ma ho l’impressione che manchino alcuni elementi. Nella storia d’Italia e nella storia di classe la stabilità del lavoro, la sua garanzia normativa, la sufficienza del reddito e le prospettive di mobilità sociale sono stati di eccezione, non la normalità. La mobilità sociale è figlia del boom economico, le garanzia normative risalgono solo al 1970 e sono frutto di un ciclo di lotte che si è sviluppato grazie a precise condizioni (le concentrazioni industriali, l’operaio massa, la fase di crescita economica, ecc. ecc.). Per inerzia, godiamo ancora della rendita di quel ciclo di lotte, anche se intorno è cambiato tutto. La produzione è stata destrutturata e delocalizzata, poi è emigrata ad est (nel frattempo, vi sarete accorti, è caduto un muro) . La concentrazione e la mobilità dei capitali hanno raggiunto proporzioni inimmaginabili trent’anni fa. Sul piano geopolitico altre potenze si disputano l’egemonia del sistema mondo, e ciò che era centro diventa sempre più periferia. La classe operaia (alla faccia di chi ne aveva teorizzato la fine) riemerge e lotta in Cina e in India, ma ovviamente non ci risolve il problema su che cacchio dobbiamo fare qua.
Sicuramente, fra le cose da NON fare, c’è quella di colpevolizzarvi se non riuscite a ripercorrere le forme di lotta dei vostri padri, che non si possono riproporre tal quali in tutte le situazioni.
Sul cosa fare non ho soluzioni, propongo solo qualche idea (non particolarmente originale) tratta dall’osservazione di ciò che succede.
Intanto ragionare sui cambiamenti nell’organizzazione della produzione e dello scambio di merci, identificando i punti dove è più facile che possano crearsi rapporti di forza favorevoli. Non offendetevi … ma il precariato cognitivo in campo letterario non è particolarmente favorito da questo punto di vista. Altre forme di schiavitù, come il facchinaggio nella logistica, invece si. I facchini egiziani dell’IKEA di Piacenza hanno identificato perfettamente un punto del sistema dove rompere i coglioni diventa efficace, perché è vero che in questo cacchio di paese la roba si produce sempre meno, ma è anche vero che si sposta sempre di più.
Ce ne sono altri di punti fragili ? Perché non ci ingegniamo a scoprirli?
E per chi invece non è collocato in un punto di forza del sistema?
Uno dei terreni possibili e più promettenti è quello del riprendersi la roba, come dimostra l’ultima campagna di occupazioni di case nella capitale (a centinaia e in contemporanea, con l’alleanza di tutte le situazioni prima divise in distinte parrocchie). Certo funziona meglio nelle grandi realtà metropolitane dove ci sono grandi numeri di occupanti che resistono meglio agli sgomberi.
La crisi intanto accellera i processi: in Spagna si estendono le recuperadas come in Argentina 10 anni fa (c’è mica qualche scrittore argentinofilo a caso che abbia voglia di parlarne?).
Riguardo alla questione “generazionale”, mi sembra che il tentativo di contrapporre i “garantiti di mezza età contro i precari under 30” si stia superando nei fatti con la precarizzazione completa di tutte le componenti del lavoro, dalla fabbrica al pubblico impiego, dagli apprendisti ai pensionati poveri. Questo processo di devastazione sociale apre nuove possibilità di alleanze. Certo, le relazioni bisogna farle nascere e crescere, non si creano dal nulla. Ma a volte per rompere il ghiaccio basta poco: un’iniziativa di solidarietà in un circolo, un salto a un picchetto …
Una considerazione finale : non è detto che un borghese decaduto non diventi meno determinato, coerente e combattivo di un proletario doc. Nelle occupazioni di Roma, da anni a forte prevalenza migrante, la componente di italiani proveniente dal ceto medio proletarizzato è in continua crescita. Allo stesso tempo a Pomigliano un migliaio di operai doc non se la sentono di muovere un dito per far rientrare al lavoro 19 loro compagni.
PS (poi ho finito davvero) C’è un piccolo patrimonio, tutto italiano, di esperienze sulla precarietà (è dal ’96 che se ne parla in interessantissimi convegni di movimento, dove avevamo previsto tutto ma proprio tutto, tranne che cazzo fare di veramente efficace): occupazione delle agenzie interinali, boicottaggi, sportelli legali, vertenze singole e collettive, abbozzi di reti di solidarietà e mutuo soccorso fra gruppi di lavoratori… I risultati di tali azioni sono spesso stati precari quanto i loro attori, ma non è detto che qualcun altro non possa trarne spunto per fare di meglio.
Complimenti a Alexik per tutto il materiale che ha messo sul fuoco. Aspettando i lettori in replica, voglio solo accennare a due brevi cose:
_l’argentinofilo in questione dovrei essere io, ma manco da Buenos Aires (querido) ormai dal 2008 e mi rendo conto che non ho il polso della situazione. Sto invitando persone più competenti di me sul tema a dibattere qui. Vediamo se accettano.
_oltre alle imprese, bisognerà pensare anche a rioccupare i campi. I campi e le officine. Ovviamente con modalità più moderne di quelle del quarto stato (che però sarebbe un bel modo di diventare imprenditori, anche agricoli, con le occupazioni e le autogestioni collettive). Anche perché vedo che la cosa in provincia si può fare facilmente per piccoli appezzamenti di poco valore economico che però danno autosussistenza (che non è poco, di questi tempi). Scappo a cercare altri argentinofili più scafati di me…
Alexik, non riesco a trovare il tuo commento in cui mi chiedevi se potevi copiare un mio post su http://illavorodebilita.wordpress.com/ e quindi ti rispondo qui. Certo. Ma ti riferisci a questa conversazione qui su Giap? “Avoglia te”, anche a nome degli altri (e pena l’esclusione dalla Quinta Internazionale Precaria Intergalattica di prossima fondazione). Il blog di Alexik è una miniera di materiale (anche tecnico) sulle nocività industriali e io l’ho visitato spesso per dare sostanza alla critica.
Ancora un commento per quanto riguarda la questione EBOOK: nello specifico, pubblicheremo quello di Aminanto non appena sarà pronta la piattaforma adeguata. per il resto, purtroppo, la questione è molto ampia e meriterebbe un thread apposito, che credo possa interessare vista anche l’uscita dell’ebook su Giap curato da Tommaso De Lorenzis.
vado per punti:
1) l’ebook sembra essere tutt’altro che la manna dal cielo per la piccola editoria. in generale, i numeri sono ancora bassissimi e si tratta di un fenomeno ancora elitario. in particolare, non è né un bene né un male. soltanto un cambiamento di medium, inevitabile, a cui non ha senso opporsi, solo comprenderlo e servirsene con consapevolezza.
2) “problema” pirateria? La X dopo Agenzia sta per Idee per la Condivisione dei Saperi, un reprise del motto di Primo Moroni “Socializzare i saperi senza fondare poteri”, quindi per principio non intendiamo adottare forme di protezione tipo Dmr. D’altra parte, pubblichiamo tutto in licenza CC, e come molti di voi sanno molti pdf si possono scaricare gratuitamente dal nostro sito, quindi che senso avrebbe? il problema non è la pirateria, ma il punto che segue qui sotto.
3) il problema del profitto, che sembra secondario ma non lo è: per una realtà come Agenzia X, che non ha finanziatori di alcun tipo, è questione di sopravvivenza vera e propria. Finché si riescono a pagare i costi vivi e le spese di affitto (perché riteniamo che senza un luogo fisico dove socializzare le idee non possa esserci vera ricerca), continuiamo con fatica a portare avanti un progetto editoriale che, comunque, richiede un impegno ALMENO part-time (12 novità all’anno, più un calendario di iniziative fittissimo) su base volontaria. sfortuna vuole che i frutti di questo lavoro ottengano visibilità in un momento in cui la disponibilità di cash individuale è ai minimi storici. ma, insomma, intanto teniamo botta.
4) la vera questione, che già ponevo, è secondo me quella del “consumo critico”: piratiamo, prendiamo in prestito in biblioteca, facciamoci prestare i libri che ci interessano dei grandi gruppi editoriali, e acquistiamo – anche con eventuali difficoltà a reperirli – i libri delle realtà editoriali che ci interessano. per le festività e compleanni vari, regaliamo quelli, e non un tascabile qualsiasi recuperato per supplire all’emergenza nella prima feltrinelli di strada. 5) per quanto riguarda la precarietà, proviamo a non farci imbottigliare nella spirale di paranoia economica del precariato, che facilmente finisce per privarci dei nostri stessi interessi e passioni, che invece sono il vero antidoto alla depressione che, a mio parere, diventa un fatto sempre più sociale che individuale.
6) pensiamo al cibo, per esempio: in tanti ormai si pongono con atteggiamento consapevole nei confronti dell’alimentazione (con anche aspetti deteriori come la moda del finto bio mass market, etc., ma sono derive inevitabili), ma in pochissimi ragionano nello stesso modo per i libri. proponendosi, per così dire, di tutelare la “bibliodiversità”. di solito al massimo ragioniamo sul prestigio culturale di un editore, senza porci minimamente la questione di come siano le condizioni lavorative al suo interno. (su questo, per esempio, vale la pena di seguire le inchieste di ReRePre). ogni volta che scegliamo di comprare un libro piuttosto che un altro (magari quello sì, scontatissimo e in bella mostra in qualsiasi megastore libresco) facciamo una scelta politica.
7) DOVE vendere gli ebook: come gli stessi Wu Ming hanno più volte sottolineato (ricordo un articolo su Internazionale, per es.) , portali come Amazon sono quanto di più politicamente scorretto esista. sarebbe bello quindi creare un portale che metta a disposizione ebook di una serie di realtà editoriali unite da intenti comuni… certo è un discorso lungo, ma se provassimo a farlo partire proprio da qui, in una discussione apposita?
8) aggiungo in extremis ma mi sembra utile: ma lo sapete che TUTTI i grandi editori fanno editare gli ebook in india o in cina, a prezzi da fame? farli da soli, come stiamo facendo noi, porta via un mare di tempo e di lavoro.
chiudo, mi scuso per il caos ma scrivo di fretta e la discussione è ormai un oceano,
Andrea x Agenzia X
Colgo l’invito che mi hai fatto su twitter e provo a spiegare perchè non condivido totalmente alcune tue riflessioni. Non ho ancora una idea chiarissima in merito e ho avuto una giornata lunga e faticosa quindi mi scuso fin da subito se dovessi risultare poco chiaro.
Innanzitutto occorre partire da quello che io considero un equivoco di fondo. L’ebook non è il sostituto di un libro. L’ebook è una nuova forma di pubblicità al pari di un comunicato stampa, di una pagina su una rivista specializzata, di un publiredazione, di una recensione o di uno spot radiofonico.
Se un lettore di ebook economico costa 60 euro e posso trovare praticamente qualunque ebook gratis con una rapida ricerca sui forum, i siti di torrent o gli archivi specializzati non è più pensabile che una casa editrice, in particolare se di piccole dimensioni, possa pensare di sopravvivere tra 10 anni vendendo libri.
Il prodotto da vendere di conseguenza non può più essere il libro (inteso sia nella forma materiale che in quella direttamente “esperienziale”) ma deve essere altro. Tutto il mondo si sposta in questa direzione e con la musica e i film è in parte già accaduto.
Con i film è così da anni. Il film è il traino per la vendita di tutto ciò che realmente genera utili (gadget, diritti televisivi, adattamenti per le pubblicità, edizioni speciali e cofanetti per collezionisti, ticket del cinema, meglio se 3D, …) e le vendite di DVD sono sostanzialmente in calo e di sicuro non sono la fonte primaria di incassi. Per le piccole produzioni il discorso è leggermente diverso (entrano in gioco i contributi statali, i diritti per la proiezione ai festival e gli incassi derivanti dallo streaming o dalla pubblicità su siti tipo youtube, lo sfruttamento, a volte volontario, di chi li realizza) ma la sostanza rimane la stessa.
Le piccole case editrici dovrebbe smetterla di vendere solo libri e iniziare a vendere partecipazione e coinvolgimento emotivo. L’ebook deve essere gratuito e funzionale alla pubblicità del pensiero dell’autore e della casa editrice (che altrimenti, essendo piccola e squattrinata, difficilmente si farebbe conoscere) ma quello che deve essere venduto è altro.
E’ la copia cartacea firmata, l’edizione speciale limitata con le foto ad alta qualità e la copertina rigida autografata, la partecipazione ad una cena esclusiva con l’autore, il reading o la messa in scena di un romanzo, la partecipazione a festival e conferenze (laddove si puo’ essere pagati), la copia cartacea con allegato un cd audio in edizione limitata disegnato a mano o il portachiavi che ritrae il protagonista del romanzo, la pubblicità sul forum di discussione – con annessa community – della casa editrice, … che devono generare il ritorno economico.
Sono le iniziative collaterali che la casa editrice si deve inventare che devono creare fidelizzazione e portare il cliente/consumatore/lettore a voler spendere soldi per sostenere un percorso culturale che lo vede protagonista e parte attiva, non solo lettore.
Se le case editrici non sono in grado di generare tutto questo gli autori più intraprendenti le scavalcheranno presto e pubblicheranno direttamente gli ebook su amazon (cosa che alcuni già fanno ricavandone anche percentuali di incasso maggiori) e pubblicizzandosi attraverso i propri blog, social network e contatti. Per i nostalgici del cartaceo il print on demand sarà probabilmente più che sufficiente in un mondo dominato dagli ebook.
Le case editrici e gli autori che non si adeguano a questi cambiamenti del mercato sono destinati a scomparire o a essere sempre più irrilevanti con qualche piccola eccezione (micronicche di mercato, – forse – quello che gravita intorno alle università o sopravvive grazie a forti incentivi statali). E le case editrici che non sapranno tessere relazioni con altre realtà (radio, tv, canali su youtube, riviste, quotidiani, community online, …) e essere realmente multi-mediali saranno destinate ad una vita difficilissima con la diffusione degli ebook.
Questo molto in sintesi (e con non poca fatica) il mio pensiero, senza alcun riferimento specifico ad alcuna casa editrice e realtà editoriale in particolare e senza voler inserire in questa riflessione alcun giudizio di merito (“si stava meglio quando si poteva annusare l’odore della colla dei libri e quando gli editor erano figure valorizzate e pagate decentemente…”) ma guardando semplicemente quello che vedo succedere nel mondo.
@wuming1
molto bella in questo dialogo a tre la necessità che emerge di un “passaggio del testimone” tra padri e figli.
dici giustamente ‘essere genitori di se stessi’ alludendo -come hai già fatto altrove- all’esigenza di essere nuovi fondatori.
ecco, mi pare che tutto ciò con Recalcati e l’evaporazione del padre -la “mancanza” della norma – non abbia nulla a che fare, anzi…
qui due contributi di Paolo Godani che secondo me spiegano bene i limiti e i pericoli del neo-lacanismo:
http://labont.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Godani-.pdf
http://vimeo.com/41019560
Ti ringrazio per i link, però ci tengo a chiarire che io non ho espresso valutazioni (né negative né positive) su Recalcati o sul neo-lacanismo. Ho citato i libri di Recalcati tra i diversi esempi di discorsi sulla perdita del padre o genitore simbolico, “sintomi” della centralità del problema in questa temperie. Ci sono tanti modi di porre la domanda, e tanti modi di proporre una risposta. “Citation is not necessarily endorsement”.
ok, mi rincuori ;)
però mi pare che ci siano 2 questioni (che certo si intersecano): l’esigenza di “riattivare” la lotta di classe (e i suoi percorsi di organizzazione) e l’elaborazione della perdita (del padre, come del partito – nell’innegabile esaurimento della sinistra storica).
non credo che la soluzione sia la restaurazione di una “regola aurea” – che in parte la lotta di classe (in senso biopolitico) ha contribuito a distruggere-, come d’altronde non lo è il parricidio!
il tuo ‘essere genitori di se stessi’ credo che vada anche nella direzione di un’autopoiesi.
in questo senso mi sembra ancora utile L’anti-Edipo (e tutti gli scritti di Guattari) come anche il pensiero (post)femminista e la queer theory.
un altro testo di Godani che mette in fila una serie di cose, meglio non potevano essere dette:
http://www.leparoleelecose.it/?p=8936
Vince, non so quanto l’articolo, sicuramente denso e interessante, si applichi al dibattito in corso su Giap: qui ci si trova “senza padri” perché il capitale ce li ha ammazzati col lavoro nocivo. Diciamo che ci sono modi diversi per ritrovarsi “senza padri” e sicuramente trovarsi di colpo alla morte del padre, fisicamente, col peso del lutto, implica una rielaborazione, un senso di responsabilità diversi dal lavoro teoretico di dismettere il peso dell’autorità paterna (cosa che ho fatto probabilmente ben prima che mio padre morisse, ma poi di fatto teoria e prassi son cose diverse). Poi a livello teoretico certo che è bello rimettere in discussione le cose, “uccidere i padri” letterari, confutare le tradizioni, ripartire da zero, e via dicendo. Nessuno propone poi in Amianto il culto della figura paterna astratta. Gli scazzi generazionali c’erano e come. Ma la linea del libro è proprio quella di recuperare la memoria dello sfruttamento del passato per individuare le fondamenta dello sfruttamento del presente. E a proposito di dirlo bene, è difficile dirlo meglio di questo padre, operaio in pensione, che ha recensito Amianto su Carmilla (il blog ha avuto difficoltà per il trasloco del server e a tratti non risulta raggiungibile): http://www.carmillaonline.com/archives/2013/02/004634.html#004634
“Siamo stufi di ritrovarci solamente a dei funerali.” _ C. Lolli
Primo intervento su Giap, scritto di pancia e di testa.
Non ho ancora letto il libro di Alberto, la botta è arrivata lo stesso leggendo la presentazione e la discussione che ne è seguita su Giap (sempre sia lodato, lunga vita ai senza nome di tutto il mondo!).
Groppo in gola, flashback, ricordi rimossi per troppo tempo, rabbia, senso di sconfitta e voglia di rivincita, di disseppellire l’ascia di guerra, non solo in senso figurato.
Ogni Storia raccontata ne contiene e produce infinite altre, e raccontare il presente partendo da lontano è un modo di riavvolgere e riannodare i fili della memoria a quelli che ci legano e muovono qui e ora e a quelli che cerchiamo di lanciare verso il futuro, l’orizzonte.
Anche mio padre era operaio saldatore, in un’officina meccanica.
Non era certo un compagno, ricordo la scenata la prima volta che trovò in casa una copia di “Lotta Comunista”, era uno che lavorava da sempre sodo e a testa bassa perché quello sapeva fare, con l’orgoglio della classe lavoratrice, che va ben oltre le idee politiche. Inoltre non aveva tempo per certe cose lui, che aveva noi, figli da far studiare perché non facessimo la “stessa sporca vita”. E ci stava riuscendo bene.
Anche mia madre ha sempre lavorato, prima operaia poi infermiera, ora in pensione da pochi anni.
Con due stipendi sicuri, a quei tempi (60-70), un minimo di serenità una famiglia se la poteva permettere.
Poi, a metà anni ottanta, la ditta, dove lavorava mio padre fallì e anche lui, come molti altri, si ritrovò imprenditore di se stesso, in altre parole artigiano al soldo dello stesso padrone (che ora si teneva le mezze senza nemmeno rischiare il capitale). Finalmente impossessatosi dei mezzi di produzione (per i quali pagava l’affitto al vecchio datore di lavoro che li aveva nottetempo sottratti al pignoramento) non gli restò altro che lavorare di più, senza nessuna tutela, spesso senza nessuna garanzia di pagamento. Fece parecchie commesse per ditte che poi si rivelarono insolventi, se non inesistenti, d’altronde che ne sapeva lui, a quelle cose pensava “il geometra”, l’ex/post padrone, lui doveva lavorare, fino a tardi, anche di domenica, che domani c’è la consegna e magari pagano la fattura scaduta da sei mesi.
Cadde anche nella “rete del fisco”, della lotta all’evasione che in quegli anni “spiegava le sue ali”, e non fu’ facile. Pagarono le multe e andarono avanti, lui e il suo socio, sempre più sfruttati, sempre più stanchi, più vecchi.
Non so’ se fu una vittima del lavoro, sicuramente non poteva permettersi di spendere per la tutela della salute, e poi era un “imprenditore”, non c’erano per lui prescrizioni né sindacati, erano un po’ cazzi suoi se respirava gas o vapori tossici, se aveva o non aveva mascherine, aspiratori e filtri, era padrone di se stesso, e come tale si sfruttò fino agli ultimi giorni.
Ricordo le sue braccia scavate dalle ustioni, gli occhi rossi, sempre meno vivi.
Forse l’ha ucciso la “vergogna” di non essere più quello che portava a casa lo stipendio tutti i mesi, le preoccupazioni, le rate da pagare.
Forse l’ha ucciso la precarietà, per lui sicuramente inattesa, la perdita di sicurezza, di orizzonte.
Non l’ha mai sentito così vicino, così moderno, così simile a me.
Io? Storia generazionale, università e “lavoretti” fino a trent’anni, tentativo di “carriera” cognitiva (P.S. anch’io modificavo le cazzuole in trawel ma ho sempre preferito le originali inglesi monoblocco, carissime e introvabili, le altre mi si sfasciavano, erano giusto buone per la sabbia della pianura padana) abbandonata poi per “mettere su” famiglia e per un lavoro sicuro (e il primo che dice “beato te che un lavoro ce l’hai” lo perseguito personalmente).
Che poi quel “sicuro” te lo fanno pesare ogni giorno perché devi comunque sentirti precario, nessuno si senta escluso, che poi non basta mai per arrivare alla fine del mese, che poi ti ritrovi che pensi e parli solo di scadenze, bollettini, e chi se frega se stai male dentro o se ti stai perdendo qualcosa, c’è da tirare avanti, che i figli devono studiare per fare (se gli va bene) la “stessa sporca vita”… e una sera ti guardi allo specchio e sei uguale a tuo padre quando lo vedevi già vecchio. E scopri che sei fottuto, come lui.
Proprio per non lasciarsi fottere è importante raccontare storie, queste storie, altre storie, di testa e di pancia, storie che ci parlino di oggi partendo da ieri, storie che ci facciano soffrire e incazzare, che riallaccino tutti i fili rossi che si sono spezzati. E chi se ne frega se qualcuno ci addita come “estremisti fuori dal tempo”, dalla sassaiola dell’ingiuria ci faremo scudo con libri come “Amianto” o “Asce di guerra”.
P.S. Apro a una parente (mia zia) sulla sotto discussione “anche i ricchi muoiono”: il groppo in gola che provo/proviamo davanti ai “nostri” morti, ciò che ci fa incazzare davanti al caduto sul lavoro, non è la pietas che si rende (se si vuole o se si crede) a tutti gli uomini, ma è RABBIA verso un sistema che ti sfrutta e uccide e anche verso chi di questo sistema ingrassa, sulla “nostra” pelle. La pietà è una questione privata, la rabbia è questione di appartenenza. Non cercate di farla passare per insensibilità, cinismo o calcolo politico (… e le foibe, allora?).
Se l’imprenditore che si spara è un riformista di sinistra che ama i suoi operai mentre il lavoratore che cade dall’impalcatura è uno stronzo di ScassaPound che picchia gli immigrati, è cosa che non m’importa, sono i rapporti di classe che muovono questi sentimenti.
Poi è ovvio che nessuno gioisce se si spara un poveraccio perché gli fallisce la ditta, ma se si cerca di utilizzare questi casi per dire, come accade nei media: “Vedete, siamo tutti sulla stessa barca, anzi, c’è chi sta peggio di voi, perché, a differenza vostra, non è abituato lui, a essere povero e si ammazza”, ci si merita anche l’invettiva sarcastica del vulgo, e ci sta tutta.
Se poi gli imprenditori (i borghesi?) stanno prendendo coscienza dei meccanismi del Capitale e del fatto di essere anche loro pezzi intercambiabili di un ingranaggio ben più grande e spietato, ben venga, saltino la barricata, da questa parte c’è posto per tutti, ci incazzeremo insieme per i “nostri” morti, metteremo insieme la sabbia nel lubrificante del “grande ingranaggio”. O almeno ci racconteremo delle bellissime storie.
Orco, non c’era bisogno del P.S., era già stato detto tutto, per favore, non torniamo di nuovo nell’escrescenza divenuta digressione.
il tuo ps mi pesa, se vuoi, più del commento sui padroni. perchè leggendolo da un altro punto di vista (spero di sbagliarmi, se così rispondimi a brutte parole ma fammici credere) è come dire in qualche modo che per perorare la causa della RABBIA giusta e bene esplicata da te, ci serve abbracciare la propaganda di A MORTE IL PADRONE. visto che loro sfruttano i suicidi per farci credere che essere imprenditore equivale a distruggersi giorno dopo giorno in una fabbrica o a stare carponi per ore a stendere pavimenti, noi possiamo anche passare sopra al fatto che si buttino lì quanti? giusto 1 o 2 morti al mese (e che ci fa?) per solidificare un’appartenenza. no. no perchè me la sporchi, come il poliziotto che magari nel suo lavoro ci crede ma invece d’indignarsi per come i suoi colleghi trucidano un ragazzo, sta lì a difenderli per un fatto di appartenenza (poi, d’accordo con te, sti cazzi se si odiano le divise o se il ragazzo massacrato era un fascista). e poi le loro storie non ti interessano ma tu hai raccontato la tua perchè a te interessava farlo, perchè poi alla fine appartenenza, rabbia, pietas, lotte e rivendicazioni non hanno molto senso, anzi nessuno, se non ci sono delle storie dietro. qualunque siano. l’unica cosa che spero è che si finisca di sfruttare facili vittime per aggregarci e rivendicare, anche fosse una sola all’anno
Ultimo avviso a chi cerca di riaccendere questa polemica facendola ripartire daccapo, senza curarsi dei chiarimenti già avvenuti svariati giorni fa: evitate, please.
ciao, mannaggia volevo fare tutt’altro commento su questo argomento che m’interessa parecchio, avrei voluto parlare di operai e uomini che hanno imparato a piangere per un lavoro che non c’è o anche per quello che c’è, la stragrande maggioranza della mia famiglia ma alcuni commenti che leggo lo fanno, e bene! e poi, come direbbe alberto sono una padrona dato che ho chiesto soldi a parenti (papà ti voglio mooolto bene, tra l’altro papà 66enne muratore, due infarti, quattro bypass ed ancora continua per paura che la crisi si mangi tutto quello che mi ha dato, che è troppo) e amici per aprire un asilo, quindi chissà se posso parlare io. ce l’ho da quattro anni e guadagno, al mese, 100 euro in più delle altre ragazze full-time(indeterminato tutte), lavorando una media di 10-14ore/sett più di loro e mi pare anche sciocco doverlo sottolineare visto che ho deciso io di costruirmelo questo lavoro, quindi ovvio che devo lavorare fuori orario. indubbiamente sono una privilegiata: ho chiesto a chiunque e chiunque mi ha dato, ho rifiutato aiutini per permessi vari e la mia coscienza è salva, lavoro con persone che stimo e faccio un lavoro che mi piace, riesco anche a restituire (molto poco alla volta!), ho chiesto la convenzione per evitare di far pagare rette alte all’utenza (che comunque a mio avviso spesso paga troppo)e quando il comune tarda a pagare sono io a non prendere lo stipendio, non le ragazze, apro gratuitamente l’asilo, alcuni giorni al mese, per chiunque (iscritti e non). quello che mi fa incazzare? aver sprecato questo post su una discussione che mi interessava per rispondere ad un commento superficiale ed evitabile. ora (dopo questa immensa pubblicità su di me, di cui rimanendo presso che anonima non beneficerò) io non so chi siano le persone che si sono suicidate e io non ho proprio alcuna intenzione di farlo ma, senza modestia, se io mi suicidassi meriterei più rispetto da parte tua. viridiana (padrona da 4anni) ps ora mi odierete ma.. adoro il vostro sito!
Viri, ti vogliamo bene anche se non ti conosciamo, e siamo contenti che adori il nostro sito, solo che, dài, mica te l’ha ordinato il dottore di lasciare questo commento che si autocontesta… La questione dei suicidi e di chi si intenda quando si parla di padroni e di come molte persone siano state persuase di appartenere alla categoria (todos caballeros, tutti entrepreneurs, tutti businessmen e businesswomen) è stata stradiscussa e straspecificata fino a diventare strabordante, tanto che ha rischiato di far deragliare l’intera discussione. Credo che nessuno abbia voglia di ripetere quel che ha già scritto, è tutto nel thread per chi vuole leggere. Adesso, Viri, per favore, parlaci di più di quello di cui “avresti voluto parlare”, parlaci di più di tuo papà magari (se vuoi)…
Scusa Viridiana, io sono un pasticcione informatico e ti ho risposto fuori dalla catena… se vedi il commento successivo lo leggi, non so se devo rincollarlo di sotto… chiedo venia ai Wu Ming per la mia incompetenza con la struttura a discesa dei commenti… se è il caso “incollo”… A.
Non incollare, va bene così.
Dai, Viridiana, ne avevamo già parlato e penso che la cosa sia chiusa… io vivo in un posto in cui quelli come te li chiamiamo lavoratori autonomi o compagni, indipendentemente se siano stati costretti o meno dall’astuzia del capitale a aprire partita iva… chiamarsi imprenditore dalle parti mie non significa avere un bar o un’officina o un asilo (magari in collaborazione con altre maestre d’infanzia stanche di farsi pagare dalle cooperative che vincono le aste al ribasso con i comuni che esternalizzano i servizi pagando i “soci” 6 euro all’ora). L’imprenditore è un’altra cosa (hai presente Della Valle, Montezemolo e i loro piccoli emuli di provincia che non “arrivano più a fine mese” perché hanno 3 smart, due mercedes e 2 amanti?), ha un numero di dipendenti più o meno assunti, fa altre cose… non ci torno sopra perché se ti leggi i commenti (nel mare magnum di questo post) ci trovi le rettifiche e le spiegazioni… e se si rispiega non si va avanti… per collegare la tua esperienza al commento precedente, quello di orco primitivo, lui fa un esempio perfetto raccontando la storia di suo padre… voglio parlarne perché mi ci sono svegliato con quel commento e ho ancora il grappo alla gola… Orco primitivo l’ha detto bene, andiamo oltre la retorica, parlando di morti operaie, di replicare emotivamente con le morti degli imprenditori (e allora le foibe?) e vediamo cos’è successo negli anni ottanta, in piena ristrutturazione del capitale, con nuovi margini di pace sociale… perché gli operai sono diventati proprio in quegli anni “imprenditori”, perché i camionisti sono diventati “padroncini”, perché i redattori editoriali sono diventati “professionisti”, perché le guide turistiche e le maestre d’asilo sono diventate “socie” di cooperative sociali in cui si ottiene lavoro per tre mesi all’anno per sei euro orari… perché si è fatto questo, individualizzando e smembrando una dimensione collettiva, di rappresentanza, di consapevolezza di classe?…. perché anche a livello discorsivo c’è stato questa trasformazione linguistica (al punto che c’è chi pensa che “siamo tutti imprenditori”?).
E soprattutto perché invece in altri contesti, in situazioni di crisi violente, si è risposto diversamente, per esempio in Argentina con l’esperienza delle fabbriche recuperate? Con l’esperienza delle mense comunitarie, dei forni vicinali, delle scuole e degli ospedali autogestiti… collegati tra loro nelle assemblee di quartiere… tutte cose che hanno funzionato in una città di otto milioni di abitanti come Buenos Aires per anni… perché in Italia ti dicono comprati la fabbrica, diventa padrone (anche solo a livello psicologico o linguistico) e assumi i tuoi colleghi, o tienili in nero tanto siamo tutti amici, è quasi una famiglia… mentre in Argentina la gente ha pensato “blocchiamo la svendita dell macchine e lavoriamo noi, licenziamo il padrone e facciamoci tutti lo stesso salario”… siamo tutti compagni e non c’è il padrone…e l’hanno fatto in forni, farmacie, hotel e mense scolastiche, e poi hanno obbligato i tribunali del lavoro a riconoscere nel diritto uno stato di fatto conquistato con la lotta… questo è il dibattito che mi piacerebbe lanciare…
“i loro piccoli emuli di provincia che non “arrivano più a fine mese” perché hanno 3 smart, due mercedes e 2 amanti?”
…
http://www.youtube.com/watch?v=Fd0uYqRE5vU
Beh Alberto il libro lo regalerò’ a molti amici perché’ questa storia deve circolare il più’ possibile. L’inquinamento e le morti causate dal lavoro sono storie troppo note purtroppo ma quando le unisci ad un racconto che emoziona diventano così’ vivide che riesci a raccontarle con molta piu’ forza e convinzione, forse questo è’ uno dei compiti della letteratura, dare forza alle storie e premettere a chi non le ha vissute di divulgarle a sua volta. Grazie a te agenzia x e Giap (lunga vita) per avere diffuso questa storia.
Prendersi la fabbrica senza diventare padroni:
http://www.wsm.ie/c/occupied-greek-factory-viome-workers-control
…una fabbrica in Grecia sotto controllo operaio
[…] Conversazione su Amianto di Alberto con WU MING […]
Tornando sul tema dei suicidi vi segnalo:
La lista di Giuseppe
Di lavoro si muore, di non lavoro pure.
Il tre febbraio si è ucciso a Guarrato (Trapani) Giuseppe Burgarella, 61 anni, operaio edile e sindacalista. Non era un funzionario sindacale col culo al caldo, Giuseppe, in una terra dove fare sindacato nel settore più amato dai mafiosi non ti comporta vantaggi, semmai minacce e intimidazioni. “Qui – dice il fratello – chi è di sinistra, chi fa sindacato, è segnato, non è facile che trovi lavoro chi è così schierato a difendere i diritti”.
Continua su: http://illavorodebilita.wordpress.com.
[…] prima versione di questa corrispondenza è apparsa su Giap nel corso del dibattito sul libro di Alberto Prunetti “Amianto. Una storia […]
ho finito di leggerlo stamattina. tutto d’un fiato, come quelle medicine, quegli antibiotici densi che da bimbo mia madre mi faceva prendere tappandomi il naso, “giù che ti fa bene”, tremendi, ma salutari, ché poi la bronchite e la febbre passavano.
che cosa hai scritto, davvero.
mentre leggevo, ho istintivamente collocato le tue parole come il seguito, o meglio *il lato oscuro* de La chiave a stella di Levi, altro libro che avevo a suo tempo divorato, e che Wu Ming 1 ricordava proprio l’altro giorno nell’intervista su Fenoglio. forse il termine giusto è la neccessaria integrazione, anche se non sono sicuro che sia poi così necessario incasellarlo, dargli una collocazione precisa.
mi sono commosso, sentendoti parlare del tuo papà, del tuo babbo. ciò che sei riuscito a trasmettermi non è solo un generico senso di pietà, di empatia dovuta alla vicenda tragica di cui siete stati vittime: ciò che ho provato è veramente simile alla perdita di un congiunto, ad un torto rivolto contro la mia famiglia, ad un’ingiustizia che brucia come se fosse stata portata al mio sangue.
compagno, commuoversi, condividere; la radice è la stessa, ed è esattamente quella che ci è stata tolta. non voglio scadere nella retorica, ma credo che libri come il tuo, e vicende come quella di Renato, possano concorrere alla creazione di una coscienza comune, di una base dalla quale ripartire, tutti insieme, con la consapevolezza che, anche se siamo il portato di storie molto diverse, il nostro futuro appare ora più che mai simile.
vorrei scrivere altre mille cose, mi auguro siano comprensibile quelle poche che ho scritto qua sopra.
I commenti dei lettori integrano sempre il testo e portano a riflettere sulle intenzioni di chi ha scritto. A un certo punto ho maturato l’idea che nella figura di Renato dovessero concentarsri i “babbi” di tutti i miei compagni d’infanzia, quasi tutti operai. Era un modo di uscire dal personalismo spinto di una narrazione auto/biografica. A me ha fatto pensare molto una compagna che mi ha detto che durante la lettura del libro, a tre/quarti del libro, quando Renato muore, lei ha vissuto un vero e proprio lutto. E aveva i lucciconi agli occhi mentre lo diceva. Questo mi ha colpito molto, anche perché io speravo di chiudere, di elaborare il mio lutto personale con questo atto di scrittura ed è evidente che non avevo un progetto vittimista, non volevo dare il magone o dire “povero me, ce l’hanno tutti con me, cosa ci è successo…”. Non solo non mi aspettavo di commuovere tanto ma neanche di indurre altri a un lutto, come dire, testuale, letterario, eppure neanche tanto fittizio, visti i lucciconi che mi capita di vedere durante le presentazioni. E allora mi sono chiesto: perché la gente si commuove così tanto leggendo il libro (anche se poi non tutti hanno le stesse reazioni e studiando i messaggi che mi arrivano o le lettere, mi sembra che più aumenta l’immedesimazione nel contesto raccontato, per ragioni di provenienza sociale, più aumenta la possibilità di una fusione emotiva, patemica, tra lettore e autore)? E che cosa piange chi piange questo lutto narrativo? Chi muore davvero in Amianto? Renato? La centralità della classe operaia? Il padre del lettore? Un mondo provinciale di rapporti conviviali e solidali che è stato dimenticato nei condomini urbani? Non lo so, ovviamente sono cose che ogni lettore conosce dentro di se. Io rimango sorpreso perché non ho programmato una macchina emotiva. O se l’ho fatto, la macchina girava di moto proprio, e io le ho dato solo qualche goccia di lubrificante… (a proposito, OT di brutto ma di macchine e di riparazioni informali se ne parla nel libro… qualcuno che si occupa di meccanica e componenti per l’automobilistica sa qual è il prezzo dei cilindretti dell’impianto frenante posteriore di una Ford Fiesta del 1996, anche ricambi non originali ma compatibili?).
E’ dal 6 febbraio che ho questo post sul computer. L’indecisione su mandarlo o meno mi ha accompagnato a lungo.
Non ho letto il libro, ma la discussione fra Prunetti, Wuming1, De Michele, più tutti i commenti, mi hanno smosso dentro una serie di cose che mi parlano da molto a voce alta in testa. Questo post su “Amianto”, fra i molti ha un gran pregio: quello di spingerti a fare conti con la memoria, a ripescare nel cono, a ricordare.
Il mitologema indicato nella morte del vecchio, credo entri parecchio anche nella mia storia personale. Che vorrei condividere proprio perché non credo abbia nulla di molto speciale, ma che accomuni molti, chiaramente non solo i figli degli operai.
Il mio babbo insomma, nato a metà degli anni ’30, era inizialmente un contadino, figlio di contadini, nella provincia aretina in Valdichiana. Prima “a padrone”, poi con un ettaro e mezzo di terra e qualche bestia. Poi il lavoro salariato, gli anni sessanta, il posto fisso da bidello nella scuola di massa, la DC. Un democristiano militante, con tanto di inaugurazioni di “case dell’amicizia”, con Fanfani e un piccolo polpettide che porge le forbici per il taglio del nastro, in una foto, ora in una scatola di cartone nel cassetto di casa.
E il mondo operaio l’ho conosciuto “di rinterzo”, attraverso parenti alla lontana e amici del babbo e della mamma, che erano migrati nelle città industriali, che le loro famiglie non ci avevano neanche l’ettaro e mezzo di terra ne le bestie, e c’era la miseria dopo la guerra. E allora Prato nel tessile, Genova nei cantieri navali. E le dita tagliate dello zi’ Nanni, mangiate dai telai; le “cento Malboro al giorno” fumate da Claudio, figlio dello zi’ Bistino; tutta una famiglia nelle fabbriche a Prato, a rovinassi la salute e l’anima. Ma con queste persone, parenti di secondo o terzo grado, c’era un legame che andava oltre l’appartenenza familiare, che aveva a che fare forse con la tradizione contadina. C’era, nonostante la lontananza fisica, una solidarietà, derivante forse da un senso di appartenenza, che non so se definire di classe. E allora quando si andava in “città”, si portava il vino, e l’olio, e le ceste piene di verdure. Con queste si “pagava” a volte anche l’ospitalità durante le ferie estive, quando si condivideva la casa al mare, (che non ci si faceva ad affittarne una per ogni famiglia). Il mi’ babbo e lo zio Bistino poi, litigavano per quale telegiornale guardare. L’operaio voleva rai tre, lo statale rai uno, s’accordavano su rai due, almeno si trovavan d’accordo a parlar male dei socialisti.
Più crescevo però, più il legame, la base solidale, di mutuo aiuto si allentava. Gli anni ottanta inoltrati, l’individualismo, il volerti far vergognare delle tue origini. Il vicino di casa figlio di imprenditore (imprenditore vero, con la ditta edile e la villa “moderna”) che mi pigliava per il culo perché il mi’ babbo andava a far legne nei boschi dei ricchi, e non ci si aveva i tozzi tutti belli precisi, e mi diceva che noi s’adoperava “la legna usata”.
Ecco alla fine degli anni ottanta qualcosa s’è rotto. Le visite fra famiglie eran sempre più rade, ognuno pensava sempre di più al “suo” e il mi babbo s’è ammalato. Di testa, un esaurimento, che gli si riverberava però sul corpo, con un prurito infernale, che si grattava agli stipiti delle porte, e agli angoli delle mura della casa. Fino a scorticarsi. Come se volesse cambiar pelle, come se non ce la facesse più a vivere il suo corpo.
Lui diceva che era il lavoro. Il lavoro, come dice Prunetti, che quando va bene (e diciamolo, al babbo mio gli era andata bene) è “routine e stress”. E diceva che il lavoro lo aveva fatto ammalare. All’arrivo delle prime erosioni dei diritti, dell’incuria dello stato per la cosa pubblica. All’arrivo dei “tagli”, che alla scuola dove aveva lavorato per trent’anni, davano sempre meno risorse. E la scuola che iniziava a cadere a pezzi, a scricchiolare, a lasciare calcinacci che poi diventeranno macerie. Quelle macerie, che abbiamo trovato noi, come dice Prunetti, “quando siamo saliti di sopra”.
Ora, non voglio mica fare del mio babbo un eroe democristiano. Dalle mie parti si dice: “ognuno fa la frusta pe’ il su’ culo”. Lui quel mondo, aveva contribuito a costruirlo in maniera attiva, con scelte personali e politiche precise. E sicuramente la condizione di “impiegato statale” era molto migliore rispetto a quella operaia. Aveva accettato il clientelismo, aveva avvallato quarant’anni di governo bianco, della balena nella cui pancia stavano i peggiori mostri del capitalismo e del liberismo. Aveva “venduto” un mondo fatto di rapporti umani, solidali, in cambio di un salario, d’una macchina, d’una casa, d’una “sicurezza” per la famiglia. E alla fine credo si sia sentito tradito. Tradito nel senso etimologico del termine, da “tradere”, “consegnato”, “passato di mano”. E secondo me si era ritrovato più solo, in una situazione nella quale i “beni” materiali non potevano compensare la destrutturazione di una rete di rapporti umani e sociali solidali.
Non una vittima del sistema, ma vittima di se stesso. Tradito infine dalla terra anche, ultimo rifugio nel quale lavorava spasmodicamente. Tradito da un muricciolo dei terrazzamenti di un uliveto, dove ci faceva l’olio per la famiglia. Il muricciolo che gli ha “slamato” sotto le ruote del trattore troppo vecchio, senza cabina di sicurezza, che il tubo poi gli ha tagliato la gola.
Ecco, ancora il lavoro, l’autosfruttamento, morire di lavoro.
Il mi’ babbo è morto nel luglio del ’92, pochi mesi prima di poter vedere il crollo conclamato del suo mondo, con le inchieste che ad uno ad uno, facevano cadere tutti i caporioni di un potere politico-economico durato quarant’anni, capace poi di travestirsi e rigenerarsi in nuove forme di sfruttamento anche più invasive.
Ci rientra questa storia nel mitologema “della morte del vecchio”? «un fondatore / capostipite / capofamiglia muore, la sua morte coincide con la crisi terminale di un mondo e i figli / eredi / successori devono decidere come andare avanti in uno scenario radicalmente mutato».
Non voglio dire che la storia di un impiegato statale, sia sovrapponibile a quella di un operaio esposto a una serie di nocività e sfruttamento sicuramente maggiori.
Ma possono essere storie parallele? Può essere che questo lutto, sia un altro esempio di “un mondo provinciale di rapporti conviviali e solidali che è stato dimenticato nei condomini urbani?” (come dice Prunetti nel suo ultimo intervento).
Dalla mancanza, dal lutto, di questi *rapporti solidali*, *conviviali*, è da questo vuoto che bisogna forse ripartire?
Scusate se il post è confuso, troppo lungo. Sicuramente mi son perso, causa coinvolgimento personale.
Spero però di non aver cacato troppo fuori dal vaso, e di non aver scritto solo un polpettone “autosfogatorio”.
Maiala quanta roba, altro che falla fori dal vaso…
Solo alcune osservazioni, perché il tuo commento è così pieno di storia e di vita nuda che mi verrebbe solo da dirti: lavoraci ancora, trasformalo in qualcosa di più, in un oggetto narrativo…
Però alcune cose al volo, sulla ruminazione lenta che ho fatto delle tue parole, voglio dirle:
_è molto interessante quel periodo fondamentale della storia italiana, quando nel dopoguerra si fa la riforma agraria… in Amianto ne parlo a un certo punto, perché è un episodio che ci cambia, ci trasforma antropologicamente… alcuni accettano la terra, altri la rivendono (magari ai vecchi proprietari latifondisti) e vanno a vivere in città. Assieme al boom economico, c’è una nuova mutazione culturale degli italiani. La tua zona poi in Toscana è particolare, perché era un feudo bianco, era zona “fanfanizzata”… eppure anche da me, dove c’era l’Ente Maremma – ma Bianciardi lo chiamava l’Ente Merenda – era la Dc che da Roma decideva se si poteva avere la quota di terra o no, e bisognava far vedere la tessera. Son storie che ha raccontato molto bene una mia amica, una contadina e pastora che in pensione si è messa a scrivere, si chiama Luciana Bellini, cercate i suoi libri. Allora nel grossetano anche il PC acconsentì bene o male che la gente pigliasse la tessera Dc per un anno, il tempo di fare le pratiche… te lo diceva anche il prete: prendi la tessera DC, poi ti faccio avere la terra, e poi ritorni comunista. L’hanno fatto in tanti, quasi tutti, dei contadini nostri e sostanzialmente hanno fatto bene. Poi c’è anche chi non si voleva piegare: un’altra mia amica, che adesso vive in un bel pezzo di terra, mi racconta che suo babbo da piccolo, a otto anni, nel dopoguerra ci andava a rubare la legna in quel fondo che non era suo (hai parlato anche di legnatico, e anch’io mi riscaldo con gli avanzi di potature): se tornava a casa a mani vuote, il nonno lo picchiava. Il nonno non volle prendere la tessera DC e non gli toccò la quota. Poi se l’è comprata coi risparmi di una vita e il bimbo che ci veniva a rubà la legna ora ci fa l’orto, ci ha messo gli ulivi e ci tiene i cavalli (erano una famiglia di cavallai, e in parte lo sono ancora oggi). Son storie queste della fine del latifondo e della mezzadria che sono importanti, anche perché chi non ha preso la quota o l’ha rivenduta è diventato operaio o comunque, come tuo padre, si è inurbato. E in città cambiano tante cose.
_”Fanfani” in Maremma era il nome di parecchi cani da caccia al cinghiale, di quelli furbi che non andavano mai sotto al nemico e non si facevano ferire…
_le risse politiche al tavolino la domenica a pranzo erano un classico: le più belle me le racconta un mio amico che aveva babbo e zio operai a Piombino, ma uno comunista e l’altro socialista (socialista alla maniera di Pertini, per intenderci). Iniziavano a leticà prima ancora di mettersi a sedere e le donne si sbrigavano a rovescià i tortelli per sedare la rissa domenicale. Il comunista tra l’altro era pantagruelico e non riusciva a attendere che i tortelloni (che qui sono enormi) si posassero sul piatto: alzava il piatto con una mano al livello del naso e lo disponeva in piano inclinato tra la sua moglie in piedi col vassoio e la sua bocca e con la forchetta agevolava lo scorrimento. E’ morto anche lui di un tumore, ormai tanti anni fa.
_sugli anni ottanta: per me la crisi che viviamo noi è iniziata lì. O meglio ancora con la crisi petrolifera del ’73. Nei primi anni ottanta va in crisi l’industria pesante e soprattutto il petrolifero (infatti mio padre che fa l’operaio nelle raffinerie si trova in cassaintegrazione). Quel che segue sono ristrutturazioni del capitale che ha cercato di spacciare opportunità in un’economia al collasso: qualcuno le ha colte e momentaneamente ci ha guadagnato, salvo poi ritrovarsi adesso indebitato con banche indebitate, ma il grosso ha visto benessere e occupazione sfumare. Come generazione noi ci siam cresciuti dentro e retrospettivamente possiamo dire che è andata sempre peggio, ma davvero noi siamo in crisi da 30-40 anni. Posso affermare senza che scoppi un altro casino che mi viene da sorridere quando gli imprenditori si lamentano d’essere da un paio d’anni col la canna alla gola? Noi ci siamo da 35 e siamo ancora vivi.
_di quelli che muoiono: terribile la storia di tuo padre, com’è morto in quell’incidente sul trattore. Da una parte ci leggo una cosa che capisco benissimo, il bisogno di continuare a tenere i piedi nella terra, anche in pensione (o nelle ferie: da me si prendevano le ferie in fabbrica per fare le olive, lo faceva anche mio padre; è quello che a Taranto chiamano il “metalmezzadro”). Dall’altra una riflessione breve sui morti sul lavoro. Quando si dice che sono tre ogni giorno e perlopiù operai, al solito ci si dimentica qualcosa. E’ come quella pessima battuta che dice: morti due uomini e un contadino. Ci si dimentica dei contadini. Di quelli morti sul trattore rovesciato (o con la mano finita nel trinciasarmenti o peggio ancora, com’è successo a un ragazzo, risucchiato dalla rotoballatrice, che è una cosa che mi vengono i conati di vomito a pensarci, per chi non si intende di campagna è quella macchina che risucchia il fieno o la paglia tagliati e essiccati e li avvolge strettamente a formare le rotoballe, cioè quei cilindroni di fieno o paglia a cui a maggio i turisti fanno le foto dalle piazzole dell’autostrada…). Questi morti non vengono conteggiati come morti sul lavoro: il pensionato non risulta all’INAIL per quel lavoro, quindi è escluso. Ma è escluso anche il trattorista professionista, che magari lavora per conto terzi in una grande azienda, perché statisticamente fanno rientrare quelle morti… come incidenti stradali. I morti sul trattore li conteggiano come incidenti stradali, capito, nemmeno ti riconoscono come vittima del lavoro! (Poi al solito è più facile morire se hai un trattorino, magari una cingolina Fiat degli anni 60 o un pasqualinaccio… perché il John Deere con la cabina ha più protezioni e non ti si sfracella addosso, però insomma… può succedere di tutto). Basta perché sennò vado off topic.
_la crisi economica è un’opportunità per il capitale (che come dice Girolamo De Michele non è in crisi occasionalmente, è la crisi, è crisi strutturale, sistemica, perché aggiungo io è fallimentare, ed è per questo che alla fine chi fa impresa fallisce mentre chi è rimasto in un contesto di rapporti sociali mangia cipolle ma si “indebita” del “debito buono”, quello con il vicino che ti taglia la legna e te gli restituisci una dozzina d’ova, non col debito tossico del capitale, che ti indebita per mangiarti la casa). Il capitale è un cancro che avanza: deve distruggere i rapporti sociali buoni per espandersi, per aprire nuovi mercati, per elaborare nuovi bisogni e creare aspettative di consumo e quindi produzione. Per questo per avere nuove chance di produzione e consumo deve indurre a trasformazioni antropologiche che cambino il modo di vita delle persone, i loro desideri, le loro aspettative. Da noi è successo con la riforma agraria e con il boom economico, e poi con la crisi degli anni Ottanta (che noi ce li ricordiamo di merda, anni di erosione delle conquiste sindacali dei lustri precedenti, ma per i ceti padronali medio-alti sono stati anni di successi, appunto sulla base della pace sociale e della sconfitta dei ceti subalterni, medio bassi e bassi). In altri paesi l’irruzione del Capitale e la scoperta del mercato è arrivata con il colonialismo. Ma qui si apre un altro discorso e mi fermo.
Polpettide e Prunetti, questo scambio è molto importante. L’Italia è quella del ‘metalmezzadro’, è quella che negli anni ottanta e novanta si è smarrita senza sapere più che era e dove andava e cosa faceva. Tutto un gigantesco rimosso.
Ora si cercano nelle storie dei nonni e dei padri le ricette della vita contadina, i vecchi mestieri, le vecchie storie. Ma non si racconta come si viveva veramente (partorire, e il giorno dopo dover scendere a mungere le vacche. Dare ai bambini il papavero per farli dormire quando si lavorava nei campi, e pazienza se qualcuno rimaneva un po’ tonto – Negli anni ’60-70 eh, mica chissà quando).
E non si racconta cosa è successo quando tutto questo è cambiato, quando è finita la mezzadria, quando i diritti hanno preso il posto dei privilegi (no, figurati, sono passati pochi decenni e quei diritti si stanno rivelando dei semplici colpi di fortuna, il denaro è sempre la misura del privilegio).
Non è cosa recentissima, ma quando sono arrivata in campagna io dalla città, nessuno del posto voleva ristrutturarsi la vecchia abitazione coi travi a vista (ambita dai forestieri), perchè i travi gli ricordavano la prima cosa che vedeva, all’alba, aprendo gli occhi, e non voleva saperne più. Nessuno più voleva andare a far legna, e non voleva più tenere il bosco. Così ora altri hanno i casali, e i boschi sono discariche.
Di tutta la transizione fra un’epoca e l’altra non c’è traccia. Nessuno ricorda. Solo ricette, filastrocche e teneri vecchietti.
Almeno qui, terra di confine tra Toscana e Umbria, ci sono un paio di generazioni che sembrano scese da un’astronave.
Caro Alberto, bellissimo intervento, pieno di spunti da inseguire e anche di bellezza. Mi limito a sottolineare che è di questo tipo di oggetti che c’è un gran bisogno. Bè (come ebbe a dire Cionfoli) per adesso ti scrivo solo grazie :)
Per Alberto
Grazie innanzitutto. Perché dopo più di 190 commenti riesci sempre a risponderci a tutti con puntualità.
-Per quanto riguarda lavorare ancora sui miei ricordi… beh diciamo che mi è venuta la voglia… non so se ne ho le capacità e (toh!) il tempo…
Però vedi, a parlarne delle cose si fa chiarezza. Il passaggio dallo “stare a padrone”, la mezzadria, alla piccola proprietà terriera, è iniziato nel 1950, appunto con la riforma agraria.
A vederla così, mi pare che questo “cambiamento antropologico”, possa essere considerato come un prodromo per il “boom economico” che si dispiegherà pochi anni dopo, dalla fine dei cinquanta.
-Per le tessere che dire… mi vien da ridere. Mi hai fatto ricordare una storia speculare!
Il babbo del mio babbo, il nonno Nello, era anche lui un democristiano convinto. Una persona dura come il bastone con il quale l’ho visto sempre accompagnarsi. Con il nipotino più piccolo (cioè me) era a volte però un po’ più tenero.
E mi ricordo bene (anche se non so bene perché…) una volta mi fece vedere, nascoste nel fondo del cassetto del suo canterano, come un peccato cacciato giù in fondo all’anima, due o tre sue tessere del PCI, degli anni immediatamente successivi alla guerra. Mi disse che le aveva prese, perché sennò le mietitrebbie non gli avrebbero trebbiato il grano. Non so se a lui o al padrone di cui era mezzadro…Ma è un ricordo vago, da bambino… mi informerò meglio…
Infatti, in mezzo al feudo fanfaniano della “Chiana”, c’era Cortona, che invece era rossa, e insomma evidentemente la tessera del PCI lì serviva, nell’immediato dopoguerra, in maniera analoga a quella della DC in maremma nella storia che hai raccontato te.
Quando, molto tempo fa, chiesi a mia mamma di queste tessere, lei mi disse che sicuramente mi sbagliavo…che non esistevano…
Mica glie le avranno infilate nel vestito buono al nonno Nello, e giù tutto insieme nella fossa? Indagherò…
–
Una precisazione. Forse non mi son spiegato bene nel commento, mio padre e la mia famiglia, siam rimasti sempre a Cortona (Camucia), quindi lui non si è siamo inurbato in senso fisico, cioè non ci siamo trasferiti in città.
Io si, per l’università, e poi ci son rimasto a Firenze…
-Si Fanfani era molto furbo, l’associazione con il cane da cinghiale è meravigliosa!
Per Paola di Giulio
-Tu dici: “Ora si cercano nelle storie dei nonni e dei padri le ricette della vita contadina, i vecchi mestieri, le vecchie storie. Ma non si racconta come si viveva veramente”
Ecco, io non voglio assolutamente mitizzare un periodo aureo, di vita contadina, nel quale si stava meglio quando si stava peggio.
Le condizioni di vita della mezzadria, del mondo contadino in genere, erano chiaramente molto dure. La famiglia della mia mamma, è rimasta a mezzadria fino ai primi anni ottanta, e mi ricordo benissimo la mia cugina che faceva il bagno in cucina in un gran tino ( di plastica chiaro…), che io ci avevo sei o sette anni. Niente di grave, ma non stavano proprio agiati.
Per me, parlare della capacità che c’era di esprimere mutuo aiuto, di costruire rapporti solidali, non vuol dire rimpiangere un mondo che non c’è più.
Vuol dire che certe caratteristiche che a me paiono positive, mi piacerebbe ripescarle dal cono della memoria, riattualizzarle, riusarle, in maniera propositiva, anche in un contesto totalmente diverso, dell’ora e del qui… non so se mi son riuscito a spiegare…
Ora basta, altro commento lunghissimo… che dire ancora
Per Alberto,
Le cose che hai messo in ballo son molte. Leggerò al più presto il libro, (e anche Bianciardi, e cercherò anche la Bellini), comunque spero di poterne parlare a voce, il 3 marzo al nEXtemerson, per la presentazione del libro. Che l’altra volta che venisti per presentare il “Fioraio di Peròn”, mi morsero il cane e mi toccò andare dal veterinario, e mi persi quasi tutta la presentazione.
Il cane lo lascio a casa a questo giro.
Eh polpettide, oggi è mercato a Camucia, che ti perdi…
Ho capito il tuo discorso, sono d’accordo, ovvio. Io mi riferisco al rimosso, a tutto quel che è stato veramente rimosso dai cervelli e dagli animi. Perchè senza consapevolezza non puoi nemmeno ripescare i valori che dici tu.
Arrivato e letto! Come figlio di metalmeccanico che iniziò a lavorare a 14 anni (ma ha avuto più fortuna di Renato, e ora sta leggendo la sua storia a sua volta) posso capirti abbastanza, e il mio commento nel thread su Grillo, che poteva sembrare un po’ baravantano, era dovuto all’associazione di idee con la tua descrizione degli anni Settanta “plumbei ‘na sega!” In Piemonte c’è stato per fortuna Nuto Revelli a fermare su nastro e su carta le vive voci dei vinti e la transizione dalla campagna alla fabbrica (Ferrero, Michelin, e Fiat naturalmente) fino alla città è registrata con tutte le sue differenze (non era la stessa cosa in pianura, in montagna e in collina, come si diceva…)
Avere il padre operaio di questi tempi è vivere una sorta di handicap nei confronti di tutta la società. “Ah, hai il padre operaio? Mi spiace che sfortuna”. Come se dovessimo chiedere scusa se non si possiede alle spalle la famiglia borghese o del ceto medio che possa alleviare il dolore dell’ instabilità lavorativa. Questa instabilità come un virus si porta via tutto, affetti, emozioni. Le tue relazioni diventano sempre più fragili. Come è fragile la tua posizione a questo mondo. Ti perdi e forse non ti puoi più ritrovare. Stai sempre con lo zaino pronto per andar via, e sei sempre il primo ad andare via dai posti di lavoro. Hai la tua rabbia e quella anche del tuo babbo. Cerchi di far valere i tuoi diritti, la tua dignità, Ma ti ritrovi quasi sempre solo. E in fondo lo sappiamo da sempre. Il padrone ‘rogne’ non ne vuole. “Mi spiace sei brillante, ma non possiamo tenerti. Sono brutti momenti per tutti”. Chi ha un padre operaio, conosce la cassa integrazione, le trasferte, il conto bancario in rosso, il medico fiscale, le ingiustizie lavorative. La tua voglia di riscatto parte sin da piccolo. Il tuo modo di vedere le cose cambia radicalmente rispetto alla maggior parte dei coetanei che questo fardello non l’hanno addosso. Tuo padre ti fa studiare, diventi giornalista, dipingi, sei un creativo. Ma poco conta. Per lo Stivale tuo padre è uno sfigato. Tu di conseguenza. “Che conoscenze hai?” “Quali le tue amicizie?”. “Chi ti raccomanda?”.
Ciao, con gran fatica ho messo in fila alcuni pensieri suscitati da Amianto e, inevitabilmente, dalla discussione qui su Giap, tirandone fuori un commento finito sulla mia libreria di anobii. È stato come dovere infilare a forza una grande quantità di materia in un recipiente che più di tanto non può contenere, alla fine metterci il tappo non è stato facile. Lo riporto anche qui [e lascio alla fine del commento il rimando a questa stessa discussione, un rimando che è parte importante di quel che ho scritto e che volevo scrivere: leggete Amianto, parliamone, ancora].
——
Perché leggere Amianto? Perché Alberto Prunetti ha scritto un libro importante, la cui lettura per me ha significato tanto, così che ora è difficile trovare le parole da mettere in fila per scriverne un commento. Amianto è *una storia operaia* che racconta attraverso una singola vicenda umana un mondo e la sua fine, quella comunità operaia fatta di uomini e donne che dentro le fabbriche ci hanno passato una vita respirando fibre di amianto e particelle di metalli pesanti. Una storia del passato – nel nostro paese – ma che non è passata, che continua a fare vittime, anche se sono decenni che si cerca di epurarla dalle nostri menti. Storia di dolore e ingiustizia, ma che agli occhi e nelle parole di un figlio di quel mondo restituisce al lettore la dignità e la combattività di quella comunità, proprio quella parte su cui ci si accanisce con la fresa dell’ideologia individualista e competitivistica, per renderne inenarrabile il desiderio e la passione, la forza e la solidarietà. In questi nostri tempi schiacciati su un eterno presente lo sguardo di Alberto Prunetti è quello del testimone che è nato e ha passato l’infanzia in quel mondo, vivendone poi l’estinzione e la disfacimento antropologico, per trovarsi – come troppi fra noi nati negli anni Settanta, ma non solo – sì fuori dalle fabbriche, ma non liberi dal giogo dello sfruttamento e nemmeno liberi dalle nocività che dai perimetri delle fabbriche hanno invaso il territorio.
Amianto vi farà piangere, sorridere, incazzare, ridere. Soprattutto, come ha scritto Wu Ming 1 su Giap, “è un libro di quelli che si leggono per poi parlarne insieme.” E poi ci si sente meno soli.
Tante e tanti lo hanno fatto, con interventi colmi di emozione, rabbia, commozione e la voglia di un *levamiento*, per riprenderci ciò che ci spetta, dopo che siamo stati presi troppo tempo per il culo, noi, i nostri padri e le nostre madri.
Lo hanno fatto qui http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=11255
E sempre bravi ad Agenzia X.
[…] Conversazione con Alberto Prunetti su Giap—> Classe operaia, anima precaria. Conversazione con Alberto Prunetti, autore di «Amianto» […]
Abbiamo questa Yaris del 2005, comprata coi soldi regalati dagli invitati al matrimonio, più un finanziamento in comode rate mensili. Di solito la guida mia moglie, che la usa per andare al lavoro. Io sono un pessimo guidatore. Vado troppo piano. In autostrada e ai semafori faccio l’en plein delle strombazzate degli altri automobilisti. Non so parcheggiare. Ho totalmente sminchiato i parafanghi, strisciandoli decine di volte contro la porta del box.
Quando parcheggio, subito prima di togliere la chiave dal quadro, con la frizione pigiata do un ultimo colpo di acceleratore. Ci dev’essere un motivo tecnico, ma non so quale. So che mio padre ha sempre fatto così.
La prima macchina di mio padre che mi ricordo è un’Alfasud bianca, fine anni settanta. La comprò, in concomitanza con la sua decisione di tornare al paese, per contribuire al riscatto storico del meridione. Era un’auto veramente pessima; dopo pochi anni aveva già la carrozzeria tutta arrugginita. Rottamata l’Alfasud, mio padre si comprò una Ford Fiesta nera. La cambiò una decina d’anni dopo con un’altra, stessa marca modello e colore, e poi con un’altra ancora, dopo altri dieci anni. Oggi mio padre è in pensione ed è alla sua terza Ford Fiesta nera.
Mio padre emigrò dalla Calabria a Milano nel 1969; lavorò per un periodo alla Necchi come operaio, poi come impiegato. Nel 1978, come ho detto, diede le dimissioni e tornò in meridione con la famiglia. (Scelta dei tempi non particolarmente felice: in quel periodo, dopo due decenni di lotte sociali accese, il nostro paese d’origine era piombato in un riflusso senza speranza, e per tutti gli anni ’80 sarebbe stato funestato da una tenace faida tra gruppi di trafficanti). Coi soldi della liquidazione, mio padre aprì nella piazza principale un negozietto di filati e ricambi per macchine da cucire. Ma gli affari non andavano bene e dovette chiudere. Trovò impiego in un ente parastatale. Mia madre invece non riuscì a trovare altre supplenze alle elementari.
Mio padre, finché è esistito quel partito, ha sempre votato PCI, da posizioni vicine ad Amendola (quindi piuttosto “moderate”). Ora vota per il PD e credo abbia anche la tessera.
Non ricordo una sola volta che Bossi compariva nella televisione dei miei senza che mio padre lo ricoprisse di insulti coloriti e veementi, in dialetto.
Il suo grande cruccio credo consista nel fatto che tutti e tre i suoi figli hanno dovuto emigrare al Nord, come già fece lui a suo tempo.
Non ho ancora chiesto a mio padre, durante una delle nostre laconiche telefonate settimanali, cosa ne pensa di Beppe Grillo. Probabilmente nulla di differente da ciò che ne penso io. Glielo dirò: gli farà piacere.
Una cosa che mi piace di questa conversazione su Giap è che ha contribuito a riattizzare la memoria autobiografica di chi è intervenuto. Anche altrove ho ricevuto molti messaggi simili al tuo: la memoria biografica, una forma di resistenza in bianco e nero alle immagini contrastate con i colori vividi e plasticosi della modernità digitale. Mi piace anche quello che scrivi sulle tue vecchie automobili: abbiamo inventato la “biografia automobilistica”! Però non sono bravo nel campo dei motori. Anche a me hanno insegnato a sgassare prima di spengere il motore, “per liberare” le vie della carburazione, credo. Quanto alla Ford Fiesta, guido spesso quella della mia compagna: è del 1996 ma va che è un incanto.
Sul supplemento domenicale del sole 24ore di oggi ho appena letto una bella critica del libro di Alberto Prunetti – a firma Giosuè Calaciura. Volevo segnalarlo.
Paola, non ne sapevamo nulla e ormai è tardi per comprarlo… hai per caso il giornale? se sì, potresti mooolto gentilmente fare una foto o una scansione e mandarcelo a press@agenziax.it
?
grazie!
Scusate se uso questo spazio: per Agenzia X: sì, ho provato a mandare delle foto. Se non ha funzionato riproverò domani con una scansione.
Leggo solo oggi questa notizia, non mi pare che sia già stata postata qui, quindi la aggiungo per completezza.
http://goo.gl/O6J7w
En passant, mi ha fatto un effetto strano e automatico (quindi magari non è “giusto”): quello di essere nato in Somalia e di essere incazzato con l’Italia.
Vi segnalo l’intervista ad Alberto Prunetti su Radio Città del Capo. http://radio.rcdc.it/archives/luomo-che-respirava-amianto-115395/
Car* Compagn*, cercavo di scaricare come ePub questa immensa conversazione ma non trovo il tasto; è un problema solo mio o effettivamente non lo si può scaricare? grazie per l’aiuto.
ps: prenotata la mia copia
Il link è subito sotto il post (cioè prima dei commenti), c’è scritto “Download as ePub”.
In effetti però il pulsante “solito” non c’è..
Brutto intervenire la prima volta su Giap per un commento del genere, ma in effetti avevo già provato in passato a scaricare questa conversazione e non ci sono riuscito.
In effetti è vero. Non so spiegare perché, il plugin risulta attivo, e non c’è motivo per cui il bottone debba comparire sotto un post e non esserci sotto un altro… C’è un bug di quache genere. Cercheremo un altro plugin simile. Intanto, grazie per la segnalazione.
@oske: Ho trovato una soluzione alternativa. Prova a copiare questo
http://www.wumingfoundation.com/giap/wp-content/uploads/2013/02/11255.epub
nella barra dell’indirizzo.
@WM1 dovesse ricapitare in futuro: è “www.wumingfoundation.com/giap/wp-content/uploads/anno/mese/numeropost.epub”, teoricamente dovrebbe funzionare per ogni post.
Grazie, però mica si può pretendere che tutti i lettori adottino quest’escamotage, che è… molto poco user-friendly. Bisognerà capire qual è il problema.
Grazie per la dritta, adesso provo. L’avevo chiesto proprio perchè il bottone stranamente non c’era.
[…] Il 20 marzo scorso, a Bologna, in un’aula della facoltà di Lettere (via Zamboni 38) abbiamo presentato Amianto. Una storia operaia di Alberto Prunetti, libro del quale ci siamo occupati a fondo. […]
Faccio copia/incolla di un mio articolo pubblicato lo scorso 26 aprile sull’edizione regionale toscana di Repubblica, che non è disponibile per i giapster che vivono in altre regioni. Si intitola “Steve McQueen e la cooperativa”:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/04/26/gli-operai-lamianto-morire-come-steve-mcqueen.html
A STEVE McQueen è bastato qualche mese e non era un uomo normale. Era uno de I magnifici sette, era L’ultimo buscadero. Era bello come un dio. Eppure a metterlo ko sono bastati tre mesi accanto all’amianto,a contatto con le coibentazioni dei mercantili, quando era un giovane dannato e sbandato. Oppure sarà successo quando non aveva una lira in tasca. Forse quando stava pensando di scegliere se fare l’attoreo il piastrellista.O forse è stato quando ha indossato quella tuta bianco sporco, per evitare ustioni in caso d’incendio, mentre sfrecciava su un bolide nel circuito delle 24 ore di Le Mans. Un sospiro, un respiro profondo e una microfibra sfonda la barriera di filtri che abbiamo nel naso, scivola nell’esofago e si apre la strada verso i polmoni. Poi passano vent’anni, diventi l’attore più pagato del mondo, eppure mentre giri una scena in un film western, ovviamente senza controfigura, ti rendi conto che non sei più il bastardo di sempre: ti manca il fiato, il respiro non ha profondità. Allora ti guardi allo specchio e devi ammettere che Steve McQueen ha la pelle di un vecchio e solo gli occhi sono un’esplosione di metallo azzurro. Il resto è cuoio, pelle coriacea, unghie annerite per lo scarso ricambio di ossigeno. E i polmoni che si fanno neri. E quando si spengono i riflettori, il vecchio Steve torna a essere quel bambino abbandonato, malnutrito, nato nel 1930, vissuto in un pezzo dell’America di “Furore” di Steinbeck, un frammento di una foto di Dorothea Lange.
Allora ti ricordi che sei solo un povero sfigato con gli occhi troppo belli, che da piccolo dormivi per terra e che nella vita non hai mai smesso di scappare. Come Papillon, come ne “La grande fuga”, come in “Getaway”. Come Steve McQueen.
Se poi non sei neanche Steve McQueen e magari vivi nella Toscana della crisi, allora è davvero un disastro. Perché le fibre d’amianto le hai respirate per trentacinque anni e la vita che hai fatto è stata un passaggio da un mutuo alla cassa integrazione. Hai rincorso la pace ma la vecchiaia ti ha fatto l’anticipo e il cancro è intervenuto a gamba tesa e sei rimasto a mani vuote sulla soglia della bara. Senza nemmeno un “ciak, motore”, senza neanche andartene in moto a torso nudo fino alle spiagge della Florida con una bionda che ti abbraccia da dietro. Magari sei uno della Cooperativa Vapordotti, quelli che nell’Alta Maremma, nella zona boracifera di Larderello e Pomarance, rivestivano di amianto il sistema linfatico di tubi che trasferiva il vapore estratto dalle viscere della terra. Facevano un “cappottino” alle condotte con l’amianto, il cemento e il fil di ferro. Erano venti e ne sono morti sedici. Uno a uno, li operano ai polmoni, li imbottiscono di cortisone, perdono la vista e poi se ne vanno via e se ancora li ricordiamo è solo perché uno di loro, Franco Berti, che con la pasta d’amianto stuccava i tubi rovinati, continua a chiedere giustizia, con voce sempre più placida, ora che le loro vite sono state cantate in una splendida ballata, semplice, ingenua e toccante, che ti fa ribollire le viscere, dal cantautore Marco Chiavistrelli.
Altro che Vasco, altro che vite spericolate, quelli il metallo lo fasciavano d’amianto friabile, lo spruzzavano, lo respiravano. E nel tempo libero mica andavano sulla Harley-Davidson. Facevano l’orto, qualcuno andava a caccia, parlavano di Baggio e Batistuta al circolo Arci. Eppure sono morti, come Steve McQueen.
Io i film di Steve me li guardavo con mio padre. Tutti, ce li siamo visti, i western e quelli di azione. Mamma diceva quant’era bello, io e babbo, quant’era bastardo.
“Nevada Smith”, “Quelli della San Pablo”, tutti ce li siamo visti. A casa, in tv e in qualche cinema estivo sotto le stelle che cadevano nelle notti d’agosto sopra i paesi minerari delle Colline Metallifere, da dove veniva un pezzo della nostra famiglia, da quei colli pieni di vapori geotermici, dove le forze del sottosuolo andavano imbrigliate con un minerale potente e malefico, fibroso: l’amianto. Che ne sapeva, mio padre, che sarebbe finito anche lui come Steve McQueen? Io la storia di mio padre l’ho raccontata in un libro e dicevo che la ferita si era ricucita nella scrittura. Ogni tanto mi grattavo la cicatrice, quando incontravo un ferroviere con la leucemia in una presentazione o quando un vecchio operaio piombinese, che ha lavorato trentacinque anni negli altiforni delle acciaierie edè diventato cieco, mi ha messo in mano un cd e mi ha detto che il libro era in una nastroteca della Biblioteca Nazionale di Firenze, nel Centro nazionale del libro parlato, perché un’attrice l’aveva lettoe così avevano inciso la sua voce e adesso anche gli operai ciechi per il cortisone potevano ascoltare quella storia, che è la loro storia. Ero contento quel giorno, neanche troppo tempo fa, quasi ieri, perché mi sembrava di aver fatto una cosa utilee di aver chiuso i conti con le mie ferite. Ma è durata poco. Perché dopo un po’ mi ha chiamato mia madre da Follonica e io avevo un sesto senso che mi diceva di non rispondere. Però ho risposto e lei mi ha detto che si è ammalato anche un operaio che ha lavorato con mio padre spalla contro spalla, respirando la stessa aria in mille cantieri per quindici anni, uno con cui ho guardato le partite della Nazionale nel Mondiale del 1982, uno che con mio padre ha costruito il sistema di tubi per le serre di fiori più grandi d’Europa, sul Monte Amiata, uno che ci divideva mentre ci prendevano a cazzotti tra bambini figli d’operai, ma non subito perché prima qualche colpo dovevamo scambiarcelo, che la prepotenza è un buon segno, quando sei il figlio d’un operaio e ti aspetta un futuro di debolezza e di diritti incancreniti, come c’insegnava Steve McQueen.
Dove sono i saldatori, dove i manutentori, dove i carpentieri in ferro e i tubisti? Dove sono gli operai della Cooperativa Vapordotti? Erano venti, ne sono morti sedici.
Dormono sulla collina? Sarebbe comodo immaginarseli così: rigidi, zitti e muti, in uno Spoon River operaio. E invece no. Sono scappati, sono in fuga dal mostro che li ha fatti ammalare. Getaway, in fuga. La grande fuga. Come Papillon, come “L’ultimo buscadero”. Ma torneranno. Li stiamo aspettando e un giorno si rifaranno vivi almeno in uno schermo di un cinema estivo di provincia, sotto le stelle cadenti, per regolare i conti alla maniera di una pellicola americana di Peckinpah, come ne “Il mucchio selvaggio”. Cammineranno lungo le strade delle nostre città, col cappello texano abbassato sulla fronte, l’uno accanto all’altro, mio padre e quelli della Vapordotti e tutti gli altri metal cowboy. Anche Steve. Torneranno con gli occhi di ghiaccio e le tube blu e le tute verdi che ancora portano il loro odore, un sentore di ferro tagliato che respiro ancora in quella tuta che mia madre si ostina a stirare facendole la piega in fondo, nello stesso punto di una volta, come ha fatto per trent’anni, anche se io sono qualche centimetro più lungo di mio padre. Tracanneranno un gotto al circolino e sistemeranno le cose a modo loro e non basterannoi soldia ripagarli delle loro vite, perché non accetteranno rimborsi, neanche “Un dollaro d’onore”. Lo sanno bene loro che i soldi non sono tutto, loro che – esposti a ogni pericolo, tra lavori esageratamente nocivi, usuranti, letali, pericolosi- hanno lavorato una vita. Una vitaa rischio, piena di guai. Una vita spericolata.
Una vita come Steve McQueen.
[…] tratta di Voi, onesti farabutti (Ghelli, Caratteri Mobili) e Amianto (Prunetti, Agenzia […]
Per i torinesi, domenica sera Alberto sarà a parlare di Amianto al CSOA Gabrio (via Revello 3), all’interno di un ‘minisalone del libro’ che si chiama Alla Fine Della Fiera (programma)
Aggiungo soltanto che il giorno dopo, lunedì 20 maggio, sono in un luogo emblematico, a Casale Monferrato, a presentare il libro nella libreria labirinto, alle ore 21. L’organizzazione è di Voci della Memoria, col patrocinio dell’Associazione Familiari Vittime Amianto: http://vocidellamemoria.org/