Non possiamo cadere dalle nuvole parlando de La Stampa, giornale del potere FIAT non a caso soprannominato «La Busiarda».
Non possiamo cadere dalle nuvole parlando di un quotidiano che annovera tra le sue firme di punta – per fare un solo esempio – uno del calibro di Massimo Numa, già condannato per diffamazione, più volte apparso in resoconti di vicende poco chiare e sempre coperto dal direttore uscente Mario Calabresi, il quale si è rifiutato di fornire chiarimenti. Lo stesso Calabresi che in questi giorni si sta insediando a Repubblica.
Non possiamo cadere dalle nuvole, e nemmeno isolare La Stampa dall’andazzo generale dei giornali e di tutti i media mainstream italiani. Lo squallore e il servilismo sono dappertutto.
Tuttavia, è importante segnalare passaggi di fase, salti di qualità, ulteriori salti in basso e spostamenti a destra.
Il nuovo direttore de La Stampa è Maurizio Molinari, grandissimo frequentatore di studi televisivi, dove è sempre introdotto come «esperto di Medio Oriente».
Tra le altre cose, Molinari è autore di un instant-book sull’ISIS che sembra proprio un grezzo copia e incolla di articoli della stampa internazionale e pezzi di un libro americano sullo stesso argomento. Qualcuno lo ha segnalato, ma Molinari ha fatto finta di nulla. È un uomo di mondo, lui. Ha fatto un anno di militare a Oxford.
Il 10 gennaio 2016, Molinari ha inaugurato il proprio mandato con un editoriale intitolato «Da dove viene il branco di Colonia». Con il pretesto di “spiegare” gli eventi di Capodanno nella città tedesca, il neodirettore si è tuffato in un’ambiziosa ricostruzione storico-antropologica, affrontando molto alla carlona temi ben più larghi delle sue spalle.
Diversi commentatori – ma sempre troppo pochi – hanno esaminato quelle righe, denunciando i numerosi falsi storici e le pseudo-teorie che Molinari ha preso in prestito da apologeti del colonialismo e propagandisti del più vieto razzismo culturale. È un fatto che discorsi del genere, così platealmente ed esplicitamente colonialisti, sulla prima pagina de La Stampa – e quindi in un ambito di accettabilità mainstream – non si vedevano da un’ottantina d’anni.

La Stampa, 20 febbraio 1935.
Come da sempre accade, le migrazioni di uomini e donne stranieri permettono agli autoctoni – o agli emigranti dell’ondata precedente – di specchiarsi nei nuovi arrivati per sentirsi più civili, più colti, attribuendo ai diversi le proprie mancanze. Così, proprio nella repubblica dei clan mafiosi e dei regolamenti di conti tra famiglie di camorra;
nella repubblica del più bieco familismo amorale e del più solido welfare familiare;
nel regno delle grandi signorie industriali e capitaliste, dove un pugno di cognomi torna e ritorna in tutti i gangli del potere economico;
nell’Italia di stupri e violenze sulle donne da parte di mariti, ex-mariti, compagni e padri;
in quest’Italia qui ci tocca leggere, su uno dei principali quotidiani del paese, un editoriale che accusa di atavico tribalismo – o ancestrale, primordiale, Molinari abbonda in riferimenti temporali vaghi – e maschilismo tutte le genti arabe da Gibilterra a Hormuz.
Detta come va detta: l’editoriale di Molinari è una pericolosa sequela di pericolosi sfondoni. Cercheremo di elencarli e smontarli uno a uno.

Manifestazione femminista e antirazzista a Colonia, 9 gennaio 2016.
Prima, però, tocca dire alcune cose sugli eventi di Colonia, o meglio, su quel che gli eventi di Colonia sono diventati nei media nostrani e nel clima del razzismo italiano, tra invenzioni di sana pianta, foto false, video falsi trasmessi anche dai TG, invettive, deliri sulle «nostre donne» e perché le femministe non dicono niente? Dove sono, eh?
Già, dov’erano le femministe?
È presto detto: erano in piazza. A Colonia sono state le prime a mobilitarsi, contro le violenze di genere e contro la strumentalizzazione delle violenze di genere a fini razzisti.

Giù le mani dalle donne di Bruno Vespa!
Come ha scritto su Vice Mattia Salvia,
«I principali quotidiani italiani, per esempio, hanno parlato subito dei fatti di Colonia come di un attacco premeditato, nonostante la stampa tedesca non abbia dato credito a questa versione.»
Secondo Repubblica, «governo federale e [polizia federale] non smentiscono e di fatto confermano» l’ipotesi di violenze pianificate. [Per capirci, si sta descrivendo un attacco terrorista.]
Rileggiamo la frase: «non smentiscono e di fatto confermano». Cioè non hanno detto nulla al riguardo, ma il cronista è intelligente, lui capisce.
L’unica pezza d’appoggio (si fa per dire) era una congettura, un pour parler del ministro della giustizia che i giornali tedeschi e internazionali hanno riportato in quanto tale mentre in quelli italiani è diventato oro colato. Ne è derivato il titolo più sudicio della storia del giornale. Buon quarantennale.

Non è Stormfront, è Repubblica. «Titolista, dillo con parole tue!».
Il ministro Heiko Maas aveva detto: «Nessuno può dirmi che questo non era coordinato e preparato».
E invece il rapporto dell’Ufficio Federale Anticrimine Nord Reno – Westfalia ha escluso che si trattasse di violenze pianificate, e se vi fate un giro sui siti dei giornali europei, la sicumera di Repubblica non ha un corrispettivo da nessuna parte.
Va ribadito: non stiamo parlando di pagine FB rivoltanti e piene di bufale come «Tutti i crimini degli immigrati». Non stiamo parlando nemmeno di Libero o de La zanzara. Parliamo della stampa mainstream presuntamente “seria”, faro della democrazia e quant’altro.
«E dai loro costumi ancestrali si originano…»
Torniamo a Molinari, e prendiamo in esame i suoi sfondoni, uno per uno. Ci vorrà molta pazienza. N.d.R. I numeri tra parentesi quadre sono nostri.
«[1] L’assalto di gruppo alle donne di Colonia è un atto tribale che si origina dall’implosione degli Stati arabi in Nordafrica e Medio Oriente. Il domino di disintegrazione di queste nazioni fa riemergere tribù e clan come elementi di aggregazione, esaltando forme primordiali di violenza. [2] Regimi, governi ed eserciti si dissolvono e vengono sostituiti da capo-villaggio, assemblee tribali, milizie.»
 Molestare, aggredire e scippare donne per strada durante i festeggiamenti di Capodanno sarebbe dunque un atto tribale, riferibile a tribù nordafricane e mediorientali. Chissà da quale studio etnografico o storico-culturale è desunta questa affermazione. I responsabili di quelle violenze venivano da diverse parti del mondo. C’erano marocchini, e il Marocco non è uno stato arabo imploso. C’erano musulmani e cristiani. Ci sono state molestie tedeschissime.
Molestare, aggredire e scippare donne per strada durante i festeggiamenti di Capodanno sarebbe dunque un atto tribale, riferibile a tribù nordafricane e mediorientali. Chissà da quale studio etnografico o storico-culturale è desunta questa affermazione. I responsabili di quelle violenze venivano da diverse parti del mondo. C’erano marocchini, e il Marocco non è uno stato arabo imploso. C’erano musulmani e cristiani. Ci sono state molestie tedeschissime.
E poi: capivillaggio, assemblee tribali, milizie… Le molestie e le violenze di capodanno erano guidate da colleghi arabi di Abraracourcix? Erano state decise da assemblee di tribù? Per strada c’erano milizie?
Secondo il già citato Ufficio Anticrimine Federale di Nord Reno e Westfalia, dall’inizio di questo decennio sono undicimila i casi accertati di furto e violenza nei pressi della stazione centrale di Colonia. La zona è ad alto rischio, per varie ragioni legate all’urbanistica, all’esclusione sociale, alla mancata prevenzione ecc. Molinari, invece, tira in ballo imprecisate milizie e fantomatici capivillaggio.
«Le tribù sono protagoniste del deserto dall’antichità e dai loro costumi ancestrali si originano [3] il chador per le donne, [4] la decapitazione dei nemici, [5] la vendetta come proiezione di forza, [6] il saccheggio per arricchirsi, [7] la poligamia e [8] il potere assoluto degli uomini sulle donne.»

Nel settembre 1937 gli italiani decapitarono il capo guerrigliero etiope Hailù Chebbedè. La testa girava in una scatola di biscotti, tra la truppa ridacchiante. Dopo il dileggio, fu appesa nella piazza del mercato di Socotà e lasciata marcire.
Non fa una piega. La decapitazione dei nemici è esclusiva delle tribù del deserto mediorientale, Molinari è certo che non si sia mai vista altrove, né in Europa né in estremo oriente né nelle Americhe. Nessuno ha mai tagliato teste in città, sulle montagne o nelle foreste.
Per non dire del potere assoluto degli uomini sulle donne: non è mai esistito se non nel deserto.
Il saccheggio per arricchirsi, poi, chi l’ha mai praticato se non questi selvaggi del deserto?
Quanto alla vendetta, nessuno se non nel deserto si è mai vendicato per mostrare la propria forza. Mai.
Idem per la poligamia, si è vista solo nel deserto.
Due parole sul velo femminile, per il quale Molinari – con involontaria sineddoche – usa la parola persiana chador. Il velo lo prescrive anche San Paolo, un ebreo ellenizzato di città, nella prima lettera ai Corinzi, e lo fa con toni più perentori di quelli che più tardi avrebbe usato il Corano. Il velo lo hanno portato per secoli anche le donne europee, fino a poche generazioni fa. Insomma, sospettiamo che la genealogia desertocentrica proposta da Molinari non regga al minimo fact-checking.
Va anche detto questo: se tra gli «atti tribali» sventati la notte di Capodanno c’erano almeno l’incappucciamento forzato e le decapitazioni (forse gli scippi possono essere derubricati alla voce «saccheggio»), non è andata malaccio, tutto sommato.
Ma se fino a qui l’editoriale di Molinari flirta con l’etnografia, è quando si lancia nella retrospettiva storica che raggiunge la vetta. Ma prima c’è da fare un excursus.
Excursus. Molinari e la nostalgia delle colonie

Omar al-Mukhtar in catene tra i panzoni del regime, Bengasi, 1931
Questa storia delle «tribù del deserto» Molinari l’aveva già introdotta un anno fa, il 4 febbraio 2015, sempre su La Stampa. Scrivendo del pilota giordano Moath al-Kasasbeh bruciato vivo da Daesh, Molinari aveva infilato questa perla:
«Trattare un pilota da guerra come un animale – o un infedele – da arrostire è un messaggio nel linguaggio delle tribù del deserto che [9] evoca quanto Omar el-Muktar, leader della guerriglia libica anti-italiana, faceva ai carabinieri [10] negli Anni Trenta, usando le loro schiene per cuocere il tè ai propri uomini.»
Chi segue Giap sa bene chi era Omar al-Mukhtar, per gli altri riassumiamo: era il leader della resistenza anticoloniale in Cirenaica. Per molti anni tenne in scacco le forze di occupazione fascista, finché – già settantenne – nel 1931 non fu catturato, portato a Bengasi, sottoposto a un processo-farsa e infine impiccato nel campo di concentramento di Soluch, di fronte a migliaia di civili libici deportati.
La propaganda fascista e neofascista, per giustificare i crimini commessi in Libia (guerra chimica, torture, deportazioni su vasta scala, un vero e proprio genocidio sull’altopiano del Gebel-Achdar) ha sempre enfatizzato le crudeltà dei guerriglieri, selvaggi che si opponevano alla gloriosa «missione civilizzatrice» italiana.
Quanto all’esercito italiano, dopo decenni di silenzio si è autoassolto nero su bianco per il tramite della sua storica embedded, Federica Saini Fasanotti.
Fasanotti pubblica libri per la casa editrice dello stato maggiore dell’esercito, scrive su riviste della destra cattolica e in pochi anni è diventata un punto di riferimento per gli apologeti del nostro imperialismo, tanto in Africa quanto nei Balcani. Un sample a caso della sua produzione:
«La data dell’8 settembre per le pacifiche popolazioni italiane dell’Istria segnò l’inizio di sofferenze che ebbero termine solamente dopo l’occupazione dell’Istria da parte dell’esercito tedesco.»
Viene quasi da ringraziare Hitler, lenitore delle italiche sofferenze.
Lo stato maggiore dell’esercito ha messo a disposizione i suoi archivi e sembra aver dato a Fasanotti un preciso compito di framing: relativizzare, ridimensionare, sminuire e in ultima istanza giustificare le violenze perpetrate nelle ex-colonie, descrivendole come risposte alla ferinità indigena.
Repetita iuvant: è un vecchio espediente quello di mettere sullo stesso piano la violenza del colonizzatore e quella del colonizzato. Non è necessario leggere Fanon – benché sia utile farlo – per capire che tale equivalenza rimuove troppe cose.
Abbiamo il forte sospetto che la fonte più recente della cazzata neocolonialista su al-Mukhtar scritta da Molinari – con tanto di sfondone temporale, perché «negli anni Trenta» la guerriglia era già stata stroncata – sia proprio un libro di Fasanotti sulle operazioni militari italiane in Libia. Il neodirettore de La Stampa potrebbe esserci arrivato via Wikipedia (il che è tutto dire). Questo forte sospetto è condiviso anche da Nicoletta Bourbaki. Ma ora è tempo di tornare all’editoriale.
«Ehi, ma quello è Lawrence d’Arabia!»

Una scena del film «Lawrence d’Arabia» di David Lean, 1962. No, aspetta…
«[11] Fino all’Impero Ottomano tale società tribale sopravvisse pressoché intatta nello spazio geografico fra Gibilterra ed Hormuz. [12] Fu la Prima Guerra Mondiale ad arginarla grazie al colonnello britannico Thomas Edward Lawrence che raggiunse con i leader delle maggiori tribù l’intesa che portò alla nascita dei moderni Stati arabi.»
Per essere uno che ha studiato a Oxford, Molinari dà sfoggio di un’ignoranza dei fatti storici a dir poco imbarazzante. Si dà il caso che negli anni precedenti il Primo conflitto mondiale e durante il conflitto stesso, l’Impero Ottomano fu guidato dal partito laicista dei Giovani Turchi, che agì proprio nella direzione di modernizzare lo stato e limitare il potere tribale regionale, altro che mantenerlo intatto. Anche per questo le tribù si rivoltarono contro l’impero e gli agenti occidentali come T.E. Lawrence ebbero buon gioco a farle combattere come truppe irregolari al fianco dell’esercito britannico. Quanto agli accordi raggiunti con le suddette tribù, vennero del tutto disattesi. Il trattato segreto Sykes-Picot infatti prevedeva la spartizione del Medio Oriente e della Mesopotamia tra le potenze dell’Intesa. A guerra finita gli inglesi, a cui era toccato il boccone più grosso, organizzarono la conferenza del Cairo, che fu l’occasione per disegnare con il righello – letteralmente – i nuovi stati nazionali e mettere a capo di ciascuno non già i capi-tribù (o i capi-villaggio?), bensì un membro della dinastia hashemita che aveva condotto la rivolta anti-turca, e farlo così governare come re fantoccio dell’impero britannico.
Di seguito, Molinari fa un salto in avanti di un secolo:
«[13] Da allora al 2011 tali nazioni, create dalle potenze coloniali e moltiplicatesi con la decolonizzazione, hanno dominato le tribù. Ma le leadership di tali Stati raramente sono riuscite a legittimarsi nelle rispettive popolazioni col risultato di innescare periodiche proteste, di origine diversa, che cinque anni fa hanno iniziato a travolgerli.»
Quindi, secondo Molinari, dal 1919 al 2011 le nuove nazioni avrebbero dominato sulle tribù del deserto, ma queste ultime si sarebbero infine ribellate, dando avvio alla Primavera Araba… Uhm, c’erano le «tribù del deserto» in Piazza Tahrir? E nello sciopero generale in Tunisia? E negli scontri nelle città siriane?
«[14] Il risultato è su più fronti: le guerre in Siria, Iraq e Yemen, la nascita di entità non-statuali come il Califfato di Abu Bakr al Baghdadi, il dilagare del terrorismo jihadista come virus ideologico e soprattutto [15] il riemergere della società tribale che il colonnello Lawrence, detto «d’Arabia», era riuscito a contenere.»
Un pot-pourri incredibile: nazioni che scompaiono, altre che si disgregano, jihadismo e tribalismo uniti nella lotta… E il solito colonnello Lawrence arruolato nel contenimento della società tribale, lui che sulla potenza del nomadismo delle tribù arabe ha incentrato un tomo di ottocento pagine, I Sette Pilastri della Saggezza. Ma almeno dare un’occhiata al film di David Lean, no? E’ piuttosto famoso… Se Molinari andasse a raccontarla a Oxford questa versione dei fatti, non lo prenderebbero a pernacchie dai due lati di High Street solo per britannica politeness. Ora, però, è il momento di un altro excursus.
Excursus. Italiani per il tribalismo

Dalla nostra storia coloniale possiamo trarre un buon esempio di come gli europei si sono serviti del tribalismo, fomentandolo per il loro tornaconto e guardandosi bene dal combatterlo.
A partire dal 1950, per dieci anni, l’Italia ha amministrato la Somalia con un mandato fiduciario delle Nazioni Unite. La formula, con il classico pretesto di esportare la democrazia, consisteva in una sorta di “colonialismo a tempo”: nel 1960 i somali avrebbero proclamato l’indipendenza, dopo aver imparato a costruire la loro brava repubblica da un paese così ben ferrato in materia. I risultati, infatti, si sono visti e si vedono ancora.
Il percorso didattico prevedeva, nel 1956, le prime elezioni dell’Assemblea legislativa, una sorta di parlamento provvisorio. In quel frangente, l’amministrazione italiana temeva la vittoria schiacciante della Somali Youth League, il partito più intransigente con i rappresentanti del vecchio potere coloniale. La Lega era un partito nazionalista, deciso a superare le divisioni tra le diverse cabile. Di fronte alla tipica domanda “A che tribù appartieni?”, gli iscritti al partito rispondevano orgogliosi «Soomaali baan ahay!» (Io sono somalo!).
Ecco perché il governo italiano decise di introdurre una strana legge elettorale: nelle città si sarebbe votato a suffragio universale, mentre in boscaglia, vista la natura nomade e dispersa della popolazione, alcuni “grandi elettori”, scelti in base ai sottoclan di appartenenza, avrebbero avuto tanti voti quanti erano i membri del loro gruppo. In questo modo, nacquero un centinaio di partitini, ciascuno legato a una determinata famiglia.
Per i vecchi colonialisti, quel risultato fu la dimostrazione che i somali non erano in grado – per «mentalità di razza» – di emanciparsi dal potere dei clan. Un’idea di atavismo e predisposizione che si ritrova tal quale nelle parole di Molinari; un’idea razzista, perché descrive interi popoli come vincolati per destino, tradizione e cultura a una certa organizzazione sociale, che invece si mantiene o riemerge grazie a fattori economici e politici. Bisogna tenersi alla larga da tutte quelle “spiegazioni” nelle quali la cultura viene descritta come una parte del corpo, qualcosa che le persone «hanno» e «si portano dietro», e non una valigia che ognuno «fa» e «si costruisce» mentre cammina per il mondo.
Scontro di civiltà a Desenzano del Garda
Torniamo a Molinari.
«È il declino del nazionalismo arabo che spinge individui e famiglie a ritrovare nelle origini tribali la propria identità. È un processo di portata storica, che accelera, con conseguenze imprevedibili in Nordafrica e Medio Oriente. Gli Stati arabi-musulmani sono le prime vittime di questo processo: lacerati da un confronto interno fra modernità e tribalismo che è un conflitto di civiltà.»
Dunque le popolazioni arabe post-nazionaliste cadono in balia del tribalismo, della selvatichezza, e ovviamente, migrando… li importano da noi:
«L’Europa ne è investita a causa delle migrazioni di massa verso la sponda Nord del Mediterraneo. [16] Fra chi arriva vi sono portatori di usi e costumi che si originano dalle lotte ataviche per pozzi d’acqua, donne e bestiame. Le conseguenze sono nelle cronache di questi giorni: dagli abusi di massa a Colonia [17] al grido di «Allah hu-Akbar» per intimorire il prossimo a Brescia e [18] Vignola.»
Attenzione: l’immigrazione dai paesi arabi porta con sé la lotta per l’acqua, il ratto delle donne e l’abigeato! I fatti di cronaca parlano chiaro.
Quali fatti di cronaca?
Beh, le molestie collettive a Colonia, ovviamente, che non sarebbero già una manifestazione di maschilismo, frustrazione sessuale e bestiale ignoranza da parte di giovani maschi immigrati (ma non solo), bensì il riemergere di forme ataviche di lotta per le donne inscritte nel DNA culturale di certe popolazioni neo-tribali morte di sete.
Oppure l’episodio avvenuto in quel di Desenzano del Garda (Brescia), dove pare che un facchino pakistano – non arabo – in sciopero abbia invocato Dio mentre la polizia trascinava via lui e altri partecipanti a un picchetto. Apriti cielo! Tutti a parlare di Allah e non della lotta di quei lavoratori. Ma è colpa loro. Se fossero stati italiani e avessero gridato «Oh, madonna santa!», sarebbe stato facile distinguerli dalle tribù del deserto in cerca di acqua, figa e bestiame.
O ancora, lo scherzo idiota a danno di cinque adolescenti di Vignola (MO), che si sono sentiti domandare se fossero cristiani o islamici con una pistola puntata addosso da parte di alcuni balordi nordafricani, i quali successivamente si sono costituiti ai Carabinieri, rivelando che la pistola era caricata a salve. Ridateci i nostri teppisti autoctoni modenesi, che non rubano i pozzi d’acqua a nessuno.
Ed eccoci alla conclusione dell’editoriale di Molinari:
«[19] Non si tratta della maggioranza degli immigrati ma di una minoranza in grado di scuotere la sicurezza collettiva. Da qui la necessità di una rigida applicazione della legge, grazie ad un’intesa fra cittadini e forze dell’ordine, [20] per difendere l’Europa dal ritorno delle tribù.»
Chiaro, no? Cittadini e forze di polizia devono allearsi contro il tribalismo allogeno, difendere l’Europa dalla barbarie atavica insita in altre culture e importata da una minoranza di stranieri. Altre volte, nella storia europea – davvero tutta europea – si è visto a quale sbocco politico ha portato questa rappresentazione delle cose.
«Da noi c’è stato Gesù Cristo» (ma ci ha dato «pessimo» su Tripadvisor)
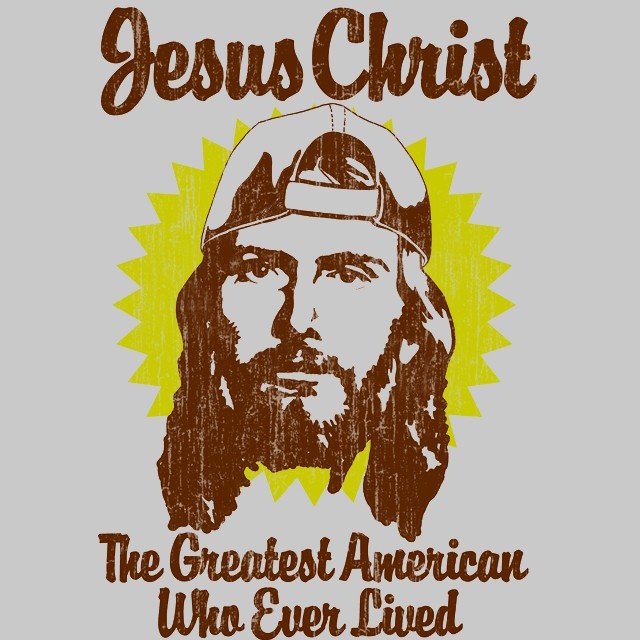
L’impasto di notizie e false notizie in arrivo da Colonia è stato un macigno gettato nel brodo di stereotipi e clichés che moltissimi italiani si portano dietro a proposito dell’Islam, con il risultato che i liquami sono tracimati senza controllo. Anche una scrittrice come Dacia Maraini, in un articolo per il Corriere della Sera, ha infilato un passaggio come questo:
«Da noi c’è stato Gesù Cristo che ha sconvolto e rovesciato le prescrizioni della Bibbia: le parole “amore” e “perdono” hanno sostituito il “dente per dente” e l’odio di religione. Nei Paesi musulmani un Gesù è mancato, ma è invalsa la prassi di una saggia convivenza fra popoli e culture diverse. In certi momenti di crisi però si sente la mancanza di un libro sacro che reclami l’amore per il prossimo e la misericordia, come predica il Vangelo.»
Cosa intende Maraini dicendo che Gesù è stato «da noi»? Forse che è nato dalle parti di Zagarolo? A quanto dicono le mappe, Betlemme, Nazaret e la Galilea sono più vicine alla Mecca o a Medina di quanto non lo siano a Roma. E cosa significa che «nei paesi musulmani un Gesù è mancato», dal momento che Gesù compare nel Corano, fa miracoli, viene chiamato «il messaggero di Dio» e nasce dalla Vergine Maria per volontà di Allah? E che dire della «mancanza di un libro sacro che reclami l’amore per il prossimo e la misericordia»? Tra i 99 nomi che i musulmani attribuiscono a Dio, «Il Misericordioso» è forse il più ricorrente, e sarebbe molto lungo elencare gli hadith sulla vita del Profeta dove si riportano i suoi insegnamenti sulla carità, l’amore, la cura.
E’ strano come in certi momenti ci si dimentichi che il Corano, la Bibbia, il Vangelo e tutti i libri sacri dell’umanità hanno ricevuto interpretazioni contraddittorie, e che sono di volta in volta queste ad avere giustificato guerre e conflitti, spesso proprio tra individui che credevano nelle stesse parole, ma le leggevano in maniera differente.
Poco più avanti, l’autrice si domanda:
«Che c’entra tutto questo con le molestie contro le donne in una piazza tedesca in un giorno di festa? In realtà c’entra, soprattutto se si riconoscerà che i molestatori sono giovani emigrati.»
E’ significativo che anche Dacia Maraini, abituata a una scrittura riflessiva e ponderata, si sia lasciata prendere dall’esigenza di stendere un articolo, prendere posizioni e additare problemi, sulla base di un dato che lei stessa giudica ipotetico: «Se si riconoscerà…» (il pezzo è stato pubblicato il 10 gennaio).
E per concludere, l’invito a «ragionare insieme» a «inventare nuove strategie»:
«se non vogliamo cascare nella loro provocazione, ovvero in una guerra mondiale che farebbe migliaia di morti.»
L’eurocentrismo che porta a considerare Gesù come un «nostro» profeta, porta anche, drammaticamente, a non considerare che la guerra c’è già, che la si può già considerare mondiale, e che i morti, fuori dall’Europa, sono ben più di migliaia.
Altre letture
Lorenzo Declich sull’editoriale di Molinari
Il capodanno del patriarcato e l’urgenza di una politica femminista – di Paola Rudan
I corpi su cui si uniscono le civiltà: non su Colonia ma sul nostro passato – di Loredana Lipperini
Violenza di genere e femminicidi politici – di Nicoletta Poidimani
La Colonia in sé e la colonia in te – di Giulia Blasi
L’indice di Colonia – di Ida Dominijanni
Grazie a Nicoletta Bourbaki e Anubi d’Avossa Lussurgiu.


 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

[…] nonostante fossero già di per sé estremamente gravi sono stati fin da subito cristallizzati e presi in ostaggio dal frame dello scontro fra civiltà rendendo estremamente difficile leggere gli eventi semplicemente per quel che son stati […]
[…] Stampa di Torino non è solo un giornalaccio il cui direttore propala la peggiore propaganda razzista coloniale e il cui vicedirettore è quel monumento al populismo di Massimo Gramellini*, ma ha il pregio di […]
[…] violenza sulle donne siano gli appartenenti a una precisa cultura. Punto, chiuso, leggete i Wu Ming sulla […]
[…] di cattiva comunicazione e di disinformazione, ne abbiamo letti tanti. Per esempio, Wu Ming risponde punto per punto a quel che ha scritto Maurizio Molinari su La Stampa e Dacia Maraini sul Corriere della Sera. Prima […]
[…] questo splendido pezzo di Wu Ming sulle papere prese dal nuovo direttore de La Stampa parlando dei fatti di Colonia: il neodirettore […]
[…] In proposito, trovo meritevole e abbastanza riuscito lo sforzo dei Wu Ming di smontare tale scritto, e lo segnalo qui. […]
Gli articoli di Molinari mi paiono parte di un generale clima ideologico in cui si è sdoganato anche tra i “progressisti” l’idea che “la nostra civiltà occidentale è superiore a quella del mondo mussulmano, noi siamo democratici, tolleranti, rispettosi dei diritti delle donne e loro sono quelli fissati con la religione, misogini e tagliatori di teste”.
Tutto questo secondo me si basa su un inganno di fondo: si confondono i valori rivoluzionari sorti dalla rivoluzione francese (enunciati in occidente per la prima volta ma per loro natura universali, quindi non è che qualcuno ha il copyright) con la «civiltà occidentale» in quanto tale. Così si usano gli enunciati universali come totem identitario, se vogliamo già che siamo in tema “tribale”. Si parla di libertà per negare la libertà di sopravvivere a chi fugge dalle guerre, si discetta di uguaglianza per approfondire il solco delle differenze di classe attraverso le discriminazioni etniche e culturali, si esalta la fraternità per dividere le persone tra i “detentori di diritti” (i cittadini degli stati occidentali) e gli “altri”, che possono pure crepare.
Dopo Colonia tutto ciò ha preso la forma del discorso “difendere la libertà delle donne negando il diritto alla sopravvivenza ai rifugiati”. Porre la questione così significa una sola cosa: affermare che quanto di buono vi è ancora nella nostra società: libertà individuale, emancipazione femminile, ecc. ecc. non sono diritti dell’essere umano ma privilegi esclusivi di una parte dell’umanità gentilmente concessi dagli stati nazione e dal sistema capitalista. Perché i diritti sono tali solo se diventano universali, altrimenti sono solo concessioni del potere, privilegi.
Non credo esista la “libertà delle donne”, la libertà è una sola per tutti, o è un diritto universale o è un privilegio di pochi. La rivoluzione francese dovrebbe averci fatto passare da “le libertà” al plurale del feudalesimo a “la libertà”, uguale per tutti. E qui si potrebbe riflettere sul fatto che i principi enunciati dalla rivoluzione francese sono stati traditi proprio dall’involucro politico ideato per realizzarli: lo stato-nazione (fallito mica solo in Medio Oriente!). Diritti basati su enunciati universali sono concretamente garantiti solo a coloro che partecipano ad una particolare comunità: i membri della nazione.
Prendiamo ad esempio il caso delle donne migranti. Qualcuno dei neo-paladini dell’emancipazione femminile si è domandato cosa subiscono durante la traversata verso l’Europa? cosa succede in molti “centri di accoglienza” lungo la rotta balcanica circondati di poliziotti ma privi persino di servizi igienici e di dormitori separati per uomini e donne? cosa succede poi nelle nostre periferie?
Tutti a denunciare quanto è brutta, patriarcale e maschilista la visione del mondo degli uomini mussulmani (in molti casi verissimo non ne dubito, sia chiaro), ma qualcuno ha pensato di offrire alle donne migranti la possibilità di costruire un alternativa a questa visione del mondo attraverso un vero accesso al lavoro e all’istruzione? Nossignori il problema lo si pone solo quando “gli altri” toccano “le nostre donne” (se no è un caso isolato, un pazzo, ecc, ecc). Donne non “occidentali” che la violenza di genere la subiscono ogni santo giorno (e non solo dai cattivoni barbuti, ma magari anche da cittadini o pubblici funzionari “occidentali”) non commuovono? Come mai? Non sarà perché hanno la pelle troppo scura o perché pregano il Dio sbagliato, o perché semplicemente perché la loro libertà può affermarsi solo attraverso una generale emancipazione sociale ed economica? E così le grida in difesa “delle nostre donne occidentali” finiscono per non risolvere nessun problema reale ma per peggiorare la condizione delle donne migranti.
Condivido l’argomentazione, ma trovo molto inquietante questa frase:
“Tutti a denunciare quanto è brutta, patriarcale e maschilista la visione del mondo degli uomini mussulmani, ma qualcuno ha pensato di offrire alle donne migranti la possibilità di costruire un’alternativa a questa visione del mondo attraverso un vero accesso al lavoro e all’istruzione?”
Credo che alle donne migranti vadano offerte opportunità di vita degna, ma non in quanto alternative alla visione del mondo degli “uomini mussulmani”. Se la mettiamo giù così rischiamo di islamizzare una questione, quella di genere, che certo si incrocia con religione e cultura, ma non ne dipende in maniera essenziale. Le donne migranti devono essere libere e realizzarsi come persone e come donne, indipendentemente dal fatto che siano mogli, figlie, sorelle o compagne di mussulmani brutti e cattivi.
Non è un caso che la destra e il liberismo europeo (vedi Marine Le Pen) siano spesso prodighi di attenzioni nei confronti delle donne musulmane, pronti a denunciare, in quanto tipicamente islamico, il maschilismo che le circonda, occultando così quello di noialtri. Ci sono discorsi xenofobi e nazionalisti che vampirizzano i valori di libertà e uguaglianza del femminismo, per un motivo molto semplice: le donne migranti servono, come domestiche, baby sitter e badanti. Questi lavori sono più delicati di altri, perché si basano su relazioni d’affetto e di fiducia che rendono le salariate più difficilmente sostituibili rispetto al classico “esercito industriale di riserva”. Molte badanti vivono in casa dei loro datori di lavoro (soluzione grazie alla quale questi ultimi possono risparmiare somme considerevoli). Diventano parte della famiglia. Nemmeno i leghisti hanno mai affermato che queste donne “vengono qui a rubarci il lavoro”. Proprio per questo, però, bisogna rapidamente assimilarle, occidentalizzarle, trasformarle in merce standard, toglier loro il velo (che è sempre visto come colpa dei maschi della famiglia, come imposizione, dal momento che queste donne non sarebbero capaci di scegliere). E in tutto questo, però – ecco la contraddizione – bisogna mantenerle in uno stato di inferiorità in quanto donne e in quanto minoranze etniche migranti.
Ritengo molto importante capire e decostruire quali discorsi vengono fatti passare sotto e dentro la crociata contro il patriarcato islamico-e-solo-islamico. A chi vuole approfondire, suggerisco la lettura del saggio di Sara Farris “Il femonazionalismo in Italia”, contenuto nel volume “Il colore della Nazione”, a cura di Gaia Giuliani, un libro davvero importante, stracolmo di spunti, sul quale vorrei tornare in un prossimo commento
In effetti mi sono espresso parecchio male. Polemizzando con l’assunto che ci hanno propinato un pò tutti i giornali italiani (appunto l’islamizzazione della questione) ho finito per costruire la frase come se accettassi quell’assunto come punto di partenza.
Quello che volevo dire in realtà è che per poter rompere le forme di oppressione di genere, di qualunque cultura e religione siano frutto, occorre dare a tutti la possibilità di realizzarsi dal punto di vista individuale al di fuori della famiglia e delle mura domestiche attraverso lo studio e il lavoro. Perché questo accada servono però proprio quei servizi di welfare state (ad esempio perso alle borse di studio) e quei diritti dei lavoratori su cui le politiche austeritarie e neoliberiste si sono accanite rendendo ancora più difficile la vita delle persone che si trovano a scontare contemporaneamente forme di discriminazione di genere, di classe e di tipo etnico-culturale.
per quello che riguarda le violenze che subiscono le donne migranti è uscito ieri un rapporto di amnesty international che evidenzia proprio questo fatto: le donne migranti sono soggette ad abusi sia da parte di altri migranti uomini, sia da parte di europei (operatori di centri di accoglienza e poliziotti). Di seguito posto il link
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/
Post potentissimo.
Questa storia delle “tribù”, in particolare, è un jolly spiegatutto con cui colmano di cliché il vuoto lasciato dalla nostra ignoranza di quella regione del pianeta. Ma il post spiega bene che non sono sciocchezze innocue, fanno tabula rasa della storia e dei dati di fatto perché su una lavagna vuota si può scrivere qualsiasi cosa.
Sono incappato in un articolo molto lungo e in inglese ma davvero interessante che mette sotto scrutinio la teoria dei “confini tracciati su una mappa vuota”. È una teoria versatile, tant’è che è stata utilizzata tanto dall’Occidente per dire che con Sykes-Picott ci eravamo “inventati” l’Iraq e quindi ora potevamo distruggerlo, quanto da quelli dell’ISIS per dire che bisogna ridisegnare i confini piazzando un bel Califfato lì in mezzo. Qualche volta la usiamo anche noi di sinistra, confondendo l’idea che il popolo arabo sia unitario al di sopra delle sue divisioni “nazionali” interne, che reputo fondamentalmente giusta e progressista, con una visione consolatoria e vittimista per cui tutto ciò che è avvenuto in Medio Oriente è opera di onnipotenti cospirazioni occidentali senza nessun ruolo soggettivo da parte di classi sociali, partiti politici, correnti di pensiero di tipo endogeno. Questa immagine stereotipata è pericolosa perché in fondo tratta quei popoli (non solo gli arabi, ma anche tutti gli altri che condividono quella regione, che sono una caterva) come gente senza storia, socialmente e politicamente non strutturata ma al tempo stesso polverizzata in una miriade di etnie e confessioni che siccome non capiamo etichettiamo come incomprensibili o insignificanti, di cui raccontare al massimo le sfighe ma mai le lotte e le aspirazioni.
Questo è l’articolo: “‘Lines Drawn on an Empty Map’: Iraq’s Borders and the Legend of the Artificial State”, http://www.jadaliyya.com/pages/index/21759/lines-drawn-on-an-empty-map_iraq%E2%80%99s-borders-and-the (in fondo c’è il link alla seconda parte). Mi sono reso conto leggendolo che mi mancavano davvero tanti tasselli della vicenda. Uno sforzo di competenza, avere un’infarinatura di cosa succede e cosa è successo in una zona del globo così critica, mi sembra un obiettivo culturale e politico alla portata di tutti e non credo sia impossibile cominciare a rispondere colpo su colpo alle bufale e agli sfondoni, contendere credibilità ai seminatori d’odio, anche soltanto con un esercizio di umiltà: dare voce a chi ne capisce di più perché viene da là.
Dopo aver ragionato e discusso, con molte persone, sull’articolo di Molinari e le sue ricadute, sui fatti di Colonia e intorno a Colonia, vorrei aggiungere qualche appunto al post che abbiamo scritto qualche giorno fa:
1) Il rimosso coloniale. Qui su Giap abbiamo utilizzato spesso questa espressione, in senso lato, per indicare che la storia del colonialismo italiano è stata espulsa dalla memoria collettiva del nostro paese, proprio come certi ricordi imbarazzanti e dolorosi – secondo la psicanalisi – vengono cancellati dagli individui, si depositano nell’inconscio, e ritornano in particolari condizioni sotto forma di fantasmi, sogni, lapsus, atti mancati, ecc. In questa prospettiva, l’articolo di Molinari darebbe voce ai “fantasmi del deserto”, evocati dagli avvenimenti di Colonia – o meglio: dalle parole spese intorno a quegli avvenimenti. Ebbene, questo tipo di lettura non mi convince più e trovo anzi che abbiano ragione gli studiosi – come Gabriele Proglio – che mettono in dubbio l’idea di “rimosso coloniale”. Anche perché la rimozione avviene spesso in maniera inconscia, mentre il colonialismo italiano è stato messo in un angolo, imbellettato e sfrondato con meccanismi piuttosto consapevoli e mirati.
L’editoriale di Molinari dimostra, mi pare, che la presunta rimozione non è soltanto rimozione, e che sarebbe più corretto parlare di selezione o ellissi.
La leggenda di Omar al-Mukhtar che usa le schiene dei prigionieri italiani come tavolini da tè – figlia della più sordida propaganda fascista – non è uno spettro che risale dall’inconscio collettivo dello Stivale: è un pezzetto della sua storia coloniale che si è scelto di trattenere e tramandare. Quella storia, dunque, non è stata rimossa, ma si è deciso – anche con metodo – cosa tenere e cosa no, cosa tradurre in termini più accettabili e dicibili e cosa invece occultare, cosa censurare e cosa celebrare (vedi il monumento di Affile, vedi l’odierna toponomastica di molte città, vedi certi attualissimi discorsi sulla Libia e il Mare Nostrum). La categoria del “rimosso”, dopo l’articolo di Molinari, mi pare inadeguata per comprendere in pieno il rapporto che ancora ci lega alle ex-colonie e, più in generale, ai crimini del colonialismo europeo. Invece di sostenere che quel passato è stato rimosso, e a tratti ritorna come un mai-morto, mi pare più utile chiedersi come ha operato la selezione, l’ellissi: cosa è stato trattenuto, cosa è stato tradotto, cosa è stato eclissato, cosa è stato davvero rimosso. Questa riflessione deve molto alla lettura di un libro, “Il colore della nazione”, uscito in questi giorni per Le Monnier Università, a cura di Gaia Giuliani. (si veda soprattutto l’articolo di Gabriele Proglio, “Filigrana dell’immaginario. Cinema e razza al tempo della globalizzazione. 1980 – 2001“)
Ed è partecipando, lunedì pomeriggio, alla presentazione del volume, che ho maturato qualche nota ulteriore.
2) La Conversione sulla via di Damasco. Sei giorni dopo l’editoriale sul Capodanno coloniale, Molinari ne pubblica un altro, di stampo molto diverso. Lo trovate qui: http://www.lastampa.it/2016/01/17/cultura/opinioni/editoriali/il-rischio-della-zona-grigia-pz6CykFJtgR3XlBxYDBRHO/pagina.html
Il neodirettore della Stampa, dopo aver denunciato il tribalismo di nordafricani e levantini, ora se la prende con i razzisti nostrani, con chi gioisce per la morte degli immigrati, con chi osteggia la società multiculturale. Citando Primo Levi e la sua “zona grigia”, bacchetta la maggioranza che si volta dall’altra parte quando il vicino diffonde odio per gli stranieri. Denuncia come retrogrado e dannoso l’ideale di un’italianità basata sulla bianchezza. Tu dirai: ok, il ragazzo si è accorto di averla pestata grossa e puzzolente e adesso corre ai ripari. Probabile, ma questo secondo articolo dimostra pure quanto un certo multiculturalismo (retorico) sia perfettamente compatibile con una pratica imperial-coloniale , al punto che spesso la traduce e la occulta.
L’esempio paradigmatico di questa relazione pericolosa mi sembra essere un bel film di Clint Eastwood, Gran Torino, che molti hanno salutato come antirazzista e progressista, quando invece non lo è affatto. La storia racconta di come un ragazzino di origini Hmong vietnamite riesca a integrarsi nella società americana solo e soltanto grazie all’aiuto di un maschio americano bianco, razzista e nazionalista (però di origini polacche, se no il giochino era troppo scoperto). Tutta la comunità Hmong, compresa la famiglia del ragazzino (orfano di padre), non è in grado di aiutarlo nella crescita, e anzi lo porterebbe sulla cattiva strada, se non fosse per il buon Walt Kowalski, che pian piano si converte al multiculturalismo e per quanto “all’antica” è pur sempre “un americano” (e quindi meno retrogrado di qualsiasi maschio tradizionalista hmong). Gli unici afroamericani che compaiono nella pellicola sono potenziali stupratori (a fermarli ci pensa Clint/Kowalski), mentre i maschi hmong – ad eccezione del ragazzino protagonista – si danno allo stupro come forma di vendetta e guerra tra bande (e allora Clint, per fermarli, deve immolarsi e rinunciare alla violenza, come un Cristo suburbano).
3) Un atto di guerra??? Navigando e discutendo ho scoperto che Dacia Maraini si era espressa sulle vicende “coloniali” anche prima di scrivere l’articolo per il Corriere che commentiamo qui sopra, quello su Gesù Cristo, il Figlio di Noi, nato dalle parti di Zagarolo.
In un’intervista al Mattino di Napoli, la scrittrice ha affermato che gli episodi di Capodanno sono un “atto di guerra misogino” e che come sempre, quando c’è una guerra, quella guerra si combatte anche sul corpo delle donne. Il che è antropologicamente ineccepibile, ma mi chiedo: di quale guerra sta parlando, Dacia Maraini? Nell’articolo del Corriere afferma che la Terza Guerra Mondiale non c’è ancora, ma se non stiamo attenti potrebbe scatenarsi e fare migliaia di morti. Non è dunque di una guerra con bombe e mitra che parla Maraini, ma – evidentemente – di una guerra di civiltà: quella tra Islam e Occidente. Una simile opinione mi pare il risultato di una tendenza in atto fin dall’11 settembre 2001, quella a islamizzare episodi criminali, di violenza sulle donne, oppure di classe (come certe rivolte di periferia, vedi il libro di Daniele Salerno, “Terrorismo, sicurezza, post-conflitto”). L’idea che mi sono fatto rispetto agli eventi di Colonia è che quanto accaduto abbia a che fare con la criminalità (il taccheggio e i vari diversivi, anche sessuali, per facilitarlo), con i diritti delle donne e la questione di genere (le molestie e le violenze in quanto tali) e solo in un’ultima analisi con la cultura e la provenienza degli aggressori (in una percentuale che non è zero, non lo è mai, ma è comunque bassa). Da segnalare che Maraini, il 7 gennaio, dichiarava di non credere che “rifugiati e profughi” potessero essere responsabili di quanto accaduto, perché costoro non rischierebbero di finire in galera dopo aver messo a repentaglio la vita e aver attraversato il deserto per arrivare da noi. Mi pare che, ancora una volta, faccia capolino in queste parole l’uso dei diritti umani come strumento per dividere i migranti in buoni e cattivi, degni di accoglienza e meritevoli di respingimento. Finché i profughi rimangono profughi – e quindi precari e ricattabili – sono meno pericolosi. La stessa logica vale magari per i clandestini – che rischiano di essere espulsi. I mussulmani più pericolosi sarebbero allora quelli ormai accolti e regolarizzati, pronti a pugnalarci alle spalle: meglio quindi renderli più indefesi e innocui, mantenendoli disperati?
Sul punto 1, sono d’accordo con mi compadre, e intendo leggere quanto prima il libro curato da Giuliani, perché mi sto interrogando da tempo su questi nodi. La “rimozione” del nostro colonialismo e del ruolo imperialista dell’Italia è stata operata, è il risultato di precise scelte politiche, di un costante agire diplomatico e giudiziario per garantire l’impunità dei criminali di guerra italiani (gli storici Focardi, Di Sante e Conti hanno fatto molta luce su questo lavorìo) e di un accorto occultamento degli orrori coloniali, iniziato con la censura dell’informazione durante la dittatura fascista e proseguito in seguito, a colpi di stereotipi e falsificazioni.
Lo vediamo molto bene guardando al confine orientale: i propagandisti da Giorno del Ricordo sanno molto bene che il fascismo perseguitò sloveni e croati, e sanno molto bene che l’Italia invase la Jugoslavia e non viceversa. Lo sanno, non sono affatto ignari di come andarono le cose. Ma quando parlano, quando comunicano, quando fanno uso pubblico della storia, descrivono l’opposto: annessionismo slavocomunista, persecuzione degli italiani ecc. ecc.
Personalmente, quando uso “rimosso” e “rimuovere” a proposito del colonialismo e dell’imperialismo italiano, mi riferisco a questo multiforme agire deliberato. Non dò ai termini principalmente l’accezione che hanno nella psicanalisi, però è inevitabile che i termini “risuonino” con quell’accezione e vengano in parte connotati in tal senso.
Del resto, nel “rimosso coloniale” c’è anche una dimensione del genere, se parliamo di cultura di massa e vita quotidiana. I miti degli «italiani brava gente» e del «buon soldato italiano» – su questo Focardi è una lettura indispensabile – sono serviti a lenire il trauma della guerra mondiale, a darne una spiegazione di comodo (tutta colpa dei tedeschi!), e questo si è sposato alla perfezione con gli interessi che hanno prodotto la rimozione selettiva e l’ellissi.
C’è un affiorare del rimosso, in questo senso, anche se non dovremmo prendere l’espressione alla lettera, è più una metafora. Mi riferisco al fatto che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini non sa assolutamente nulla del ruolo di invasore e carnefice che ha avuto l’Italia (e men che meno delle guerre che l’Italia sta combattendo oggi, va detto), e quindi non ricorda (non conosce) la matrice ideologica di molti tòpoi del discorso razzista che ripete ogni giorno, al bar, sul posto di lavoro, a casa, sui social.
Persino il frasario di oggi non fa che aggiornare quello di allora. Ho trovato molto interessante questo articolo dove si confronta l’uso odierno di «buonismo» con l’uso di «pietismo» per difendere le leggi razziali del 1938. Lo stesso discorso si potrebbe fare per un altro cliché di destra: «radical chic». Quest’epiteto copre più o meno il medesimo campo semantico di una delle parole più usate dai propagandisti del ventennio, «panciafichista».
Ecco, a naso mi sembra che ci siano due livelli: una rimozione selettiva e intenzionale, e un rimosso inconsapevole, risultato dell’ignoranza. Quest’ultimo riguarda la genealogia delle stronzate che vengono dette, e dell’odio che le alimenta.
Aggiungo: sì, Molinari sa molto bene che, riproponendo quelle storie su Omar al-Mukhtar, sta ripetendo la propaganda coloniale dell’epoca e aderendo al frame usato da tutti i colonialisti (e nello specifico dall’esercito italiano) per giustificare la violenza (strutturale) del dominio e la brutalità (“evenemenziale”) della contro-insorgenza. Molinari lo sa benissimo, non è solo un lapsus.
Per quanto riguarda i crimini italiani nei Balcani, campo che conosco meglio, l’opera di selezione e occultamento sistematico era iniziata già in corso d’opera, nel biennio ’44/’45, quando lo stato maggiore dell’esercito del Regno del Sud cominciò a selezionare materiale da contrapporre ai dossier compilati dall’ Esercito di Liberazione Jugoslavo. Quel materiale poi finì direttamente negli atti della commissione parlamentare sui crimini di guerra nel 1947, cioè quando l’Italia era già repubblica.
http://www.criminidiguerra.it/MemoriaCommInch.shtml
dalla relazione sui crimini di guerra italiani in jugoslavia:
“A prescindere, invero, dall’indole degli Italiani, alieni, per il loro tradizionale senso di umanità e giustizia, da quegli atti di crudeltà; e da quegli eccessi che vengono loro addebitati, è dimostrato da una larga documentazione che le rappresaglie più feroci e spietate, gli assassini più atroci, le barbare distruzione di interi villaggi e di edifici di ogni specie, che ora vengono attribuiti agli italiani, furono invece commessi dai gruppi etnici e religiosi in lotta fra loro.- Le nostre Autorità di occupazione ebbero anzi ad intervenire per porre un freno a tali eccessi e per tutelare, come si é accennato, la vita del militari italiani e della popolazione per assicurarle una vita pacifica: circostanze queste in assoluto contrasto coi propositi di distruzione che si vogliono loro attribuire.-”
anche qui le “tribù” in lotta tra loro e gli italiani che cercano di riportare l’ordine, di difendere gli jugoslavi da se stessi.
spariscono gli incendi e le stragi commesse dai militi *italiani*, sparisce la morte per inedia di migliaia di uomini e donne nei campi di concentramento *italiani*.
e si occulta il fatto che ante pavelić era stato in esilio a roma per diversi lustri prima di essere messo da mussolini a capo dello stato fantoccio di croazia. si occulta il fatto che l’italia promosse l’albanizzazione del kosovo. e che appoggiò i nemici cetnici serbi sia in funzione anticomunista, sia per mettere in riga gli alleati ustascia, sia per dimostrarsi autonoma dagli alleati tedeschi (eh, il prestigio…). and so on and so on.
(queste cose sono spiegate bene da Davide Rodogno in “Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista (1940-1943)”, ed. Boringhieri, 2003)
Da quel che diciamo – e che dicono alcuni studiosi citati – mi sembra emergano TRE livelli: 1) rimozione selettiva e consapevole (chiamiamola ellissi, censura, ecc), 2) rimosso inconsapevole, soprattutto per ignoranza (ma teniamo conto che l’ignoranza di molti è spesso il frutto della scelta consapevole di pochi: rispetto al colonialismo, ma più in generale rispetto alla storia contemporanea e alla figura dello storico nell’educazione e nel discorso pubblico italiano) 3) La traduzione di concetti, espressi con termini inaccettabili, in parole dicibili e scrivibili (con tutto quello che viene lost – and acquired – in translation).
Su quest’ultimo punto vorrei soffermarmi perché l’articolo di Molinari è un chiaro esempio di come certi avvenimenti (il Capodanno di Colonia) vengono sfruttati come occasioni per spostare il confine di quel che si può dire/scrivere su certi argomenti. Il confine tra ciò che deve essere tradotto e ciò che invece può essere espresso senza remore. Per questo motivo è tutto sommato irrilevanti, agli occhi dei “traduttori”, che cosa è davvero successo: conta l’occasione, l’esperimento che essa permette. E cioè: proviamo a vedere se nell’editoriale in prima pagina di un grande quotidiano nazionale (e non di Libero) si possono scrivere determinate cose in un determinato modo. Ecco perché trovo importante che in tanti abbiano reagito alle parole di Molinari, rigettandole come inaccettabili, perché questa sanzione sociale, dal basso, impedisce di spostare il confine e segnala che quel confine è ben presidiato.
Con ciò non voglio dire che la “traduzione” in termini accettabili sia più innocua rispetto all’uso di parole indicibili. Dobbiamo vigilare anche sulle traduzioni e capire quando un giornale, con termini aggiornati e corretti, sta titolando “I negri sono esseri inferiori” senza direttamente scriverlo in un linguaggio deprecabile. Tuttavia non nego che preferisco vivere in un paese dove certe frasi costano a chi vuole scriverle su grandi giornali quantomeno uno sforzo di traduzione, che non in uno dove “Molestate la donna bianca” può essere il titolo del giornale di dom… Come dite? L’hanno già fatto un titolo così? Pochi giorni fa? Su Repubblica? Ehm…
«Sanzione sociale dal basso» è perfetto. Una forma di pressione, anche da parte di una minoranza dell’opinione pubblica, purché sia una minoranza significativa, una parte riconoscibile nel discorso pubblico. Riguardo alla vicenda del colonialismo e – questo lo voglio aggiungere sempre – del ruolo imperialista dell’Italia, anche odierno, sul piano della “sanzione sociale dal basso” c’è tutto un terreno da costruire.
Io faccio spesso quest’esempio, ne ho scritto anche in Point Lenana: qualche anno fa sono emersi moltissimi documenti sulle torture e le uccisioni a sangue freddo commesse negli anni Cinquanta da militari e civili britannici nei cosiddetti “screening camps” del Kenya. Dietro l’espressione neutra (“centri di schedatura”, più o meno), si trattava di campi di concentramento dove fu deportata buona parte della popolazione maschile Gikuyu, per stroncare l’insurrezione dei Mau Mau. C’erano più di cento campi del genere, in Kenya. Ai prigionieri, considerati “subumani”, poteva capitare di tutto. Diversi furono castrati. Altri furono bruciati vivi. Non si contano quelli picchiati a morte.
Ebbene, nel 2009 emersero evidenze incontrovertibili di questo carnaio, dettagliati come mai era accaduto in passato. Questo ha dato coraggio ad alcuni reduci di quei campi, che hanno superato l’umiliazione, la vergogna, l’annichilimento pluridecennale, e hanno fatto richiesta di risarcimento al governo del Regno Unito (allora era la coalizione Lib-Con).
I giornali di tutto il Commonwealth ne hanno parlato molto, c’è stata pressione dal basso da parte di gruppi, associazioni, opinionisti, e il governo (stiamo parlando di un governo di destra della potenza più colonialista della storia) ha dovuto avviare un negoziato con il Kenya per un risarcimento di tutte le vittime. Non lo ha certo fatto volentieri, ma la questione era grossa, ed era sentita. Era sentita perché in UK esiste un dibattito pubblico su passato coloniale e realtà postcoloniale, e non resta confinato nell’accademia. Nel 2005 uscirono due libri importantissimi sulla violenza britannica in Kenya, che fecero molto discutere, fin dai titoli: Britain’s Gulag di Caroline Elkins e Histories Of the Hanged di David Anderson.
In Italia, per ragioni di cui discutiamo da anni, una circostanza del genere permane *inimmaginabile*.
E non che manchino libri di storici corrispettivi di Histories Of The Hanged: ne sono usciti svariati, a partire dal lavoro seminale di Angelo Del Boca. I libri di Del Boca hanno pure venduto bene. Ma quelle ricostruzioni non sono ancora riuscite a perforare quella sorta di “diaframma” che protegge il senso comune dalle narrazioni scomode.
La mia impressione è che il mito degli italiani brava gente non sia solo una autoassoluzione italica, ma ci sia qualcosa di più.
Sto leggendo “la banalità del male” di Hanna Arendt, 1961.
E’ un potentissimo libro che narra del processo tenutosi a Gerusalemme al criminale nazista Eichmann, responsabile di organizzare le emigrazioni, prima, e le deportazioni poi degli ebrei.
Parlando esclusivamente della risoluzione del “problema” ebraico, riferendosi all’Italia sembra che:
– I territori occupati dall’Italia (sud della Francia, Grecia e Jugoslavia) fossero zone franche dove arrivavano perseguitati da tutta Europa sicuri di trovare asilo;
– Che in sostanza l’Italia sabotasse la “soluzione finale”, in maniera quasi beffarda nei confronti della Germania, adducendo scuse che sembravano più una farsa che altro;
– Che anche nel varare in Italia le leggi antiebraiche agli inizi degli anni 30, Mussolini avesse mantenuto le eccezioni come in Germania (per i veterani e decorati della prima guerra, ecc ) ampliandole però anche a chiunque fosse iscritto al partito fascista e a tutti i suoi parenti di ogni ordine e grado (cioè praticamente a tutti);
soltanto con l’occupazione tedesca dell’Italia, insomma, Eichmann poté iniziare la sua opera, mandando a morire gli ebrei italiani ad Auschwitz.
La Arendt spiega questa ritrosia italiana con un’assimilazione di fatto degli ebrei italiani nel tessuto sociale italiano, con il fatto che l’antisemitismo in Italia non fosse ideologia diffusa e con una, testuale, “spontanea umanità di un popolo di antica civiltà”.
Allora, io non so se, dal 1961 ad oggi ci siano documentazioni diverse, e non so quindi se quello che c’è scritto nel libro sia vero fino in fondo, però mi sembra proprio, leggendo le 4 pagine dedicate alle deportazioni in Italia, che gli italiani siano descritti appunto della “brava gente”.
Eh, Massimo, purtroppo, a distanza di oltre cinquant’anni, quel libro di Hannah Arendt (quelle 4 pagine del libro di Hanna Arendt) continua a fare danni. Arendt aveva una conoscenza molto superficiale e frettolosa del fascismo italiano e del nostro colonialismo, e per giunta scriveva in anni in cui molti archivi erano segretati e il cover-up sui crimini italiani funzionava alla grande. Qualunque storico contemporaneo che si sia occupato seriamente di antisemitismo italiano, leggi razziali, ruolo italiano nella Shoah, collaborazionismo, crimini di guerra e coloniali italiani, occupazione della Jugoslavia ecc. può demolire in poche mosse il vetusto luogo comune degli “italiani che salvavano gli ebrei”. Proprio su questo consiglio il libro I carnefici italiani di Simon Levi Sullam, Feltrinelli, 2015.
Confermo quanto sottolinea WM1: nei suoi studi sui fascismi (lo si vede ancor più in “Le origini del totalitarismo”), Arendt non ha approfondito la conoscenza del fascismo italiano, e ciò le costa qualche giudizio superficiale. Il principale (da cui derivano gli altri) è che per lei il fascismo non fu un regime totalitario (al più una sorta di totalitarismo imperfetto): giudizio singolare, giacché la stessa parola “totalitarismo” fu coniata (più o meno in contemporanea nel giro di pochi mesi da Amendola, Salvatorelli e Matteotti) per designare il nascente movimento fascista. Questo giudizio, a distanza di mezzo secolo, è confutato dalla storiografia (a partire da Emilio Gentile, e dagli storici della generazione successiva). La mancata necessità di approfondire la conoscenza del fascismo italiano da parte di Arendt deriva da questo abbaglio. Peraltro, molte delle intuizioni concettuali di Arendt sono utili a comprendere il totalitarismo fascista, e le sue dinamiche (anche non volendo accettare in toto la categoria di “totalitarismo”).
Quel giudizio di Hannah Arendt è stato usato anche da (fascisti) studiosi del fascismo come James Gregor, con cui ho personalmente parlato in quanto insegnava (e se non è morto lo starà ancora facendo…) nell’università americana in cui mi sono addottorato. In quell’occasione mi disse che in fondo durante il ventennio i fascisti avevano ucciso appena circa 15 persone (più o meno testuali parole), e la sua ‘fonte’ era appunto la Arendt.
Come osserva Michele Sarfatti in questo saggio, all’inizio degli anni ’60, quando Hannah Arendt scrisse il suo libro su Eichmann, la storiografia sulla Shoah in Italia era in realtà appena agli inizi. Lo stesso pionieristico studio di Renzo De Felice sulla “Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo”, uscito nel ’61 (che comunque non sembra essere conosciuto dalla Arendt), manifesta gravi limiti di documentazione e di trattazione proprio per il periodo successivo all’8 settembre 1943, che De Felice espone in modo alquanto sommario e affrettato. Tali difetti del testo defeliciano finirono per influenzare lo stesso George L. Mosse, il quale anch’egli, inizialmente, sottovalutò l’entità dell’antisemitismo fascista. Insomma, per studiare la storia della persecuzione antiebraica in Italia è meglio non fare troppo affidamento sulla storiografia più vecchia.
L’articolo di Gabriele Proglio che cito qui sopra si trova anche su Academia: http://www.academia.edu/18184206/Filigrana_dellimmaginario._Cinema_e_razza_al_tempo_della_globalizzazione_1980-2001
Ho inserito il link anche nel mio commento precedente.
Molto interessante questo articolo.
Per quanto riguarda Molinari, si tratta di propaganda politica, niente di più. più interessante invece capire cosa spinga una scrittrice a usare termini così approssimativi. Penso che, al contrario di Molinari, non ci sia ‘dolo’ da parte della Maraini e che anzi siano discorsi più o meno sinceri e senza secondi fini. La penso così anche in seguito ad un articolo di Claudio Magris successivo alle stragi di Parigi.
Magris è tra i più colti e importanti intellettuali italiani. Il suo ultimo romanzo è un’opera in cui il pacifismo, il rifiuto della guerra è un tema centrale. Magris è, per così dire, al di sopra di ogni sospetto. Però in questo articolo sul Corriere http://www.corriere.it/esteri/15_novembre_15/gli-attentati-parigi-quel-complesso-colpa-che-ispira-l-equivoco-buonista-0e5ec956-8b65-11e5-85af-d0c6808d051e.shtml anche lui sembra lasciarsi irretire dal clima di scontro di civiltà.
In particolare mi colpì questo passaggio:
È recente la notizia di una gita scolastica annullata dalle autorità della scuola elementare «Matteotti» di Firenze perché prevedeva una visita artistica che includeva un Cristo dipinto da Chagall, nel timore che ciò potesse offendere gli allievi di religione musulmana. Il Cristo di Chagall è un’opera d’arte, come le decorazioni dell’Alhambra, e solo un demente o un fanatico razzista può temere che l’uno o le altre possano offendere fedi o convinzioni di qualcuno.
la notizia è falsa, in realtà la scuola aveva disposto il blocco di ogni visita didattica, per motivi organizzativi, non certo per motivi religiosi. Magris è stato sicuramente informato male.
Ma a parte le colpe dei media, credo che tanto in Magris quanto in Maraini si manifesti un modo di pensare tipicamente novecentesco, tipico di quella cultura borghese anche di sinistra, secondo cui le conquiste culturali, di libertà intellettuale, dei paesi europei e occidentali sono sempre e comunque un baluardo contro la barbarie, contro ogni barbarie.
WuMing1 cita a proposito HaKeillah, rivista dell’ebraismo di sinistra torinese; e proprio il rapporto della sinistra con Israele rappresenta il simbolo di questo atteggiamento.
Bobbio, Agosti, il giro torinese di Resistenza Giustizia e Libertà, sono i padri nobili del pensiero che oggi porta ad articoli come quello di Molinari: noi occidentali dobbiamo combattere ogni cultura retrograda ed anti illuminista; ed oggi come nel 1967, questa cultura considerata retrograda è quella musulmana.
Quella generazione, probabilmente in buona fede, ha fornito le armi dialettiche che usano ora questi propagandisti dello scontro di civiltà, dalla combriccola neocon italiana fino ai razzisti veri e propri per finire a chi, come Magris e la Maraini, per sostenere la ragione illuminista, arriva a confondersi con questi mercanti di odio.
Ciao a tutti,
e complimenti per il post!
Forse avete già fornito un po’ di bibliografia altrove nel blog e me la sono persa (e in tal caso me ne scuso), ma nel dubbio chiedo: avreste qualche testo o articolo da consigliare sull’amministrazione italiana in Somalia negli anni 50? Mi piacerebbe approfondire.
Grazie!
Una buona introduzione all’AFIS è il libro di Angelo Del Boca, “Una sconfitta dell’intelligenza”, pubblicato da Laterza nel ’93 o giù di lì.
In narrativa, è molto interessante il romanzo/reportage di Shirin R. Fazel, Lontano da Mogadiscio. Noi ci siamo occupati di quelle vicende in un libro intitolato “Timira”: è un romanzo, ma in fondo, ci sono diverse pagine di bibliografia, dove trovi anche i link a documentari e filmati d’epoca che si trovano anche su YouTube.
Poi, se hai tempo, cercando la parola “Somalia” negli archivi on-line di quotidiani come L’Unità o La Stampa, per il periodo 1950 – 1960 (e in particolare: luglio 1960, tempo di indipendenza somala e di bilanci), vengono fuori alcune perle notevoli.
Qui si può leggere la postfazione scritta da Simone Brioni per la nuova edizione italiana di Lontano da Mogadiscio: http://www.laurana.it/pdf/postfazione%20LdM_Brioni.pdf
Di Shirin Fazel, non facile da trovare, segnalo anche il secondo romanzo, “Nuvole sull’equatore”, ambientato proprio durante il periodo dell’AFIS.
Breve messaggio solo per ringraziare per tutti i suggerimenti e i link che varie persone hanno postato… grazie davvero!
Ciao C., qua puoi leggere il resoconto stenografico della seduta parlamentare in cui si discusse del finanziamento all’amministrazione fiduciaria della Somalia, il 3 febbraio 1950.
http://legislature.camera.it/_dati/leg01/lavori/stenografici/sed0382/sed0382.pdf
Notevole il discorso del relatore di maggioranza:
“L’ltalia ritorna in Africa per continuare a svolgere una missione di civilta che è consona al suo temperamento e alle sue tradizioni; e vi torna (…) a titolo di amministratrice fiduciaria (…) Il fatto che il mandato riguardi un territorio limitato e non l’insieme dei territori ai quali gli italiani pensavano, non presuppone che esso abbia minore importanza (…)”
“L’Italia sicuraniente adempirà con scrupolo il mandato di civiltà affidatole. E potrà farlo con comprensione completa, riferendosi alla propria tradizione e a quanto già aveva realizzato per il progresso materiale e morale delle popolazioni delle quali ci occupiamo.”
“Sono ben note tutte le vicende che hanno accompagnato la questione della sorte degli antichi territori italiani d’ Africa; e non occorre quindi su di esse soffrmarsi. Basterà dire che l’Italia assume il mandato somalo per continuare l’opera che aveva intrapresa e portarla a termine nell’interesse delle popolazioni locali, della civiltà, e della valorizzazione in genere dell’Africa”
“In altri termini, si tratta di un‘opera immane di valorizzazione del territorio e di civilizzazione della popolazione, che l’Italia aveva compiuto e che sarà lieta di portare a termine, perché le popolazioni somale possano reggersi da sè stesse nel periodo dei dieci anni indicato.”
P.S. se poi hai voglia di spulciare in questo thread a partire da qui http://bora.la/2014/02/20/67081/#comment-326996, puoi vedere cosa ne pensava di questa faccenda un noto ipovedente ;-)
Interessantissimo il dibattito parlamentare che linki, dove il governo e la sua maggioranza rivendicano piena continuità tra il colonialismo fascista, dipinto in tinte rosee, e il neocolonialismo “democratico” con copertura ONU.
Fa cascare le braccia la relazione di minoranza di Eugenio Dugoni, socialista, ex partigiano e padre costituente, più tardi sindaco di Mantova. Fa critiche tutte dal punto di vista di interclassisti interessi nazionali italiani, lodando comunque l’approccio ipocrita e falso del relatore di maggioranza. Ancora peggio fa Guido Mazzali, anche lui socialista ed ex partigiano, che fa una lunga premessa citando la dottrina marxista sul colonialista per poi incredibilmente usarla per tutta una filippica geopolitica in cui si dice che bisogna dire no alla Somalia per difendere gli interessi nazionali italiani contro l’impero britannico, perché se ci danno un pezzo lì non ci danno un’altro territorio là ecc. Addirittura, nel suo intervento davvero vergognoso per la totale mancanza di riferimenti ai doveri internazionalisti di un presunto socialista nei confronti dei popoli africani, si lamenta una cospirazione angloamericana per impedire la formazione futura dell’Unione Europea.
Arriva poi un terzo partigiano, il comunista (se volete aggiungete pure due paia di virgolette) Giancarlo Pajetta, che non richiede presentazioni, che dice frasi di questo tenore, di qualità retorica simile a un comizio di CasaPound:
«più prezioso di ogni ricchezza, è il sangue dei nostri soldati e più preziosi di ogni ricchezza ed anche del sangue dei nostri soldati sono l’onore, il prestigio e la bandiera della nazione, che voi minacciate, che voi compromettete gravemente.»
Dopodiché, si intende, Pajetta si appresta a svolgere il suo compitino e quindi a votare anche lui contro il governo, ma non prima di aver fatto questa agghiacciante premessa “post-ideologica”, diciamo:
«Onorevoli colleghi, qui non si pone il problema trascendentale del diritto dell’ Italia ad avere dei mandati o di ritornare in Africa in un senso generale. No! Qui si pone un problema concreto.»
E poi:
«Altri hanno la tradizione della brutalità, dell’ingegno, della furberia coloniale, io credo che noi abbiamo la tradizione della leggerezza coloniale.»
Ossia: siamo troppo buoni, spendiamo miliardi in avventure che non danno un buon ritorno economico. Il buon Pajetta si riprende sul finale, decide finalmente di parlare del fascismo e lì si scatena, ricorda i massacri e l’odio da parte dei colonizzati, e denuncia anche che per il mandato ONU il governo De Gasperi stesse spolverando proprio lo stesso apparato coloniale e lo stesso personale dirigente dell’epoca imperiale. Il picco massimo lo raggiunge quando cita parole non sue, ovvero quelle de “l’Unità” del 1935, quando ancora c’erano idee chiare sull’imperialismo italiano. Chiude l’intervento dicendo che non si può dar fiducia al governo De Gasperi per compiere una missione di civiltà, perché finirà per fare la solita politica colonialista. Applausi dai seggi della sinistra, scleri isterici da quelli della destra, con uno che tira fuori i prigionieri italiani in Russia e un altro che gli risponde dai banchi del PCI ricordandogli le mazzate che ha dato l’Armata Rossa agli invasori fascisti.
Quel che conta è che comunque si siano opposti? Forse sì, ma di certo fa spavento l’arretramento ideologico subito a causa dello stalinismo dai due partiti più importanti della sinistra italiana rispetto alla loro antica tradizione antimperialista e rispetto alla linea di Lenin che aveva portato alla Rivoluzione d’Ottobre ed era stata alla base della politica internazionale della Terza Internazionale nella sua epoca d’oro.
A dimostrazione del fatto che per combattere il rossobrunismo non basta puntare il dito contro i nazimaoisti, e nemmeno contro i fusaro, i giulietto chiesa, i fulvio grimaldi e le varie lunatic fringes prodotte dall’impazzimento del post ’89. Bisogna scavare proprio nella merda che si è sedimentata nella sinistra socialista e comunista e nelle sue organizzazioni di massa a partire dalla svolta “geopolitica” stalinista del “socialismo in un solo paese”.
Il Reperto n.5 della sezione “Archivio storico” di Timira (p. 257) riporta stralci dell’articolo che L’Unità del 4 febbraio 1950 dedicò all’intervento di Pajetta nel dibattito parlamentare sulla Somalia.
Anche dall’articolo emerge una posizione del PCI contraria al “ritorno italiano in Africa” non in linea di principio, ma per colpa del passato fascista, dell’attualità democristiana e della continuità tra i due regimi politici.
Dalle ricerche che facemmo per quel libro ho ricavato l’impressione che il PCI, nel Dopoguerra, fosse piuttosto confuso e distratto sul tema della decolonizzazione.
Uno dei protagonisti del romanzo, Lamberto, è ispirato a un giornalista comunista che negli anni Cinquanta è tra i pochi a interessarsi delle lotte anticoloniali africane.
Nel Reperto n.6 dell’Archivio storico (p. 325) riportiamo stralci di un suo articolo (“Bilancio dell’amministrazione fiduciaria italiana in Somalia”) comparso su un numero speciale di “Rinascita”, uscito nel nov-dic 1958, e tutto dedicato al colonialismo. Si trattava, però, di uscite saltuarie, di un interesse ancora sporadico. Immagino non fosse facile, per i compagni, appoggiare la liberazione della Tunisia dal colonialismo francese e, quasi nelle stesso momento, l’ingresso dei carri armati sovietici in Ungheria.
Del resto, nemmeno il cambio dei nomi delle vie della Cirenaica (intesa come rione di Bologna), deciso nel 1949 dal consiglio comunale, avvenne per motivazioni anticoloniali. Nel libro «Resistenze in Cirenaica» riportiamo ampi stralci di quella seduta, con queste premessa:
—
[…] Nel periodo che va dalla Liberazione al Trattato di pace del 1947, non si trova nessuna dichiarazione dei partiti della sinistra italiana – PCI, PSI e Partito d’Azione – critica nei confronti del nostro colonialismo, ovvero del fatto che l’Italia avesse diritto a colonie oltremare. Tutte le forze politiche erano per la conservazione e di queste ultime. La presa di distanza – quando c’era – riguardava il modo in cui il fascismo aveva condotto le sue guerre coloniali, ma le colonie stesse erano luoghi dove si era esercitato «il lavoro degli italiani», dove si era «versato sudore». Lo storico Enzo Collotti ha parlato di «una tradizione nazionalista assai pervicace» anche nelle varie correnti dell’antifascismo italiano. Se ci aggiungiamo che nel PCI vigeva un autentico culto della realpolitik, il quadro si precisa ulteriormente.
Una coscienza anticolonialista – comunque non priva di ambiguità e reticenze sull’esperienza italiana – si sarebbe formata solo più avanti, con l’inizio della decolonizzazione, con la battaglia di Dien Bien Phu che cacciò i francesi dall’Indocina (1954), con la guerra d’Algeria, con la celebrità di leader anticoloniali come Ahmed Ben Bella, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta. In ogni caso, si sarebbe formata solo dopo il Trattato di pace del 1947, che privava l’Italia delle sue colonie. In buona sostanza, in Italia si è sempre stati contro il colonialismo degli altri.
In quel contesto, la decisione di sostituire i nomi coloniali del rione Cirenaica con nomi di caduti partigiani fu senza dubbio coraggiosa. Non diciamo “pionieristica” perché i pionieri aprono la strada a comportamenti che saranno di tutti, mentre quell’esempio non fu seguito quasi da nessuno. Fu coraggiosa, ma non poteva essere troppo esplicita. Questo spiega le numerose perifrasi, distinzioni, excusationes non petitae che costellano la discussione, nonché il “contentino” di lasciare il vecchio nome a via Libia, rimanendo il quale «rimane, diciamo così, il valore morale, il significato di un nostro eventuale diritto a questa terra.»
In nessun punto della discussione troverete la critica al colonialismo che siamo in grado di fare oggi. Nondimeno, la decisione fu presa, e su quella decisione oggi possiamo fare leva, per andare oltre (molto oltre) quelle cautele, quelle circonlocuzioni, quelle frasi pesate col bilancino.
—
Ne approfitto per ricordare che il libro lo presentiamo stasera a Bologna e, da questo pomeriggio, sarà ordinabile on line sul sito distribuzionidalbasso.com
Salve a tutti e complimenti per il post anche da parte mia.
Per quanto riguarda il ruole dell’Italia in Somalia, ti suggerirei un libro di un’antropologa americana, Catherine Besteman, Unravelling Somalia: Race, Class, and the Legacy of Slavery. Tanto per contestualizzare il suo lavoro, lei ha fatto ricerca in Somalia prima del collasso del governo e si e’ concentrata sulle comunita’ agricole del sud del Paese, tra i fiumi Juba e Shabelle. E’ stata tra i primi ad occuparsi delle dinamiche razziali e di classe in quello che ha lungo e’ stato definito, erroneamente come dimostra, l’unico Paese etnicamente omogeneo d’Africa. Mescolando storiografia (basata sia su fonti orali che su documenti di epoca coloniale) ed etnografia, sostiene che i governi coloniali italiani (pre- e fascista) e poi l’amministrazione fiduciaria hanno avuto responsabilita’ enormi nel cristallizzare le identita’ etniche (rompendo ad esempio meccanismi di ‘adozione’ tra un clan e un altro) e quindi nel costruire attivamente le ‘tribu’. Quello che e’ in discussione non e’ tanto l’esistenza di gruppi etnici, che esistono come spazi di identificazione, mappe sociali e politiche, ma il fatto che i confini di questi gruppi siano sempre stati rigidi – quando invece proprio il caso della Somalia dimostra come questi confini siano sempre stati fluidi e negoziabili. L’aspetto interessante della faccenda e’ che, delineando e fissando i contorni di ‘caratteri tribali’, l’Italia ha creato delle classi sociali – gettando le basi per le tragedie degli anni a venire. Per farti un esempio, nelle piantagioni agricole nel sud della Somalia gli amministratori coloniali impiegarono agricoltori cosiddetti bantu (discendenti di schiavi portati da Tanzania e Mozambico nel Benadir da commercianti arabi nel secolo precendente) perche’ ritenuti piu’ ‘docili’ rispetto a membri di clan pastorali – che, ovviamente, vivendo in ambienti piu’ ostili, avevano piu’ dimestichezza con le armi (nota che aspetti legati a fattori strutturali venivano fatti rientrare ancora una volta nel concetto di carattere naturale). Cosi’ facendo, si rafforzarono delle divisioni in verticale (tra clan dominanti e cosiddetti ‘minoritari’, i primi in ruoli chiave dell’economia, della politica e dell’esercito, i secondi rimasti sui margini) e orizzontali (con le elite Darod e Hawyie, messe una contro l’altra e pronte a scannarsi alla prima occasione – com’e’ poi stato).
Per concludere, e’ interessante come, secondo chi ha osservato queste dinamiche di formazione di razza/classe in Somalia (Besteman, ma anche Ali Jimale Ahmed, Omar Eno e Ken Menkhaus), la carta etnica non sia stata giocata consapevolmente dall’Italia, ma con quel misto di sciatteria e superficialita’ che contraddistingue certe narrative odierne di tribalismo e rivalita’ ancestrali.
Parafrasando Hannah Arendt, potremmo quasi parlare di “cialtroneria del male”.
Grazie per il contributo, molto interessante. Sono d’accordo sul fatto che gli italiani non giocarono (e consolidarono e modellarono) la carta etnica della Somalia in maniera intelligente e sempre funzionale ai loro interessi. Ma dire che lo fecero in maniera “inconsapevole” mi pare eccessivo. La sciatteria del colonialismo italiano diventa troppo spesso un’attenuante, auto-commiseratoria e vittimista: il nostro colonialismo è stato meno cattivo di altri perché noialtri non siamo capaci di essere cattivi sul serio, se non “bravi”, siamo quantomeno “sciatta gente”, cilatroni irresponsabili, che magari il danno lo combinano, ma senza volere, per errore, per distrazione. Non come i tedeschi: quelli sono bravi, ligi e determinati in tutto, e quando si applicano nella cattiveria, allora sanno essere terribili, mica come noialtri, simpatici arraffoni che tirano a campare. Detto questo, è innegabile che i colonialisti italiani furono spesso sciatti e cialtroni, ma non perché non volessero applicarsi, quasi che “fare il male” li ripugnasse un pochino. Il male avrebbero voluto farlo… per bene, e in tanti casi fecero pure peggio.
Post e discussione davvero molto interessanti, grazie Wu Ming. Sull’AFIS consiglio anche il libro di Antonio Maria Morone, L’ultima colonia. Come l’Italia è tornata in Africa 1950-1960 (Laterza 2011), e quello di Mohamed Issa Trunji, Somalia. The Untold Story 1941-1969 (Looh Press 2015). C’è poi un breve documentario del 1960 intitolato “Somalia: dieci anni dopo” (lo trovi su Youtube), dove si dice che gli italiani hanno la consapevolezza di “avere tanto più dato di quanto hanno ricevuto” al termine dell’amministrazione fiduciaria. Valeria Deplano ha parlato di Settimana nera (1961) di Enrico Emanuelli e del film che ne è stato tratto, Violenza segreta (1963) di Giorgio Moser, nell’articolo “Settimana nera e Violenza segreta. Denuncia e rimozione dell’eredità coloniale negli anni Sessanta”, presente nel volume Subalternità Italiane. Percorsi di ricerca tra letteratura e storia (Aracne 2014). Il romanzo di Emanuelli è ambientato nella Somalia dell’AFIS.
Verso una nuova guerra dell’Italia in #Libia? Ricordiamo cosa abbiamo fatto in quel paese.
A far da ponte tra questo post e quello sulla Libia, segnalo una chicca da La stampa sera del 30 dicembre 1936. In una rassegna di notizie sull’Impero – “dal Mediterraneo all’Indiano” – compare un articoletto dal titolo: “I nomadi libici hanno i loro campi”. Occhiello: “Un ardito esperimento riuscito”. Nel testo si parla dello “spostamento definitivo delle genti magarha dalla regione dello Sciueref nello Uadi Es-Shati, nel Fezzan, spostamento che è valso ad eliminare i vecchi dissensi ed i continui motivi di incidenti fra loro e le tribù degli Ueb-bu-Sef e dei Zintan”. Da notare che: a) Lo spostamento è di quasi trecento chilometri; b) Siamo nel 1936, oltre il periodo delle grandi deportazioni ordinate da Graziani e Badoglio, della gente dell’interno verso i campi di concentramento della costa Cirenaica. Anche nella “Libia pacificata” (secondo la propaganda fascista, già all’inizio del 1932) l’Italia ha continuato a giocare a scacchi con intere popolazioni (i Magarha sono il secondo gruppo più numeroso del paese); c) La scusa del “tribalismo”, della rivalità, dei “vecchi dissensi” e del nomadismo, veniva utilizzata per giustificare “arditi esperimenti” sulla pelle dei colonizzati.
[…] Daesh, il sedicente califfato islamico, lo stato d’eccezione permanente in Francia – dopo gli attacchi del 13 novembre a Parigi – e l’informazione mainstream che da tempo ha messo l’elmetto, in particolare nel nostro Paese, con le invocazioni guerresche del Corriere della Sera (in particolare sulla Libia) e i richiami al “branco” di Colonia del neodirettore de La Stampa, Maurizio Molinari, autore tra le altre cose pure de “Il califfato del terrore”, istant book su Daesh e dintorni, analiticamente “scorticato” dal punto di vista politico e mediatico dal collettivo di scrittori Wu Ming (clicca qui per il loro post al riguardo). […]
C’è poco da commentare questo post. E’ un trattato di anatomia descrittiva su cosa sono e cosa sono diventati i media mainstream italiani. D’altronde se “La Stampa” ha il soprannome “la busiarda” qualcosa vorrà pur dire. Molinari meriterebbe un richiamo dell’Ordine ( se ciò significa qualcosa) e anche un’accusa di plagio a quanto pare. Scandalosa poi l’ignoranza di FATTI storici. Fatti che, in teoria, sarebbero il pane quotidiano per un giornalista. E Calabresi, neodirettore di Repubblica non fa eccezione. Ed è un peccato perché alcuni suoi libri ( uno su tutti “Spingendo la notte più in là” ) non sono affatto male. Il guaio più grosso è però di Repubblica, data la sua diffusione tra la gente che si definisce, e lo è, di sinistra, che prende per buona la panzana dell’attacco premeditato, con una sciatteria e una superficialità disarmanti. Nemmeno controllare le fonti ufficiali della polizia tedesca, cioè il minimo sindacale. Lontani i tempi delle inchieste che hanno fatto epoca tipo “Telekom Serbia”, “Nigergate” e “Scandalo Telecom Sismi”. Da quando Giuseppe D’Avanzo ci ha lasciato è diventato un giornalaccio, cosa acuitasi da quando è premier il fiorentino.
Molinari ha aperto una strada, cioè quella della disinformazione a tutto campo della questione Daesh e della questione migranti, appunto un ” pot-pourri incredibile” che genera solo confusione. Finché questo modus operandi e scrivendi rimaneva isolato ai fogli dichiaratamente di destra non ci sarebbe stato nulla di nuovo, se però la breccia si allarga…
Non so se sia l’effetto delle proteste che l’articolo di Molinari ha generato in rete, ma oggi sulla Stampa (pag 30) c’è un articolo che, finalmente, parla anche degli Italiani “cattiva gente”, che contribuirono attivamente alle persecuzioni razziali, ed alla consegna degli ebrei ai nazifascisti. Non che un articolo buono valga da indulgenza plenaria per gli altri… ma è bene se qualcosa si muove anche nel mainstream
A proposito del fatto che la stampa continua a colpevolizzare gli stranieri a priori, segnalo l’articolo apparso oggi (26 gennaio) sul Corriere a proposito della vicenda dell’Audi gialla:
“Treviso, l’Audi Gialla ritrovata bruciata in un campo” http://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/16_gennaio_26/treviso-l-audi-gialla-ritrovata-bruciata-un-campo-a69768b6-c41f-11e5-8e0c-7baf441d5d56.shtml
Ecco il testo: “Ritrovata in un campo in provincia di Treviso, bruciata, l’Audi Gialla con targa svizzera rubata il giorno di Santo Stefano a Malpensa e utilizzata per compiere una serie di rapine: i quattro albanesi a bordo della vettura sono responsabili anche della morte di una donna russa in un incidente stradale causato durante una delle loro fughe. Secondo il procuratore della Repubblica di Treviso Michele Della Costa “ le possibilità di risalire ai protagonisti della vicenda sono ridotte al minimo. Sarà difficile trovare qualche reperto utile – ha commentato dopo il ritrovamento dell’auto bruciata – e purtroppo, se fino a ieri avevamo qualche aggancio per individuare gli occupanti, oggi non c’è più neppure questo”
Mi chiedo: se le possibilità di risalire ai protagonisti della vicenda sono ridotte al minimo, come si fa a sapere che erano albanesi, dal momento che nessuno li ha identificati e nessuno nemmeno li ha visti o ci ha parlato?
Sempre sull’editoriale di Molinari, segnaliamo quest’importante documento collettivo, Il male della banalità.
[…] vari conflitti mediorientali, asiatici e africani? Basta rileggersi un recente ma già famigerato editoriale del direttore della Stampa Maurizio Molinari. Caos e barbarie. Incomprensibili, disumani e proprio per questo da addomesticare. Che è poi il […]
[…] vari conflitti mediorientali, asiatici e africani? Basta rileggersi un recente ma già famigerato editoriale del direttore della Stampa Maurizio Molinari. Caos e barbarie; “quelli là” sono incomprensibili, disumani, e proprio per questo da […]
[…] segnalare passaggi di fase, salti di qualità, ulteriori salti in basso e spostamenti a destra.” (http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=23250. Si veda anche la recensione di tutti gli editoriali comparsi sul tema pubblicata da Valigia Blu al […]
[…] e prive di ogni scrupolo e qualsivoglia senso di responsabilità. La decisione scaturì da questa notizia (poiché nel grande fiume di internet tutto scorre, allego a più imperitura memoria, a questo link […]
[…] Maurizio Molinari, dopo i fatti di Colonia del Capodanno 2015 aveva attribuito in maniera razzista la causa degli eventi a una generica cultura araba tribale del branco, scelga di ascoltare (anche) […]