
In Italia e in buona parte d’Europa le ultime settimane del 2010 hanno visto un brusco inasprimento del conflitto sociale. La questione della “violenza” è tornata all’ordine del giorno. Questione banale, che costringe a essere banali: la “violenza” che accende di sdegno gli opinionisti, fa esplodere i titoli dei TG e riempie articoli e servizi non è mai quella dei padroni e dei governi. Non è la violenza di chi taglia o licenzia, discrimina ed esclude, non è quella di chi specula, gioca d’azzardo con soldi virtuali ma ne incassa di veri, e se perde paga Pantalone (“privatizzare i profitti, socializzare le perdite”), non è la violenza di chi reprime. Queste violenze sono anzi elogiate, chi le compie è un moderno benefattore o, se si vola basso, “sta soltanto facendo il suo lavoro”. Proprio come, a suo tempo, il figlio di Maria Schefferling e Adolf Karl Eichmann.
No, la “violenza” di cui si dibatte, la “violenza” che si condanna è sempre quella della rivolta. Non solo per ipocrisia e servilismo, ma anche perché la rivolta è … poco sottile. E’ visibile e vistosa. Fotogenica, telegenica e al contempo inaccettabile. La rivolta attrae e respinge, coinvolge anche chi non la vuole e, in segreto, esalta anche chi la condanna. Non c’è filmato di riot o sommossa che non attivi i neuroni specchio di chi lo guarda, facendolo sentire in quelle strade, tra chi alza barricate, fugge o insegue. La critica, la spiegazione, la condanna, gli argomenti…Tutto questo viene dopo.
La rivolta affascina anche chi la reprime. Il celerino “compartecipa”, il suo “reducismo” ha toni non dissimili da quelli dell’insorto. Sui forum e nelle chat delle forze dell’ordine, rievocazioni e ricostruzioni riecheggiano quelle del campo avverso.
Per tutti questi motivi, la rivolta è ancora e sempre un enigma, costruisce e fa vivere – sia pure per un breve lasso di tempo – un mondo insondabile, dove non c’è ieri né domani ma il qui-e-adesso è in contatto con l’altroieri (ogni rivolta somiglia a tutte le rivolte del passato) e con il dopodomani (ogni rivolta invoca, con le azioni prima che con le parole, la fine del mondo che ha contro).
“La rivolta non conosce se stessa”, disse Jacques Lacan poco dopo il maggio ’68. Il senso era: a scendere in strada, insieme agli individui e prima di essi, sono delle strutture: forme, ruoli, simboli, tradizioni, modi di vivere la temporalità.
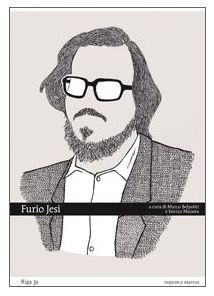 Ecco, la rivolta è tornata un tema su cui interrogarsi. Lo aveva previsto la rivista Carta, che ormai da molto tempo ospita i bollettini dell’antropologo Alain Bertho sulle rivolte e sui tumulti che scoppiano nelle città d’Europa. Aveva iniziato a interrogarsi al riguardo Pierandrea Amato, filosofo napoletano, il cui libro La rivolta è uscito nel 2010 per l’editore Cronopio. Sociologi, filosofi e scrittori si stanno interrogando sulla rivolta, sulle sue modalità, sul suo essere politica o impolitica. E tornano a circolare nomi come Albert Camus, Frantz Fanon, Furio Jesi…
Ecco, la rivolta è tornata un tema su cui interrogarsi. Lo aveva previsto la rivista Carta, che ormai da molto tempo ospita i bollettini dell’antropologo Alain Bertho sulle rivolte e sui tumulti che scoppiano nelle città d’Europa. Aveva iniziato a interrogarsi al riguardo Pierandrea Amato, filosofo napoletano, il cui libro La rivolta è uscito nel 2010 per l’editore Cronopio. Sociologi, filosofi e scrittori si stanno interrogando sulla rivolta, sulle sue modalità, sul suo essere politica o impolitica. E tornano a circolare nomi come Albert Camus, Frantz Fanon, Furio Jesi…
Quest’ultimo, lo abbiamo ricordato varie volte, nel 1969 scrisse un testo fondamentale, Spartakus. Simbologia della rivolta. Testo denso, divagante, criptico in molti passaggi, ma in grado di fornire chiavi preziose per aprire lo scrigno, quel piccolo forziere di misteri che è la rivolta.
E allora avviciniamoci al punto. Come i lettori di Giap sanno, da poco più di un mese è uscito in libreria un numero monografico della rivista Riga interamente dedicato a Jesi, a cura di Marco Belpoliti ed Enrico Manera. Per conoscere vita e pensiero del mitologo e militante torinese, morto a soli 39 anni, questa rivista/libro è il viatico migliore. Raccoglie testi e contributi vari di Georges Dumézil, Giorgio Agamben, Franco Volpi, Gianni Vattimo, Sergio Givone, David Bidussa, Antonio Gnoli, Angelo D’Orsi etc.
Eccoci al punto. Il numero di Riga si apre con un racconto di WM1 intitolato “Estratto da Trommeln in Genua“. “Estratto” perché è presentato (anche tipograficamente) come stralcio di un testo più lungo, in realtà inesistente. Almeno alla data di oggi. Lo proponiamo qui di seguito.
Il racconto si svolge a Genova il 20 luglio 2001, ed è ispirato – sin dal titolo – al dramma di Bertolt Brecht Tamburi nella notte [Trommeln in der Nacht, primo allestimento nel 1922]. O meglio: è ispirato alla lettura di Tamburi nella notte che fa Jesi in Spartakus. Alcune citazioni da quest’ultimo testo sono inserite nel flusso di coscienza del protagonista e io narrante. La rivolta a cui vengono applicate (sommariamente) suggestioni jesiane, tuttavia, non è quella dei dimostranti (che, a rigore, non ebbe luogo), bensì quella delle forze dell’ordine.
L’interpretazione del G8 di Genova come “riot dei poliziotti” non è una trovata di WM1: è solo una puntualizzazione, il tentativo di elaborare uno spunto del blogger, pubblicista e insegnante Leonardo Tondelli (è un nom de plume). Il 16 luglio 2007, Leonardo pubblicò un post intitolato “Passa la Storia, fai ciao con la manina”, in cui scriveva:
Genova dovremmo iniziare a raccontarcela in un modo diverso […] Il nostro racconto pecca del solito vecchio peccato: l’autoreferenzialità. Siccome a Genova c’eravamo anche noi, riteniamo giusto raccontarlo dal nostro punto di vista […] È tempo di ammetterlo: noi non siamo i protagonisti di Genova. Un livido, una cicatrice, un bello spavento, non ha fatto di noi i protagonisti […] Genova avrebbe dovuto essere la nostra manifestazione, ma non lo è stata.
Genova è stata la manifestazione dei ragazzi in uniforme blu […] Genova è stata la sagra del tonfa, il manganello multiuso. Genova è stata la dimostrazione delle forze dell’ordine, che venivano da tutte le parti a confrontare le proprie esperienze: bella la tua divisa, forte il tuo manganello, fammi vedere come usi lo spray. Come se qualcuno avesse detto (e qualcuno deve averlo detto): adesso vi facciamo vedere quanto riusciamo a essere fascisti, se c’impegniamo […] preso atto che a Genova ci fu una colossale manifestazione delle forze dell’ordine, che eclissò la manifestazione anti-g8, vorremmo sapere per quale motivo i poliziotti e i carabinieri manifestavano. Vorremmo capire il senso: era un messaggio? A chi era rivolto? E ha funzionato? Perché alla fine della fiera rimane in noi la sensazione di essere stati menati a casaccio, per nessun motivo, da gente che in realtà pensava ad altro, e menava la nuora perché la suocera intendesse.
Perché iniziare il 2011 di Giap con un post come questo?
Perché è plausibile, anzi, probabile che l’anno nuovo prosegua com’è finito quello vecchio; perché dopo il 14 dicembre studentesco si è parlato molto del 20 luglio genovese; perché quel 20 luglio era dell’anno 2001, ovvero esattamente dieci anni fa.
Ricorrenze e anniversari, quando servono, servono a questo: nei prossimi mesi tutti i non-detti e i rimossi, tutti i ricordi e i brutti sogni, tutti i discorsi e gli scazzi, tutte le sentenze e le ingiurie troveranno una nuova sintesi. Precaria, come tutte le sintesi, e come le esistenze di molti che aiuteranno a trarla.
***
Estratto da TROMMELN IN GENUA
di Wu Ming 1
PRIMO UOMO: – Certo che li stanno suonando, quei tamburi.
SECONDO UOMO: – Diavolo, sì! E nella nostra parte di città!
Bertolt Brecht, Tamburi nella notte
.
 …Fu allora, svoltando in Piazza Alimonda, fu allora che vidi la macchina. Piazza Alimonda: omphalos e ultimo avamposto, spazio d’incontro tra vivi e morti, luogo a cui sarei tornato ancora e ancora da pellegrino, per sempre edotto che la sorte di Carlo Giuliani era anche mia, mia e di chiunque era stato lì, perché sarebbe potuto accadere a me, perché ciascuno di noi, nell’istante delle infinite potenzialità, era stato Carlo Giuliani e all’inverso Carlo Giuliani, prima di essere ucciso da un carabiniere, era stato ciascuno di noi e, precisamente, me.
…Fu allora, svoltando in Piazza Alimonda, fu allora che vidi la macchina. Piazza Alimonda: omphalos e ultimo avamposto, spazio d’incontro tra vivi e morti, luogo a cui sarei tornato ancora e ancora da pellegrino, per sempre edotto che la sorte di Carlo Giuliani era anche mia, mia e di chiunque era stato lì, perché sarebbe potuto accadere a me, perché ciascuno di noi, nell’istante delle infinite potenzialità, era stato Carlo Giuliani e all’inverso Carlo Giuliani, prima di essere ucciso da un carabiniere, era stato ciascuno di noi e, precisamente, me.
La sera del venti di luglio duemilaeuno, in Piazza Alimonda, reporter e carabinieri si aggiravano intorno satolli e un po’ spersi mentre sirene cantavano rauche, orde di sirene come ciuchi raglianti, e nella coda di ogni occhio sembravano ammucchiarsi stracci bruciati, e dietro ogni angolo si smorzavano pian piano i lampi d’azzurro che tutti ricordiamo, e qualcuno ancora urlava.
Là vidi la macchina, il corpo blindato, le cento teste sui colli retrattili.
Capii subito, vedendola a riposo ma ancora calda – come la fessura di un tostapane, pensai – capii che aveva funzionato tutto il giorno e prima ancora per mesi e mesi, ruggendo, ridendo, battendo la cadenza dei discorsi che avevano portato a Genova le genti, la “moltitudine”, i miei recenti compagni di fuga e rimpiattino, persone mai viste prima con cui, per tutto il giorno, avevo rotto pane e fiato. Capii cos’era, perché il giorno che stava finendo mi aveva insegnato tanto, e senza esitare la riconobbi.
La macchina mitologica.
Intendiamoci, solo anni dopo sarei giunto a chiamarla così. Quella sera, essa non aveva nome.
Fu uno spettacolo per me soltanto: presenza minacciosa che nessuno vedeva, pesante eppure sinuosa, come un micio elefantiaco che sonnecchia. Le teste avevano gli occhi chiusi e le fauci a riposo. Il corpo blindato sembrava risucchiare l’energia di tutti, chi le andava vicino sentiva un cerchio alla testa e non sapeva perché. Era un paradosso, così solida ma evanescente, trasparente, vedevi attraverso di essa, vedevi la piazza, la gente che si affannava. La macchina ronfava e chissà, forse sognava nuovi disastri.
 Solo per accidente mi ero ritrovato in quei cunicoli di tonnara, le strade di Genova durante la grande caccia all’uomo. Era in corso una rivolta, sì, ma come non ne avevo mai immaginate. Una rivolta di sbirri. Erano gli sbirri i “sovversivi”, quelli che all’improvviso violavano ogni legge e calpestavano le consuetudini recenti, gli accordi di piazza, la “minima decenza” di cui qualcuno avrebbe – inutilmente – parlato. Nella loro rivolta, in quel tempo di qualità inconsueta, nessuno di essi era solo, perché ogni cosa era comune, ogni calcio era dato da tutti, ogni manganellata, ogni candelotto sparato nella folla, ogni scontro in qualunque zona della città era la battaglia di tutti, con le stesse armi, contro lo stesso nemico – la “zecca”, il “comunista”, il “no global” – nel medesimo spazio simbolico. In quella rivolta dei repressori, tutto sembrava avvenire per sempre: non c’era più un domani, un giudizio futuro a cui sottoporsi, non c’erano vera tattica né tantomeno strategia, Genova era il regno dell’ora-o-mai-più, il regno dell’una-volta-per-tutte. Picchiare, calpestare facce, sbraitare inseguendo gli inermi, drogarsi – stricto & lato sensu – come se il mondo stesse per finire: ogni azione era irrevocabile e magnificamente fine a se stessa. I dimostranti non dimostravano alcunché, potevano solo subire la rivolta degli sbirri, l’interruzione del continuum in cui erano vissuti. Fine della “normalità”.
Solo per accidente mi ero ritrovato in quei cunicoli di tonnara, le strade di Genova durante la grande caccia all’uomo. Era in corso una rivolta, sì, ma come non ne avevo mai immaginate. Una rivolta di sbirri. Erano gli sbirri i “sovversivi”, quelli che all’improvviso violavano ogni legge e calpestavano le consuetudini recenti, gli accordi di piazza, la “minima decenza” di cui qualcuno avrebbe – inutilmente – parlato. Nella loro rivolta, in quel tempo di qualità inconsueta, nessuno di essi era solo, perché ogni cosa era comune, ogni calcio era dato da tutti, ogni manganellata, ogni candelotto sparato nella folla, ogni scontro in qualunque zona della città era la battaglia di tutti, con le stesse armi, contro lo stesso nemico – la “zecca”, il “comunista”, il “no global” – nel medesimo spazio simbolico. In quella rivolta dei repressori, tutto sembrava avvenire per sempre: non c’era più un domani, un giudizio futuro a cui sottoporsi, non c’erano vera tattica né tantomeno strategia, Genova era il regno dell’ora-o-mai-più, il regno dell’una-volta-per-tutte. Picchiare, calpestare facce, sbraitare inseguendo gli inermi, drogarsi – stricto & lato sensu – come se il mondo stesse per finire: ogni azione era irrevocabile e magnificamente fine a se stessa. I dimostranti non dimostravano alcunché, potevano solo subire la rivolta degli sbirri, l’interruzione del continuum in cui erano vissuti. Fine della “normalità”.
 La mattina del venti luglio, di tutto questo non sapevo ancora nulla. Ero giunto in treno a Brignole, ignaro di zone rosse o gialle, e tra ali spiegate di poliziotti e carabinieri, in una nube di voci e crepitii radiotrasmessi, mi ero incamminato verso casa di Anna, la mia fidanzata. Piombavo in città in medias res dopo un anno, un anno trascorso da prigioniero in un paese africano. Un gruppo guerrigliero mi aveva sequestrato insieme ad altri due italiani, colleghi ingegneri, per fare pressione sull’industria petrolifera che distruggeva l’ambiente e impoveriva etc. Tre o quattro volte ci avevano filmati e fotografati, nostre notizie erano giunte in patria insieme a proclami e richieste di riscatto. La mia famiglia e Anna mi avevano visto al telegiornale, lacero e sudicio, ridicolissimo col mio cartello al collo.
La mattina del venti luglio, di tutto questo non sapevo ancora nulla. Ero giunto in treno a Brignole, ignaro di zone rosse o gialle, e tra ali spiegate di poliziotti e carabinieri, in una nube di voci e crepitii radiotrasmessi, mi ero incamminato verso casa di Anna, la mia fidanzata. Piombavo in città in medias res dopo un anno, un anno trascorso da prigioniero in un paese africano. Un gruppo guerrigliero mi aveva sequestrato insieme ad altri due italiani, colleghi ingegneri, per fare pressione sull’industria petrolifera che distruggeva l’ambiente e impoveriva etc. Tre o quattro volte ci avevano filmati e fotografati, nostre notizie erano giunte in patria insieme a proclami e richieste di riscatto. La mia famiglia e Anna mi avevano visto al telegiornale, lacero e sudicio, ridicolissimo col mio cartello al collo.
Chissà come, il governo aveva ottenuto la nostra liberazione. Dal buco di culo in cui ci tenevano, fummo portati nella capitale. Ore di viaggio nel retro puzzolente di un furgone Nissan, poi ci mollarono in una periferia colorata e triste, come sacchi di rumenta, e avvisarono la polizia. Questa ci raccolse e ci torchiò a lungo, come e più dei rapitori. Detto il pochissimo che sapevamo, ci affidarono alla nostra ambasciata. Tre giorni dopo atterravamo a Ciampino.
Al nostro mesto ritorno in patria, i giornali avevano dedicato articoli blasés, poco più che trafiletti. L’attenzione era per il G8 imminente e le annunciate contestazioni. Gli sguardi convergevano su Genova, la mia città natale. Da quando i guerriglieri mi avevano liberato, non ero ancora riuscito a sentire Anna. Chiamavo il suo numero e una voce la diceva “irraggiungibile”, invitandomi a provare più tardi. Gli sms partivano, ma non ero certo che arrivassero da qualche parte. La Farnesina aveva tenuto i contatti con la mia famiglia, mai con Anna, che non mi era parente. A quanto avevo capito, un TG l’aveva intervistata una volta soltanto, nei primi giorni del mio sequestro, poi la mia promessa sposa aveva rifiutato ogni richiesta dei media. In TV era sempre andato mio fratello. Da Roma ero riuscito a parlare con mia madre, ma quando le avevo chiesto di Anna, si era messa a farfugliare. Alle mie insistenze aveva risposto in modo enigmatico: “Ma no, figurati, non è niente”. Cosa non era niente? Anche mio fratello reticeva. Perché? Anna stava male? Le era capitata una disgrazia? “Ma no, Anna sta benissimo… Non metterti in testa chissà cosa”. Mi trattavano da persona sotto shock e incapace di intendere. Anna mi aveva lasciato? Era incinta di un altro? Avevo deciso un’improvvisata. Partire senza indugi, arrivare a Genova senza dir niente a nessuno.
 Nella roulette del G8, casa di Anna era caduta sul rosso, nella zona recintata. Alte cancellate tagliavano i carrugi. Ai rari varchi, poliziotti chiedevano lasciapassare. Io avevo un aspetto ramingo, che pareva urticare i tutori dell’ordine. L’aria pesava di rischio.
Nella roulette del G8, casa di Anna era caduta sul rosso, nella zona recintata. Alte cancellate tagliavano i carrugi. Ai rari varchi, poliziotti chiedevano lasciapassare. Io avevo un aspetto ramingo, che pareva urticare i tutori dell’ordine. L’aria pesava di rischio.
Decisomi a non insistere, vagai intontito finché non mi sentii chiamare: – Ma quello là non è Kragler? Ma sì! Ohu, Andrea!
Due vecchi compagni d’infanzia e di scuola. Ai tempi del liceo giravano sempre insieme, tanto da essere soprannominati “Primo e Secondo”. Si aggiravano ai bordi della zona proibita, esploratori nella propria città. Osservavano i movimenti di truppe, ascoltavano i silenzi e le cacofonie improvvise. Aspettavano, mi dissero. – Cosa? – domandai. – Di sicuro qualcosa di brutto. – rispose Secondo. Primo si limitò ad annuire.
Passeggiammo insieme, io raccontai piuttosto in fretta della mia cattività africana, loro mi riassunsero gli ultimi eventi, le manifestazioni a Seattle, a Praga e in Québec, le tute bianche e il Black Bloc, il salire della tensione, pacchi-bomba recapitati ai carabinieri, farsesche dichiarazioni di guerra, scrittori che evocavano la morte sul web e sui giornali… Un corso intensivo, full immersion, e mi accorsi che non pensavo più ad Anna. Fu proprio così, dal pensiero di un vuoto, che Anna mi tornò in mente. Non ne avevo ancora fatto cenno con Primo e Secondo, e la domanda partì da sola: – Sapete qualcosa di Anna, la mia fidanzata? Non sono ancora riuscito a sentirla…
Imbarazzata triangolazione di occhiate.
Intanto, non so nemmeno come, avevamo raggiunto Piazza Manin. Ero in fondo al dirupo e non lo sapevo. Oltre il ciglio cominciava la mia nuova vita, tutto quel che ero stato prendeva congedo da me. Di lì a poco, la piazza si sarebbe riempita di urla, di sangue, di carne pestata, di cocci di vetro. La fuga stava per separarmi dai vecchi compagni d’infanzia, che non avrei rivisto più. Quel pomeriggio conobbi Furio, l’egittologo torinese. Fu il nostro primo e unico incontro, durante l’anabasi, nel cuore della rivolta. Di lui non ho più saputo nulla, svanì poco prima che giungessi in Piazza Alimonda. Mi girai per interpellarlo e all’improvviso non c’era più, risucchiato in un’altra dimensione. Forse, chissà, non è proprio mai esistito. Forse è stato allucinazione, miraggio, “amico immaginario”. L’ho inventato per non sentirmi troppo solo? Eppure, nelle pause della fuga, quel ragazzo barbuto mi raccontò storie vere. Mi indicò, uno per uno, i fantasmi che marciavano in quelle strade. Mi spiegò in quale trappola fossero caduti i dimostranti, e come si era giunti a quel punto. Soltanto grazie a lui, al termine di quel venti di luglio, potei riconoscere la macchina; e quando la riconobbi, il motivo che mi aveva ricondotto in città era ormai spento, remoto come il fischio di un treno di cent’anni fa, ricacciato nel niente. Anna non era più importante. Ma forse dovrei procedere per ordine. Dunque, quando arrivammo in Piazza Manin, una foresta di braccia alzate…
Wu Ming 1 ed Enrico Manera presenteranno il numero di Riga su Furio Jesi venerdì 18 febbraio 2010, h. 21, al Modo Infoshop, via Mascarella 24/b, Bologna.
“A chi è rivolta?” – Articolo di Marco Belpoliti uscito su La Stampa il 15 dicembre 2010
Leonardo Tondelli, “Passa la storia, fai ciao con la manina”, leonardo.blogspot.com, 2007
Anthropologie du présent, il blog di Alain Bertho, studioso delle rivolte metropolitane
Pierandrea Amato, La rivolta, Cronopio, Napoli 2010

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Il discorso dello scontro sociale è attuale oggi più che mai. Ne parla anche Loredana Lipperini: http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/
Anche quei pochi giornali che ancora si guardano attorno. Un grave, gravissimo problema del nostro paese è legato alla rappresentanza: in Italia una buona fetta di società non è rappresentata in Parlamento e alcuni temi sono usciti dall’agenda politica: lavoro, tutela dei diritti, assistenza, scuola di qualità. Quando non ci si sente rappresentati è naturale cercare di far sentire la propria voce manifestando. Che poi la polizia agisca difformemente dal lecito non è una novità. Tra i pensierini per il nuovo anno, visto che si fa un gran parlare di elezioni anticipate, ci metterei il ritorno in Parlamento di una certa sinistra, seria stavolta, che riproponga i temi passati in dimenticatoio e riprenda un minimo di dialogo attivo.
Non ti si può che dare ragione su più punti. Ma spero tanto che la soluzione a questo momento non sia tutta parlamentare e, soprattutto, che si possa continuare a manifestare anche quando una certa sinistra sarà rappresentata.
Altrimenti siamo bloccati, secondo me.
La rivolta in questo momento è un fenomeno europeo, non italiano. Anzi, noi ci siamo arrivati più tardi di altri paesi.
E la sinistra ufficiale è annaspante e smarrita in tutto il continente, non solo in Italia.
Il problema che poniamo nel post, e che io pongo in forma letteraria nel racconto, è proprio questo: di fronte alla rivolta, cerchiamo di essere il meno possibile autoreferenziali. Cerchiamo di moltiplicare le angolature, di “uscire da noi stessi”. Rovesciamo le prospettive.
Se vogliamo, è sempre – rideclinata in un altro modo – la questione dello “sguardo obliquo” e della simulazione di un punto di vista “ecocentrico” di cui parlavo nel memorandum sul NIE.
Quando Leonardo dice che il G8 di Genova fu una manifestazione non nostra, bensì dei poliziotti, esce esplicitamente dall’autoreferenzialità e forse contribuisce a “stappare” il rapporto con la memoria di quegli eventi.
Analogamente, se noi guardiamo alla rivolta come a un fenomeno europeo, usciamo dall’autoreferenzialità italiana e forse ci raccapezziamo meglio.
Attenzione, dunque, a ridurre il problema al fatto che la miserevole sinistra italiana non è più rappresentata in parlamento. Così rimaniamo in un’autoreferenzialità (noi di sinistra) dentro un’autoreferenzialità più grande (l’Italia rappresentata a Roma). E’ la stessa impostazione alla base della metafora dell’Assedio: il potere è nel Palazzo, le cose si decidono a Roma etc.
Ma i tagli al welfare, le risposte padronali alla crisi etc., tutto questo *non* viene deciso davvero a Roma, ma a livello europeo, sovranazionale.
E la rivolta è una risposta, diretta o indiretta, alle politiche di Bruxelles.
Di recente, ha riassunto la questione in modo molto chiaro e sintetico Bifo, che quando si mette d’impegno sa ancora essere un osservatore lucido e un polemista incisivo:
http://www.alfabeta2.it/2010/12/18/cominciamo-a-parlare-del-collasso-europeo/
cari tutti,
d’accordo sulla necessità di aprire lo sguardo e andare oltre la farsesca rappresentazione violenza si/no che abbiamo visto nelle settimane precedenti,
apro anche un altro fronte di discussione, proprio a partire da Jesi, di cui sintetizzo in proposizioni elementari alcune considerazione di ordine pratico che dal suo ‘scrigno’ emergono.
La dimensione politica non può esistere senza un certo livello di ‘mitologia’, che indica gli obiettivi e sostiene l’azione di cambiamento sociale;
ma un eccesso di ‘mitologia’ spinge a fare gesti azzardati, prematuri o e realizza i peggiori sospetti dei controrivoluzionari i quali dunque reagiscono con la repressione. ieri come oggi.
Si chiedeva Jesi già nel 1965:
come fare dunque a mobilitare le persone in nome di un ideale e al tempo stesso mantenere razionalità e senso critico?
è possibile far appello all’emozione che il mito politico genera senza che questa diventi o appello ai sentimenti irrazionali cari al nazionalismo e al fascismo o semplice fascino estetizzante, simbolo carico di fascino ma privo di contenuti?
Per Jesi, il cui punto di riferimento era in Luxembourg, il primo Brecht e Benjamin, i marxisti dovrebbero essere più sognatori e gli anarchici più realisti,
c’era in lui qualcosa che mi ha sempre colpito e che riguarda non tanto la critica della stigmatizzazione della violenza da parte dei penbensanti (Jesi aveva parole durissime contro la grande stampa liberale) ma la critica della sua parte, la nostra, nella quale intravvedeva il rischio che Che Guevara diventasse brand sulla maglietta per intenderci e con lui tutto l’apparato rituale della battaglia/sconfitta/martirio/sacrificio fondazionale
Tutto questo si avvita e complica la situazione, perché sopra il legittimo impulso di ribellarsi e l’elementare sentimento di giustizia, quella che vibra anche nel più piccolo gesto di rivolta, c’è il rischio dell’estetizzazione della politica.
mi è tornato in mente questo video oramai datato dei chemical brothers, che mi sembra una splendida allegoria dei rischi della macchina mitologica, intendo dire la mitologizzazione della rivolta fine a se stessa che diventa adesione al fascino del mito-immagine
(da guardare fino in fondo, almeno fino al momento catartico fiction/realtà)
http://www.youtube.com/watch?v=6sOpbRL8R4g
la questione è come diceva Jesi demitologizzare, ovvero sfrondare la tecnicizzazione del mito conservando il
il nocciolo duro del mito, quello che è immagine vivente e pulsante della realtà senza cui non ci sarebbe neanche la possibilità di pensare e senza cui non c’è un passo avanti nelle scelte personali e collettive.
In altri termini, credo che l’inconscio ribelle vada ascoltato e incanalato nel principio-realtà e soprattutto in un progetto collettivo.
per un ulteriore approccio a Spartakus:
http://www.rigabooks.it/index.php?idlanguage=1&zone=9&id=853
poi cliccare su extra e su Spartakus pensare la rivolta
e ovviamente il forum precedente
un buon 2011 a tutti
arrigo
Certo, non possiamo fermarci alle miserie della nostra “sinistra” italiana e non comprendere come il cuore di questa famosa “crisi” stia tutto nei meccanismi dell’Europa di Maastricht, Lisbona e Bruxelles, ma anche nel Wto, nel Fmi nella Banca Mondiale…Insomma di tutte quelle istituzioni che avevamo preso di mira (mi si passi il termine volutamente ambiguo e sbrigativo) nei giorni del luglio 2001.
Ma se negli ultimi dieci anni le istituzioni economiche internazionali si sono solo leggermente de-europeizzate in favore delle economie emergenti (il G8 che diventa G20, e nemmeno perde la sua peculiarità di essere un consesso di Stati che si riunisce per non decidere niente!), senza mettere in discussione il liberismo delle loro politiche neanche dopo la crisi del 2008, cosa possiamo fare se non continuare ad aggrapparci ai vecchi Stati, e quindi ai governi e ai parlamenti “liberamente eletti”, dove personaggi sempre più biechi vengono quantomeno chiamati a decidere se aumentare o tagliare i finanziamenti alla Cultura, all’Università o alle pensioni?
E appunto, proprio nei parlamenti e nei governi ovviamente o non ci siamo o perdiamo (in Francia con le pensioni, in UK con le tasse universitarie etc etc etc).
Oltre a connettere le lotte in Europa, bisognerebbe porsi il problema, per dirla con Gramsci, dell’Ordine nuovo. Che non è certo l’ordine della polizia, ma è qualcosa che riesce a condizionare o addirittura a spazzare via il marciume che ci sta trascinando nel baratro.
Ciao e buon 2011!
@ pallinov,
la questione è il “come”, chiaramente. Secondo me si stanno sbrogliando dei nodi, ma il processo è lungo e contrastato. Individuo questi problemi:
1) abbiamo visto che “fare pressione” sui suddetti personaggi biechi è, in questa fase, impossibile, perché
a) vivono in un’altra dimensione, in una bolla, completamente sganciati dal corpo sociale e dalla realtà che tutti noi esperiamo;
b) sono poco più che passacarte di pratiche avviate altrove.
2) abbiamo visto che la via del convergere su Roma per fare pressione sul Palazzo (“assediare i palazzi del potere”), almeno in questa fase, non paga. Non porta risultati e quindi genera frustrazione, non assedia nessuno, e la cornice angusta
a) impoverisce le forme, imponendo la Dinamica Unica della “jacquerie”;
b) devia il messaggio, costringendo a discutere di violenza e non-violenza anziché dei motivi per cui si sta lottando.
[Per fortuna il movimento studentesco è stato bravo, dopo il 14 dicembre, a ri-diversificare le forme di lotta.]
“Roma”, poi, è un buco nero che inghiotte le voci e le energie. Solo strutture con basi solide riescono a reggere la Grande Scadenza Nazionale e a far passare un messaggio (vedi la FIOM nell’ottobre scorso).
Invece abbiamo visto che alcune lotte ec-centriche rispetto al Palazzo, lotte sul territorio, quando toccano articolazioni strategiche e decidono di “insistere su un punto”, di tenere fermo quel punto costi quel che costi, riescono quantomeno a tenere in scacco poteri anche forti, fortissimi, a rallentare i loro piani, e spesso vanno anche più in là, riuscendo a mettere i propri temi sull’agenda nazionale. E anche il movimento studentesco ha mostrato il massimo della forza non il 14 dicembre, ma nelle giornate del “blocchiamo tutto”, dell’occupazione dei monumenti, delle mille forme coesistenti.
Noi siamo il paese delle “cento città”, delle migliaia di campanili, delle decine di sostrati linguistici che continuano a “scompigliare” l’idioma nazionale, delle tante tradizioni. C’è stata molta omologazione negli ultimi decenni, ma l’Italia rimane un paese policentrico. A me sembra che nella nostra storia funzionino più a lungo (nel senso che non perdono energia e specificità) i fenomeni che riescono a interpretare questa policentricità e a fornirne una sintesi. Invece perdono ben presto energia e specificità i fenomeni che si “accentrano” subito.
E’ chiaro che essere policentrici non basta. A queste lotte manca quella che Marx chiamava una “forza materiale”, manca l’organizzazione, non c’è un coordinamento forte. Ed è altrettanto vero che manca la politica (in tutti i sensi) e lo spazio che ha lasciato vuoto viene riempito da “surrogati” (vari populismi, complottismi, culti carismatici para-politici), ai cui canti di sirena i movimenti spesso non sanno resistere. Basti vedere quanto ottundimento e spreco d’energie abbia prodotto un pluriennale discorso unicamente incentrato sull’antiberlusconismo… O i danni che l’antipolitica qualunquistica/forcaiola ha causato al cervello sociale.
C’è tutta una serie di acrobazie da fare, per trovare il bandolo della matassa (l’Ordine Nuovo, se vogliamo riprenderci quest’espressione gramsciana poi scippata dai neofascisti): coordinarsi e organizzarsi senza precipitarsi lungo vie “obbligate” e stra-percorse; stare sul territorio senza diventare “parrocchiali”…
Ecco il link preciso al testo su Spartakus indicato da Arrigo Malera (nonché scritto dal suo alter ego :))
http://www.rigabooks.it/extra.php?idlanguage=1&id=853&idextra=861
Spesso nei dibattiti televisivi e in quelli sul web – per ragioni opposte – si perdono le elementarità di base.
Un ABC – firmato Blissett – sulla questione della violenza è apparso su Global Project pochi giorni fa (ve lo segnalo):
http://www.globalproject.info/it/community/Pacifica-difesa-della-violenza/6979
[…] obliquo” e inquadrare l’Italia nei più ampi contesti, europeo e mondiale ( Pensando alle rivolte del 2011: Tamburi a Genova (nell’anno del decennale) | Giap, la stanza dei…. Particolarmente interessante, come spesso accade, la discussione che si sviluppa e si amplia nei […]
@ Wu Ming 1,
completamente d’accordo. Diciamo allora, senza affidarci alla speranza (che come ci ha ricordato Monicelli, è sempre una trappola), che il nostro auspicio per il nuovo anno è un rinnovato impegno creativo alla ricerca di nuove e sempre più efficaci connessioni tra le lotte.
Post interessantissimo, complimenti a tutti.
Io credo che il problema del mito e della narrazione sia, in parte, un problema di mancanza di memoria e di autocoscienza. Ultimamente, a proposito della manifestazione di Roma del 14, m’è capitato di sentire parole che rendevano un luogo del dissenso studentesco assai più simile a una caserma che non a uno spazio in via di liberazione. Ora mi sembra che si sia riusciti a prendere un’altra via ed è una cosa che mi rincuora.
Ma quando quelle parole sono state dette, i molti che avevano parlato non erano riusciti a sentirne la puzza, a percepire quanto fossero pregne di tutti gli orrori che avevano accompagnato e giustificato. Ci vogliono memoria e coscienza di ciò che la storia ha fatto di noi.
Alcuni interrogativi mi assalgono ogni qual volta si parla di Rivoluzione.
1) è possibile concettualizzare “modalità altre” atte alla destrutturazione degli effetti “mortiferi”di senso prodotti dalla biopolitica al di là di quelle reificate dalle epiche narrazioni degli accadimenti del 1789, 1848, 1917…?
2) E, soprattutto: siamo sicuri, per citare Foucault, che “la conquista del Palazzo d’Inverno” sia “all’altezza” di un “insieme-mondo” ibernato nelle relazioni semantiche del bio-potere?
Per chi lo desiderasse invito alla lettura di quest’articolo:
http://haecceitasweb.com/2011/01/04/biopolitica-evento-e-rivoluzione/
@ sentieri erranti
per chiarire: questo è un post sulla rivolta, non sulla rivoluzione (men che meno sulla Rivoluzione), basato sul lavoro di teorici che ne hanno fatto addirittura due concetti antitetici (e su più piani). Ed è un post descrittivo, non prescrittivo.
Dopodiché: grazie per il link, però il tuo commento, di per sé, non è molto comprensibile, per favore sii meno criptico, meno ipse-dixit, meno ci-siamo-già-capiti. Su questo blog non basta menzionarlo, Foucault, e usare la parola “biopolitica”. Ci si sforza anche di sciogliere i concetti. Non è un blog specialistico per filosofi, ma un luogo dove si incontrano persone con formazioni ed esperienze diverse.
Provo a chiarirmi.
Il commento vuol soltanto provare a problematizzare, senza alcun intento polemico (avrebbe poco senso), la difficoltà nel pensare la “Rivoluzione” (credo che nel Vostro interessante articolo ci si riferisca al suo concetto, non a quello di “rivolta” che rimanda invece, come ricordava Alberto Tenenti, ad una semantica pre-moderna) nell’epoca della “politica della vita”.
Se il “dato biologico”, e quindi l’universo di senso che ne deriva, è già da sempre catturato da “relazioni di potere” che hanno come fine il “plasmare soggetti utili alla ratio economica”, non ne consegue la necessità di pensare a delle”contro-condotte” all’altezza di questa situazione? E queste non devono riguardare soprattutto l’elaborazione di “nuovi” linguaggi-senso?
Da qui la necessità, anche a costo di “balbettare con linguaggio criptico”, di ri-pensare il concetto di “Rivoluzione”, le sue modalità attuative, le sue possibilità, il suo ruolo, correndo il rischio impopolare di affermare che oggi “la possibilità e il carattere della Rivoluzione sono cambiati” (Tilly) e che, magari, non abbiamo bisogno di una Rivoluzione (almeno non secondo il modello conosciuto durante l’età moderna).
Siamo immersi in un problema di “reificazione del senso”, per questo ritengo utile provare a:
1) “raschiare”, anche a sviscerare (come dite Voi), i “concetti-strumenti” che disegnano il “mondo che viviamo”, magari mettendoli addirittura in discussione (in questo caso quello di Rivoluzione) .
2) elaborare “nuovi linguaggi-senso” e contro-condotte “utili” per disarticolare la”presa invalidante” della politica che si fa carico dell’esistente. MI sembra interessante l’idea di Agamben di una biopolitica minore. Perchè non provare a concettualizzare secondo queste “linee di fuga”, meno visibili certo, il concetto di “Rivoluzione” oggi necessario?
Con stima.
@ sentieri erranti
se vuoi dire (provo a tradurre) che oggi la rivoluzione non può più consistere nella presa di un Palazzo d’Inverno perché la natura del potere è decentrata, diffusa, reticolare, biopolitica, transnazionale e trans-tutto, mi sembra un’acquisizione per nulla nuova, anche se repetita iuvant. E’ una necessità che sento affermata da quand’ero ragazzo.
Detto ciò, di Evento e Rivoluzione abbiamo parlato varie volte (non solo su questo blog: si può dire che è il tema conduttore di tutti i nostri romanzi collettivi), ma in questo post, te lo ribadisco, stiamo *davvero* parlando di rivolta, nel senso di riot, jacquerie urbana, sommossa, improvviso raduno di casseurs. Non di rivoluzione, che è un’altra cosa. La rivolta è un tema su cui si stanno interrogando in tanti, e non appartiene affatto esclusivamente a una semantica “pre-moderna”: oggi il riot è quanto di più contemporaneo possa darsi. Tant’è che ne scoppiano in continuazione nelle metropoli più avanzate.
Innanzitutto, grazie per l’opera di “traduzione”…
Mi risulta difficile da comprendere soltanto il tono “infastidito”, vista la mia vena non polemica, comunque…
1-Se parlo di “Rivoluzione” lo faccio , senza nessun intento polemico (lo ripeto), soltanto per situare il discorso all’interno di un preciso “ordine significante” ed evitare quelle “vaghezze discorsive” che inficiano simili discussioni.
2-Se parlo di “rivoluzione” non lo faccio per “sanzionare” un altrui uso scorretto del concetto (ho detto che non mi interessa) ma per cercare di mostrare, implicitamente e facendo leva sull’intelligenza ermeneutica di chi legge, che i concetti non sono degli “universali” (ma questo so che Voi lo sapete), cercando di attenermi ad una ad una semantica ben precisa, nella fattispecie quella di Alberto Tenenti (si rifà a Braudel) che divide le “rivolte” dalle “rivoluzioni” (ma questo Voi lo saprete benissimo).
Detto ciò, per quanto criptico (ma credo di aver tra le righe indicato le ragioni di ciò: è il linguaggio che deve essere forzato se si vogliono produrre nuovi “effetti di senso”) il mio intervento, che non aveva pretese di novità (in un orizzonte di senso reificato, quale quello della biopolitica, il “nuovo” è proprio ciò che risulta per definizione “mancante”…) voleva soltanto “indicare” una problematica: la necessità di ri-pensare il concetto di “Rivoluzione”.
So benissimo che il tema è stato da Voi varie volte sviscerato (anche in ambito seminariale ) ma non capisco perchè leggere quanto da me detto assumendo una posizione di “sufficienza infastidita”: chi ha mai voluto dire che l’argomento “non è (stato) il tema conduttore di tanti vostri-piacevoli-romanzi?
Sarà banale quanto si vuole ma io volevo soltanto indicare una prospettiva che mi sembra “mancante” in questi discorsi: qual è la “Rivoluzione” adatta all’epoca della “politica della vita”?
E’, dal mio punto di vista, un problema di “trascendentali” non di declinazioni “attuali” (per tirare in ballo Deleuze).
Con stima immutata.
Guarda che non ci stiamo proprio capendo, chi ha detto che il tuo intento fosse polemico? Io ti segnalavo la scarsa pertinenza del tuo intervento con il focus di questo specifico post. Il modo in cui lo hai agganciato mi è parso labile. Qui di rivoluzione non si stava proprio parlando. E segnalavo anche un eccesso di gergalità accademica. Tutto qui. Il tuo mi sembra un eccesso di reazione, su.
Voglio dire, avrei capito di più se ti fossi agganciato alla discussione su Foucault in Iran, non a questa, È chiaro che tutto si collega a tutto, ma di volta in volta si rende necessario mantenere un focus. Dixi, poi vedi tu.
“Normali” incomprensioni discorsive che non mutano i “miei” riconoscimenti nei confronti del “vostro” lavoro e la stima nutrita.
A presto.
[…] Punti di vista Genova dovremmo iniziare a raccontarcela in un modo diverso […] Il nostro racconto pecca del solito vecchio peccato: l’autoreferenzialità. Siccome a Genova c’eravamo anche noi, riteniamo giusto raccontarlo dal nostro punto di vista […] È tempo di ammetterlo: noi non siamo i protagonisti di Genova. Un livido, una cicatrice, un bello spavento, non ha fatto di noi i protagonisti […] Genova avrebbe dovuto essere la nostra manifestazione, ma non lo è stata. …]
Post interessantissimo, a tratti incomprensibile (e ho anche una laurea triennale in filosofia! che vergogna).
Un appunto: la biopolitica è un concetto affascinante, e pur reputandomi un buon lettore di Foucault, ho l’impressione che ultimamente sia una supercazzola filosofica, poco indagata e poco discussa, ma molto, molto citata (penso a Bauman, per esempio).
Ma qui si stava parlando di rivolta, riot. Avevo già letto il racconto su Riga, ed è davvero molto spiazzante. Io al riot dei poliziotti non ci avevo mai pensato.
Però ho delle riflessioni in testa sul concetto di rivolta, legate anche alla lettura di due libri di Giuseppe Genna, “Italia De Profundis” e “Assalto a un tempo devastato e vile”. Sull’opportunità di avvicinarmi alla politica in forma molecolare, mi sembra che una delle intuizioni del primo testo sia la rivolta del vecchio contro il tempo, e la solo conseguente apparenza del giovane che si rivolta alla vecchia società italiana. Viviamo in una delle società fra le più ottuagenarie del mondo per motivi a volte molto antichi: l’Italia è un coacervo incredibile di geni, mezzo mondo antico ha sparso seme e uova nelle nostre regioni a lungo, e l’altra metà lo ha fatto rapsodicamente in modo anche violento, fino a pochissimo tempo fa.
Questo porta a una resilienza delle persone in età senile piuttosto invidiabile per altre comunità i cui geni siano meno misti (alla faccia dei leghisti, tiè!). Tuttavia queste persone sono cresciute durante un periodo in cui il tempo libero era una cosa nuova, non vissuta dai propri genitori, ma da loro data per scontata.
Questo significa molti cinquantenni cresciuti nel mito del giovane, che non è sempre esistito: Jon Savage ne parla come di una invenzione, in “L’invenzione dei giovani”.
Qualche post fa parlavate del tabù della vecchiaia, che io vorrei qui riproporre: la rivolta contro il tempo della società che rifiuta la vecchiaia non è collegata strettamente alle richieste di una parte consistente dei “giovani” (dai 18 ai 40 anni!)che strilla il diritto di essere adulti?
La vera rivolta sembra essere davvero quella contro il tempo che passa, e che come intuito da Genna, l’Italia appare come al solito l’avanposto in cui scoprire, ancora una volta, cosa succederà a breve nel resto del mondo. Da questo punto di vista sembriamo un eterno laboratorio sociale. In questo senso, la rivolta (non la rivoluzione) sembra essere la cartina al tornasole del presente che non si infutura mai. Forget domani.
http://www.youtube.com/watch?v=ntbdIbleElE
@ Giorgio1983
“Post interessantissimo, a tratti incomprensibile”
Hai scritto “il post” ma intendevi alcuni dei commenti sotto, mi pare di capire. Perché a noi il post sembrava sì denso, ma non criptico. Comunque, colgo la palla al balzo per ricapitolare, ché non fa mai male:
– si parla solo della violenza dei rivoltosi e non di quella dell’economia o dei poteri costituiti;
– questo per motivi di ipocrisia, ma anche perchè la rivolta, scoppiando, ci attira, e ci attira perché ci rivela qualcosa su di noi;
– eppure, quel che succede *durante* una rivolta, nella psiche di chi vi partecipa, è in parte un mistero, che tutti i discorsi ex post, nel migliore dei casi, riescono appena a lambire;
– la rivolta ha una sua *specificità*, un particolare rapporto con il tempo; questa cosa l’ha indagata Furio Jesi. Secondo lui il modo che ha il rivoltoso di vivere il momento, il qui-e-ora, è ciò che distingue la rivolta dalla rivoluzione, che invece è progettuale e vuole costruire il domani;
– a questo punto si rovescia la prospettiva: ecco l’aggancio al racconto sul G8, basato sulla suggestione di Leonardo che a Genova vi sia stata sì una dimostrazione, ma fascista; la mia “precisazione” è che a Genova vi sia stata una rivolta, ma di sbirri. Un riot delle forze dell’ordine. Il particolare “spiazzamento” (sacrilego ma a fin di bene!) che ho provato a fare nel racconto è di descrivere la repressione genovese con le frasi che Jesi utilizzava per descrivere in generale la rivolta, e nello specifico la rivolta spartachista del 1919.
Ora: il *tuo* ulteriore rovesciamento mi sembra molto interessante, ne prendo un elemento e lo evidenzio: se la rivolta è (anche) l’apoteosi del qui-e-ora, può essere definita (metaforicamente) una rivolta anche il rifiuto dell’invecchiamento. C’è un “riot” culturale in corso. E anche questo, in fondo, è un riot di sbirri, perché sono sbirri quelli che impongono il modello unico omologante, la “Falsa Bellezza” (come la chiama Ariemma nel suo pamphlet filosofico sulla chirurgia estetica).
Molto interessante e suggestivo.
Ovviamente, la accolgo come una metafora, con dei limiti. Perché una caratteristica basilare della rivolta (quella vera) è la volontà di aggredire i “mostri”, i simboli orrendi del potere. La guerra contro la vecchiaia è invece una rivolta di mostri, fatta dai mostri.
@ Wu Ming 1,
Ragionissima, mi riferivo ai commenti. :D
Il post è molto chiaro!
Ovviamente la metafora ha dei limiti evidenti, e gioca sul filo di quell’ordine scompigliato di cui riesce a puzzare ogni passo in una “piazza” di destra, che è una ogni volta una rivolta contro se stessi, e quindi soltanto una messa in scena: l’ordine di chi comanda sovvertito dall’ordine di chi comanda? con altre immagini: un pidocchio che fa le pulci, un ammasso di tardi gattopardi dinamitardi (sono volutamente brutte, puoi storcere il naso, tranquillo!).
Sulla bellezza, non ci si muove in linee diverse, solo più sfuggenti: la rivolta di mostri fatta da mostri è fatta quasi sempre dagli stessi di qui sopra, ed è per quello che i due discorsi assieme non stridono, e mai come ora l’estetica rientra nella politica. Urge riflessione, altrimenti non si capirà mai la connessione balorda di nani e ballerine, avvenuta soltanto prima qui che altrove.
@Giorgio1983
Sul concetto di “biopolitica” mi trovi per certi versi d’accordo: è abusato e, come molta della “terminologia” utilizzata nei dibattiti, soffre di una certa “vaghezza concettuale”. Bisogna “perimetrarlo”, contestualizzarlo, per questo ho indicato un articolo in cui cerco di mostrare la “mia” prospettiva.
Foucault, nei suoi “corsi” ha soltanto “presentato” il concetto, non lo ha mai definito, lasciandolo sospeso tra gli estremi sviluppati rispettivamente da Agamben e Toni Negri (banalizzando: tanatopolitica Vs vitalismo affermativo).
Detto questo, il concetto di “biopolitica” rimanda ad una problematica dal mio punto di vista inaggirabile: la “situazionalità” del nostro agire politico, sempre in ultima istanza “catturato” in dispositivi di “sapere-potere”.
L’interrogativo è: quanto siamo liberi di ri-disegnare il “vivere in comunità”?
Detto ciò mi sembra che “in giro” ci sia una certa “fatica discorsiva”, i termini vengono utilizzati come “loghi” (un pò come le “faccine degli sms:buoni per tutti gli usi) e, come afferma R.Ronchi, ciò facilità una “reificazione” del linguaggio politico (il problema è sempre quello).
E’ ciò che ho cercato di indicare nei commenti sopra. Ciò di cui si sente il bisogno (ma qui non sto ad affermare alcuna novità) è una rinnovata educazione alla “fatica concettuale”, quella disposizione necessaria alla “produzione dei mondi im-possibili”.
Deleuze diceva che “siamo catturati” in “vincoli semantici” che rendono illusorio il “trascendentale-libertà”. Ecco:forzare il linguaggio, non aver paura di “una certa cripticità” è, secondo me, una condizione (Logos declinato in Ethos per tornare a Foucault) per cercare di dis-articolare, rivoluzionare, i “dispositivi linguistici” attraverso i quali il potere oggi ci “cattura”.
@ sentieri erranti,
il problema è che, scrivendo in questo modo involuto e citazionistico, nonché facendo tutto questo “name-dropping filosofico” (non ce l’ho con te, è una cosa che ho già rimproverato ad altri), non dis-articoli i dispositivi linguistici: dis-articoli l’attenzione e la pazienza degli interlocutori.
Suvvìa, un maggiore sforzo di chiarezza. Questo è un blog dove ci si sforza di *divulgare*. Che è cosa MOLTO DIVERSA dal banalizzare, e di cui non bisogna avere paura.
Nessun problema. MI è abbastanza chiaro quanto già “segnalatomi” nei precedenti commenti .
Quella sopra era soltanto una risposta a Giorgio 1983 che, dal mio punto di vista, l’aveva sollecitata.
Per il resto, credo che gli “interlocutori con poca pazienza” possano semplicemente “guardare e passare avanti”.
Mi spiace soltanto constatare una certa svalutazione di quello che individui quale “name-dropping filosofico”. Per me è soltanto “sforzo di chiarezza discorsiva” (chiamiamolo uno “sciogliere i concetti”…) .
Che poi questo sforzo possa risultare “criptico”… è tutta un’altra storia.
A presto.
Detto questo, il concetto di “biopolitica” rimanda ad una problematica dal mio punto di vista inaggirabile: la “situazionalità” del nostro agire politico, sempre in ultima istanza “catturato” in dispositivi di “sapere-potere”.
L’interrogativo è: quanto siamo liberi di ri-disegnare il “vivere in comunità”?
Scusa, ma io di questa frase non capisco nulla, e mi sono laureato in filosofia, giuro. Cosa caspita è la situazionalità? e il dispositivo di sapere-potere? Non ha senso fare un post tutto virgolettato, senza spiegare proprio il virgolettato. Il name-dropping filosofico è un modo carino per dire che getti un sacco di fumo negli occhi. E io non richiamo all’ordine perché poi gli altri non capiscono, alla fine il blog non è mica mio. Io non capisco solo granché, e magari sotto quel metro di citazioni hai di sicuro da dire qualcosa, però ancora bene non ho capito cosa tu voglia dire. Il fatto è che se vuoi sciogliere i concetti, tocca fare un sacco di stretching!
problemi con il copia&incolla, oggi:
@ Wu Ming 1,
che ne dici del legame estetica-politica? è così azzardato? è roba che non si deve toccare? Sono curioso, mi sembra che possano legarsi, anche nei modi che ho (tentato) di spiegare.
Mi sembra che in questo frangente siano molto collegate, anche dal punto di vista letterario: l’estetica (seppur si possa parlare di estetica di una nebulosa) di quello che tu hai definito NIE, per esempio, confligge con l’estetica di molta altra fiction uscita nello stesso periodo, magari scritta dagli stessi autori. Prendo una cantonata clamorosa?
Non ti preoccupare, Giorgio, a richiamare all’ordine ci penso io.
‘scolta me, Joe Sentieri:
io non li sopporto, quelli che elencano gli ingredienti ma non cucinano la pietanza.
Una frase come:
«Foucault, nei suoi “corsi” ha soltanto “presentato” il concetto, non lo ha mai definito, lasciandolo sospeso tra gli estremi sviluppati rispettivamente da Agamben e Toni Negri (banalizzando: tanatopolitica Vs vitalismo affermativo).»
io magari riesco a “scioglierla”, perché ho letto (molto) Foucault, ho letto (troppo) Negri e ho letto (un po’ di) Agamben, ma ciò non toglie che questo sia name-dropping, e della peggiore specie. Che è precisamente l’opposto dello “sciogliere i concetti”.
“Sciogliere i concetti” significa, come è accaduto in questo thread, nominare Furio Jesi ricapitolando (entro certi limiti, ovviamente) cosa diceva, spiegando perché tra i tanti pensatori si nomina proprio lui, e magari fornendo dei link esplicativi. Cioè quello che ha fatto Manera pochi commenti più sopra.
Tu invece hai linkato un tuo articolo attaccandolo a questo thread con la sputazza, hai lasciato commenti grevi di cognomi (Tenenti, Ronchi, Foucault, Deleuze, Agamben, Negri, Tilly e Braudel) e irti di virgolette, e quando ti si è fatto notare che non si capiva niente, cos’hai risposto?
Hai risposto, in pratica, che te ne fotti.
L’esortazione a “guardare e passare avanti” (in parole povere: se non capiscono, cazzi loro) qui da noi non è gradita. Parrà strano, ma qui è in voga il rispetto per chi legge.
Ragion per cui, se vuoi per forza fare il criptico, vedi di farlo da un’altra parte.
Niente di personale, sia chiaro! Anzi, guarda, ti faccio un bel regalo.
HOW TO WRITE LIKE AGAMBEN
http://leniency.blogspot.com/2008/12/how-to-write-like-agamben.html
@ Giorgio1983,
su due piedi, non saprei bene cosa risponderti. Intanto lascio saltellare la pulce nell’orecchio.
@Wu Ming 1
Evidentemente non ci comprendiamo. Ma è un problema mio, sicuramente. “Un paio di cose” soltanto a titolo conclusivo”, le chiacchiere sterili annoiano tutti.
Premetto una banalità: intervenendo in uno “spazio” non mio accetto implicitamente di “rispettare”la linea di chi lo amministra . Sarebbe contraddittorio il metterla in discussione. Diversamente ne sarei rimasto fuori.
1) Detto ciò, non mi sogno minimamente di voler mancare di rispetto a chi legge nè di voler far intendere:” che se non capiscono, cazzi loro”. Diciamo che questa è una sovra-interpretazione “forzata” di ciò che volevo dire.
Ritengo soltanto che, vista la specificità degli argomenti, magari non tutti hanno nel bagaglio gli strumenti per cogliere referenze e nessi (come io non li ho di infiniti altri argomenti). Cerco di essere chiaro:magari il discorso risulta scontato a chi “sa” di cosa si sta parlando. Gli altri, che legittimamente potrebbero annoiarsi, possono”guardare e passano avanti”. Non per questo si vuol mancare loro di rispetto…
Se tu (permettimi la declinazione colloquiale, è una libertà che mi prendo nell’ottica della “democrazia del web”) non hai avuto problemi a “sciogliere il senso” di quanto affermavo, perchè dovrei partire dall’assunto che il problema dovrebbero averlo gli altri? Sono più stupidi?
2) Parliamoci chiaro. Il commento da me fatto, fuori contesto quanto si vuole, risulta chiaro, e addirittura banale (perchè di questo si tratta), a chiunque abbia “veramente” letto anche soltanto qualche pagina di Foucault, DeleuzeLacan, etc. E, visto che gli autori sono qua e là citati, non capisco perchè non dare per sontato che si sappia di cosa si sta “discutendo”. Diverso è , come dici tu, riempirsi la bocca con i nomi di tali autori salvo poi dimostrare di conoscerli soltanto “di seconda mano”, non condividendo di fatto le “procedure discorsive” dagli stessi autori adottate (Foucault, che stiamo utilizzando, dice nè più nè meno le stesse cose nelle ultime pagine della “bella”intervista fattagli da Duccio Trombadori). Ma io questo non lo do per assunto…
3) Ho imparato durante i miei studi (Agamben, da te consigliatomi, mi sembra dica la stessa cosa nella premessa di “signatura rerum”) che l’unico modo di “utilizzare” in modo non riduttivo, nè banale, i concetti è quello di cercare di situarli all’interno dell’ordine discorsivo prodotto dagli autori cui i concetti rimandano. Diversamente, il rischio è un “minestrone” di ovvietà che, mi sembra, è ciò da cui tutti cerchiamo di emanciparci. Per favore, non mi si dica che non ci siamo capiti: un concetto ha senso soltanto se lo utilizziamo secondo prospettive determinate (quello degli autori che ne hanno fatto uso…). Non torniamo al problema degli universali, per favore.
Comunque:grazie per lo spazio che indebitamente “mi sono preso”.
ps: a proposito…grazie anche per il “regalo-Agamben”:). Mi ha ricordato i “paternali” consigli di lettura che a scuola, nel periodo di Natale, mi propinavano i professori. Allora erano graditi, oggi saprebbero di “presa per i fondelli”.
@Giorgio1983
Il mio era soltanto un tentativo di chiarimento costruttivo che, però, mi appare, ora, totalmente inutile. Scusa, ma il dispositivo di “sapere-potere” non puoi dirmi di non coglierlo, da lettore di Foucault…O mamma…:(
“Agamben, da te consigliatomi…”
(!)
Ecco, da qui si capisce tutto il resto.
Grazie e ciao.
Il post sollecita la riflessione su alcuni temi fondamentali e urgenti. Volevo scrivere le mie seguendo le regole di Agamben, ma poi ho lasciato perdere :)
1. “Hard Times…”
Il primo è quello del Tempo. La rivolta sconvolge la logica del tempo lineare. Eppure molte delle culture politiche e delle narrazioni che vivono nei cosiddetti “movimenti” cercano di inscatolare il tempo nella gabbia “a due dimensioni”. Il tempo lineare accomuna sia i reduci dello “sviluppismo” che i fautori della cosiddetta “decrescita”, visto che entrambi si collocano lungo la strada che conduce dalla “arretratezza” alla “crescita”, o dalla “decrescita” allo “sviluppo”. Ma i precari che hanno manifestato a Roma il 14 dicembre vivono sulla loro pelle un’altra situazione. Le condizioni che attraversano la composizione sociale del lavoro e della produzione, la sua mobilità, la sua capacità di forzare i vincoli e di subire forme di sfruttamento al tempo stesso iper-tecnologiche e schiavistiche. Convivono modi e tempi diversi di produzione nello stesso settore produttivo, all’interno dello stesso spazio fisico e persino addirittura nello spazio di una stessa giornata. Si pensi ai ricercatori precari costretti a saltare da mattina a sera dal lavoro ad alta specializzazione dei laboratori informatici a quello neoschiavistico degli sgabuzzini di un ristorante in cui fanno da lavapiatti a nero. La cosiddetta “eccellenza” è mescolata alla cosiddetta “arretratezza”. Richard Donkin ha scritto sul Financial Times a proposito dei consigli agli schiavisti dell’antica Roma del «De re rustica» di Columella: «Dovremmo considerarlo il padre delle risorse umane?». Un dirigente della iper-moderna corporation At&T, parafrasando quel manuale schiavistico, afferma che ogni lavoratore «dovrebbe sentire che gli sei superiore, ma che rispetti i suoi sentimenti e le sue esigenze».
Il nostro problema principale è oggi proprio quello di afferrare il tempo. Se ne parlava fugacemente proprio qualche settimana fa a proposito di free-jazz e “seize the time” ;)
2. “… and Nursery rhymes”
C’è poi la gigantesca questione di Genova. Sullo sfondo, la necessità di ragionare del decennale senza fare reducismo. Della “rivolta poliziesca”, rappresentata con forza dalle filastrocche fascistoidi cantate dagli agenti a Bolzaneto, ha parlato chiaramente un giornalista che conosce bene (per usare un eufemismo) il mondo delle forze dell’ordine: Carlo Bonini in “A.C.A.B.” descrive con dovizia di particolari gli umori che hanno condotto il corpo sociale degli uomini in divisa a pensarsi come soggetto in campo. Valerio Marchi citava la teoria della “terza tribù” per dire che negli stadi italiani si tendeva sempre più a considerare la polizia non come una forza di interposizione tra due tifoserie avverse ma come una parte dello scontro, con cui regolare conti e giurare vendette, misurarsi ogni domenica. Ma la “rivolta poliziesca”, vera rivolta al contrario, è metafora di un altro fenomeno fondamentale per comprendere il ventennio berlusconiano: quello della rivoluzione conservatrice. Walter Siti sostiene che l’obiettivo del premier, la sua personale rivoluzione passiva, è quello di “essere sintomo di liberazione e magari di libertinismo senza assumersi il duro compito di trarne esplicite conseguenze culturali”. Lo spirito del berlusconismo è quello di essere comunque forza capace di muovere e attivare. Ecco perché gli anni ottanta, vera origine della rivoluzione al contrario del quindicennio berlusconiano, vanno letti come reazione violenta e impietosa ai moti degli anni settanta: l’edonismo in luogo dell’autonomia personale, la spregiudicatezza maschilista che fa il verso alla liberazione sessuale, lo smembramento della fabbrica e il mito della piccola impresa come epifenomeni del rifiuto del lavoro, la rottura a favore di Berlusconi del monopolio della televisione pubblica come effetto giuridico delle radio pirata dei movimenti. Si potrebbe continuare all’infinito.
Scusate la lungaggine!
[ascoltando “Hard times and nursery rhymes”, il nuovo album dei Social Distortion in uscita tra dieci giorni ma già disponibile in rete ;)]
Intanto scoppiano rivolte in tutto il Mediterraneo, su entrambe le sponde. Non solo in Grecia e Italia, ma in Nordafrica, soprattutto in Tunisia e Algeria. Se uno si iscrive al feed o al profilo Twitter di Alain Bertho
http://berthoalain.wordpress.com/
http://twitter.com/alainbertho
è tutta una sfilza:
“Emeutes en Kabylie”
“Emeutes à Ighzer Amokrane (Béjaïa), Bouira et Ain Defla”
“Emeute à Oran”
“Emeute à Akbou (Bejaia)”
E qui c’è un accenno di analisi (in italiano):
http://www.uniriot.org/uniriotII/index.php?option=com_content&view=article&id=2384:mediterraneo-in-rivolta&catid=86:speciali&Itemid=288
Però il punto rimane: la rivolta come sintomo del forget domani.
Pongo tre problemi sul campo, che secondo me puntano tutti a una ricollocazione della rivolta come un fattore non evidentemente inaspettato date una serie di motivazioni. Sarò poco sistematico, ma abbiate pazienza.
Le reazioni sono molto dure, nei casi africani in modo particolare, ma provo a fare un salto nella rete.
Inizio da un appunto di carattere tecnico: spesso il dispositivo di sapere come potere è un clamoroso boomerang, soprattutto perché certe cose rese pubbliche mortificano la stessa azione a cui tendono. Ormai il fatto che ci si organizzi via mail e fb rende molto semplice il controllo “soffice”, e queste rivolte subiscono repressioni molto dure anche perché a differenza della lega di Spartaco, questi si organizzano su media molto controllabili, e spesso coloro che controllano non devono neanche decrittare. Il controllo della protesta sfocia in manifestazioni molto divertenti, tuttavia soggette a denuncia in molti stati, anche il nostro, e a pressioni. Questo risulta in azioni che poi perdono il carattere
pacifico (viste anche le reazioni) e sfociano in rivolte. Il processo di formazione della rivolta potrebbe dipendere dall’eccessivo controllo delle azioni di protesta. In questo frangente ho provato di nuovo a fare la persona razionale.
Poi è ovvio che questo possa unirsi a delle letture di carattere più culturale e di lettura su più piani, ma quella descritta è una genesi probabile dell’insofferenza, a cui poi si aggiungono molte altre cose, ovviamente. A ritroso, il networking ha maglie larghe, e controllabili. Sapere è potere.
Storicamente per la prima volta i laureati fanno dei lavori di merda esattamente come i non laureati, e ritorna il problema di classe. Tutti i ragionamenti occorsi negli anni ’70 ragionavano a partire da una situazione in magmatica evoluzione, che evidenziava una stabilità del sistema: l’ingresso nelle caste medie e alte era difficoltosa ma possibile. Negli anni ’80 salì la difficoltà ma la corsa al marketing proseguita nei ’90 ha attutito non di poco la caduta (il mercato del marketing di massa si è formato in quegli anni, alcuni tipi di marketing, il “guerrilla marketing” nasce a fine anni ’90, per esempio). Tutti i laureati respinti entrarono in quel mondo e lì restarono.
Ora, nessun cuscino e culata secca, da rompersi il coccige. Non esiste e non è mai esistito in Italia un mercato del lavoro per laureati di dimensioni accettabili, ma la selezione all’ingresso in tale mondo ha limitato i danni per molto tempo. Ora invece le università fanno laureare anche i cammelli, e questo riempie il famoso mercato che scoppia. Di nuovo, altro elemento da considerare: dopo anni e anni di balle sulla possibilità di cambiare status grazie a una laurea (forse vero ancora per medici e pochi altri) torna il problema della classe, di cui ricordo si fosse già parlato altrove in questo blog. Ma torna anche il problema della attuabilità della protesta, che diviene rivolta perché anche la percezione sociale è evidentemente quella di essere al fondo di una strada senza uscita.
Infine: il frame entro cui vengono posti i problemi si nutre del linguaggio da rivoluzionario fascista o comunque di destra: marchionne contro i poteri forti dei sindacati, gelmini contro gli schiavi dei baroni ecc. E allora? Allora niente domani, tanto diranno che siamo “quelli dei poteri forti”. E allora? Allora riot!
Sulla rivolta degli sbirri, c’è gente che la mette sul ridere:
http://www.repubblica.it/persone/2011/01/07/foto/scultura_poliziotta_che_fa_pip_polemica_a_dresda-10946867/1/?ref=HRESS-7
:)
Prezioso post di Mazzetta sulle rivolte in Nordafrica, con un tot di video
http://bit.ly/dTeDy7
Grazie per questo post, che invita tutt* noi a ripensare Genova fuori dalla logica del reducismo, e fuori dalle omologie artificiali e strumentali, come quelle proposte dall’informazione mainstream in questi mesi. Negli ultimi 10 anni c’è stata, del resto, una sostituzione simbolica, che ha portato a identificare la complessità di quei fatti (e di quei percorsi politici) con l’icona dei bancomat sfasciati. Anche nel linguaggio comune, si è irrigidito il sintagma “gli scontri di Genova”. Io non ricordo scontri, ma pestaggi e assalti. Come a volte ci viene anche rimproverato, le abbiamo prese come tamburi (per citare sempre Brecht ;-)), che si sia andati imbottiti di gommapiuma a “rappresentare” il conflitto o che ci si sia esposti a mani alzate (e bianche) alle cariche dei celerini.
Le debolezze di quel movimento, del resto, erano tante. Una delle più gravi è stata proprio l’incapacità di articolare una riflessione vera sulla violenza, accettandone le rappresentazioni eterodirette e riducendo la riflessione sulle forme della lotta a uno squallido televoto, violenza sì violenza no. Ma anche la debolezza, ad essa collegata, di rimanere un movimento astratto, per molti aspetti “illuminista”, poco capace di articolare insieme teoria e azione, se non sul terreno delle micro-azioni, che pian piano hanno perso spinta propulsiva e trasformativa. In compenso, noi eravamo un po’ più consapevoli della scala globale delle lotte. Gli studenti di ora, che peraltro stimo e ammiro, sembrano un po’ meno interessati a questo aspetto, che peraltro potrebbe spiegare molte cose, soprattutto rispetto all’esistenza (o al ritorno, per chi lo vede così) delle “classi” sociali.
Quanto al racconto: il vostro frammento, così come quello di Leonardo, sono provocazioni rivelatorie. E’ vero, ad esempio, che nella “rivolta” dei poliziotti sono diventate visibili a tutti le violenze portanti della nostra società, quelle che l’ideologia anni ’90 spostava oltre il campo visivo, nascondendole o proponendole come momenti di una ‘preistoria’ da superare. Nella “rivolta” dei poliziotti, poi, sono diventate evidenti le connessioni di violenza e di piacere, e l’incapacità di molta sinistra di provare “piacere”, contro il vitalismo gioioso e “stupido” della destra. Basta accostare le campagne “Be Stupid” e gli slogan sulle magliette del Blocco Studentesco (tipo “la nostra rivoluzione sarà una ficata”), per rendersene conto. In questo condivido abbastanza le riflessioni di Jimmyjazz, in uno dei commenti precedenti. E’ indubbio che il piacere sia un dispositivo liberatorio ma, allo stesso tempo, potenzialmente castrante. Esiste un piacere come liberazione, ed esiste un imperativo di piacere, che è quello in cui viviamo perlomeno da vent’anni. Le piazze, per chi le riempie, sono luoghi di piacere e di auto-rivelazione, di gioia autentica e non indotta. E che questo piacere abbia natura esplosiva, mi pare indubbio.
Ciò detto, credo che i nostri siano anni di rivolte e non di rivoluzioni. Con questo intendo dire che sembra venuta meno la capacità di pensare un’alternativa, un potenziale trasformativo che non sia quello dell’apocalisse, incessantemente ritrasmessa dalla cultura pop. Poi, certo, si può anche vedere questo come un fatto positivo, nella prospettiva debole di chi vuole stare sul margine (Franco Cassano, ad esempio, vede nella rivolta un’alternativa al vizio metafisico della rivoluzione), ma sinceramente non è il mio punto di vista.
Ora, io credo che la critica sia un imperativo politico. Primo, perché di teoria c’è bisogno per passare a una trasformazione. Il nomadismo rivendicato negli anni ’90 dal pensiero della differenza ci ha portati a un eclettismo molto post-moderno e, talora, inconcludente. Nel movimento di oggi vedo, invece, un ritorno al desiderio di letture “forti”, di un metodo (in fondo anche la pratica del book bloc sembra indicare questo), con un’altra debolezza, semmai: noi eravamo un movimento di aspiranti assistenti sociali e cooperatori, mentre ora la parola più gettonata è “narrazioni”, anche a scapito di rigorose analisi economiche e politiche.
La critica è necessaria anche per constrastare il classismo insisto nella nostra cultura (da cui, forse, dipende anche lo stile oscuro caro a noi umanisti, e la nostra propensione al gergo, che è il filo spinato del ragionamento). E’ solo in virtù di questo classismo che lo smantellamento dei saperi umanistici può esser fatto passare come un’abolizione di antichi servaggi, e che le scienze umane possono apparire come lussi inutili, anziché il terreno dove si costruisce un’idea sistemica di mondo, oggi più necessaria che mai.
Rileggere la critica, come qualcosa che sfugge alla proletarizzazione (!) dell’università, ma anche alla sua identificazione con una fabbrica (nazionale e globale) di classi medie: un vizio, quest’ultimo, che rischia di minare anche le lotte studentesche, identificandole con la semplice disillusione di una generazione di figli.
Mi scuso per la lunghezza. Ce n’era per scrivere un post, ma invece di scrivere sul mio blogghettino, ho preferito contribuire qui alla discussione.
@ valentina
“Il nomadismo rivendicato negli anni ’90 dal pensiero della differenza ci ha portati a un eclettismo molto post-moderno e, talora, inconcludente.”
magari fosse solo inconcludenza! ho la sensazione che molti, dopo la risacca del 2003, siano passati dal pensiero della differenza al razzismo differenzialista (spacciato per “antirazzismo” differenzialista). non ho dati per provarlo e (non essendo un umanista) non ho nemmeno gli strumenti teorici per dimostrare che un simile slalom sia possibile. pero’ l’ho visto coi miei occhi, ho visto dei “compagni” passare dal movimento alla lega. ne ho visti altri che, in nome delle differenze, hanno cominciato a dire peste dell’ illuminismo e sono finiti ratzingeriani.
@valentina
Forse sbaglio in pieno, ma non mi sembra di vedere un bisogno così diffuso di narrazioni “forti” nel panorama delle lotte di questi ultimi anni. Dirò di più: magari ci fosse!
Mi sembra anzi che il riconoscimento della necessità di costruire delle letture forti sia appannaggio di un'”avanguardia suo malgrado”; che per giunta, nei fatti, mi sembra pure poco ascoltata.
Forse sono eccessivamente pessimista, ma mi pare che molte di queste lotte nascano dal fatto che le chances di emancipazione sociale si sono nuovamente ristrette, come ha suggerito Giorgio1983… le differenze di classe tornano d’attualità proprio perché il livellamento delle differenze promesso dall’accesso alla “classe media” si sta rilevando per quello che è: nella migliore delle ipotesi, una conquista transitoria; nella peggiore, una menzogna.
A muovere le lotte, più che una motivazione ideale, mi sembra quindi una frustrazione di fondo, incapace di elevarsi oltre il particolare e l’individuale… incapace, cioè, di creare quella forma basilare di consapevolezza che è il presupposto dell’autocoscienza di classe. Forse è anche per questo che il grillismo miete tanti consensi…
Scuola e università sono casi esemplari, secondo me.
L’aumento delle possibilità di conseguire certi titoli di studio (mi riferisco a diploma di liceo e laurea), è un fatto incontestabile degli ultimi 10 anni. Avrebbe però rappresentato un reale progresso, se fosse stata messa in discussione la loro funzione di dispositivi di selezione sociale.
Mi spiego: se l’iscrizione ad un corso di laurea rispondesse, più che all’esigenza di avere un pezzo di carta spendibile nelle “fasce alte” del mondo del lavoro, ad un bisogno generalizzato, da parte della popolazione, di migliorare la propria cultura, quel bene non si sarebbe degradato così tanto… ma questo avrebbe potuto accadere solo se le “classi medie” non avessero fatta propria in modo così solerte la mentalità individualista e falsomeritocratica tanto in voga negli anni ’80.
L’istruzione superiore, nella nostra società, è uno di quei classici beni che gli economisti chiamano “beni posizionali”: sono destinati a pochi, pena la congestione, l’affollamento e la perdita di valore. Ma la natura di “bene posizionale” deriva all’istruzione dalla sua “scarsità sociale”, che dipende a sua volta dal particolare “significato sociale” che le viene attribuito… questo significato, a sua volta, dipende dal modo in cui i bisogni dei membri della società si rappresentano in una visione condivisa.
L’obiettivo che doveva essere perseguito era questo: ripensare l’istruzione in modo da rimuovere i presupposti culturali di quella “scarsità sociale”. Quello che si è fatto, invece, è stato sfruttare fino alla congestione e all’esaurimento quel bene, difendendo addirittura la sua funzione sociale!
Il difetto di molte lotte che hanno come tema l’istruzione (ma non solo di quelle!), secondo me è quello di non prendere atto di questo vizio di fondo.
@Don Cave
Penso che diciamo entrambi cose vere. Non vivo in Italia, e seguo il movimento soprattutto per le sue tracce in rete. Non ho, dunque, modo di misurare quanto certe istanze siano diffuse, e quanto invece siano appannaggio di una ristretta minoranza. Però ci sono, e a me preme riconoscerle e — se possibile — sostenerle. Dipingere le copertine dei libri sugli scudi è un po’ diverso che bardarsi da Mazinga Zeta: in questa scelta io vedo un potenziale, per quanto fragile e minoritario.
Ancora, di recente, nel blog di Alfabeta 2 sono stati ospitati vari contributi di Bartleby, tra cui uno, a firma di tali Antonio e Vincenzo, che rivendicano, in grassetto: “I movimenti non hanno bisogno di intellettuali-simbolo-tuttologi, ma di saperi critici specifici, che abbiano la capacità di farsi ridefinire dalle lotte.”
Ripulita da un certo gergo movimentista, una posizione del genere mi sembra un segnale incoraggiante, e spero che prenda piede.
Detto questo, è vero che l’università forma poco, è vero che non si leggono i testi (mi sono laureata nel 2008 e tutte le letture significative e importanti derivavano da un mio interesse personale: mica solo Foucault, anche La metamorfosi delle piante di Goethe: all’università ci davano solo manuali di 100 pagine editi da Il Mulino e da Carocci, e questa è responsabilità di chi insegna). Soprattutto, è vero che in luogo di una reale democratizzazione, si è avuta una svalutazione del pezzo di carta, in quanto tale poco più che una mitologia borghese. Chissà, forse una parte di chi si riversa nelle piazze forse sono ragazzi che scoprono di colpo di non essere borghesi, di non sapere nulla, di essere stati illusi da tante false promesse. (E guardate che questo non è vero solo in Italia. In America il 60% degli studenti universitari è indebitato alla fine degli studi e se non trova lavoro non sa come ripagare il proprio debito, e non necessariamente per frequentare una Ivy league, ma magari qualche squallido ente for-profit….alla faccia di chi, come Cameron&co, vuole imitare quel modello…).
Quando dico che c’è bisogno di critica, intendo più che altro auspicarne il ritorno. E’ proprio questo che volevo dire quando ho scritto che occorre “Rileggere la critica, come qualcosa che sfugge alla proletarizzazione dell’università, ma anche alla sua identificazione con una fabbrica (nazionale e globale) di classi medie: un vizio, quest’ultimo, che rischia di minare anche le lotte studentesche, identificandole con la semplice disillusione di una generazione di figli”. L’identità generazionale, su cui tanto ora si insiste, è alternativa alla lotta di classe (che invece è intergenerazionale per natura). Non è un caso che la retorica del giovanilismo sia stata cara alle “mobilitazioni dall’alto” del fascismo, e che oggi sia funzionale allo smantellamento del welfare, da parte di chi ha creato l’odioso feticcio della competizione tra ‘precari giovani’ e ‘vecchi iper-garantiti’.
In questo momento, comunque, vedo una gran confusione e un gran ribollire: ma, ancora, tutte le strade sono aperte.
@ valentina
Secondo me la critica, per essere efficace oggi, deve nascere da una nuova consapevolezza sociale.
Evitare di reagire solo sulla base di delusioni o frustrazioni individuali, così come evitare la contrapposizione generazionale, significa in fondo compiere una stessa operazione di fondo: dare un respiro “globale” alla lotta.
La lotta – ogni singola lotta – può assumere un respiro globale solo se esce dalla sua particolarità, dal suo ambito immediato, e colloca le proprie rivendicazioni sullo sfondo di una richiesta generale di cambiamento, rivolta alla società nel suo complesso.
Non sono la scuola, l’università, la sanità, il mondo del lavoro, la redistribuzione della ricchezza, la politica… ad essere messe in discussione: è il sistema stesso che da’ a tutti questi ambiti un “significato sociale” che dev’essere ripensato in modo radicale. Ripensato e trasformato, nella misura in cui l’azione di lotta dev’essere in grado sicuramente di prefigurare un’alternativa, se non addirittura di cominciare a realizzarla, creando dal basso nuove istituzioni, nuove pratiche sociali.
Per cui ci può anche stare il rifiuto della tutela di “intellettuali simbolo tuttologi”… a patto che ciò non significhi, da capo, trincerarsi nella particolarità, tirando dritti col paraocchi verso obiettivi limitati. Perché un conto è rifiutare la tutela – che va benissimo; altra cosa è tapparsi le orecchie con la cera.
Wu Ming 1 ha parlato più volte della necessità di superare la visione “a mosaico”… se non si batte con determinazione la strada della convergenza delle lotte verso un obiettivo comune (e ambizioso), chi trae vantaggio da questa situazione ci metterà poco a “normalizzare” quella confusione, magari lasciandola esplodere per poi reprimerla con il plauso di migliaia di cittadini lobotomizzati.
Premetto: è molto interessante leggere la discussione che si sta sviluppando, e dà ottimi spunti. Io sono un po’ impaurito nell’intervenire perchè, a dir la verità, molte cose che vengono scritte faccio fatica a comprenderle, quindi non vorrei sviare o semplificare troppo. Sono un laureando, e sono sceso in piazza in questi mesi.
Si parla di dare alla lotta un respiro globale. E’ vero, sono d’accordo, ma penso che inevitabilmente sarà un processo lento, e che si svilupperà passo dopo passo. Prima occorre ricostruire la società. Cioè, un senso di società. Scusate se tiro in ballo gli anni settanta: lì la lotta aveva una scopo, ed era quello appunto di cambiare la società. Perchè allora c’era una società. Ora, nelle università occupate, è difficile sentire che lo scopo ultimo è quello di cambiare la società, l’Italia per esempio, cioè è nell’aria ma non si dice, perchè la società è morta, lobotomizzata, asfaltata dalle privatizzazioni e da tutta una cultura imperante da decenni che privilegia l’individuo e non il gruppo.
E anche noi, studenti cresciuti secondo questo modello culturale, dobbiamo pian piano riscoprirla. Iniziamo a riscoprirla nel locale, nella università e nella realtà cittadina, regionale, e pian piano ci allarghiamo a tutta la nazione. E poi si scopre che sì insomma alla fine anche in Inghilterra e in Grecia combattono per i nostri stessi motivi, e che anche il Nordafrica non è così lontano come si pensava. Sempre di laureati disoccupati si tratta. Poi pian piano si scoprirà che la lotta a Mirafiori, con le debite differenze, non è poi così separata dalla nostra, e così via.
E così si arriva al “respiro globale”. Ci vuole tempo purtroppo. Per ricostruire una società bisogna almeno che ci sia una società.
@Krasnapolsky
Non penso che la presenza di una società “forte” sia una precondizione perché le lotte acquisiscano una dimensione globale, né penso che la società sia stata del tutto cancellata.
Se una lotta non ha come suo scopo quello di contribuire, per quanto poco, alla trasformazione del panorama sociale, per che cosa si lotta allora? Le lotte dovrebbero plasmare la dimensione sociale, indicando nuove forme di relazione e nuove modalità di azione e condivisione… dovrebbero, quindi, esprimere una visione di largo respiro, non limitarsi a lanciare qualche stimolo nella speranza che “la società” reagisca…
Mi sembra che in questo modo si finisca per concedere un alibi alla tendenza, da parte di molte lotte (soprattutto quelle studentesche), a particolarizzarsi… già il fatto che si dica “pian piano si scoprirà che la lotta a Mirafiori, con le debite differenze, non è poi così separata dalla nostra” è indicativo di questa tendenza! Forse
Il fiorire di lotte in contesti diversi è sintomo che del fermento, all’interno della società, c’è ancora… che i bisogni profondi che spingono gli esseri umani ad associarsi non sono stati cancellati, perché non possono essere cancellati… che le istituzioni tradizionali costruite a tutela di questa dimensione hanno fallito, e devono essere quindi reinventate, rimpiazzate da qualcosa di nuovo e diverso.
A mancare, quindi, è una visione capace di unificare queste lotte, più che “la società”.
Un buon segnale in materia di connessione delle lotte e di visione globale:
http://bartleby.info/content/cosa-cambia-1801-assemblea-di-ateneo
Noi saremo tutto! Note sul movimento degli studenti e la sua posta politica
http://bit.ly/f23oqy
Riflessioni davvero interessanti, grazie Wu Ming 1 per la segnalazione.
Soprattutto mi piace che, nel riconoscere una tendenza (e nel prefigurarne i possibili esiti), i due autori facciano appello alla necessità di “non chiudere”, ma anzi rilancino la posta in gioco e, implicitamente, auspichino che il valore “costituente” delle lotte plasmi l’autocoscienza del movimento. Non lo pongono come un esito scontato, e mettono bene in guardia dai rischi.
Non so davvero quanto e in che termini il potenziale di questa situazione sia presente agli studenti (purtroppo in questi mesi non ho avuto la possibilità di frequentare le assemblee né di partecipare alle manifestazioni… i dubbi, le perplessità e i timori che ho esposto sopra mi derivano dai resoconti di persone che vi hanno preso parte).
Martedì prossimo, finalmente, riuscirò a partecipare all’assemblea bolognese… mi riprometto di riportare qui le mie impressioni.
Sono convinto di essere fuori tema, ma volevo segnalarlo perchè lo trovo emblematico..
http://genova.repubblica.it/cronaca/2011/01/23/news/g8_poliziotti_violenti_salvati_da_una_leggina-11549395/
[…] itinerario finalmente percorribile, arricchito da immagini e testimonianze esterne… compreso un mio bizzarro racconto ispirato a Spartakus :-) In fin dei conti, anche in quel numero di “Riga” si perseguiva la famosa, […]
[…] In questo raro documento video Jesi compare in qualità di esperto all’interno di un documentario sull’identità europea, nei primi minuti del film. […]