.
[Si conclude la pubblicazione su Giap degli interventi fatti da WM1 e WM2 alla UNC (University of North Carolina) di Chapel Hill, il 5 aprile scorso. Dopo quello di Wu Ming 1 (“Siamo tutti il febbraio del 1917, ovvero: A che somiglia una rivoluzione”), ecco quello di Wu Ming 2, che fa tesoro di molte discussioni svoltesi su Giap (a cominciare da quella sulle “narrazioni tossiche”).
Le versioni italiane di entrambi gli interventi sono disponibili in un unico pdf. Quelle in inglese in due pdf separati (vedi in calce a questo post).]
– – –
A novembre dell’anno 2010, quando abbiamo proposto il titolo per questa conferenza [*], il problema di distinguere una rivoluzione da qualcos’altro non era di particolare attualità: lo avevamo scelto con un occhio alla nostra produzione di romanzi storici, dove abbiamo raccontato rivolte, rivoluzioni e guerre d’indipendenza.
Nel frattempo, però, i tumulti sono tornati di moda, come non accadeva da oltre vent’anni, e giornali e riviste sono inondati di articoli dove ci si chiede se in Tunisia o in Libia sia in corso una rivoluzione, se il Bahrein, l’Oman o la Siria ne conosceranno davvero una, e via discorrendo.Prima di questa nuova primavera dei popoli, durante lo scorso decennio, il termine che ci interessa era stato accoppiato a colori e nomi di piante per definire una serie di contestazioni elettorali in Serbia, Ucraina, Georgia, Kirghizistan, Iraq e Iran. Oggi è abbastanza evidente che quei movimenti, lungi dall’essere vere e proprie rivoluzioni, erano piuttosto campagne politiche, in alcuni casi non-violente, studiate per rovesciare una maggioranza parlamentare forte e autoritaria. Tuttavia, molti continuano a ricordarli come eventi rivoluzionari e le etichette con i vari colori (arancione, rosa, verde, porpora) sono ormai passate alla storia.
Ancora più indietro nel tempo, il crollo simultaneo dei regimi filo-sovietici dell’Europa Orientale, nel 1989, ha fatto parlare indistintamente di “rivoluzione”, anche di fronte a esiti molto diversi tra loro, come quelli che si produssero in Cecoslovacchia e in Romania.
Siamo dunque di fronte a un fenomeno che non ha caratteristiche chiare e condivise, né tanto meno condizioni sufficienti: i cambiamenti di regime possono nascere da un colpo di stato, da una guerra civile e a volte addirittura dalla normalità politica, mentre una situazione rivoluzionaria può protrarsi a lungo, e incidere nella società, senza sfociare in un trasferimento forzoso di potere.
Come per ogni concetto diacronico, affermare che «x è una rivoluzione», presuppone che x sia una scelta di eventi singoli, allineati uno dopo l’altro lungo il filo del tempo.
Di conseguenza, se volete convincermi che l’ascesa del fascismo è stata una rivoluzione, non potete mostrarmi un filmato della Marcia su Roma e dirmi: ecco, guarda. Dovete andare molto oltre la semplice ostensione di un singolo evento: dovete descrivere un pezzo della storia d’Italia. Anzi, dovete andare anche oltre la descrizione e collegare tra loro tutti gli elementi narrativi della “pentade” di Kenneth Burke: attori, azioni, scopi, scene, strumenti. In altre parole, dovete produrre un racconto di quella vicenda che rientri nel genere “rivoluzione”. Un genere dai confini piuttosto sfumati, sul quale storici e filosofi hanno prodotto diverse teorie contrapposte. Ma forse, come direbbe Wittgenstein, un concetto confuso è proprio quello che ci serve.
Altri grandi eventi storici, al contrario, hanno confini più netti, e le parole per nominarli si dovrebbero usare con meno incertezze.
Una guerra può dirsi tale nel momento stesso in cui un governo la dichiara, o quando un esercito spara a più riprese contro un altro esercito, ed è per questo che il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, si è reso ridicolo quando ha affermato che il nostro paese non è in guerra contro la Libia di Gheddafi. La guerra è auto-evidente, anche quando non la si vuole chiamare con il suo nome, e si preferiscono termini meno compromettenti come no-fly zone. Una guerra può essere oggetto di valutazione morale, non ontologica. Certo, come per tutte le parole, esistono usi allargati anche del termine “guerra”, che permettono agli storici di chiamare un lungo periodo di ostilità “Guerra dei Trent’anni”, oppure “Guerra Fredda”, ma al cuore di queste accezioni più libere, esiste un senso stretto ben definito. Se qualcuno mi dicesse che la “Guerra Fredda” non è stata davvero una guerra, gli farei alcuni esempi concreti: dalla Corea all’Ungheria, dal Vietnam all’Afghanistan, a Grenada.
Al contrario, se voi mi diceste che in Tunisia non c’è stata una vera rivoluzione, dovremmo prima di tutto confrontare le nostre idee di rivoluzione, quindi le nostre narrazioni di quella vicenda particolare.
Questo significa che per distinguere una rivoluzione da ciò che non lo è, abbiamo bisogno di un buon concetto euristico, da un lato, e di una buona narrazione, dall’altro. Storici, filosofi e sociologi possono aiutarci ad approntare il primo, mentre romanzieri e cantastorie possono dirci qualcosa della seconda. Anche perché non è questo l’unico legame che esiste tra narrazione e rivoluzione, e prima di procedere con l’analisi, vorrei elencarne almeno altri due.
Il primo è che entrambe ruotano intorno alla violazione di una norma. In una sequenza di eventi canonici non c’è storia e non c’è nemmeno rivoluzione. Senza una potenziale rottura del mondo ordinario, il gioco narrativo non vale la candela. La rivoluzione nasce dalla stessa dialettica che fa da perno per qualsiasi racconto: quella tra conservazione e cambiamento, tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere.
Secondo, ogni rivoluzione è anche un tentativo di raccontare il mondo con nomi e concetti nuovi, sia sul piano simbolico (come ad esempio per la riforma del calendario durante la Rivoluzione Francese), che su quello materiale, con leggi, soggetti e diritti prima sconosciuti. Non a caso, i fautori di un colpo di stato cercano spesso di giustificare sé stessi attraverso cambiamenti semantici che scimmiottano questa necessità rivoluzionaria.
Giunti a questo punto, mi sembra evidente che per occuparsi della rivoluzione occorre maneggiare molti più materiali narrativi di quanto potrebbe sembrare a prima vista. E all’interno di questi materiali, di questi mitologemi e di queste retoriche, vorrei individuare quali cortine fumogene possono confondere lo sguardo, avvelenare la narrazione e impedirci di distinguere tra una rivoluzione e ciò che non lo è, o meglio: tra una narrazione tossica della rivoluzione e una narrazione salubre, aperta, fedele al suo scopo.
Narrazioni tossiche
Per cominciare la ricerca, dobbiamo chiederci cosa significa essere “fedele al suo scopo” per una narrazione che intende riferirsi alla realtà.
Si potrebbe rispondere che essa dev’essere vera, ma poi bisognerebbe spiegare di quale verità stiamo parlando, se della verità come corrispondenza con i fatti – spesso invocata da politici e giornalisti – oppure della verità come coerenza interna a un paradigma, che troviamo all’opera nelle scienze o in matematica.
Nel caso di una narrazione credo sia meglio parlare di “verità poetica”, la quale non dipende dalla semplice rappresentazione dei singoli fatti, ma riguarda soprattutto il loro significato complessivo. Una narrazione è tanto più “vera” quanto più aumenta la nostra consapevolezza, la nostra comprensione (in senso etimologico) di una sequenza fattuale. In altre parole, mentre la pura cronaca si limita a descrivere i fatti, la narrazione deve anche farli parlare: deve connettere eventi, significati e individui. Una storia, come abbiamo visto, merita di essere raccontata perché insinua l’inammissibile nella normatività quotidiana. Nelle favole c’è un mondo ordinario in crisi e un eroe che parte per il mondo straordinario, allo scopo di staccarne un pezzetto e riportarlo al villaggio. Ogni storia nasce da un “what if” (cosa succederebbe se…?) e così facendo introduce una dimensione eventuale e congiuntiva nel regno dell’indicativo. Per dirla con Aristotele:
«compito del poeta non è dire ciò che è avvenuto, ma ciò che potrebbe avvenire, vale a dire ciò che è possibile secondo verosimiglianza (eikos) o necessità (anankaion).» [1]
Qualunque racconto dei fatti che vada al di là della pura cronaca e miri a far emergere una verità poetica, afferma sempre a proposito del suo contenuto: “Questo sarebbe potuto accadere”, anche quando sembra dire: “Questo è accaduto”.
Ecco allora che una narrazione tossica, una narrazione che non fa il suo mestiere, è quella che cancella la sua dimensione congiuntiva, nasconde l’ipotesi, cerca di bloccare in tutti i modi la spinta a “raccontare altrimenti”, a pensare altre storie possibili, altre verità poetiche per quell’insieme di fatti.
In questo senso, tutte le storie contengono una dose di tossine, perché – come ha dimostrato George Lakoff con i suoi studi sul legame neurale, «quando tu accetti una particolare narrazione, allora ignori i dati che la contraddicono. Le narrazioni hanno il potere di nascondere la realtà» [2]. Questo non significa che possiamo buttarle via e sostituirle con la fredda e dura ragione. Come abbiamo visto, per identificare una rivoluzione abbiamo bisogno di raccontarla. La proposta di Lakoff è quella di un Nuovo Illuminismo, nel quale «riconosceremo che gli schemi narrativi fanno parte dell’attrezzatura permanente del nostro cervello, ma potremo almeno esserne consapevoli» [3].
Come cantastorie, mi piacerebbe produrre narrazioni che aumentino tale consapevolezza, che limitino il più possibile il proprio potere di nascondere la realtà e che anzi incoraggino narrazioni alternative, fornendo al lettore spunti, appigli, crepe. Credo che un narratore dovrebbe essere leale, non obiettivo. Infatti, per raccontare una storia non possiamo fare a meno di adottare una prospettiva e la cosiddetta obiettività è solo una convenzione stilistica, studiata apposta per occultare questa ineludibile parzialità. Si potrebbe dire che proprio la pretesa di una narrazione “bipartisan” è il primo e più generale veleno che infetta il racconto della realtà. Al contrario, essere leali significa giocare ad armi pari, ovvero stimolare il lettore a farsi narratore a sua volta, con un suo punto di vista, e non tenerlo buono con sonniferi e tranquillanti.
Nel caso specifico della rivoluzione, allora, vorrei capire dove si annidano le tossine e quali scelte narrative contribuiscono a renderle pericolose.
Per farlo, partirò dalla struttura narrativa che il cervello utilizza nel resoconto di un qualsiasi evento, adattandola al caso particolare della rivoluzione. [4]
Prima di tutto abbiamo le Premesse, ovvero il contesto della narrazione. Nel nostro caso, tendiamo a sottolineare la presenza o assenza di fazioni con pretese incompatibili sulla gestione dello stato, la situazione dei diritti umani, la libertà d’espressione, la presenza o meno di una classe lavoratrice, le condizioni di lavoro e i principali bisogni della società civile.
Quindi viene l’Accumulo, ovvero gli eventi che portano all’Evento Centrale: proteste, scioperi, tumulti, disobbedienza civile, reazioni delle forze governative, espropri, diserzioni, azioni dimostrative o simboliche, ecc.
Da queste prime tappe, dovremmo essere in grado di capire lo Scopo, ovvero cosa vogliono ottenere gli insorti, quali sono le loro richieste.
Questo ci aiuta a identificare meglio l’Evento Centrale, ovvero il perno di tutta la storia: nella maggior parte dei resoconti, sembra che la rivoluzione ruoti attorno a un cambiamento di regime.
Ma non è finita, perché l’Evento Centrale genera la Via del Ritorno, ovvero gli avvenimenti che portano il racconto verso la sua conclusione: cosa ne è degli esponenti del regime, chi li sostituisce nell’immediato, i festeggiamenti della popolazione, ecc.
Quindi dobbiamo considerare il Risultato, ovvero la conclusione vera e propria della storia, cioè la trasformazione del contesto socio-politico descritto nelle Premesse. Infine vengono le Conseguenze Ultime, una sorta di epilogo a distanza di tempo, che ci permette di verificare la “tenuta” del Risultato: nel nostro caso dovremmo chiederci quanto a lungo il desiderio di rinnovamento è rimasto in circolo nella società civile o quanto è stato difficile, per il nuovo stato, rinegoziare i suoi rapporti internazionali, senza venir meno ai principi della rivoluzione.
Quella che ho appena descritto è una semplice struttura che si dipana nel tempo. La diacronicità, infatti, è una delle caratteristiche fondamentali dell’arte narrativa. Raccontare significa sempre dar vita a una cronologia, interpretare il tempo, spesso con effetti rassicuranti dal punto di vista cognitivo, perché mettere in fila gli avvenimenti ci dà la sensazione di dominarli, di averli compresi. Tanto che non di rado il semplice nesso temporale si trasforma in un nesso causale, nell’illusione che dire «C segue B e B segue A» sia equivalente a dire che «C segue da B e B segue da C». Più in generale diremo che le sequenze temporali di una narrazione corrono sempre il rischio di essere lette come sequenze necessarie.
Se ieri ho affermato che oggi alle 15 ci sarebbe stata una battaglia navale, la mia affermazione, oggi alle 15, è falsa, poiché la battaglia navale non infuria. Ma ieri, quella stessa affermazione era indeterminata, né vera né falsa, e la narrazione ha il compito di restituirci intatta quella sfumatura d’imprevisto. Occorre evitare la cosiddetta illusione retrospettiva di fatalità, una potenziale tossina presente in qualsiasi racconto. Sotto la sua azione tendiamo a dimenticarci che per ogni istante t ci sono infiniti futuri contingenti e che le narrazioni sono fatte per esplorare un’ipotesi, non per contrabbandarla come inevitabile. Il regime fascista, ad esempio, nel presentarsi come prodotto di una rivoluzione scritta nel destino d’Italia, fece ampio uso di questa tecnica, proponendo come “necessario” tutto il suo percorso, dalla fondazione del Partito alla Marcia su Roma.
Le Premesse
Accade spesso che l’analisi del contesto nel quale nasce la storia venga fatta solo ex-post, perché la rivoluzione scoppia – invece di maturare, come potremmo dire con una metafora migliore – in un paese di cui si sa poco, il quale improvvisamente attira l’attenzione internazionale per via dei tumulti di piazza. Finiamo così per conoscere le premesse solo dopo che ci siamo fatti un’idea di quel che sta succedendo, perché gli eventi incalzano e vanno comunque narrati. Ma se le premesse vengono ripescate in questa sorta di analessi, finiscono per cozzare contro un frame già radicato, invece di contribuire a radicarlo. Qualcosa di simile è accaduto per la Libia, dove le prime manifestazioni sono state subito inquadrate nella cornice “rivoluzioni in Nord Africa”, e soltanto quando Gheddafi ha mostrato di poter resistere molto più a lungo di Ben Ali e di Mubarak, allora ci si è accorti della differenza, e ci si è affrettati a motivarla con le peculiarità dello scenario libico. A quel punto, come si dice in italiano, la toppa è stata peggiore del buco, e si è arrivati ad attribuire un’importanza fondamentale alle divisioni claniche e territoriali dei libici, accantonando del tutto l’elemento della protesta spontanea, politica e universale.
Bisogna ammettere che in Occidente, prima di queste sollevazioni, la conoscenza della società civile tunisina, egiziana, libica, mediorientale, era tutta schiacciata sulla vulgata secondo la quale un paese arabo è un paese musulmano, e un paese musulmano è un paese dominato dalla religione. La società civile, pertanto, si divide tra fondamentalisti e moderati, ma è comunque la religione l’unica chiave per comprenderla e impostare un dialogo.

Per nostra fortuna, se c’è un regime che è stato rivoluzionato in questi mesi, quello è il nostro regime di discorso intorno al mondo arabo e ai musulmani. Gli eventi di Tunisi e di Piazza Tahrir hanno mandato in pezzi la narrazione tossica delle premesse imperniata sul teorema dello scontro di civiltà (anche se per diversi giorni, proprio quella narrazione tossica ha impedito a molti commentatori di capire ciò che stava succedendo e li ha spinti a cercare invano la leadership religiosa delle rivolte). All’improvviso, i fautori del “dialogo religioso” e del relativismo culturale si sono ritrovati senza bussola, perché i loro concetti, pensati come alternativi rispetto alla contrapposizione tra Occidente e Islam radicale, avevano finito per farle da complemento. Due versioni diverse di quelli che Marco Aime ha chiamato “eccessi di culture”.
Come ha fatto notare Hayrettin Yucesoy:
«il discorso sull’Islam portato avanti dai progressisti, somiglia più o meno alla frase di Maria Antonietta, “qu’ils mangent de la brioche” [Il popolo non ha pane? Che mangi le brioches]. Buoni propositi che rivelano scarsa comprensione e non risolvono i problemi.» [5]
Un altro esempio di narrazione tossica delle premesse è la mitopoiesi costruita da T.E.Lawrence intorno alla cosiddetta “rivoluzione araba”. Tra il 1915 e il 1916, gli inglesi attaccarono l’Impero Ottomano a Gallipoli e in Mesopotamia, incontrando una resistenza imprevista. Questo scoraggiò le società segrete arabe, che speravano nella guerra per aprire un fronte interno indipendentista. Tali società erano formate da borghesi e da ufficiali dell’esercito e avevano le loro basi in città come Damasco, Baghdad e Aleppo. Di fronte all’intiepidirsi dei loro propositi rivoluzionari, gli inglesi, che di quella rivoluzione avevano un gran bisogno, decisero di rivolgersi ai beduini dell’Hejaz. Nell’introduzione ai Sette Pilastri della Saggezza, Lawrence giustifica questo cambiamento di strategia con un’operazione ideologico-poetica intrisa di orientalismo. Spiega che la forza degli Arabi nasce e vive nel deserto, non nelle mollezze cittadine. E’ nel deserto quindi che deve svilupparsi la rivolta, grazie a una koiné di tribù nomadi, tenute assieme dalla lingua e dalla fede nel Corano.
Raccontando in questo modo le premesse della rivoluzione, Lawrence dimentica di dire che quelle tribù erano buone per sollecitare le fantasie romantiche occidentali e per dare filo da torcere ai Turchi con la guerriglia, ma non avrebbero mai portato a termine una rivoluzione, ricavando la Grande Arabia dalle rovine dell’Impero ottomano. Esse – a differenza degli arabi di città – non erano affatto interessate a costruire una “nazione”, tanto meno uno “stato”. Soltanto i loro leader, tutt’al più, avrebbero potuto diventare capi nazionali, ma di stati messi in piedi da qualcun altro.
L’Accumulo
Nel raccontare una rivoluzione in presa diretta, siamo soliti tralasciare le premesse e andare subito in cerca di un punto d’origine, che getti luce su quanto sta accadendo: una data da festeggiare sul calendario o da studiare in futuro sui libri di scuola. Qualunque storia ha bisogno di un incipit, ma nella struttura del genere “rivoluzione” esso assume una particolare valenza simbolica e fondativa, come una sorta di peccato originale. La sua scelta non è mai arbitraria, in un istante qualsiasi del continuum temporale: molto difficilmente si sente narrare una rivoluzione con un attacco in medias res. Il più delle volte ci si focalizza invece su un avvenimento che rivela una debolezza delle forze governative. Questo perché, come sostiene Charles Tilly [6], il nostro concetto di “situazione rivoluzionaria” comprende tre caratteristiche: la presenza di fazioni che avanzano pretese incompatibili per il controllo dello Stato, l’ampia adesione della cittadinanza a queste fazioni e l’incapacità da parte dello Stato di rispondere adeguatamente – con le buone o con le cattive – alle loro pretese.
In tutti i resoconti delle rivolte nordafricane, si fa già un riferimento mitico al gesto di un giovane laureato tunisino, costretto a fare il venditore ambulante di frutta, che si è bruciato vivo per protestare contro la decisione della polizia di confiscargli la merce. Il suo suicidio ha spinto molti altri cittadini a manifestare il loro dissenso, con una determinazione che ha spiazzato il regime di Ben Ali.
Un inizio del genere non è soltanto un inizio: è una genesi. Esso ha finito per simboleggiare la spontaneità della rivolta e la sua composizione sociale: proletariato giovanile con un buon livello di istruzione. Così, quando ai tumulti si sono affiancati i lavoratori in sciopero e i vecchi dissidenti del Partito Comunista, il loro contributo è stato minimizzato, perché non si armonizzava bene con la tonalità suggerita dal primo accordo della sinfonia.
Una situazione rivoluzionaria contiene sempre diverse situazioni, produce molteplici cambiamenti, in molti ambiti e in tempi diversi, e focalizzarsi su un punto d’origine rischia di occultarne il carattere plurale.
Un buon racconto della rivoluzione dovrebbe avere come prologo le premesse e come primo capitolo un incipit che non sia un punto d’origine, ma provi a racchiuderne più d’uno.
Italo Calvino ha scritto che «l’inizio è un momento di distacco dalla molteplicità dei possibili» [7]. “Distacco” non significa esclusione o isolamento. Abbiamo bisogno di una soglia che parli anche di quanto lascia fuori.
Anche perché l’eccessiva attenzione a un singolo punto d’origine può farci ammalare di miopia cronologica.
La miopia cronologica si ha quando sopravvalutiamo l’importanza degli eventi più recenti e tendiamo a dimenticarci quelli più remoti.
Nel nostro caso, essa può farci raccontare come “rottura rivoluzionaria”, un evento che invece si trova in continuità con quanto accade da tempo. Ad esempio, il “Giorno della Rabbia” organizzato nella Piazza della Perla di Manama è stato frettolosamente raccontato come punto d’origine della “rivoluzione” in Bahrein, quando nel paese sono molti anni che si verificano proteste simili, silenziate dal fatto che il Bahrein di solito non interessa a nessuno.

Qui, applicato all’incipit, si manifesta un problema che vale per qualunque altro momento della narrazione. Per raccontare una buona storia abbiamo bisogno di scendere nei dettagli, di descrivere eventi singoli, di esemplificare intere tipologie. Ma non appena lo facciamo, questa particolarità rischia di essere letta come emblematica, rappresentativa di una totalità, come in una sineddoche velenosa, dove la parte nasconde l’intero. L’unico antidoto, per un narratore leale, è mettersi sempre in cerca della contraddizione, dell’uno che diventa due e del due che diventa quattro. Ad esempio: il popolo del Bahrein protesta a Manama, in Piazza della Perla, contro i suoi governanti. Alla ricerca di dettagli per arricchire il racconto scopro che questo “popolo del Bahrein” in Piazza della Perla è formato da sciiti e che i governanti sono sunniti. Questi due particolari, da soli, attivano il frame della guerra civile tra sette religiose. E il frame della guerra civile nasconde le altre caratteristiche dell’intera rivolta. Per contrastare questo effetto sineddoche, bisogna continuare la ricerca, inseguire la molteplicità, arrivando a scoprire che nello stesso Bahrein si preparano scioperi di vaste proporzioni, che coinvolgono la Alba Aluminium, la più grande fonderia di alluminio del mondo, il cui sindacato dei lavoratori è capeggiato da Ali Bin Ali, un sunnita. E magari, con uno sforzo ulteriore, scoprire che il dettaglio scelto in prima battuta, la protesta degli sciiti in Piazza della Perla, può essere interpretato come prototipo di un’altra tipologia, perché gli sciiti rappresentano la maggioranza povera del paese, e dunque una ribellione di sciiti è anche una ribellione di classe.
Altro esempio: se qualcuno, in piazza Tahrir al Cairo, avesse bruciato una bandiera americana o israeliana, quel gesto particolare, una volta raccontato da televisioni e giornali, avrebbe assunto senz’altro il valore di una sineddoche: se qualcuno brucia indisturbato una bandiera americana, allora tutti i rivoltosi sono contro gli Stati Uniti, ovvero sono fondamentalisti (è interessante notare come questo meccanismo valga anche in absentia: siccome nessuno brucia bandiere americane all’interno di una grande manifestazione in un paese islamico, allora gli amanti del complotto sostengono che dietro l’intera rivolta dev’esserci la CIA).
Nello scegliere i particolari con cui puntellare la narrazione, siamo anche condizionati dalle regole del genere narrativo che stiamo praticando. Nel caso della rivoluzione, siamo spinti a cercare rivolte di piazza, scontri di potere, repressioni, cambiamenti di regime. A quanto pare, il genere di racconto rivoluzionario al quale il nostro cervello è più affezionato è quello delle grandi rivoluzioni novecentesche: il popolo in piazza, la presa del potere. Non consideriamo che ci potrebbero essere generi diversi di narrazione-rivoluzione. Gli Stati sono molto cambiati dall’ottobre del 1917: forse anche gli stilemi del genere “rivoluzione” dovrebbero evolversi di conseguenza. Anche perché, come già detto, una rivoluzione non riguarda sempre e solo il potere, il controllo dello stato, il diritto di espressione. Una rivoluzione si fa senz’altro per le strade, ma è soprattutto una spinta creativa a cambiare il mondo, a chiamarlo con nomi nuovi, a sperimentare l’impossibile.
Nei giorni scorsi sul sito del Guardian [8] è comparsa una cronologia interattiva delle rivolte mediorientali, con tutti gli stati elencati in parallelo e gli avvenimenti più importanti rappresentati con quattro simboli diversi: protesta/risposta governativa alla protesta; mossa politica; cambiamento di regime; reazione della comunità internazionale. In una gabbia così stretta, la demolizione del Monumento alla perla, nella piazza omonima di Manama, ordinata dal sultano al-Khalifa per cancellare un simbolo della rivolta, è stata catalogata come “mossa politica” quando invece si tratta di una mossa semantica. La rivolta ha cambiato segno a un grande monumento, dedicato ai pescatori di perle del Golfo; lo ha fatto scendendo in piazza, non a tavolino, e a quel punto anche il regime è dovuto scendere in piazza, e non per colpire i manifestanti, ma per colpire i loro simboli, in uno strano rovesciamento preventivo di quel che di solito accade quando crolla un regime: l’abbattimento dei simboli del potere e delle statue del leader.
L’unico tentativo che è stato fatto per raccontare queste rivolte senza guardare soltanto alle piazze, ha prodotto risultati insoddisfacenti: mi riferisco al meme “twitter revolution”, nato durante una potenziale rivoluzione colorata in Moldova e poi trasferito al caso tunisino, con una velenosa confusione tra mezzi e cause. Twitter e i social network sono stati strumenti utili di raccordo e di informazione per le proteste tunisine, ma queste proteste non si sono svolte su Twitter. Come ha fatto notare Tarak Barkawi, «i rivoluzionari in Francia e sull’isola di Haiti, negli anni ‘90 del Settecento, ricevevano notizie gli uni degli altri grazie ai vascelli in servizio regolare tra la Giamaica e Londra» [9].
Le narrazioni tecnofile – nel caso del Nord Africa – hanno avuto come effetto quello di rassicurare chi le ascoltava, di rendere la violazione della quotidianità meno dirompente. Se diciamo che in Tunisia si è sviluppata una “twitter revolution” ci sentiamo più a nostro agio che raccontando una rivolta dura, lontana dalle nostre abitudini, con gente che si brucia viva o si ribella contro il prezzo del pane e dell’olio da frittura. Non diversamente, il sultano Al – Khalifa ha tirato in ballo la TV – le immagini in arrivo dagli altri paesi in rivolta – per giustificare il cambiamento chiesto a gran voce dai suoi cittadini: «Questo non è il Bahrain che conoscevo», ha dichiarato. Dimenticando, per l’occasione, che rivolte simili sono in corso da anni, con centinaia di prigionieri politici torturati nelle prigioni di Manama e dintorni.
Twitter e Facebook sono in un certo senso i Lawrence d’Arabia del ventunesimo secolo: porre l’accento sui social network ci dà la piacevole sensazione che queste rivolte “per la democrazia” siano un sotto-prodotto di Internet, lo strumento democratico e partecipativo per antonomasia, il quale è a sua volta un prodotto dell’Occidente. Dunque, ci diciamo, se l’Egitto si è rivoltato grazie a Internet, allora in fondo si è rivoltato grazie a noi, e tendiamo a dimenticare così che il luogo simbolo di quella rivolta è una piazza, non il cyberspazio, anche perché rovesciare un despota via Twitter non è così semplice: primo, perché l’accesso a Internet può essere bloccato, e infatti è stato bloccato, secondo perché anche i dittatori sbirciano nei social network.
Lo Scopo
Nel definire lo Scopo, un tipico ragionamento tossico consiste nel dedurre dalla natura autoritaria di un regime il fatto che le richieste della popolazione consistano solo nella “democrazia”, nei “diritti umani”, e quindi che la rivoluzione sia finita con l’abbattimento del tiranno, dopo il quale si può invocare una “transizione ordinata”, che tenga a bada richieste più radicali.
Più in generale, è sempre tossica – oltre che narrativamente inefficace – la scelta di attribuire agli attori della rivoluzione un’intenzionalità presunta: per raccontare una buona storia, infatti, bisogna sempre attribuire intenzioni precise ai suoi protagonisti. Chi non ha intenzioni credibili diventa un fantoccio e i fantocci hanno bisogno di un burattinaio. Ecco perché, a cent’anni di distanza, torna sulla ribalta il mito di Lawrence d’Arabia, e l’eroico Occidente deve assumersi il fardello di aiutare l’Oriente a liberarsi da sé stesso.
Questo accade anche perché le storie tendono ad accumularsi le une vicine alle altre, a formare agglomerati, sulla base di somiglianze e richiami. Una tendenza che può aiutare o sviare la narrazione, a seconda dell’elemento che funge da attrattore: può trattarsi di una caratteristica superficiale, che nasconde differenze importanti, oppure di una caratteristica profonda, importante al di là delle differenze.
Ad esempio, l’aspettativa creata dal crollo di molti regimi comunisti nel 1989, ha influito negativamente sul racconto della caduta di Ceausescu in Romania (dopo la quale altri esponenti del partito sono rimasti al potere). In Romania c’erano peculiarità che sono rimaste nascoste a causa di questa narrazione comune. Né ci ha aiutato assimilare quell’evento alla tipica narrazione rivoluzionaria del popolo che giudica il Re. Mentre in Francia la testa mozzata di un monarca stimolò il processo rivoluzionario, nel caso della Romania proprio la condanna a morte dei coniugi Ceausescu è servita a nascondere il furto della rivoluzione, la revolutia furata, come già la chiamavano gli studenti rumeni pochi mesi dopo quel giorno di Natale del 1989.
A risultati come questo può portare anche la focalizzazione del racconto rivoluzionario intorno alla figura del dittatore, la cui caduta è un passaggio spesso necessario, ma certo non sufficiente per qualsiasi progetto rivoluzionario.
Una simile personalizzazione è molto presente anche nei racconti che giungono dalla Libia e rischia di essere responsabile di un nuovo effetto Ceausescu: si toglie di mezzo il dittatore per poter raccontare al mondo l’avvenuta rivoluzione, comodo paravento dietro il quale nascondere uno strisciante ritorno allo status quo.
Un’altra accumulazione narrativa di tipo etno-geografico (il frame delle “rivolte arabe”), non aiuta la nostra comprensione degli eventi che interessano l’Oman. Al momento, in quel paese, non ci sono state richieste di un cambiamento radicale nel regime, tuttavia le proteste più dure sono state a Sohar, il centro industriale più sviluppato del paese.
Un simile indizio potrebbe fornirci una ratio più profonda per mettere insieme le diverse narrazioni e allargare lo sguardo: se in Oman si protesta in un grande centro industriale e in Bahrein scioperano gli operai della Alba Aluminium, in Tunisia i giovani disoccupati, in Ohio e Wisconsin gli impiegati pubblici, mentre a Roma, Londra, Lisbona e Parigi scendono in piazza gli universitari senza prospettive, e in Grecia lavoratori e studenti, allora forse c’è una narrazione più vasta per quel che sta succedendo nel pianeta, al di là del mondo arabo, del Nord Africa e del Medio Oriente. Un’accumulazione narrativa più universale, rispetto alla quale la tossina è invece un racconto a macchie di leopardo, che spezza le connessioni e cerca di separare quel che sarebbe simile, insistendo magari su altre somiglianze.
L’Evento centrale
Il nostro frame dell’Evento centrale rivoluzionario, sempre secondo Tilly [10], è quello del cambiamento radicale ai vertici dello stato e dell’amministrazione, con ampi settori delle forze armate che si dichiarano fedeli al nuovo governo.
Anche in questo caso, il modello è centrato sul potere e sui suoi equilibri, come se avessimo bisogno di individuare un cambiamento stabile definitivo e confidassimo di trovarlo solo negli assetti statali, e non anche negli assetti delle coscienze. Così facendo, potremmo finire per confondere la rivoluzione con un colpo di stato – che è rivoluzionario nell’esito ma non nei modi.
Abbiamo visto negli esempi precedenti come ci siano narrazioni tossiche che mirano a rendere più accettabile l’inatteso, ovvero ad addomesticare la dialettica, tanto quella della rivoluzione, quanto quella tipica di ogni racconto. “Tossica” è una storia che insinua l’inammissibile nell’ordine riconosciuto non per mettere in crisi quell’ordine, ma per addomesticare l’inammissibile, per non farcelo riconoscere.
Esistono anche casi nei quali la dialettica viene addomesticata con il procedimento opposto: ovvero “gonfiando” la violazione della norma, facendo sembrare che il mondo sia stato sovvertito, quando invece non lo è stato, così da far passare per cambiamento radicale quella che in realtà è una conservazione. In altri casi ancora, si gonfia la dialettica sperando che la vera rivoluzione si materializzi dopo l’evento centrale, coinvolgendo una cittadinanza che non vi ha preso parte dall’inizio. Narrazioni intossicate da questo wishful thinking sono state ad esempio la “rivoluzione d’ottobre” di Siad Barre in Somalia, o la rivoluzione verde di Gheddafi.
La Via del ritorno, il Risultato e le Conseguenze ultime
Questa è la parte che più spesso ci si dimentica di raccontare, anche se la sua importanza non andrebbe mai sottovalutata. Ci si dimentica di raccontarla per colpa del nostro cervello, dove ogni tappa della narrazione accende emozioni diverse. L’Evento centrale rivoluzionario è un picco emotivo, che può inondarci di sentimenti positivi o negativi, a seconda delle nostre convinzioni. Difficilmente ci lascia indifferenti, visto che i nostri neuroni specchio si accendono nello stesso modo sia quando viviamo un evento in prima persona, che quando ce lo sentiamo raccontare. Se il sentimento è positivo, dopo l’Evento Centrale il nostro cervello, che ha ricevuto una scarica di dopamina, si prende una specie di pausa post coitum. Se il sentimento è negativo, allora siamo preoccupati o impauriti, e la norepinefrina riduce la nostra capacità di attenzione. In entrambi i casi, rischiamo di raccontare con minore interesse quello che ci appare come un semplice epilogo. Inoltre, il nostro frame dell’esito rivoluzionario, ci spinge a pensare che l’Evento Centrale, ovvero la presa del potere da parte dei ribelli, coincida con il risultato finale della narrazione.
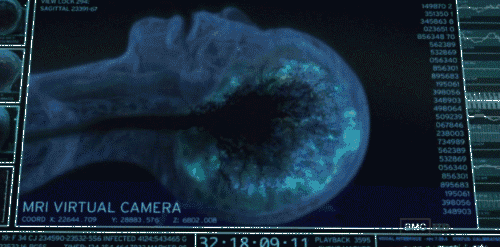
In realtà, la storia insegna che i rivoluzionari, dopo aver rovesciato il regime, fronteggiano situazioni difficilissime e sfide che mettono a repentaglio il loro successo. La narratologia, d’altra parte, ci insegna che un’avventura non finisce mai con la prova centrale, ovvero l’eroe che sconfigge il drago: altri pericoli – e spesso un ritorno in grande stile dell’avversario – attendono l’eroe sulla via del ritorno. Il senso di una storia si misura proprio nella capacità dell’eroe di tornare a casa e cambiare il suo mondo ordinario grazie agli insegnamenti appresi durante prove e battaglie nel mondo straordinario. E’ sulla via del ritorno che l’eroe sperimenta sempre un’ultima prova decisiva, per poter tornare al villaggio con l’elisir. Ed è in quell’ultima prova che l’eroe tragico, di solito, finisce per morire. L’Evento centrale, come rivela il suo stesso nome, è solo metà di una storia e una storia raccontata a metà non può che essere velenosa.
Il vero successo di una rivoluzione dipende dal desiderio di cambiamento che essa riesce a diffondere tra i cittadini, dal livello di creatività che essi investono in questo desiderio e dalla durata temporale di tale investimento.
In una vera rivoluzione questa creatività resta in circolo, non si rapprende appena conquistato il Palazzo d’Inverno. Ed è una creatività condivisa, universale, non imposta dall’alto.
Antonio Gramsci considerava il fascismo una rivoluzione passiva, ovvero una tesi che, accogliendo in sé una parte subordinata dell’antitesi, riuscì a conservarsi e a proporsi come sintesi. Ma il fascismo fu passivo anche perché dovette imporre dall’alto quella creatività che le rivoluzioni non hanno bisogno di pianificare. La rivoluzione semantica fascista fu un colpo di stato contro il dizionario, l’organizzazione del tempo, il galateo… Ridefinì concetti e linguaggi, ma lo fece soltanto a tavolino, e su un tavolino con pochi posti a sedere.
Conclusioni
Abbiamo così completato il nostro excursus in cerca di tossine lungo la struttura narrativa dell’evento rivoluzionario.
Abbiamo visto quali insidie nascondono l’illusione retrospettiva di fatalità, la miopia cronologica, il peccato originale, l’effetto sineddoche, le convenzioni di genere, l’intenzionalità presunta, l’accumulazione narrativa, le macchie di leopardo, l’effetto Ceausescu, la dialettica addomesticata e gonfiata, la stanchezza post coitum.
Il pericolo è quello di intossicare la narrazione oltre il livello di guardia, con il risultato di occultare la realtà e di non capire quel che sta succedendo.
Ma capire, vivere, immaginare e sognare un racconto – grazie all’azione dei neuroni specchio – non sono attività cerebrali tanto diverse.
Capire la rivoluzione e raccontarla in maniera efficace, significa allora saperla sognare, cominciare a viverla, provare a immaginarla.
Grazie.
Wu Ming 2, marzo-aprile 2011
***
 WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917 (47’31”)
WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917 (47’31”)
An article by Hardt & Negri in The Guardian – Are the North-African uprisings revolutions? – Are 20th century references really that useless? – Looking for a “healthily schizophrenic” narrative of the revolution – Picture yourself in a trench by a river – How the Italian working class instantly grasped the anti-war nature of the 1917 February Revolution – What did the revolution look like in their eyes? – Forked tongues and resonances – Jacques Rancière on In the shadow of young girls in flower – What is “haecceity”? And can a sense of haecceity be conveyed through a narrative? – Enter Vladimir Mayakovsky – Lev Trotsky on Mayakovsky – The 150 Million – Conclusions.
PDF HERE
 WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)
WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)
The “colored revolutions” – 1989 – What is a “toxic” narrative of the revolution? – Retrospective illusion of fatality – The first regime to fall down was our regime of discourse on the Arab world – Orientalism and revolution: T.E. Lawrence – Looking for the “Original Sin” – Chronological myopia – The Synecdoche Effect – A timeline in the Guardian website – The meme of the “Twitter Revolution” – Partial intentionality and the Ceausescu Effect – “Divide and conquer” stories – The Main Event and the Wind-Down – The Result and post-coital tiredness – Conclusions.
PDF HERE
QUESTIONS & ANSWERS (19’52”)
***
NOTE
* “How to tell [about] a revolution [from —]” = “Come raccontare / distinguere una rivoluzione da…”
1. Aristotele, Poetica
2. G. Lakoff, The Political Mind, Viking Penguin, 2008 (tr. it, Pensiero politico e scienza della mente, B. Mondadori, 2009)
3. Ibidem
4. Lo schema che segue è una mia piccola rielaborazione di quello proposto da S. Narayanan come modello computazionale di ragionamento metaforico intorno a eventi complessi.
5. H. Yucesoy, Revolutions: what went wrong in the West?, pubblicato su aljazeera.net il 27.03.11
6. Ch. Tilly, Le rivoluzioni europee, 1492 – 1992, Laterza, 1993
7. I. Calvino, Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 1988
8. Arab spring: an interactive timeline of Middle East protests
9. T.Barkawi, The globalization of revolution, pubblicato su aljazeera.net il 21.03.2011
10. Ch. Tilly, op. cit.
***
 Di questi temi si parlerà anche domani, martedì 19 aprile, all’università La Sapienza di Roma.
Di questi temi si parlerà anche domani, martedì 19 aprile, all’università La Sapienza di Roma.
H.16, Aula Amaldi del Dipartimento di Fisica “G. Marconi”
Incontro “Conflitto, rivoluzione, potere. Alla ricerca di un immaginario condiviso”
con WM1 e Geraldina Colotti
Iniziativa a cura del collettivo Militant
Clicca per vedere la locandina
(Nella locandina figura anche Serge Quadruppani, ma per via di un contrattempo non potrà esserci)
WM1 e WM5 saranno a Roma anche il giorno dopo, e prenderanno parte a due eventi diversi, vedi calendario.

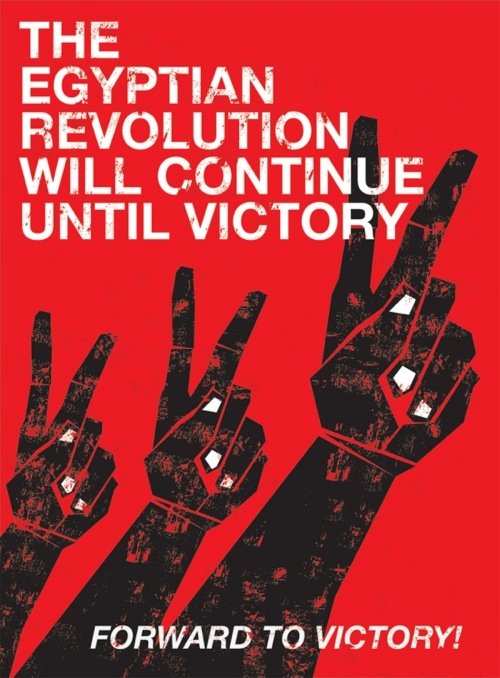
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Un piccolo commento sull’utilizzo dei social network.
Pensare di fare una rivoluzione con Facebook (!!!!) e Twitter è un po’ da ingenui. Come se il Potere non sapesse utilizzare questi mezzi, sia per bloccare il flusso di informazione che per manipolarlo. Forse è vero, per noi occidentali pensare ad una “Twitter Revolution” è rassicurante. Ci fa credere che chi è sceso in piazza voglia essere come noi, chiedendo Fornarina, MTv ed H&M per tutti.
Un mio amico che è stato in Tunisia, mi ha detto che i social network sono entrati in una seconda fase, portati dalle classi medio-alte. Le persone che arrivavano dalle campagne non sapevano neanche cosa fosse Twitter. Io penso che le eventuali manipolazioni siano state facilitate proprio dai social network. E’ solo un’ipotesi, ma non così paradossale.
[…] dunque a mantenere la promessa: questa notte ci è arrivata la segnalazione del post “Disintossicare l’evento, ovvero: Come si racconta una rivoluzione?“, traduzione italiana dell’intervento di Wu Ming […]
Soccmel, che silenzio! Vi abbiamo intimoriti? :-D
Provo a “rompere il ghiaccio” riallacciandomi al discorso sul tempo della rivoluzione fatto ieri da WM1 all’incontro organizzato da Militant, sperando che presto venga messo online cosi` da permettere a chi non era presente di poterlo ascoltare. Non so se verra` fatto un post ad hoc ma di certo il discorso non e` fuori tema qui. Quando ieri WM1 spiegava come il tempo e` ancora di piu` sincrono e totalizzante nel post fordismo (quello che ci aveva promesso liberta` e flessibilita`… ma ormai tutti abbiamo capito il vero significato di flessibilita`) mi sono venute in mente le scene raccapriccianti di store e grandi magazzini presi d’assalto all’uscita dell’ennesimo *nuovo* prodotto. Ecco, anche in quella che in teoria sarebbe una libera scelta (di massificarsi tra l’altro) del *tempo libero* – altra curiosa invenzione, produce un tempo standardizzato uguale per tutti. Sono perfettamente d’accordo sul fatto che se una rivoluzione non si pone l’obiettivo di stravolgere totalmente la temporalita` quotidiana non puo` definirsi tale.
Ps. mi scuso per gli accenti alla caxxo di can, credo di averlo dimenticato nei passati commenti, ma la tastiera americana ha questo problema.
@Wu Ming: effettivamente piuttosto si!! ;-)
Grande divergenza di pensiero e competenza.
Ho notato molti riferimenti ad autori o scuole di pensiero che non vengono citate direttamente e le vorrei condividere per tentare una sincronizzazione intellettuale.
Sulle teorie narratologiche esposte, c’è sicuramente il riferimento agli studi di J. Campbell (ripresi poi da Vogler in campo cinematografico nel celebre “Viaggio dell’Eroe”). C’è il “transfert” di Lacan in quelle riguardanti la retroattività interpretativa e nelle varie tossine “sineddochiche” ho ritrovato riverberi alla semiologia di Eco e la così detta “deriva interpretativa” di stampo gnostico-ermetica descritta in “I Limiti dell’Interpretazione”.
In ultimo, riguardo al collegamento socialnetwork/narrazione penso che funzioni un pò come un reality show, dove il destino dei concorrenti (gli utenti) non è decretato dal pubblico (i fatti) ma da chi fa il casting (chi dà le notizie), basandosi su una tabella molto simile a quelle di Vogler per il Viaggio dell’Eroe e i personaggi archetipici che si può trovare ben descritta nel libro “Fare Crossmedia” di Max Giovagnoli. Forse il concetto di crossmedia (una narrazione non solo veicolata ma rafforzata attraverso il passaggio fra più medium) può aiutarci ad interpretare l’idea di “rivoluzione” che sta passando fra l’opinione pubblica oggi. Perchè è di questo che si tratta, di rivoluzioni Crossmediali: strada, twitter, tv e di nuovo strada.
Un saluto.
mi e’ venuta questa idea balzana: ho aperto google-cerca-immagini e nella maschera ho scritto “revolution”. e’ saltato fuori questo:
http://www.google.it/search?q=revolution&hl=it&client=firefox-a&rls=org.mozilla:it:official&gbv=2&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=vi&biw=1069&bih=605
cioe’ un’ accozzaglia di immagini senza capo ne’ coda. ho riprovato scrivendo “rivoluzione” ed e’ andata un po’ meglio. “revolucion” e “revolucao” meglio ancora. “revolucija” e’ una merda.
in arabo e’ saltato fuori questo, che non so come decifrare:
http://www.google.it/search?tbm=isch&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ait%3Aofficial&hl=it&source=hp&biw=1069&bih=605&q=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
mi sembra abbastanza interessante.
Ho appena finito di leggere l’intervento… davvero stimolante, specie per il sistema immunitario dell’apparato cerebrale…
Trovo particolarmente tossico lo schematismo riduzionistico delle immagini e delle narrazione televisive che filtrano le vicende rivoluzionarie nordafricane… Nei contesti telegiornalistici esse finiscono sempre per figurare come – e ad essere ridotte a nulla più che – la mera espressione istintiva della rabbia di popoli affamati, tenuti in catene da dittatori crudeli e sanguinari (si sente spesso parlare di “rivolte del pane” e simili)… Ciò temo contribuisca in maniera notevole alla penetrazione nell’immaginario collettivo di una visione quasi “preistorica” di tali avvenimenti, nel senso proprio di antecedenti alla storia e, almeno in un certo senso, ancora estranee ad un futuro processo storico di civilizzazione (quello che le società al di sopra del Mediterraneo già avrebbero attraversato da secoli, in conformità alle pretese paternalistiche della tribù occidentale)… Ed è chiaro che da una simile distorsione narrativa all’ingerenza politica (quando non all’intervento militare) il passo è breve… come se la prima fosse propedeutica ai secondi, una sorta di operazione di propaganda di guerra…
Un’ultima cosa: se WM1 ha ragione (come credo) nel suo precedente intervento, disintossicando l’Evento è inevitabile che si verifichi una pluralizzazione di esso (con conseguente perdita della maiuscola)… o sbaglio?
@Nexus
Scorrendo il testo, i debiti intellettuali che mi vengono in mente sono tanti, almeno uno per ogni paragrafo, e sempre molto disparati. A fare un elenco, si rischierebbe, appunto, di fare soltanto un elenco, quindi rinuncio prima di cominciare. Però certo Campbell/Vogel sono un punto di riferimento per quanto riguarda la struttura narrativa, mentre rispetto all’effetto sineddoche, sono partito dalla “particolarità”, una delle dieci caratteristiche della narrazione come strumento cognitivo, illustrate da Jerome Bruner ne “La costruzione narrativa della realtà” (Versione pdf in inglese: http://goo.gl/gMDiw). Quanto all’aspetto crossmediale (che io preferisco chiamare transmediale, per fedeltà a H.Jenkins): da un lato, è forse pleonastico dire che un Evento è crossmediale, dal momento che oggi qualsiasi evento importante distribuisce i suoi contenuti su più piattaforme che poi interagiscono tra loro in maniera ricorsiva. Se vogliamo che il termine “crossmediale” non si svuoti di senso (come è successo con “multimediale”), allora dobbiamo adottarlo in senso stretto solo per quei progetti narrativi che nascono già concepiti per una fruizione e un’interpretazione di tipo transmediale. In questa accezione più “dura” non sono sicuro che le rivoluzioni in corso siano crossmediali. Spesso si limitano a trasporre in un ambito quel che è “nato” in un altro (vedi ad es. la cronaca via Twitter delle manifestazioni, o il loro racconto televisivo, o ancora slogan nati sui social network e poi portati per le strade)
@ tuco & Arcinolo86: domani rispondo anche a voi…
Quanto segue, in realtà, mi è venuto in mente leggendo il precedente intervento di WM1, ma mi pareva fosse sul limite dell’OT, ora invece – anche alla luce delle suggestioni lanciate da sweepsy, tuco e Arcinolo86 in risposta a questa bella “mappa” propostaci da WM2 – provo a condividerlo.
Tutto parte dal termine evento.
Nelle narrazioni tossiche, si è detto, ci si concentra sull’Evento, si perde di vista la pluralità degli eventi, degli agenti e delle cause, si uccide la complessità, si descrive un fenomeno come un oggetto statico o, al massimo, interessato da un movimento uniforme, unidirezionale, ordinato. All’oggetto in questione di solito viene attribuita un’unica paternità e all’atto del narrare viene isolato dalle sue conseguenze ultime.
Cambiando campo da gioco, a me pare che queste caratteristiche siano in tutto è per tutto analoghe a quelle della politica del Grande Evento.
Ovvero a quella politica di pianificazione della crescita e dello sviluppo (e qui per quanto mi riguarda siamo alle false premesse) che prevede di investire in grandi eventi e grandi opere, concentrando risorse economiche e umane su un unico obiettivo limitato nel tempo e nello spazio, senza curarsi della situazione contingente e delle prospettive future. Tali eventi/opere sono calate dall’alto e proposte come la ricetta unica per risollevare le sorti dell’economia, della cultura, dello spettacolo, della nazioni, ecc. E allora giù di grandifestival, di salonidellibro, di maratonetelevisedibeneficenza, di pontisullostretto e lineeadaltàvelocità.
Siano quello che siano, si tratta di grandi oggetti/eventi che standardizzano, omogeneizzano, appiattiscono la pluralità e la complessità piuttosto che esaltarla, e una volta finiti – l’ottica è quella di non fare prigionieri – cio che resta sono i loro inutilizzabili rifiuti (vedi la fine che hanno fatto le piste di bob e i campi di curling e decine di altre mostruose e costosissime opere costruite per le olimpiadi invernali di Torino 2006)
Ecco qualcuno, mi potrebbe dire che ho scoperto l’acqua calda e qualcun altro che sulla base della pura affinità verbale associo fiele a miele – sono in realtà le critiche mi muovo io stesso – ma credo che quella del narrare la complessità, sia la stessa lotta di chi prova a creare sui territori spazi sociali autonomi, e che la critica spietata alle narrazioni tossiche vada nella direzione all’opposizione ferma alla politica dei grandi eventi.
Mi sembra che negli ultimi commenti si sia iniziato a usare la parola “Evento” (da sola, al singolare e con l’iniziale maiuscola) in un’accezione negativa, più o meno come sinonimo di “falso evento”, ma così facendo si introducono elementi di confusione concettuale.
Quando nei miei interventi ricorro a quella parola, sto usando un concetto filosofico. Quando un filosofo come Badiou scrive “Evento” (Évenement), usa la maiuscola non per semplice reverenza, bensì per un motivo “tecnico”: vuole distinguere l’Evento da un mero “fatto” e/o da ciò che “succede”, cioè si sussegue a qualcos’altro in una serie più o meno ripetitiva e più o meno prevedibile (cfr. quando commentiamo un episodio dicendo, laconicamente: “Sono cose che succedono”).
L’Evento non è qualcosa che, semplicemente, “succede”, ma qualcosa che *interrompe* le serie e, nel farlo, modifica in modo significativo e riconoscibile la nostra soggettività, il nostro modo di stare al mondo.
In questo discorso, “Evento” non può essere sostituito con “gli eventi”, perché quest’ultima espressione farebbe pensare a dei semplici “fatti”, a degli episodi, o addirittura a degli appuntamenti. Non a caso si parla di “eventi della giornata” etc.
L’Evento è invece quello che noi riconosciamo come momento di svolta nelle nostre vite:
– è Evento un innamoramento che dà vita a un rapporto di coppia e magari in futuro ci renderà genitori;
– è Evento il manifestarsi di un processo rivoluzionario;
– è Evento una conversione religiosa;
Etc. etc.
Noi ci guardiamo indietro, e riconosciamo l’Evento.
A questo punto Badiou introduce un concetto che io trovo bellissimo, molto poetico: la “fedeltà all’Evento”. Ovvero: a quella svolta che ha modificato in modo significativo il mio modo di stare nel mondo, e quindi mi ha fatto conoscere e vivere una nuova verità del mio stare nel mondo, io rimango “fedele”, cioè mi sforzo di vivere quella trasformazione e quella verità nel modo più pieno, mi impegno per vivere quell’esperienza nel modo migliore.
L’Evento è già (ed è sempre) una molteplicità, non è un singolo fatto.
Faccio un esempio: Badiou ha scritto un libro sulla “fedeltà all’Evento” da parte di Paolo di Tarso (aka San Paolo).
Bene, l’Evento a cui Paolo è fedele è la resurrezione di Cristo, ma ovviamente, la resurrezione non è concepibile come *singolo episodio*, per quanto eccezionale sotto ogni punto di vista: l’Evento è tale perché rende manifesto un insieme che include la predicazione di Gesù, il riconoscimento di Gesù come messia e Figlio di Dio, la passione e la morte, la Pentecoste, l’apostolato e – soprattutto, nell’ottica di Paolo – la conversione sulla via di Damasco. Tutto questo è parte dell’Evento, è una molteplicità, una costellazione di accadimenti che, a un certo punto, viene messa nella giusta prospettiva e acquisisce un senso nel suo complesso.
[L’esempio torna utile anche per precisare un’altra cosa: l’Evento non deve nemmeno appartenere per forza all’ordine dei “fatti” nel senso di accadimenti riscontrabili, comprovabili, reali nell’accezione più rigida del termine: la resurrezione di Cristo è un Evento anche per chi, come me (e del resto anche Badiou), la ritiene un’invenzione, perché l’insieme, la costellazione di accadimenti che l’espressione racchiude e riassume ha un senso complessivo riconoscibile e marca una svolta, un’interruzione delle serie precedenti, tant’è che noi contiamo gli anni dalla presunta data di nascita dell’uomo che i cristiani credono protagonista della resurrezione.]
Nel parlare di “Evento rivoluzionario”, io mi riferisco sempre (ma anche WM2 si riferisce sempre) al macro-evento molteplice.
Invece, quando giornalisti e opinionisti vanno in cerca dell’evento, hanno in mente un episodio da *individuare*, un singolo punto su cui piantare la bandierina dell’informazione. Appunto, il cosiddetto “evento [presuntamente] principale” su cui WM2 si è spiegato molto bene, e che la narrazione tossica della rivoluzione descrive come culmine, quando invece è solo l’inizio, e l’Evento vero (cioè, a questo punto penso che ci siamo capiti, la *fedeltà* all’Evento) sta cominciando.
Di fronte a un processo, a una costellazione, a una durata estesa nel tempo, a un senso complessivo da attribuire retrospettivamente, l’informazione quale noi la conosciamo si trova a disagio, se non in brache di tela.
[Un inciso: la similitudine che filosottile riscontra, cioè quella tra il modo “tossico” di descrivere un processo rivoluzionario e il modo tossico di impostare una politica culturale (investendo su grandi, “puntiformi”, *occasionali* kermesses anziché sull’essere fondativi operando in profondità), funziona molto bene. Faccio presente che il candidato del PD alle amministrative bolognesi sta interpellando scrittori ed editori attivi in città riguardo all’idea di “Bologna capitale mondiale del libro” nel 2014; e mentre si vagheggiano astrattezze (Grandi Eventi che solitamente rimangono avulsi e alla città lasciano ben poco) vengono tagliati i fondi alle biblioteche comunali, vengono ridotte le ore di apertura, si insiste sulla precarizzazione e l’esternalizzazione etc. Per approfondimenti, chiedere ai Bibliotecari Necessari. Fine dell’inciso.]
Per rendere l’idea della molteplicità del momento della svolta, e sopratuttto per spiegare che, se il *riconoscimento* dell’Evento è in fondo retrospettivo (o almeno, sembra esserlo in Badiou), al contrario la *visione* dell’Evento può invece essere in anticipo sullo stesso, ho cercato di impostare quel discorso sull’ecceità, cercando esempi storici e “mettendo al lavoro” testi di Deleuze, Proust, Rancière, Majakovskij.
@WM1
Ti ringrazio di questo chiarimento, per me che non ho mai letto Badiou (se pensi che stia dicendo una castroneria fammi un fischio) è possibile ravvisare alcune tracce di ciò che dici nelle Tesi di filosofia della storia di Benjamin. In ogni caso mi documenterò, anche perché, il concetto di fedeltà all’evento piace molto anche a me.
Ciò che stavo cercando di dire – forse anche grazie a un parziale <i<misunderstanding – però è un’altra cosa.
Ci sono narrazioni di un evento – è vero e sono d’accordo, e la promenade delle cinque ragazze di Proust, come hai brillantemente fatto notare, ne è una realizzazione – che restituiscono la molteplicità, la complessità, la stratificazione, la sedimentazione e il groviglio di forze in gioco, e che di un Evento X sanno al medesimo tempo mostrare le origini, le parti, il tutto, le possibili connessioni, quelle impossibili e quelle auspicabili. Al contrario, è qui siamo a quelle tossiche, ci sono narrazioni che precedono, sottendono e divulgano e sintetizzano un evento in maniera univoca e totalitaria, gli esempi si sprecano.
Azzardavo (con quel rovello: scopro l’acqua calda? metto insieme razzo e mazzo?) che i fautori di tali narrazioni totalitarie appartengano alle stesse forze che propongono e si fanno paladine di grandi Eventi millantati come “rivoluzionari”, fondanti, formativi, risolutivi. Ritengo, e qui sì, affermo cose che a qualsiasi materialista storico (e poetico) appaiono evidenti, che ogni Evento (innamoramento e conversione compresi) sia il frutto dell’interazione caotica di forze che riescono a coalizzarsi e organizzarsi. Dico azzardo, ché allo stato attuale, mi mancano le connessioni sufficienti a dimostrare ciò che dico.
a proposito delle “twitter revolution” e di come internet e i social network possano essere usati anche dai dittatori, non solo per sbirciare:
Syria’s Twitter spambots
Twitter isn’t always a tool for protest – in Syria pro-regime accounts have been set up to flood the pro-revolution narrative
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/21/syria-twitter-spambots-pro-revolution
Per un problema tecnico il mio commento su Evento etc. era scomparso, adesso è di nuovo tutto a posto, grazie a filosottile x la segnalazione!
C’è un’intervista di Michel Foucault in cui vengono toccati molti temi di cui i vostri due pezzi provano a render conto, a narrare. La si trova all’inizio di Microfisica del potere. Ne cito alcuni pezzi.
Sull’evento (qua definito avvenimento):
“Il mio problema non è stato affatto di dire: siamo nella discontinuità, restiamoci. Ma di porre la domanda: come è potuto accadere che si diano in certi momenti ed in certi ordini del sapere, questi bruschi distacchi, queste precipitazioni dell’evoluzione, queste trasformazioni che non rispondono all’immagine tranquilla e continuista che se ne ha di solito.”(6) Ciò che è rilevante è la “modificazione nelle regole di formazione degli enunciati che sono accettati come scientificamente veri”(6) Mentre secondo alcuni etnologi e antropologi, “l’avvenimento è ciò che ci [a loro etnologi e antropologi] sfugge, è il luogo della «contingenza assoluta». Noi siamo i pensatori, gli analizzatori di strutture. La storia non ci riguarda, non sappiamo cosa farcene” (8) per MF “Il problema è allo stesso tempo di distinguere gli avvenimenti, di differenziare gl’insiemi di relazioni ed i livelli ai quali appartengono, di ricostituire i fili che li legano e fanno sí che si generino gli uni a partire dagli altri.” (8)
Sul narrare, scrivere:
“La storia non ha «senso»; il che non vuol dire che sia assurda, o incoerente. Essa è al contrario intelligibile,e deve poter essere analizzata sin nel piú piccolo dettaglio: ma secondo l’intelligibilità delle lotte, delle strategie e delle tattiche.” (9) “la teoria politica è rimasta ossessionata dal personaggio del sovrano. […] Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non sia costruita intorno al problema della sovranità, dunque della legge, dunque dell’interdizione.” (15)
Sulle rivoluzioni:
“lo Stato è una codificazione di relazioni di potere molteplici che gli permette di funzionare, e la rivoluzione è un altro tipo di codificazione di queste relazioni. Il che implica che ci siano molti tipi di rivoluzione, tanti quante sono le codificazioni sovversive possibili delle relazioni di potere e che si possano d’altronde perfettamente concepire delle rivoluzioni che lascino per l’essenziale intatte le relazioni di potere che avevano permesso allo Stato di funzionare.” (16-17)
A partire da queste osservazioni di MF e dalle vostre mi pare che si potrebbe aprire un interessante tavolo sul ruolo delle discipline contemporanee, dei/delle loro interpreti, su un possibile ritorno “politico” del ruolo dello scrittore/narratore (anche se Wu Ming non è “semplicemente” categorizzabile in tal modo, per esempio), ma anche del “metastorico” (Hayden White potrebbe essere molto utile se confrontato con il saggio di WM2).
Mi spiace di esser andato per le lunghe, ma se voi postate di ‘ste cose, ci tirate per i capelli…
@Arcinolo86
Sulla pluralità dell’Evento ti ha già risposto il mio compadre WM1: disintossicare l’Evento significa riportarlo alla sua pluralità – perché l’Evento è plurale – e allo stesso tempo sottolineare le verità universali che esso manifesta – perché ogni soggetto che partecipa all’Evento è trafitto dalla stessa verità, cioè da un principio comune a gruppi e individui, al di là delle differenze.
Sulle “rivolte del pane”: come dice Lakoff, ogni narrazione contiene tossine. In questo caso, “rivolta del pane” evoca scenari ottocenteschi (non direi preistorici) e può farci credere che i popoli del Nordafrica sono “rimasti indietro”. Specie se riduciamo *tutte* le motivazioni degli insorti alla questione dei generi di prima necessità. Eppure, ricordare che tra quelle motivazioni c’è stato *anche* il prezzo del cibo, mi sembra invece un elemento salutare, che ci costringe a fare i conti con la questione del cibo trattato come un merce qualsiasi, una merce sulla quale si specula, in borse apposite, come si specula sul prezzo del petrolio o dei diamanti.
In Occidente tendiamo a “decaffeinare” tutto, dal latte 0% grassi al gelato di soia alla “transizione ordinata” post-rivoluzionaria. Dire che queste rivolte nascono *anche* dal prezzo del pane, significa introdurre caffeina nel racconto “zeropercento”, tutto incentrato sulla “libertà di espressione” e la “democrazia” come richieste fondamentali degli insorti.
@tuco
Le immagini che Google restituisce per “revolution” si riferiscono più a marchi, loghi, sigle & prodotti che non a eventi reali: la rivoluzione francese (2 immagini) e quella haitiana (1) mi sembrano gli unici due esempi (e di sicuro arrivano grazie a pagine francofone…). Se ne può concludere che “la rivoluzione è ormai soltanto un marchio”, oppure che “rivoluzione” è uno dei pochi termini della tradizione culturale marxista ad essere ancora cool, egemone, affascinante. Non so…
La ricerca con la parola araba restituisce soprattutto immagini che vengono dall’Iran e dalla “rivoluzione” di Komheini, perché quella, nel mondo arabo, è la rivoluzione per antonomasia. Sarà interessante verificare tra qualche mese se ci saranno cambiamenti: a patto che la traduzione del termine sia quella corretta, dovremmo veder spuntare immagini dell’Egitto, della Tunisia, e magari anche dello Yemen, della Siria… Stiamo a vedere.
Pezzo cristallino. Mi piace soprattutto questo passaggio:
“Come cantastorie, mi piacerebbe produrre narrazioni che aumentino tale consapevolezza, che limitino il più possibile il proprio potere di nascondere la realtà e che anzi incoraggino narrazioni alternative, fornendo al lettore spunti, appigli, crepe. Credo che un narratore dovrebbe essere leale, non obiettivo.”
Rifacendomi anche ai commenti in coda al epzzo di WM1, direi che tutte le arti (o perlomeno, tutti gli *artisti* che condividono un certo sentire) dovrebbero adottare questo punto di vista. Mi sembra che il mondo dei giochi di ruolo possa essere molto fertile in questo senso (anche perché nel giro di 30 anni è diventato qualcosa di molto più profondo, complesso e “serio” rispetto alle robe tipo Dungeons&Dragons…): incoraggiare narrazioni alternative fornendo spunti e appigli è proprio quello che i giochi di ruolo fanno. Se poi lo facessero intenzionalmente, stimolando nei partecipanti non solo una generica “capacità creativa” (che pure sarebbe socialmente utilissima!), ma anche una capacità critica che passi dalla protesta alla proposta… sarebbe il massimo.
Nel resto d’Europa da questo punto di vista sono avantissimo. Due esempi a caso: http://nordiclarptalks.org/post/584157482/transmitting-a-political-vision-through-larp e http://www.gentechegioca.it/smf/index.php/topic,3839.0.html). In Italia è stata fatta qualche sperimentazione (di recente ho visionato “Brigata Monicelli”, che devo leggermi per bene) ma, a quanto ne so, niente di particolarmente visibile/memorabile/organico.
Ciao
FG
…allora mi sbagliavo: non conoscevo Badiou, e da sempre diffido delle maiuscole… ringrazio comunque WM1 per l’ampiezza e la precisione del chiarimento…
@WM2: non era affatto mia intenzione sminuire o mettere in discussione l’importanza della componente “alimentare” nella rivolta… il rischio di rendere tossica la narrazione si nasconde a mio avviso dietro l’elevazione di essa a vero ed unico motore rivoluzionario… come a dire: dategli da mangiare e smetteranno subito di urlare per le piazze… poi, per il resto, siamo perfettamente d’accordo…
[…] Continua qui Questo articolo è stato pubblicato in Antigone ed etichettato con mitopoiesi, narrazione, rivoluzione. Includi tra i preferiti il permalink. […]
Edit: mi dicono che il gdr di cui parlo sopra si chiama ora “Brigata Brancaleone”, per evitare di confondersi con le “Brigate Monicelli” che – per davvero! – hanno iniziato a comparire a Roma (basta una google-ricerca). Quando la realtà supera la fantasia…
Qualche settimana fa al Free Media Days di Perugia si è parlato dell’espressione “Twitter Revolution” e del suo uso improprio. Qui gli interventi (si ascoltino a riguardo quello di Silvano Cacciari e soprattutto quello di Daniele) http://arav.ventuordici.org/?path=RnJlZV9NZWRpYV9EYXlzLzIwMTEvU29jaWFsTWVkaWE – Viene citato anche “the twitter revolution must die” di Meijas http://blog.ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/ e The Net delusion di Morozov http://www.guardian.co.uk/books/2011/jan/09/net-delusion-morozov-review
Allora io non penso che la rete sia la soluzione di tutto. Quello che voglio dire è che la TV ha remato tantissimo contro i referendum. E ha preso anche lei le sue sberle.
La caratteristica fondamentale della TV è nell’essere unidirezionale. Non si riesce a fare contenuti senza una potenza editoriale dietro. La tv sceglie cosa guardi e quando. Se te vedi dei pezzi di cose su youtube è diverso. Sono state girate dalla televisione ma non le fruisci come loro vogliono. Scegli i pezzi. Li ripubblichi. Alla fine può nascere una tendenza su un pezzo di trasmissione. Che ti abbiano messo la partita della nazionale quel giorno o meno.
Coi social network, alla fine credo facebook più di twitter, si riesce a fare informazione e opinione (anche attiva talvolta) come coi blog. Che il pensiero dominante sia dominante anche li è un fatto, ma perchè lo è anche nella società. Con la TV (vista in modo tradizionale soprattutto) si creano pensieri dominanti che non lo sono nella realtà.
@ pedrilla
scrivi:
“la TV ha remato tantissimo contro i referendum”.
Ok, ma
[il resto del commento è scomparso per un errore di edit, N.d.R. :-/]
Sono d’accordo sul clickactivism (io per esempio cerco di farlo il meno possibile). Quello che mi preme sottolienere è che
quando di ci
“Solo che la TAV non la fermi coi trending topic di Twitter, non la fermi cliccando su “Like” né lasciando il tuo nome in calce a una petizione on line. La fermi se fai tutto questo *e* vai a dare solidarietà attiva a chi fa il presidio, che è un’attività fisica, una cosa che costringe a muovere il culo.”
sono d’accordo al 100%. Pensare di spostare la vita reale in una in rete (esperimento second life) non funziona. Ti può servire da nuovo e pericolosissimo “oppio dei popoli” ma non aiuta. Quello che invece vedo di positivo è come sostituivo (per ora parziale) del mezzo televisivo e delle modalità storiche di comunicazione delle notizie e delle idee.
La TV comunque ancora vede la centralità di 2/3 editori. SE questi decidono che di TAV non si parla nel dettaglio, non si analizzano le cose e non se ne discute. Puff… succede che va così. Dopo di che la mobilitazione e soprattuto il coinvolgimento ai soggetti meno politicizzati diventa più difficile.
Impedire una cosa del genere sui social network è praticamente impossibile, per come sono stati pensati e per quella che è la caratteristica principale del WEB 2.0.
In queste cose ci vedo una differenza profonda tra TV e SN. Ora alcuni prodotti TV sono acceduti e ridiffusi in un modo che deriva dai social network, anche questo un po’la sta cambiando.
Però se te guardi alla TV nelle ultime settimane raccontava un paese profondamente diverso da quello che è andato a votare. I social network raccontavano invece questo paese.
Diciamo che sono uno strumento assai migliore per raccontare la realta`?
Ovviamente sostituircela sarebbe una pazzia
p.s:
Quando dico televisione intendo canali televisivi.
concordo sul clickactivism (anche se di norma utilizzo slacktivism). e non credo che il web sia salvifico di se (ogni volta che sento qualcuno magnificarlo gli ricordo che la maggior parte dei siti più visti tratta porno).
quindi, benchè creda che la rete abbia svolto un ruolo importante nel successo dei referendum, non ritengo che ad essa vada tutto gran parte del merito che, a mio giudizio, sta nei contenuti (e, come ogni cosa, nel momento storico).
per spiegarmi meglio porto ad esempio quanto accaduto nel paese della mia compagna, Roccarainola, dove 2 anni fa la gestione dell’acquedotto è stata data ai privati. la popolazione residente è composta principalmente da anziani non scolarizzati che sicuramente non usano social network (la maggior parte dei giovani è fuorisede). l’affluenza è stata del 61,95% (di pochissimo inferiore a quello delle regionali 2010) ed i SI sono stati 99,11%. (purtroppo non so in quali altre città sia stata privatizzata la gestione, ma un analisi del dato sarebbe interessante).
in ogni caso, riconoscendo comunque il ruolo dei social network, provo a darmi una spiegazione sul perchè hanno avuto questo successo per i referendum mentre non ha canalizzato le energie sufficienti per #italianrevolution? (so che è stato discusso già nell’altro post):
perchè, in questo caso, il gesto era semplice, ‘familiare’ e, soprattutto, molto limitato nel tempo (veni, vidi, #iohovotato). mentre, azioni del tipo #italianrevolution implicano una dedizione che in molti non sono disposti a concedere ( http://goo.gl/GCTna un commento di @iRevolt su questo che vi avevo già segnalato su twitter ma credo possa avere senso anche qui).
Sulla vecchia e nuova non unidirezionalità credo che la differenza sostanziale consista nel fatto che ‘dall’altro lato della cornetta’ ci siano gli altri commentatori e non con lo strumento… e non credo che chi lascia un messaggio lo faccia nella speranza che venga letto da un membro della redazione. ciò detto lo strumento può essere il meglio programmato ma, se la community non produce contenuti*, allora è realmente interpassività.
ciao
* su questo. è una mia ferma convinzione che l’utilizzo di hardware come ipad, iphone e tavolette in genere, spinga verso un utilizzo più passivo della rete . (consumatori piuttosto che produttori di contenuti…. un po come la metamorfosi da cittadino in consumatore)
p.s. sorry for the chaos ma ho scritto in ufficio durante una pausa caffè
Non solo la rete non è la soluzione di tutto, ma il discorso “la rete ci salverà. La rete ha vinto” a me pare che sia paurosamente funzionale al mantenimento dello status quo. Se la rete vince, vuol dire che noi non abbiamo smosso il culo, ergo non è cambiato niente.
Non posso fare a meno di pensare che tutti quelli che proclamano “la rete è buona, la rete ci salverà” siano dei gran reazionari.
Riprendo un attimo qua il discorso che stavo facendo su Twitter, premettendo che parlo da non esperta di filosofia, semplicemente da appassionata occasionale.
Trovo particolarmente significativo, riguardo al tema clicktivismo, anzi, quasi una perfetta metafora filosofica di esso, il concetto di “Soggetto interpassivo” di cui parla Zizek, contrapponendolo al concetto a la page di “interattività”. Voi citavate (Sempre su Twitter) l’esempio delle risate registrate nelle sitcom (E’ il media a ridere per noi togliendoci dalla responsabilità di ridere) e c’è anche il passaggio di dopo che spiega perfettissimamente il concetto.
Riportando pari pari
“L’altra faccia dell’interattività è l’interpassività. L’inverso dell’interazione con l’oggetto (…) è la situazione nella quale l’oggetto mi prende, mi espropria della mia passività cosicchè è l’oggetto stesso a godere dello spettacolo al mio posto sollevandomi dal dovere di goderne a mia volta. Pressochè qualsiasi aficionado del videoregistratore (…) sa bene che l’effetto immediato del possedere un videoregistratore è che si guardano meno film di quanto non si facesse ai bei vecchi tempi del semplice apparecchio televisivo (…) Benchè io non guardi realmente quei film la consapevolezza che le pellicole che amo siano archiviate nella mia videoteca mi da una profonda soddisfazione, come se il videoregistratore le stesse guardando per me, al mio posto”
Sostituendo il lottare al “godere dello spettacolo”, si capisce perfettamente. Ora, considerazioni mie personali derivate:
A) Tocca distinguere tra -appunto- web come mezzo di interattività (buono) e web come mezzo di interpassività. Nella prima categoria rientrano sia l’hacktivismo che l’uso informativo/aggregativo/comunicativo del web. In questo senso, la parola “interattività” (E derivati) si potrebbe/dovrebbe intendere come frutto delle INTERazioni mediatiche tra persone attive (Nel reale), non come attività derivata dall’interazione (Con terze persone via media o con il media stesso, a seconda dei casi).
Dall’altro lato c’è l’interpassività che pare (Almeno dal passaggio riportato sopra e da quanto ci ho capito io) coincidere col clicktivismo: si delega al media (Al web) l’attività e credendo di impegnarsi ci si disimpegna, è un impegno disimpegnato, o un disimpegno senza sensi di colpa.
B) Non mi è chiarissimo un passaggio di dopo. Di nuovo, riporto pari pari dal testo:
“Contro questa impostazione interpassiva -nella quale siamo costantemente attivi per sincerarsi che nulla effettivamente cambi- il primo passo davvero critico da vare è ritirarsi nella passività e rifiutarsi di partecipare. Questo primo passo prepara il terreno a una vera attività, a un’azione che effettivamente cambi le coordinate della scena”
Che vuole dire qua? Che finchè il costantemente attivo resta falsamente attivo (ovvero interpassivo/clicktivistico) nulla effettivamente cambia e credendo di agire per il cambiamento agiamo per la staticità, che poi è esattamente quello che diceva Adrianaaaa sopra, con cui concordo in pieno? Che -dando una valenza sociale al tutto- finchè non alziamo il culo dalla sedia e spegnamo Twitter e Facebook (Ci rifiutiamo di partecipare alla costante attività clicktivistica) scendendo in piazza, nulla cambia? Ma il “ritirarsi alla passività” non svilisce anche la parte interattiva e pseudobuona? Personalmente, ripeto, non mi è chiarissimo sto pezzo.
E comunque, accantonando un attimo Zizek, ripeto, come ho scritto su Twitter, la forza sta nel fatto che movimenti, comitati, ecc. ecc. ecc. si sono uniti come non facevano da tempo, hanno dato un primo impulso di collettivizzazione. La rete è stata solo un mezzo, non l’agente. Un mezzo di diffusione di contenuti che -però- venivano creati in strada.
Faccio un esempio pratico e riferito alle mie esperienze personali di attivismo nella campagna referendaria:
-la rete Commons BN, che si vede tutti i giovedì in assemblea, deve organizzare una serie di giornate di piazza, fare volantini e comunicati e preparare azioni.
(Nel frattempo viene creato un gruppo privato su Facebook sul quale vengono comunicati gli appuntamenti orari degli incontri della rete, eventuali spostamenti ecc. ecc. ecc.)
-I membri della rete Commons, per organizzare le giornate di piazza, fare i volantini, i comunicati e le azioni, si scambiano sia in assemblea che sul gruppo di Facebook una serie di contenuti trovati in rete (Qualche articolo di Carta, qualche considerazione di Mattei, qualche articolo vostro, video di azioni fatte in altre parti d’Italia e/o all’estero, articoli di unicommon, militant, di Globalproject e compagnia cantante, non mi metto a citare tutto che sennò non ne usciamo più)
-I membri della rete Commons, usando anche i contenuti trovati in rete discutono in assemblea, personalizzano i contenuti trovati e organizzano le giornate di piazza.
-Delle giornate di piazza vengono fatti video ed articoli. I video vengono messi su Youtube e ricondivisi in rete diventando a loro volta contenuto per altri gruppi di movimenti.
Si capisce (Spero si capisca, almeno :P) che gli agenti eravamo noi, rete Commons, soggetti reali e i destinatari erano le persone reali che affollavano le piazze, le strade, i mercati e tutti i posti dove abbiamo fatto azioni e volantinaggio. Poi, la rete, è stata il mezzo. Sia di contenuto, che di collegamento con altri gruppi simili a noi e geograficamente lontani (Ma anche mezzo inter-nos per comunicazioni di orari e altre facezie che altrimenti avrebbero dovuto essere comunicate via cellulare con relativo dispendio economico).
Quindi, in conclusione, web buono con le dovute attenzioni, si. Web salvezza dell’umanità e fonte di rivoluzione, per-un-cazzo.
Condivido. E` da lunedi` che leggo ovunque, anche su twitter, che e` stata una vittoria dei social. Infatti noi siamo qui per caso, i comitati che si sono sbattuti passavano di la` giusto un attimo e il merito e` di twitter (e magari di facebook, perche` no?) Sinceramente a me tutta ‘sta beatificazione del web non piace. Il web e` un mezzo, i social network si sono potenti e ci danno nuove opportunita`, ma allora vien da chiedersi come avran fatto le vecchie generazioni a realizzare ad esempio le grandi vittorie referendarie dei decenni passati. Ecco, avremmo bisogno di un’analisi piu` critica ed oggettiva del web, partendo dal presupposto che si tratta di uno strumento e non del fine. Il fine, come sempre, sarebbe l’umanita` (o no?)
Come mi sta sul cazzo che il mio commento sia stato cancellato per sbaglio, porcozzìo… :-P
Anche se state dicendo pure voi (anche meglio e più approfonditamente) alcune cose che avevo scritto, è veramente irritante vedere quella voragine in mezzo al thread…
Ventisette milioni di persone hanno votato i quattro sì.
Se si sfugge per un momento alle percentuali, che spesso fungono da cortina fumogena, i numeri acquistano chiarezza molto maggiore.
E sono numeri enormi. Superiori, in termini assoluti, a quanti votarono per divorzio e aborto.
E allora?
Ancora. Le firme raccolte per i quesiti sull’acqua, valide e timbrate dalla cassazione, sono state oltre unmilionequattrocentomila. Cioè più del doppio di quelle mai raccolte per qualsiasi altro referendum della storia repubblicana, con le stesse regole di tempo a disposizione (sei mesi) e nessuna grande organizzazione (partiti o sindacati) a fornire un appoggio logistico strutturale.
Altri numeri enormi.
E allora?
Allora l’eterno e logoro gioco di chi ce l’ha più lungo è solo l’ennesima cortina fumogena. E bisogna sottrarsi, subito.
Ce l’ha più lungo facebook o twitter? E loro due ce l’hanno ormai senz’altro più lungo della TV? E Di Pietro di Bersani?
Compagne/i, si tratta di merda purissima. Priva di senso.
Ventisette milioni di voti.
I dati parlano chiaro. Sono tornate in gioco categorie che sembravano perse per sempre alla politica, ostaggio delle manipolazioni d’opinione, e cioè giovani e anziani. Non solo come votanti, ma come soggetti di sensibilizzazione e mobilitazione.
E’ fin troppo ovvio e banale che le giovani generazioni a questo scopo utilizzino gli strumenti che gli sono propri e familiari. Qualcuno pensava che avrebbero usato il ciclostile? Si parla del dito per distogliere lo sguardo dalla Luna.
Allo stesso tempo, ritengo molto sottovalutato, in particolare nella provincia profonda italiana, il coinvolgimento diretto e capillare dei soggetti un bel po’ in là con gli anni. Con la questione dell’acqua pubblica a fare da traino e motore almeno quanto il nucleare.
Nasce una domanda fortissima, dal basso e intergenerazionale, di totale ribaltamento del paradigma di gestione e amministrazione dei beni collettivi e di partecipazione diretta alla formazione di scelte fondamentali in materie strategiche.
La realtà è che milioni di cittadini su questioni cruciali come rifiuti, acqua, energia, ne sanno a pacchi di più di coloro che le gestiscono, non solo i politici, ma anche dirigenti e aziende.
La realtà è che questo voto referendario è, prima di ogni altra cosa, una sconfessione e una sconfitta del dogma neoliberista che ci ossessiona da trent’anni. Una radicale messa in discussione dell’individualismo proprietario come religione, anzi indicato come portatore di crisi e malessere sociale.
E’ chiaro che è di tutto questo che non si può, non si deve, non si vuole parlare.
La Luna.
Una volta tanto da qui, un paese logoro e stanco ma ancora vivo, parte un segnale che avrà una valenza non banale per il mondo intero.
Non si sottovaluti, infatti, la ricaduta di questo voto su tutta l’industria nucleare del pianeta.
Diradate le cortine fumogene.
Andiamo al sodo.
Seguimos en combate.
L.
@luca
“La realtà è che milioni di cittadini su questioni cruciali come rifiuti, acqua, energia, ne sanno a pacchi di più di coloro che le gestiscono, non solo i politici, ma anche dirigenti e aziende.”
Tanto per aggiungere legna al fuoco: quello che dici qui è esattamente quello che succede in Val Susa per il TAV (non lasciamoci fuorviare da Grillo, che ha solo cavalcato la tigre).
In valle c’è gente che conosce le cifre fornite da chi vuol fare l’opera meglio di quegli stessi che le hanno fornite, e con quelle stesse cifre dimostra aritmeticamente il nonsenso del TAV. Gente che usa le armi del nemico per combatterlo.
Il nemico come sempre è costretto a raccontar balle, schierare i media e i manganelli, appellarsi ai Princìpi, perché sui Fatti ha già perso in partenza.
In tutto questo, più dell’approssimazione e dell’incompetenza di chi lavora per fare il TAV, è impressionante (direi quasi commovente) la preparazione e la competenza di chi ha passato notti e domeniche a leggere, studiare, documentarsi, discutere, diffondere, per difendersi dal mostro.
A me questa roba ricorda molto da vicino il Chiapas, ma posso sbagliarmi…
Nat,
hai ragione su tutto.
Aggiungo, le Mamme Vulcaniche di Terzigno sono tra le massime competenti italiane in materia di gestione dei rifiuti. E si potrebbe andare avanti.
Le soluzioni sono là dove sono i problemi.
L.
@Luca hai ragione. Abbestia. Soprattutto su cosa è la luna e cosa è il dito.
Ho riparlato qui della questione TV/ Social Network, non perchè la ritengo la più importante ma perchè stavo facendo una discussione su twitter con wu ming e odio i cazzo di di 140 carettereri. Stavo uscendo scemo e siccome comunque mi sembrava una discussione interessante che si riallaccia alla narrazione dell’evento (non la piu`interessante) volevo riprorla qui. Concordo che l’ideologia neolibersta ha preso una botta gigante dalla realtà e che questo è il momento per ributtarla nel luogo che le appartiene (seconda meta`del 1700)
“La realtà è che questo voto referendario è, prima di ogni altra cosa, una sconfessione e una sconfitta del dogma neoliberista che ci ossessiona da trent’anni. Una radicale messa in discussione dell’individualismo proprietario come religione, anzi indicato come portatore di crisi e malessere sociale.
E’ chiaro che è di tutto questo che non si può, non si deve, non si vuole parlare.
La Luna.”
E’ la stessa impressione che ho avuto io. Non si parla minimamente delle conseguenze economiche e di sistema di questo voto, politiche nel senso più vero. Tutti a vedere se il governo cadrà domani o dopodomani, e qual’è il video proreferendum più fico. Nessuno che parla di come l’hanno presa l’industria nucleare, appunto, o la Veolia.
Solo una piccola osservazione per non farsi prendere troppo dall’ entusiasmo: qui al nord, soprattutto nella pedemontana lombarda e veneta, c’e’ una consistente quantita’ di persone che ha votato per l’ acqua pubblica e contro il nucleare per motivi completamente diversi da quelli che ci piacerebbero. La spinta per loro viene da un comunitarismo tipo Blut und Boden, che li porterebbe a votare con la stessa determinazione contro la costruzione di una moschea o l’ assegnazione delle case popolari agli immigrati. Per queste persone, gli immigrati sono come le scorie radioattive e viceversa. Non vogliono essere contaminate ne’ dagli uni ne’ dalle altre. Ieri ho ascoltato uno spezzone di microfono aperto su radio padania, e c’e’ da rabbrividire. Ci sono tantissimi ex elettori della lega che contestano la lega da destra, molto da destra.
pedrilla,
non mi riferivo affatto alla discussione in corso qui, ma quella che impazza sui media tradizionali e non solo.
Ha vinto twitter? Ha vinto fb? Ha vinto il video più strafico del bigoncio?
E ‘sticazzi no?
E’ la solita fuffa per non parlare delle cose vere. Sono i soliti opinionisti che adesso scoprono i social network e ci faranno due palle così, da domani, come li avessero inventati loro.
Ma i dati reali sono di tutt’altro genere.
Per fortuna.
L.
p.s.
ciao adrià. spero tutto bene, e buon umore.
@tuco
“Ci sono tantissimi ex elettori della lega che contestano la lega da destra, molto da destra”.
Pensa che anni fa, quando gli eventi fecero conoscere la protesta NoTav fuori dal Piemonte, c’era anche Borghezio là a farsi vedere e a sbraitare a modo suo. Non so se la cosa sia nota, non so cosa gli abbiano detto per farlo rientrare tra i ranghi, ma non importa. Quello che conta, credo, è che può non essere facile, se sei là, non far confusione.
Altra storia. Un amico “a posto” che stava ai presidi arrivando una sera in birreria ci disse qualcosa tipo: “Certo che noi a volte siamo proprio snob. Vedi della gente, dei ragazzi, che guarda il Grande Fratello, veste e si comporta da tamarro e parla e scrive da bimbominkia, non scommetteresti un euro su di loro da nessun punto di vista, eppure quando è ora arrivano anche loro e hanno capito tutto”.
Tante domande…
http://goo.gl/oCrX5 Voi di Bologna: è vera questa cosa?
Ciao Luca, tutto bene e anche l’umore. Anche se una buona fetta delle esperienze antropologiche di piazza sono state assai inquietanti. Un’altra buona fetta no, però. :) Spero tutto bene anche a te.
@ tuco
Le spinte di cambiamento non sono mai completamente progressive o regressive, in ogni passaggio storico ci sono correnti carsiche di vario orientamento e grado. Eppur si muove, verrebbe da dire. Che nel passaggio attuale sia in atto anche un sentimento “NIMBY”, così come la nostalgia fittizia da piccola patria leghista o addirittura nazista, è probabilmente vero. Ma questo significa semplicemente che la partita è aperta e tutta da giocare.
Si può dire che lo stesso discorso che tu fai sulla destra vale anche a sinistra. L’interpretazione che Bersani dà della vittoria referendaria non è meno regressiva: crede ancora che i partiti possano essere cinghie di trasmissione tra la società civile e il potere politico, è più o meno questo che va dicendo in questi giorni, cioè che il centrosinistra deve farsi carico della spinta popolare e interpretarla a modo suo (e c’è di che mettersi le mani nei capelli). Ed è curioso come un Di Pietro – nella sua apparente maggiore rozzezza – sembri avere invece capito qualcosa di più sulle trasformazioni paradigmatiche in atto che riguardano le reti comunicative e sociali attive, nonché la consapevolezza, sempre meno timida, che il meccanismo della delega non funziona più. Riproporlo tale e quale, come pensa di poter fare ancora il PD, dimostra come il piatto sia ancora tutto sul tavolo. In un certo senso, a voler essere un po’ paradossali e provocatori, questa tornata referendaria sancisce soprattutto la sconfitta di certa sinistra partitica, che è saltata sul carro dei vincitori all’ultimo momento. Costoro rimangono comunque drammaticamente sprovvisti degli strumenti di analisi e interpretazione efficaci per applicarsi a una reinvenzione delle forme della politica. E questo significa che potranno a loro volta essere travolti dalla trasformazione. Nel bene e nel male.
@wm4
Sono d’accordo: l’analisi del voto fatta da Bersani e’ completamente sballata, ed e’ semplicemente una proiezione dei suoi desideri.
Pero’ io credo che bisognerebbe riuscire a farsi raccontare le cose da Varese. O almeno sforzarsi di immaginare le cose viste da Varese. Io a Varese non ci ho mai messo piede, e allora provo a portare un esempio che arriva dal Friuli (che e’ meno “Varese” di Varese). Tra i vari movimenti identitari che da anni si battono per l’acqua pubblica, contro il TAV, contro gli elettrodotti ecc. ce n’e’ uno che si chiama Front Furlan. Ha anche una rubrica fissa autogestita su Radio Onde Furlane. Sul sito del Front Furlan c’e’ una sezione dedicata ai libri: si puo’ trovare Latouche, pubblicazioni sul potere delle multinazionali, saggi sulla critica del processo di unificazione italiano, e poi fa capolino un “Filosofia, Dottrina e Mistica dell’Etnonazionalismo Völkisch”, che viene presentato cosi’: “E’ indispensabile e doveroso, in un’epoca come l’attuale che disprezza profondamente ogni distinzione qualitativa, fornire i fondamenti filosofici e dottrinari per capire e comprendere appieno l’azione metapolitica intrapresa dall’Etnonazionalismo Völkisch. E’, infatti, profondo convincimento degli autori che, qualsiasi azione politico-culturale che abbia come meta finale la piena salvaguardia d’una ben determinata e specifica Blutsgemeinschaft, non possa assolutamente prescindere dalla necessità di ri-destare nei Popoli Europei l’ancestrale Volksgesit [sic!] indogermanico, al fine di conferire nuovamente ad essi quell’essenza smarrita e così importante che è la facoltà e la volontà d’essere se stessi.”
Okay, si tratta di un movimento che conta solo pochi militanti. Okay, si tratta di una rubrica su un sito web. Pero’ secondo me si tratta anche di una lucetta spia, che sarebbe sbagliato trascurare.
A proposito del significato economico e politico generale della consultazione referendaria sul tema dell’acqua, vale forse la pena ricordare (se qualcuno non l’ha già fatto), che la legge Ronchi si limitava a coprire un vuoto normativo, ossia un “gap” fra le leggi italiane e i diktat europei.
La privatizzazione dell’acqua è stata decisa in sede europea, in una logica di ideale continuità politica con il GATS (General Agreement on Trade and Services), accordo alla base del famoso “Uruguay Round” del WTO, che rappresenta l’ultimo ritrovato in materia di imperialismo neoliberale: i servizi come “nuova frontiera”, nuovo terreno di conquista del turbocapitalismo.
Quindi non è vero che dopo la vittoria del “sì” al referendum viene riaffermata in senso “positivo” la proprietà pubblica dell’acqua, o la necessità di una sua gestione pubblica (si trattava, in fondo, di un referendum abrogativo). Semplicemente, si ritorna al vuoto normativo di prima.
Questo significa che a breve ci propineranno un altro decreto molto simile, che verrà magari da un governo di centrosinistra… e dovremo stare attenti a non farci trovare narcotizzati dall’euforia per il tanto atteso “cambio di regime”.
Insomma: altro che festeggiare… qui c’è da rimanere all’erta, col coltello ben serrato fra i denti.
@ Don Cave
Parole sacrosante. Poche ore dopo la vittoria, Bersani ha dichiarato di avere già una proposta di legge nel cassetto che esclude “l’obbligatorietà” della privatizzazione dell’acqua. E questo significa che non esclude la “possibilità” che ciò avvenga, anzi, direi che lo dà per implicito.
@ tuco
Aiuto. Figùrati che Radio Onde Furlane ebbe una parte durante la storica beffa di Luther Blissett a “Chi l’ha visto?”…
@ nat
Credo che sia vero. E pare che l’IDV bolognese abbia perfino chiesto le dimissioni dei vertici di Hera, dato che si erano espressi a gran voce per il No. Non ti dico dove li manderei io costoro…
@wm4
Radio Onde Furlane resta bel un punto di riferimento in Friuli. Solo che forse dovrebbero stare un po’ piu’ attenti e controllare meglio a chi concedono spazi autogestiti.
Il fatto e’ che c’e’ una frontiera frattale che divide la sacrosanta difesa delle culture minoritarie dalle derive identitarie paranoidi, e credo che quel confine vada sorvegliato con molta attenzione.
@wm4
per dire: radio onde furlane fa anche questo:
http://www.ondefurlane.eu/immigra-net/
@tuco
“Il fatto e’ che c’e’ una frontiera frattale che divide la sacrosanta difesa delle culture minoritarie dalle derive identitarie paranoidi”.
Le frontiere penso che siano due, e abbiano a che fare con il concetto di “minoritario”.
La prima è oggettiva, numerica. Quello che resta dei nativi americani dopo George Washington.
La seconda è soggettiva, e riguarda la percezione che ha di se stessa una pretesa cultura minoritaria rispetto al preteso resto del mondo.
Mi riferisco a cose come questa http://goo.gl/IjwlQ straconosciuta e sicuramente più efficace che comica.
Mi riferisco a discorsi che si sentono molto facilmente in giro (tipicamente pensionati sul tram), del tipo “Questi qui (i musulmani) vengono qui e fanno tanti figli (dato oggettivo), i nostri invece vogliono la vita comoda e nemmeno più si sposano (dato numericamente oggettivo), così tra vent’anni saranno loro i padroni e dovremo obbedire alle loro leggi (estrapolazione ad penem botuli: 2+2=5)”.
La percezione del confine tra identitario e paranoide mi sembra fuori portata per chi dispone solo di una lettura immediata di ciò che vede con i propri occhi e (inevitabilmente?) vede minacce in qualsiasi diversità.
Nella mia ignoranza temo che la paranoia sia un istinto molto più primordiale e profondo della convivenza.
Quanta “cultura” ci vuole per una interpretazione diversa? Quanti ne dispongono? E non solo tra i residenti ma probabilmente anche tra coloro che arrivano.
E non intendo alta cultura accademica, né letture e frequentazioni sofisticate. Quanti hanno visto “Ausmerzen” di Paolini? (che spiega il motorino di avviamento della deriva identitaria paranoide). Facile, evidente, accessibile, gratis. Immagino solo quelli che non avevano nulla da imparare.
Penso che sia inevitabile diffidare di tutte le risposte.
@ nat
Mi permetto di intervenire su un punto, contestando questa tua affermazione: “Nella mia ignoranza temo che la paranoia sia un istinto molto più primordiale e profondo della convivenza.”
In realtà tutto dipende da quale “istinto” viene alimentato. Se guardiamo alla storia umana è ben difficile, per non dire impossibile, stabilire con precisione il peso rispettivo della reazione paranoica e della convivenza. Da un certo punto di vista la storia non è altro che il prodotto dell’attrito (fatto di scontro, incontro, meticciato) tra popolazioni in movimento. I discorsi paranoici dei vecchi sugli autobus sono gli stessi che trent’anni fa qui a Bologna, ad esempio, si sentivano a proposito degli immigrati dal Sud Italia e cinquant’anni fa sugli “immigrati” dalla bassa ferrarese (la primissima ondata migratoria che investì questa città).
Allo stesso modo, restando all’oggi, potremmo dire che la convivenza è assolutamente già in atto, basta entrare in un asilo o in una scuola elementare per rendersene conto. Certo essa subisce la contro-spinta della paura del mutamento, che è sempre presente e ben alimentata dalla retorica e dalla narrazione di destra, ma quest’ultima, appunto, pretende di negare una realtà già in atto ed esperibile da chiunque, al di là del livello di consapevolezza e istruzione. Ciò che fa la differenza e che rende la battaglia primamente politica, è la retorica che pesa sull’uno o sull’altro piatto della bilancia. Trent’anni di attacchi ai diritti dei lavoratori e dei cittadini hanno introdotto diffusamente l’idea che questi non siano affatto “diritti”, bensì “privilegi”. Fin dal XVIII secolo la caratteristica del diritto è la sua universalità, al contrario del privilegio che è sempre per alcuni (l’intera moderna società politica occidentale nasce a partire da questa affermazione). Ecco quindi che oggi si inculca la narrazione paradossale di un diritto per pochi, identificabili in base a parametri etnici e di provenienza, fingendo che la convivenza non sia già nei fatti. A ben vedere l’unico motivo per cui una persona che vive, lavora, paga le tasse, si sposa, abita (o perfino nasce) in un dato territorio non dovrebbe avere gli stessi diritti e doveri di un altra è precisamente la sua origine più o meno lontana. Non è già quindi lo stato reale delle cose a determinare una presa di posizione politica (o il discorso da autobus – la differenza ormai è labile), bensì qualcosa che si colloca al di fuori dello stesso. Eppure, ripeto, quello stato delle cose è già qui e non produce affatto soltanto conflitto, ma anzi, nonostante gli attriti, tende piuttosto a produrre convivenza, adattamento al nuovo contesto (che è pure un istinto molto forte negli esseri viventi).
Non credo quindi che una risposta diversa dalla paranoia necessiti di chissà “quanta cultura”, ma semplicemente appunto di una cultura diversa, di un discorso diverso, di uno stimolo all’osservazione del reale nella sua complessità.
@nat
Il fatto e’ che c’e una vera e propria industria della paranoia identitaria al lavoro. Poi e’ sorprentente notare come, molto spesso, cercando di dipanare il filo della paranoia si finisca per imbattersi nei soliti noti.
Ad esempio il libro consigliato sul sito del Front Furlan e’ di S. Lorenzoni, che e’ un leghista evoliano. Scavando ancora un po’, si scopre che Lorenzoni nel 2006 ha partecipato a un congresso che si e’ tenuto a Mosca, intitolato “The white world future”. Al congresso aveva partecipato anche David Duke, ex leader del KKK. Il congresso era stato organizzato da tale Pavel Toulaev, esponente dell’ estrema destra russa, che si presentava pero’ come linguista. Toulaev si serve delle teorie linguistiche di Mario Alinei (di cui non mi azzardo a valutare la validita’, visto che di linguistica ne so meno di nulla). Secondo tali teorie, se ho capito bene, le lingue parlate oggi in Europa non sarebbero state portate da popoli migrati dall’ est, ma sarebbero autoctone, e i Veneti sarebbero il nucleo originario dei popoli europei (pero’ secondo alcuni nazionalisti sloveni i Veneti non sarebbero altro che gli antenati degli Sloveni).
Altro esempio: sempre sul sito del Front Furlan, viene consigliato il libro “Euroschiavi”, trattato sul “signoraggio” (eccolo il complottismo, che fa capolino). Edizione? Arianna (casa editrice rossobruna “euroasiatica”, e poco importa che le posizioni “euroasiatiche” siano in contrasto con quelle di Lorenzoni&co).
Tutto questo pippone decisamente ot per dire che la paranoia identitaria non e’ solo un istinto primordiale, ma e’ anche il precipitato di una produzione “culturale” che la rete mette a disposizione di tutti.
A me pare invece che sia proprio la paranoia identitaria ad avere una radice culturale, che potrei riassumere nel concetto di “lotta per la sopravvivenza”, estrapolato a cazzo di cane dagli scritti di Darwin e poi disseminato nei cervelli fino a diventare una “metafora primaria”: diciamo che la vita è una lotta che premia il più adatto, così come diciamo che la moralità è pulizia e l’affetto è calore. In realtà lo stesso Darwin spiega che “lotta per la sopravvivenza” è appunto una metafora e spesso l’evoluzione e la selezione naturale non sono affatto la conseguenza di una lotta. Lakoff fa l’esempio delle farfalle verdi e bianche in una giungla tropicale: la selezione evolutiva tenderà a premiare le farfalle verdi, ma senza che ci sia nessuna “lotta” tra queste e quelle bianche. Piuttosto, se ne potrebbe trarre un’altra metafora: sopravvivere significa trovare un ambiente favorevole.
Questo per dire che la paranoia identitaria molto spesso fa vittime tra coloro che un contesto meticcio non lo vivono davvero e non lo esperiscono fino in fondo, tutti i giorni, con i loro figli e i loro amici. Hai paura perché non conosci il tuo ambiente e quindi credi alla metafora della “lotta per la sopravvivenza”: i musulmani fanno più figli, quindi diventeranno maggioranza, quindi verranno premiati perché più forti. Invece, se ti rendi conto di vivere in un ecosistema che è già meticcio, e lasci perdere il darwinismo da autobus, allora ti appare chiaro che la tua stessa sopravvivenza ha a che fare con quell’ecosistema e che se lo inquini con le tossine della paranoia, sei fritto. Di fronte a un ambiente del genere, ti domandi: come posso renderlo favorevole per la mia vita sociale? Facendo la guerra agli stranieri o sostenendo una politica di convivenza? A me pare che il famigerato “voto di via Padova”, a Milano, abbia evidenziato questo: la gente che in certi quartieri ci vive comincia a capire – anche contro le sue stesse convinzioni culturali – che la paranoia identitaria è un danno per tutti, mentre la convivenza, per quanto difficile, è senz’altro più salubre.
Questo per dire che la paranoia identitaria molto spesso fa vittime tra coloro che un contesto meticcio non lo vivono davvero e non lo esperiscono fino in fondo, tutti i giorni, con i loro figli e i loro amici. Hai paura perché non conosci il tuo ambiente e quindi credi alla metafora della “lotta per la sopravvivenza”: i musulmani fanno più figli, quindi diventeranno maggioranza, quindi verranno premiati perché più forti. Invece, se ti rendi conto di vivere in un ecosistema che è già meticcio, e lasci perdere il darwinismo da autobus, allora ti appare chiaro che la tua stessa sopravvivenza ha a che fare con quell’ecosistema e che se lo inquini con le tossine della paranoia, sei fritto”
E’ esattamente per questo motivo che, ad esempio in un raffronto Torino-Resto del Piemonte, la destra leghista, identitaria, securitaria, e a questo punto paranoica, si rivela molto forte nelle province e pochissimo forte nel capoluogo di Regione.
Perchè è indubbio che in una città da un milione d’abitanti circa il meticciato “forte” è già in atto, nelle scuole elementari medie e superiori, nelle piazze, nei mercati, nei luoghi del divertimento. Dunque dove il meticciato è vissuto quotidianamente come *strutturale*, c’è meno foga verso la paranoia identitaria, e ci si abitua, e non si vogliono per forza sceriffi. Laddove il meticciato esiste ma non è quantitativamente fondamentale nelle relazioni sociali e lavorative, le persone inseguono narrazioni identitarie, e di cui è responsabile per prima, la nostra brava maestra televisione, che appunto arriva in “sostituzione” della realtà.
@wm4
Certo, d’accordo su tutto, però la mia non era una affermazione, ma dubbio, timore, domanda. Se avessi voluto “affermare” avrei scritto molto meno bene le stesse cose tue. Non è di queste che dubito, ma a volte della loro efficacia e della loro evidenza. Per questo parlavo di cultura e in quei termini (che forse possono essere ridotti semplicemente all’abitudine di porsi domande e di non prendere per buona nessuna risposta, e credo che basterebbe già).
Spero di sbagliarmi, preferirei che fosse così.
@wm2
Illuminante la tua analisi del “darwinismo a cazzo”. Forse qui, più che in tutto il resto, ci vedrei del dolo.
@nat
Per non prendermi meriti altrui, ad essere illuminante è il libro di G.Lakoff “Pensiero politico e scienza della mente”, dove la “mia” analisi del “darwinismo a cazzo” è spiegata pure meglio e con più esempi.
Domanda: non è che questo “darwinismo a cazzo” di cui parla WM2 è una nuova incarnazione del cosiddetto “darwinismo sociale” e cioè l’applicazione della metafora darwiniana ai fenomeni socio-culturali in forma tecnicizzata o strumentale?
@tuco: mi è chiaro cosa siano le derive identitarie paranoidi che, se non intendo male, sono rappresentazioni o narrazioni dell’identità attraverso cui una maggioranza si autorappresenta come minoranza minacciata per giustificare la propria egemonia nei confronti dell’altro. Autorappresentazione che si sostanzia di dati quantitativi imprecisi.
Ma cosa intendi con l’espressione “sacrosanta difesa delle culture minoritarie”?
Dal mio punto di vista, parlare di difesa di una cultura non ha senso se si intende la difesa nei termini di una preservazione (come si preserva un ecosistema, ad esempio un biotopo). Non ha senso perché in questo modo ci si nasconde come la cultura sia sempre il risultato di una negoziazione tra elementi diversi, che di solito presuppone un confronto tra tratti culturali che si risolve più o meno violentemente in una sintesi di essi.
Un esempio di questa dinamica si può fare rispetto al Congo: prima del colonialismo, durante il periodo del commercio degli schiavi, il Kongo era uno dei regni più vasti e potenti del continente africano, i cui sovrani facevano affari coi portoghesi ed i cui sudditi erano convertiti alla religione cattolica (al punto che il figlio di un sovrano fu ordinato Vescovo).
Quando le potenze europee si spartirono l’Africa fu evidente che un’unità statale così forte e coesa avrebbe rappresentato un pericolo e fu così adottata la classica politica divide et impera che portò alla formazione di clan tribali, i cui capi erano scelti tra gli ufficiali reclutati in loco per le varie operazioni militari. Tale logica comprendeva anche la cancellazione della memoria dei precedenti scambi tra il Kongo e l’Europa: il Kongo divenne così il Congo: lo spazio vuoto primitivo per eccellenza raccontato in “Cuore di tenebra”.
Pochi anni dopo il Congo divenne meta prediletta per quegli europei che, improvvisandosi esploratori e avventurieri, volevano vedere coi loro occhi i “primitivi”. Tuttavia questo primitivismo era una creazione del colonialismo che aveva distillato, a partire da una rappresentazione lineare dello sviluppo delle culture (per cui la cultura e la civiltà occidentale e bianca era più sviluppata di quella africana), che era anche la propria rappresentazione, un’immagine ed una narrazione dell’Africa come “continente nero” e primitivo, del tutto artificiale e culturalizzata. Senza sapere tutto ciò, se noi oggi decidessimo di batterci per la “difesa della cultura minoritaria” delle tribù congolesi minacciate, chessò dall’avvento di internet, staremmo in realtà difendendo, almeno in parte, una creazione della politica occidentale e colonialista.
Io non credo si possa preservare una cultura senza musealizzarla (e dunque uccidendola) o tecnicizzarla, piuttosto penso che sia necessario capire le logiche attraverso cui una cultura può mutare e dunque dare vita a sopravvivenze sempre nuove. Un esempio è quello del dialetto, possiamo accanirci nella difesa del dialetto in stile leghista, proponendo di insegnare il dialetto nelle scuole, oppure usare il dialetto, che è un modo per dire tutto un mondo di suoni, odori, sapori, forme di vita, ecc. ed usarlo per produrre uno sguardo obliquo sul mondo in cui viviamo (quello che fa Paolini nel “Bestiario veneto”).
Insomma, tornando al titolo del post, per disintossicare l’evento è anche necessario mostrare le posizioni e le posture da cui lo si osserva…
@flaviopintarelli
Condivido. E faccio ammenda per essere stato troppo sintetico. Io scrivo da una terra di confine, e avevo in mente soprattutto la situazione della minoranza slovena, che a partire dal 1918 ha subito una violenta persecuzione. Anche dopo il 1945 le varie amministrazioni locali hanno fatto di tutto per rendere invisibile la presenza degli sloveni a Trieste, e per cancellare l’ identita’ composita della citta’. Fa’ conto che a Trieste non esiste nessuna scuola in lingua italiana che preveda l’ insegnamento dello sloveno come seconda lingua straniera. Quando parlavo di “sacrosanta difesa delle culture minoritarie” avevo in mente la legge di tutela delle minoranze linguistiche, che e’ arrivata solo nel 1999. Mi rendo conto che per chi vive qui certe espressioni attivano immediatamente un certo frame (per restare a Lakoff), ma per chi vive lontano non e’ cosi’.
Sono d’accordo con te anche per quanto riguarda i dialetti, che spesso qui a nord vengono usati per marcare il territorio.
A proposito di “la convivenza e` gia` in atto” m’e` venuto in mente un post di Gilioli di qualche giorno fa: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/06/12/quello-che-e-gia-successo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
“quello che e` gia` successo” -> “Come se io cercassi oggi di oppormi – chessò – alla caduta dell’impero romano”
@flaviopintarelli
il darwinismo sociale applica il concetto della “lotta per la sopravvivenza” all’intera società, nascondendo il fatto che si tratta di una metafora, cioè di un’immagine. La confusione tra metafora e verità scientifica è invece il darwinismo alla cazzo, che quindi, se vogliamo, è un prerequisito del darwinismo sociale ;-)
Ma ecco, facciamo parlare lo stesso Darwin:
I use this term [lotta per la sopravvivenza] in a large and metaphorical sense including dependence of one being upon another, and including not only the life of the individual, but success in living progeny. Two canine animals, in times of death, may be truly said to struggle with each other, which shall get food and live. But a plant on the edge of a desert is said to struggle for life against the drought, thought more properly it should be said to be dependent on the moisture
Tra l’altro il fatto che la presenza slovena a Trieste sia stata per tanti anni un rimosso nell’ autorappresentazione ufficiale della citta’, ha fatto si’ che gli sloveni si siano a loro volta in parte chiusi in una autorappresenzazione in cui si vedevano estranei alla citta’. E qui si vede molto bene la genesi di quella “frontiera frattale” di cui parlavo prima.
@flaviopintarelli
Ancora una precisazione. Tu scrivi “mi è chiaro cosa siano le derive identitarie paranoidi che, se non intendo male, sono rappresentazioni o narrazioni dell’identità attraverso cui una maggioranza si autorappresenta come minoranza minacciata per giustificare la propria egemonia nei confronti dell’altro.”
Questo e’ esattamente cio’ che fa la Lega. Io pero’ nel mio post (in cui parlavo del Friuli) mi riferivo a una situazione piu’ ingarbugliata. Cioe’ a una situazione in cui ci sia veramente una minoranza (ad esempio una minoranza linguistica, come quella friulana, o quella sarda), e in cui e’ molto importante evitare che la tutela della lingua minoritaria degeneri in musealizzazione o in chiusura identitaria. E infatti secondo me (e su questo ho litigato furiosamente con alcuni amici friulani) il friulano non si preserva insegnandolo nelle scuole, ma facendo hip-hop in friulano.
@tuco: guarda io sono altoatesino, per cui comprendo bene le dinamiche di confine di cui tu parli, anzi, più volte leggendo i tuoi commenti, ho ricavato spunti molto interessanti e produttivi.
Rispetto alla situazione triestina, invece, qui da noi la situazione sembra rovesciata. Anche qui c’è stata una minoranza linguistica che, dopo il 1918, è stata violentemente oppressa. Ma dopo la guerra e una stagione di terrorismo (i cosiddetti Bombenjahre, gli “anni delle bombe”), questa minoranza ha potuto, grazie al concordato ed in parte al fatto che al di là del confine non c’erano dei comunisti come da voi, affermare la propria identità in maniera più libera, o almeno così mi pare da quanto dici, rispetto alla minoranza slovena a cui fai riferimento.
Questa situazione, invece che produrre una vera e piena integrazione, ha creato una sorta di muro contro muro culturale, in cui gli italiani (che nei numeri sono la vera minoranza altoatesina, se non si tiene conto dei ladini, che però restano ai margini di queste dinamiche) rivendicano la vittoria in guerra e l’italianità dell’AA, mentre i tirolesi (che nei numeri sono la maggioranza in provincia, ma sono minoranza nello Stato italiano) ne affermano, al contrario, la “tedeschità”.
Il tutto cancellando completamente il dato di fatto che, storicamente, l’AA è sempre stato una terra di passaggio e soprattutto di scambio ed ibridamento tra le culture “italiana” (mediterrenea) e “tedesca” (nordica). A testimoniarlo stanno le opere d’arte, in particolare quelle trecentesche, dove la scuola giottesca si fonde con le scuole fiamminghe bavaresi. Esiste, ad esempio, tutta una tradizione di facciate dipinte, che per metodi pittorici, stile e linguaggio unisce, come un filo rosso, il Baltico al Triveneto passando per Polonia e Baviera.
Insomma, a ben guardare, l’AA ha una sua identità propria che nasce dalla fusione di cultura nordica e mediterranea, ma questo dato di fatto, viene sistematicamente e strategicamente ignorato.
Rispetto alla tua precisazione, sono d’accordo al 100%, lo dicevo anche nella chiusa del commento: se riusciamo ad usare il mondo che è costruito e custodito nel dialetto per raccontare ciò che di quel mondo stiamo perdendo e come si sta trasformando vuol dire che siamo riusciti a rendere produttiva quella cultura e, dunque, anche a proteggerla.
L’hip-hop, come dici giustamente, è un linguaggio capace di fare cose incredibili in questo senso, penso, ad esempio, al lavoro di Herman Medrano, che, con tutti i suoi limiti, riesce a raccontare il Veneto e quel suo misto di rudezza contadina (dialetto) e rozzezza piccolo borghese (il ‘talian)…
@flaviopintarelli
Negli ultimi anni alcuni esponenti del mondo sloveno hanno cominciato a caldeggiare una soluzione “altoatesina” per Trieste e Gorizia. Secondo me sarebbe un disastro. Ti risparmio il dibattito surreale sulla ricostituzione del TLT. In concreto ci sono mille alternative possibili per ricostituire il tessuto multiculturale della citta’, e la geografia ci aiuta, perche’ il mare e’ sempre stato un luogo di scambi. A me piacerebbe che si usassero gli strumenti legislativi previsti dall’ Unione Europea per cominciare a organizzare Trieste-Sezana-Koper/Capodistria come un’ unica realta’ metropolitana (mettere in rete gli ospedali, prevedere il multilinguismo in tutte le scuole, unificare la gestione dei rifiuti, ecc.) . Mah, forse i miei figli potranno vedere una cosa del genere. A me resta il rammarico di essere monolingua, pur avendo avuto una nonna che, con la sola terza elementare, parlava tre lingue (sloveno, italiano e tedesco). Tutta questa ricchezza si e’ persa a causa del fascismo.
tuco:
La soluzione “altoatesina” è stata caldeggiata praticamente per tutti i conflitti etnico-lingustici o quasi: dalla Palestina ai Balcani, passando per Irlanda e Paese Baschi. Ha un unico difetto, costa moltissimo in termini di soldi ed impone alcune storture come la famigerata proporzionale etnica (una corsia preferenziale su base linguistica nei concorsi pubblici). La realtà è che se non si persegue una volontà di integrazione si possono sopire i conflitti sotto fiumi di soldi, ma questi saranno sempre pronti a riaffiorare quando meno te lo aspetti. La questione dei monumenti (http://larottaperitaca.wordpress.com/2011/01/27/le-incredibili-iconoclastie-di-bondi-e-dellsvp/), col conseguente valzer di estremismi (http://larottaperitaca.wordpress.com/2011/03/02/dalla-storia-non-si-impara-mai-abbastanza/) che abbiamo vissuto quest’inverno sta lì a ricordarcelo.
poi la smetto. guardate cosa si puo’ fare mescolando il friulano e la musica klezmer:
http://www.youtube.com/watch?v=Ielz2O3lemg
il testo con la traduzione si trova qui:
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=4209&lang=it
@flaviopintarelli
A Trieste una soluzione di tipo altoatesino non potrebbe mai funzionare, perche’ negli ultimi vent’anni, con l’ immigrazione dalla ex Jugoslavia, a Trieste si e’ ricreato in piccolo il mosaico balcanico: la comunita’ serba conta ormai piu’ di 15mila residenti, che si sono innestati su una piccola comunita’ storicamente gia’ presente in citta’ da piu’ di 200 anni. Poi ci sono i croati, i bosniaci musulmani, i kosovari… Ti lascio immaginare cosa accadrebbe se si cominciasse a parlare in termini di appartenenza etnica!
@WuMing2
Ti convince la spiegazione di Roberto Genovesi sui significati dei termini multimediale, crossmediale e transmediale? La copio e incollo:
“Il prodotto multimediale nasce per un medium e con lo sviluppo diventa altro; Il crossmediale ha invece in matrice un linguaggio che viene declinato in più media. La transmedialità al contrario rappresenta un prodotto che muovendosi da un medium all’altro ne acquisisce gli elementi.”
“Crossmediale secondo Genovesi” mi pare equivalga a “crossmediale/transmediale secondo Wu Ming 2” nell’accezione “dura”. E mi pare anche e quindi che tu, quantomeno nel commento di cui sopra, reputi crossmediale e transmediale due sinonimi, con il secondo che semplicemente ti garba di più/ti pare più appropriato, mentre la sfumatura di significato di cui parla Genovesi non è poi cosi sottile. Che opini?
PS: l’audio o anche una review di qualche altro tipo, del tuo intervento a Talking Ied su copyleft e transmedia è reperibile?
Il mio uso della parola transmediale è lo stesso di Jenkins (dato che quella parola ho imparato a usarla leggendo i suoi libri): una narrazione transmediale è pensata, fin dall’inizio, per non esaurirsi in un solo medium, o in più media convergenti, ma per distribuire il suo contenuto attraverso media diversi. Mi pare che questa definizione non corrisponda a nessuna delle definizioni di Genovesi.
Il termine “crossmediale” l’ho trovato equiparato a “transmediale” nei libri di Max Giovagnoli, e mi sono fidato di quella sinonimia.
Quanto a “multimediale” la definizione di Genovesi non mi convince: credo che un prodotto multimediale nasca fin da subito per più media convergenti, ovvero fin da subito è fatto di audio, video, testo, ecc. ma non distribuisce pezzi di narrazione su canali diversi. Per questo credo che definire “multimediale” un prodotto ormai sia quasi un pleonasma. E anche crossmediale, nella definizione di Genovesi, mi sembra un termine molto, molto ampio.
@akaOnir
L’audio del Talking IED non ce l’ho, ho solo una massa di appunti, ma partirò da lì per l’intervento che devo fare giovedì all’incontro “Pensare collettivo, Scrivere Collettivo” di Roma. E in quell’occasione penso registreremo…
@wuMing2
Grazie, a me le definizioni di Genovesi hanno fatto più confusione che altro, necessitavo un chiarimento. Sulla natura pleonastica di multimediale non vi è dubbio, come dice Janos Petofi anche dicendo “ciao giovanni” si produce un testo non mono-mediale e quindi multi-mediale (medium concettuale/lessicale + medium acustico).