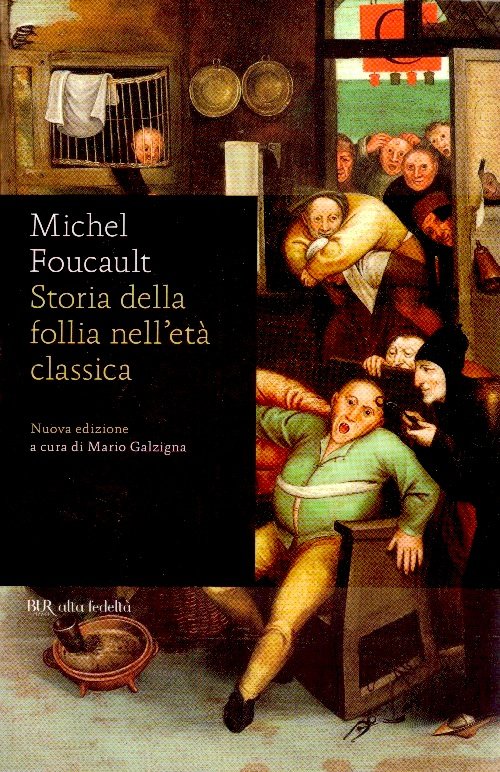
[E’ giunta in libreria da pochi giorni, a cinquant’anni esatti dalla prima uscita in Francia, una nuova edizione italiana di Storia della follia nell’età classica, capolavoro (storico? letterario? filosofico?) di Michel Foucault. Non si tratta di una mera ristampa, bensì di un nuovo esordio. Infatti, il libro è proposto per la prima volta in versione integrale. Il curatore, Mario Galzigna, ha reinserito nell’opera brani mai tradotti in precedenza e ha recuperato la Prefazione di Foucault all’edizione del 1961, espunta per volontà dell’autore dalle edizioni successive. Nella sua Introduzione, Galzigna spiega perché ha deciso di ripescare quel “reperto”, e in che modo la riscoperta del Foucault “lirico” dei primi anni Sessanta, con le sue riflessioni sulla poesia e sull’esperienza letteraria, possa gettare luce sul presente e le odierne pratiche di resistenza. Naturalmente, è un discorso che a noi interessa parecchio. Di più: è un discorso che incrocia le nostre riflessioni degli ultimi mesi e ha forti risonanze con il romanzo che stiamo scrivendo.
Galzigna è docente di Storia della cultura scientifica e di Etnopsichiatria e psichiatria clinica (epistemologia e storia) all’Università Ca’ Foscari di Venezia. E’ autore di molti libri ed è il curatore delle edizioni italiane degli ultimi corsi di Foucault al Collège de France. A novembre le edizioni Feltrinelli pubblicheranno, con sua traduzione e curatela, Il coraggio della verità, ultima grande riflessione di Foucault prima della morte (1984), incentrata sul tema della parresìa (il “parlar franco” degli antichi Greci).
In accordo con l’editore Rizzoli e il blog Ibridamenti, pubblichiamo su Giap il testo integrale dell’Introduzione a Storia della follia. E’ un testo denso, che si rivolge a chi già conosce Foucault, eppure crediamo che anche il “principiante” possa trarne qualcosa di suggestivo, magari partendo dalle “vociferazioni” di Antonin Artaud che abbiamo incorporato e linkato nel testo.
Ne approfittiamo per segnalare che Storia della follia nell’età classica verrà presentato a Venezia il 5 ottobre. Per maggiori informazioni ecco il volantino (pdf).]
.
INTRODUZIONE [1]
“Le persone che amo, le utilizzo. Il solo segno
di riconoscimento che si possa testimoniare
a un pensiero […] è precisamente di utilizzarlo,
di deformarlo, di farlo stridere, gridare. Allora,
dicano pure i commentatori se si è o non si è
fedeli, ciò non ha alcun interesse”
(Michel Foucault, 1975)
Nella follia l’opera sprofonda, scrive Foucault al termine dell’Histoire de la folie. “Dove c’è opera non c’è follia; e tuttavia la follia è contemporanea dell’opera, poiché inaugura il tempo della sua verità”. La follia interrompe l’opera, “apre un vuoto, un tempo di silenzio, una domanda senza risposta”.
E tuttavia, nella “lacerazione senza rimedio” che essa provoca, “il mondo è obbligato a interrogarsi”. Il mondo – quello stesso mondo che pretendeva “di misurarla e di giustificarla con la psicologia” – ora “si trova citato in giudizio” e “deve giustificarsi davanti a essa”(p. 455). La follia è “assoluta rottura dell’opera”, ma al tempo stesso “rappresenta il momento costitutivo di un’abolizione che fonda nel tempo la verità dell’opera”(p.454).
Al vertice estremo della singolarità, viene scoperta e svelata, nella follia, la compresenza di due dimensioni eterogenee: irriducibili ma segretamente complici, speculari e a volte complementari. Laddove il soggetto mostra la sua costitutiva vulnerabilità – la sua esposizione ai molteplici fattori patogeni che producono in lui passività, dissoluzione, rovina, frammentazione –, ebbene, proprio lì può emergere un movimento di riscatto: un’energia progettuale che lo rende capace di ridiventare protagonista attivo della propria esistenza. Proprio lì può emergere un’intima ed enigmatica solidarietà tra distruzione e costruzione, tra perdita e arricchimento, tra malattia e creatività.
Un buon esempio di connessione tra dimensioni eterogenee Foucault lo fornisce attraverso l’analisi della malinconia sviluppata nel cap. III della seconda parte. Le qualità si trasmettono, senza alcun supporto, “dal corpo all’anima, dall’umore alle idee, dagli organi alla condotta”. Vi è così una meccanica delle qualità, una dinamica delle qualità e “una specie di dialettica delle qualità che, libera da ogni obbligo sostanziale, da ogni assegnazione primitiva, cammina attraverso rovesciamenti e contraddizioni”. E poiché il conflitto può nascere all’interno di una singola qualità, “una qualità può alterarsi nel suo sviluppo e diventare il contrario di ciò che era”(p. 233). Attraverso una puntigliosa analitica del testo medico, Foucault svela spostamenti, contraddizioni, rovesciamenti. Ogni condizione patologica è perciò molto fluida; subisce modificazioni continue e spesso può rovesciarsi nel suo contrario: fino al limite estremo, per cui, come afferma il medico inglese Thomas Sydenham (1624-1689), frequentemente citato nell’Histoire,
i malinconici sono “persone le quali per il resto sono molto sagge e molto sensate, e dotate di una penetrazione e di una sagacia straordinarie. Così Aristotele ha osservato giustamente che i malinconici hanno più spirito degli altri”(p. 232).
La malinconia, quindi, è certamente una condizione patologica, un’entità morbosa, ma può, in opportune condizioni e situazioni, produrre stati di eccellenza intellettuale. E’ come sospesa, sempre in bilico tra prostrazione (tristezza, paura), delirio parziale e genialità. Il malinconico, come affermava Marsilio Ficino nel De triplici vita, coglie la profondità di tutte le cose[2].
Oltre che nel rapporto tra follia e assenza d’opera, la contraddittorietà del soggetto emerge dunque anche nell’analitica del testo medico, che tanto spazio occupa nell’Histoire: un soggetto molto spesso definibile come sinergia di qualità contrastanti e soprattutto come compresenza di dimensioni attive e passive. Entro tale prospettiva, voglio proporre un breve détour: cioè un accostamento inconsueto tra Jean-Paul Sartre e Foucault, poiché per entrambi il soggetto è al tempo stesso attivo e passivo. Comincerò con Sartre.

Jean-Paul Sartre
Nelle Questioni di metodo viene citata e commentata l’affermazione di Engels, contenuta in una lettera indirizzata a Marx: “Gli uomini fanno la loro storia da sé ma in un ambiente dato che li condiziona”[3]. Sartre tematizza ampiamente la duplicità costitutiva del soggetto, delineata nel passaggio epistolare engelsiano, soprattutto nella Critica della ragione dialettica e nella grande ricerca dedicata a Flaubert, L’idiota della famiglia. Viene più volte ribadito, in questi testi, il primato dell’esistenza sulla coscienza, al fine di cogliere la presenza dell’ “uomo reale in mezzo al mondo reale”[4]. Ed è possibile il disvelamento di questa presenza – di questa situazione – solo attraverso una prassi trasformativa capace di modificarla. Il “principio antropologico” che permette di definire “la persona concreta in base alla sua materialità” – fuori da ogni ritorno “alla semplice immanenza del soggettivismo idealista” – rappresenta “un punto di partenza che ci rigetta subito tra le cose e gli uomini, nel mondo”. Entro tale prospettiva, aggiunge Sartre, “la sola teoria della conoscenza che possa essere oggi valida è quella che si fonda su questa verità della microfisica: lo sperimentatore fa parte del sistema sperimentale”[5]. Si tratta di uno snodo importante, a partire dal quale l’autore prende le distanze dalla teoria marxista della conoscenza – il vero “punto debole” del marxismo –, accusata di espellere la soggettività dalla sfera dell’atto conoscitivo. La dialettica, cara a Sartre, tra “coscienza costitutrice” (o costitutiva, come avrebbe detto Foucault) e “coscienza costituita”, mette capo a una “frattura del rapporto reale dell’uomo con la storia” nel momento stesso in cui la prima diventa “teoria pura”, “sguardo non situato”, e la seconda si limita a funzionare come “semplice passività”. Fuori da ogni tentazione idealistica, si tratta di costruire un’epistemologia realista, “che situi la conoscenza nel mondo”: che spezzi la dicotomia tra osservatore e osservato, riconoscendo il coinvolgimento del soggetto nella realtà osservata come parte costitutiva ed essenziale del processo conoscitivo.
Al di là del puntuale e pertinente richiamo di Sartre alla microfisica, è necessario ricordare che l’idea dell’osservatore come variabile capace di modificare il fenomeno osservato ha conosciuto una grande fortuna in ambito antropologico. Si tratta di un’idea ben presente in alcune importanti figure di padri fondatori, che negli anni giovanili ebbero una formazione scientifica: ad esempio Georges Devereux, creatore dell’etnopsichiatria[6], che studiò chimica e fisica a Parigi, e Bronislaw Malinowski, che prima del 1910 ebbe una formazione filosofica e fisico-matematica.
Nell’ambito delle scienze umane, vale la pena ribadirlo, è l’antropologia il campo di ricerca in cui la discussione sul rapporto tra soggetto osservatore e processo osservato è stata davvero continua e approfondita, anzitutto all’interno di quel metodo della ricerca etnografica che venne definito, a partire da Malinowski, metodo dell’osservazione partecipante. Ha forse ragione Clifford Geertz: fu “più un desiderio che un metodo”[7]. In ogni caso, Geertz rilancia e discute proficuamente questo concetto, con una particolare attenzione alle esperienze di “etnografia immersionista”[8], nelle quali l’antropologo pone al centro della sua tensione partecipativa lo sforzo di essere accettato dal gruppo sociale studiato, stabilendo con alcuni membri di questo stesso gruppo un certo afflato emozionale, una certa empatia: condizione di possibilità di ogni conoscenza autentica e radicale. Come ha ben detto Geertz in un’intervista, con disarmante semplicità: “Non si può capire la gente senza interagire con essa dal punto di vista umano”[9]. Entra in gioco, qui, quello che Geertz chiama l’osservatore situato; quello che Sartre, circa trent’anni prima, aveva definito uno sguardo situato: laddove cioè “l’atto del guardare” – come scrive Francesco Faeta, un antropologo sensibile alla curvatura probabilistica connessa al principio di indeterminazione di Heisenberg –, “modifica, com’è ben noto, la realtà osservata e diviene sensato, così, spostare il focus etnografico dai fenomeni, in sé e nel loro divenire, alle pratiche d’interazione tra osservatori e osservati”[10].
Solo a partire da uno sguardo situato – cioè da un attività conoscitiva situata, immersa e coinvolta in quello stesso mondo che occorre conoscere – possiamo cogliere la nostra duplice natura di soggetti liberi e al tempo stesso condizionati: da un lato liberi di conoscere qualcosa che sta fuori di noi, dall’altro lato condizionati dalla nostra intima adesione a questo qualcosa (un qualcosa che perciò si colloca sia dentro che fuori dalla nostra mente). Entro tale prospettiva, possiamo allora definirci all’interno di un’articolazione serrata e ineludibile tra necessità e libertà, tra la sfera dei condizionamenti e l’ambito dei processi di soggettivazione. Possiamo pensarci, in ultima analisi, come soggetti costituiti (prodotti, determinati, inglobati nella realtà da conoscere) e come soggetti costituenti (produttivi, determinanti, capaci di cooperare alla costruzione della realtà che ci ingloba). O ancora, più semplicemente, possiamo comprendere, per usare il lessico di Marx, la nostra appartenenza sia al “regno della necessità” che al “regno della libertà”. Non a caso, proprio alla fine del primo capitolo delle Questioni di metodo, Sartre cita un passaggio marxiano tratto dal Libro III del Capitale:
“Di fatto, il regno della libertà c o m i n c i a soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna: si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria”[11].
Il che significa, per Sartre, che “non appena c o m i n c e r à per tutti un margine di libertà reale oltre la produzione della vita, il marxismo avrà fatto il suo tempo; una filosofia della libertà ne prenderà il posto”[12].

Karl Marx
C o m i n c i a, c o m i n c e r à. Non appena “comincerà”, scriveva Sartre: in questo commento, l’avvento di una filosofia della libertà viene collocato nel futuro ed è perciò legato, in qualche modo, all’adozione di una prospettiva escatologica; ma il testo marxiano utilizza, a ragion veduta, il tempo presente: il regno della libertà, in effetti, “comincia” già ora; oltre a rappresentare il contenuto di una prefigurazione, esso vive anche dentro il presente, nel momento stesso in cui la logica produttiva non domina incontrastata ma subisce, incalzata dal conflitto, interruzioni, battute d’arresto, parziali cessazioni; nel momento stesso, quindi, in cui una variabile antagonista comincia a erodere e a mettere in scacco il determinismo che regola la sfera della produzione materiale.
In ogni caso, determinismo e libertà sono due dimensioni strettamente connesse. Uno spazio non ideologico di libertà e una prospettiva autentica e percorribile di liberazione si sviluppano a partire dalla complessità dei rapporti tra queste due dimensioni; non possono quindi emergere come conseguenza automatica di una loro meccanica successione temporale. La libertà si annida nel determinismo, fa i conti con le sue ferree leggi e con le sue funeste costrizioni. Il determinismo, a sua volta, nel suo storico dispiegamento, ci aiuta a definire i terreni e i momenti entro i quali deve necessariamente svilupparsi ogni movimento antagonista e libertario.
Al di là dei suoi rapporti con l’escatologia marxista – la quale, in armonia con le sue matrici ebraico-cristiane, assegna al proletariato una funzione di salvezza collettiva – va riconosciuto a Sartre il merito (un merito sia filosofico che politico) di aver assegnato una centralità strategica e ineludibile al problema del rapporto tra determinismo e libertà, e quindi tra soggetto costituito e soggetto costituente: un problema presente nella teoria marxiana, nella psicoanalisi freudiana, nell’antropologia e in non pochi luoghi essenziali del pensiero filosofico e scientifico novecentesco. Ci sembra, in verità, qualcosa di più di un problema interno alle singole discipline o a una particolare episteme: è per noi il problema fondamentale del pensiero e della condizione umana, perennemente in bilico tra i bagliori della libertà e le tenebre della necessità. Ed è in ogni caso un problema centrale e decisivo, va detto subito, in tutto l’itinerario filosofico di Michel Foucault.

Un’originale ripresa della problematica sartriana prima menzionata l’ho ritrovata, mutatis mutandis, proprio nell’itinerario di Foucault, e in particolar modo nel passaggio dalla genealogia degli anni ’70 alla successiva messa in scena dei processi di soggettivazione, presente soprattutto negli ultimi due libri (La cura di sé, L’uso dei piaceri) e negli ultimi tre corsi tenuti al Collège de France (L’ermeneutica del soggetto, Il governo di sé e degli altri, Il coraggio della verità). A ben guardare, Sartre e Foucault sono accomunati da una medesima difficoltà, che rappresenta anche la loro scommessa fondamentale: quella di concepire, di comprendere e di vivere gli aspetti attivi e gli aspetti passivi che definiscono il soggetto costituito e il soggetto costituente. Sartre direbbe: “la constitution”[13] e “la personnalisation”[14]; cioè il soggetto determinato – condizionato da una pluralità di dimensioni: l’economia, i rapporti di produzione, l’ideologia, la cultura, la biografia personale, la vicenda familiare, il contesto storico-sociale – e il soggetto determinante, capace di produrre, di mettere in gioco, di inventare spazi di iniziativa e gradi di libertà nei quali possa emergere e affermarsi un “mode de vie”, uno stile di vita, e quindi il profilo di un’identità individuale[15]. Abbiamo dunque un lato passivo – la passività costituita, come la chiamava Sartre[16] – e un lato attivo: due lati distinti ma al tempo stesso collegati da un legame forte e irriducibile, che rappresenta la cifra di ogni specifica singolarità. La singolarità, come si legge nell’Annexe a L’Idiot – pubblicato da Arlette Elkaïm-Sartre nel 1988 –, realizza una “totalisation en intériorité (sujet)” e una “totalisation en extériorité (objet)”: e il soggetto – in questo caso Flaubert – potrà fare la sintesi tra i due livelli (“totalisation extérieure-intérieure”) solo nella misura in cui sarà lui stesso un soggetto-oggetto, “un sujet-objet”[17]. Su questa composizione complessa della singolarità, tutta interna alla dialettica tra costituzione e personalizzazione, Foucault innesta una variabile anarchica – la follia – che spariglia i giochi della dialettica: già nella Prefazione la concepisce al tempo stesso come gesto originario e costitutivo, come esperienza-limite, come fattore imprevedibile, come livello precategoriale che rimane estraneo alla storia, ma che al tempo stesso, lo vedremo, la instaura e la rende possibile[18]. La follia – ancor prima che emergano i profili definiti e riconoscibili delle singolarità – si esprime come terreno privilegiato, all’interno di una “regione scomoda” (p. 9) in cui non è ancora avvenuta la scissione tra ragione e sragione; in cui si cerca di raggiungere “questo grado zero della storia della follia”, dove la follia stessa rimane una “esperienza indifferenziata”, una “expérience non ancore partagée du partage lui-même” (Préface, p. 139)[19]. Un’esperienza-limite, dunque, come lo sono, per il Foucault della Prefazione, il Tragico, l’Oriente, il Sogno, il Desiderio. Un’esperienza della partizione tra ragione e sragione. Un momento inaugurale. Un gesto originario, costitutivo, di rottura: il gesto di una distanza presa, laddove “potrà apparire il territorio in cui l’uomo di follia e l’uomo di ragione, separandosi, non sono ancora separati” (p.10). E’ alla presenza oscura della Follia, della Demenza e della Sragione che la Ragione occidentale deve “qualcosa della sua profondità” (p. 11), così come “la σωϕροσύνη dei dialoghi socratici” deve qualcosa della sua profondità “alla minaccia dell’ὕβρις”. In questa regione scomoda emerge “il problema dei limiti piuttosto che dell’identità di una cultura”. Potremmo anche dire che la definizione dell’identità di una cultura si gioca e si decide sulla percezione dei limiti, sulla messa a fuoco delle esperienze-limite, sulla “storia dei limiti”, cioè “di quei gesti oscuri, necessariamente dimenticati non appena compiuti, coi quali una cultura respinge qualcosa che sarà per lei l’Esteriore”.

Gilles Deleuze
Per cogliere la fisionomia di quella regione scomoda, nella quale l’uomo di follia e l’uomo di ragione dialogano e comunicano nell’ambito della loro radicale alterità – e quindi si separano senza essere ancora separati –, occorre abbandonare una logica dialettica. Occorre pensare ai processi storici attraverso l’uso della sintesi disgiuntiva[20],di matrice kantiana, che troverà molto spazio nel pensiero di Gilles Deleuze, dalla Logica del senso all’Anti-edipo, e che Foucault riproporrà più volte con chiarezza, ad esempio nel 1970 e nel 1979, dopo averla messa in gioco, prima e dopo la Prefazione, senza mai denominarla in modo specifico.
Nel 1970:
“Per liberare la differenza occorre un pensiero senza contraddizione, senza dialettica, senza negazione: un pensiero che dica si alla divergenza; un pensiero affermativo il cui strumento è l a d i s g i u n z i o n e; un pensiero del molteplice, della molteplicità dispersa e nomade”.
Nel 1979:
“Che cos’è la logica dialettica? E’ una logica che mette in gioco dei termini contraddittori nell’elemento dell’omogeneo. A questa logica della dialettica io propongo piuttosto di sostituire quella che chiamerei una logica della strategia. Infatti, una logica della strategia non fa valere termini contraddittori nell’elemento dell’omogeneo, destinato a garantire la loro risoluzione in unità; al contrario, ha la funzione di stabilire quali sono le connessioni possibili tra termini disparati, che restano tali. La logica della strategia è la logica della connessione dell’eterogeneo, non quella dell’omogeneizzazione del contraddittorio”[21].
Se nel Corso del 1979 era necessario tenere insieme, collegandole fra di loro, due dimensioni macrostoriche – due concezioni eterogenee della libertà, e cioè “l’assiomatica fondamentale dei diritti dell’uomo e il calcolo utilitaristico dell’indipendenza dei governati”[22] –, nella Prefazione si sovrappongono, si mescolano e si ibridano l’unità e l’opposizione del senso e dell’insensato, della ragione e della sragione, dell’uomo di follia e dell’uomo di ragione. La logica della connessione dell’eterogeneo si realizza in questo paesaggio ambiguo e contraddittorio – abitato, come verrà detto poi, da una “molteplicità dispersa e nomade” –, dove istanze inseparabili ma contrastanti, o addirittura contrapposte, “intavolano il dialogo della loro rottura”(Prefazione, p.10).
La partizione originaria su cui si fonda questa connessione dell’eterogeneo rappresenta un livello fondativo e costitutivo, a partire dal quale è possibile “parlare dell’esperienza della follia”[23]. Nel penultimo Corso al Collège de France, tracciando un sintetico bilancio del suo itinerario, Foucault dice di aver esplorato la possibilità di una storia delle “expériences”: esperienze della follia, per l’appunto, e quindi esperienze della malattia, della criminalità e della sessualità. “Foyers d’expériences”, così le chiama: focolai di esperienze che sono state importanti nella nostra cultura[24]. Il riferimento all’esperienza, che accomuna la Prefazione del 1961 e il Corso del 1983, mostra, nel sottosuolo teorico dell’intera ricerca, la presenza continua, anche se latente, di un orientamento fondamentale, riconducibile alla filosofia del senso, del soggetto e del vissuto: secondo Foucault, si tratta di un orientamento che si contrappone, nel pensiero francese del Novecento, alla filosofia dell’errore, del concetto e del vivente, alla quale lui stesso si ricollega esplicitamente (una filosofia autorevolmente rappresentata, in Francia, dal lavoro del filosofo e storico delle scienze Georges Canguilhem, uno dei suoi maestri). In un testo del 1978 dedicato a Canguilhem – un testo rivisto e leggermente modificato nel 1984[25] – Foucault ha tematizzato questa contrapposizione, riconoscendo tuttavia al pensiero di Canguilhem, al suo lavoro di storico e di filosofo, “une importance si décisive en France pour tous ces qui, à partir de points de vue si différents, ont essayé de repenser la question du sujet”[26]. Con una mossa inattesa, Foucault ripensa dunque la questione del soggetto, appannaggio tradizionale della fenomenologia e dell’esistenzialismo, situandola anche nell’alveo di una filosofia dell’errore, del concetto e del vivente. In questa prospettiva, la già citata contrapposizione, così come viene presentata negli interventi del 1979 e del 1984, appare meno rigida e definitiva. In effetti, un testo come le Meditazioni cartesiane di Husserl viene considerato “l’enjeu de deux lectures possibles” (la posta in gioco di due letture possibili): la prima che va nella direzione di una filosofia del soggetto (e qui non a caso vengono citati Sartre e Heidegger), la seconda che si muove all’interno di una filosofia del concetto, risalendo alle matrici fondative del pensiero husserliano (il formalismo e l’intuizionismo)[27].
Uno stesso testo si presta dunque a differenti possibilità di lettura, ma questa apertura plurale può realizzarsi solo a partire da una capacità di muoversi nell’ambito di momenti eterogenei del pensiero e della scrittura. In effetti, nel definire la trama delle influenze e dei debiti intellettuali, Foucault privilegia fin dal principio quella che più tardi definirà come una strategia di connessione dell’eterogeneo: non a caso, già a ridosso della thèse sulla follia – nella sua prima intervista, quella rilasciata nel 1961 a J.-P. Weber per Le Monde[28] – egli risponde alla domanda: “Influences?” con la seguente indicazione: “Soprattutto opere letterarie… Maurice Blanchot, Raymond Roussel. Ciò che mi ha interessato e guidato è una certa forma di presenza della follia nella letteratura”[29]. Un’intervista molto breve: due pagine, in cui già compaiono gli ingredienti essenziali di quella che vorrei definire una tecnologia del depistaggio. Dopo il privilegio accordato all’influenza della letteratura, emergono infatti altri punti di riferimento, importanti e in ogni caso eterogenei: Freud e Lacan, anzitutto, e quindi Georges Dumézil. Quest’ultimo, più che per la sua appartenenza disciplinare – l’intervistatore lo definisce piattamente uno “storico delle religioni” – viene ricordato per “la sua idea di struttura”: da lui applicata ai miti e utilizzata da Foucault per “scoprire forme strutturate dell’esperienza”, come lo è stata, ad esempio, la struttura della “segregazione sociale” e dell’ “internamento” dei folli. Dopo aver problematizzato la relazione tra filosofia razionalista e strutture dell’esclusione – assegnando all’internamento la responsabilità di aver sommerso le voci della follia nel “silenzio” dell’âge classique –, Foucault sottolinea l’importanza della “grande protesta lirica che troviamo nella poesia dopo Nerval fino ad Artaud”: quando cioè la follia ritrova e ripropone quella “funzione di manifestazione” e “di rivelazione che essa aveva all’epoca di Shakespeare e di Cervantes”.
Ancora la letteratura, dunque, per comprendere l’esperienza-limite della follia, le sue dimensioni pre-logiche e pre-discorsive, il suo vivere al di qua e al di sotto della storia, il suo essere “irreparabilmente meno della storia” (Prefazione, p. 13). Nella stessa pagina della Prefazione in cui vengono menzionati i deliri di Thorin, “le sue visioni fuggitive”, “i latrati del suo spavento” – Thorin era un “servo quasi analfabeta”, un “demente furioso”, citato come autore di un manoscritto di fine seicento conservato alla Biblioteca dell’Arsenale –, Foucault utilizza la poesia per sondare l’enigma di questa dimensione sfuggente, continuamente sospesa tra l’essere e il non-essere, tra la storia e l’ “assenza di storia”, tra la pienezza della presenza e la voragine dei suoi vuoti [“le forme del vuoto, del vano, del nulla” (Prefazione, 14): “les espèces du vide, du vain, du rien” (Préface, 163)]. La qualità letteraria di questi passaggi risalta con grande evidenza. Non si tratta solo di un esercizio di stile, ma della volontà di scegliere un registro lirico adatto a presentare la dimensione ineffabile e pressoché indicibile di una storia che “non è possibile se non si basa su un’assenza di storia”(p. 14). Il registro lirico prescelto trova una sua coerente continuità con questi due versi folgoranti[30], che Foucault cita senza menzionare l’autore:
Je nommerai désert ce château que tu fus,
Nuit cette voix, absence ton visage[31].
Questi versi del 1953 non vengono commentati, poiché realizzano un continuum sia con la tonalità espressiva dell’intera pagina, sia con il suo contenuto ideativo, presentato e rappresentato. Lo stesso contenuto, cioè la tensione irrisolta tra presenza e assenza – l’altalena enigmatica tra presenza e assenza di storia – attraversa omogeneamente i versi di Bonnefoy e la prosa di Foucault. Questa continuità ideativa ed espressiva rende comprensibile la scelta di non menzionare l’autore dei due versi: si tratta di Yves Bonnefoy, nato tre anni prima di Foucault, nel 1923, e diventato suo collega al Collège de France nel 1981. La tensione tra presenza e assenza, evidente nella Prefazione, trova riscontro sia nei due versi appena citati, del 1953, sia in qualche intervento critico dell’epoca (ad esempio quello del critico G. Piroué, specialista di Victor Hugo, del 1958), sia, infine, negli scritti giovanili di Bonnefoy: basti citare, qui, una prosa del 1959, L’acte et le lieu de la poésie – che il Foucault dell’Histoire potrebbe aver letto – laddove il poeta afferma: “dobbiamo sfidare l’assenza di un essere, il tempo che ci ha frodati, il baratro che si apre nel cuore stesso della presenza”[32].
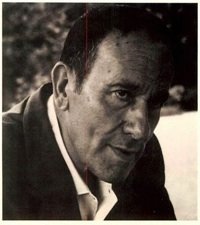
René Char
La scelta di evitare ogni attribuzione d’identità al soggetto dell’enunciazione poetica si ripete altre due volte lungo tutta la Prefazione, quando vengono riportati due passaggi, su cui torneremo, tratti da un’opera poetica di René Char, Fureur et mystère (1948), particolarmente cara a Foucault.
L’attenzione a Char e a Fureur et mystère, giova ricordarlo, emergerà anche in un articolo del 1962, dove Foucault prende lo spunto da un saggio di Jean Laplanche su Hölderlin et la question du père. In questo articolo viene messo l’accento sul “legame tra l’opera e l’assenza d’opera”, per cui si può dire, come scrive Foucault, che “ogni opera è impresa di esaustione del linguaggio”[33]: si rimane, insomma, all’interno di quella oscillazione tra presenza e assenza di storia che attraversa tutta la Prefazione. All’altezza di tale alternanza trova spazio, nell’articolo del 1962, una citazione di “Seuil”, che appartiene alla raccolta Fureur et mystère. Char mette in scena “parole che non volevano perdersi”, che “tentarono di resistere”: e proprio qui, secondo il poeta, “si decise la dinastia del loro significato”[34].
Dopo quella di Bonnefoy, vi è un’altra presenza senza nome: quella di Char, tutt’altro che secondaria. Nella Prefazione, oltre alla nota a fondo pagina in cui il poeta viene citato esplicitamente (p. 19) – e si tratta, ancora una volta, di Fureur et mystère (più in particolare della stanza Suzerain) – sono riportati, come si è detto, altri due passi della stessa raccolta, senza nessuna menzione del loro autore.
Riporto qui, in lingua originale, entrambe le citazioni, accessibili, nel testo, in traduzione italiana (p. 15 e p. 19):
Or, elle “ne dispose là que du morose état civil de ses prisons, de son expérience muette de percécutée, et nous n’avons, nous, que son signalement d’évadée” (Fureur et mystère, “Suzerain”).
Compagnons pathétiques qui murmurez à peine, allez la lampe éteinte et rendez les bijoux. Un mystère nouveau chante dans vos os. Développez votre étrangeté légitime (Fureur et mystère, “Partage formel”, Frammento XXII).
Nella prima citazione, al verbo “dispose” – che nel testo di Char ha un soggetto maschile: “l’Homme violet”, cioè Sade (come mi ha suggerito Stefano Agosti), immerso nell’età della solitudine (“l’âge de la solitude”) – Foucault assegna arbitrariamente un soggetto femminile attinto al periodo precedente: la follia, per l’appunto, la cui libertà può essere compresa solo “dall’alto della fortezza che la tiene prigioniera” (p. 15). Anche qui, come era accaduto prima con i versi di Bonnefoy, il passo poetico di Char viene per così dire sottratto al suo luogo d’origine e inserito nel contesto della Prefazione, in modo da creare un effetto di continuità rispetto ai contenuti e alle modalità espressive di quello stesso contesto.
La seconda citazione chiude la Prefazione e contiene un’incisiva ingiunzione di Char, che può essere senza dubbio considerata – ha ragione Timothy O’Leary – come un’epigrafe dell’intera opera di Foucault[35]: “Sviluppate la vostra legittima stranezza” (p. 19). La parola francese, étrangeté, ha però un duplice significato: è infatti stranezza ma anche estraneità, e riguarda sia coloro che sono strani, sia coloro che sono estranei e stranieri: due condizioni che anche nella lingua inglese vengono rappresentate da due sostantivi distinti (strangeness / foreignness). L’essere stranieri ed estranei, piuttosto che l’essere strani: mi sembra comunque questa l’accezione maggiormente compatibile con il contesto della Prefazione e con il significato che la parola assume in Fureur et mystère: nel Frammento 190 di “Feuillets d’Hypnos” (1943-1944), si parla in effetti di una “inexorable étrangeté”[36]. Si tratta dunque, più che di una stranezza, di un’estraneità legittima e inesorabile, che deve essere riconosciuta e accolta come cifra necessaria e inevitabile della condizione umana.
Questa étrangeté legittima e inesorabile, necessaria e inevitabile, rinvia all’oggetto fondamentale della ricerca, al tema di fondo della Prefazione e di tutta l’Histoire: quella “necessità della follia” che ci rivela il suo stretto legame con la “possibilità della storia” (p. 15). Tematizzare questo livello strutturale e costitutivo della follia significa mettere in gioco non soltanto un’attrezzatura categoriale, ma anche e soprattutto un’esperienza e un Erlebnis: l’esperienza di un qualcosa che, come si è visto, sta irrimediabilmente al di sotto della storia. Qualcosa di meno della storia. Ma è proprio su questo meno che Foucault intende indagare, sul piano dell’esperienza piuttosto che su quello delle idee e dei concetti.
Il che significa interrogare lo scambio, il dialogo e la differenza tra follia e ragione prima che venga realizzata la partizione tra queste due dimensioni a livello delle istituzioni e delle forme di conoscenza. Come dire: sul terreno del renfermement (cioè dell’internamento della follia nelle strutture asilari) e sul terreno delle categorie nosografiche messe in gioco dalla psicopatologia. Si tratta allora di cogliere la follia – e il suo dialogo con la ragione – prima che essa si costituisca come malattia mentale; prima, dunque, dell’internamento e della sua legittimazione psicopatologica; prima che il linguaggio della follia venga ridotto al silenzio (il “lungo silenzio classico”) e venga destinato a un inesorabile oblio. Accedere a questo prima significa addentrarsi in una “regione scomoda”: un’ “oscura regione” che è anche “origine, poiché da lei nascerà il linguaggio della storia”. Così continua poi Foucault, in un passaggio di rara pregnanza espressiva, che ci spinge a privilegiare la ripetizione (una ripetizione che “cade al di fuori del concetto”[37]), e a rifiutare l’anestesia del commento o il terreno disciplinare dell’esegesi:
“la grande opera della storia del mondo è indelebilmente accompagnata da un’assenza d’opera che si rinnova continuamente ma che procede inalterata nel suo vuoto inevitabile lungo il corso della storia stessa: e fin da prima della storia, poiché essa è già presente nella decisione primitiva; e ancora dopo, poiché essa trionferà nell’ultima parola pronunciata dalla storia” (p. 14).
Vale la pena ribadirlo: il registro lirico – privilegiato da Foucault nella Prefazione e presente in molti passaggi dell’Histoire – può restituirci l’intensità della Stimmung emotiva connessa alla messa in scena di una follia intesa come esperienza-limite, come assenza d’opera: tutta giocata sull’enigmatica oscillazione tra presenza e assenza. Il registro lirico, dunque. Questa scelta stilistica abbatte i confini tra filosofia e poesia, convocando direttamente il linguaggio dei poeti come supporto indispensabile di quello che vorrei definire una sorta di lirismo argomentativo: è un movimento espressivo sviluppato da Foucault come pathos, capace di rompere la grigia coerenza e la sacerdotale astrattezza – à la Heidegger – del discorso teoretico: capace, attraverso l’irruzione narrativa e lo slancio poetico, di colmare il vuoto che si spalanca tra la ricchezza della vita e la povertà di quelle che Florenskij chiamava le sue “definizioni razionali”[38]. In questa direzione, la pista era già stata aperta[39], con Nietzsche, Blanchot e Bataille…
Solo un’archeologia del silenzio classico – sostenuta da una solida erudizione, ben presente in tutta l’Histoire, e coniugata con le risorse di un originale lirismo argomentativo[40] – può metterci in contatto con quella terra di confine dove il dialogo tra l’uomo di follia e l’uomo di ragione è ancora possibile, quando la follia stessa non è stata ancora ridotta a malattia mentale, esiliata dalla verità e spogliata dei suoi poteri.
Ma “nella loro forma generale, le grandi strutture della sragione” rimangono comunque “latenti nella cultura occidentale”, e si collocano “un po’ al di sotto del tempo degli storici”[41]. Rimangono al di sotto della soglia di un sapere storico positivo e per essere accolte, ascoltate e intese, come si è visto, hanno bisogno del linguaggio poetico, o, quantomeno, di un lirismo argomentativo capace di riconoscersi in queste voci della follia che non sono ancora sapere, formazione discorsiva, linguaggio strutturato: voci e vociferazioni della follia che ci giungono come balbettii, come parole monche, slegate da ogni sintassi. Voci – come scrive Foucault in uno dei luoghi più intensi e vertiginosi della Prefazione –
“che fanno udire a chi tende l’orecchio un rumore sordo che proviene da sotto la storia, il mormorio ostinato di un linguaggio che dovrebbe parlare da solo: senza soggetto parlante e senza interlocutore, ravvolto su se stesso, stretto alla gola, sprofondante prima d’aver raggiunto qualsiasi formulazione, e che ritorna senza strepito al silenzio di cui non si è mai disfatto: radice calcinata del significato” (p. 14).
Viene in mente, qui, la parola sonora, la parola-grido, la parola-urlo di Antonin Artaud[42], cioè di uno degli autori più frequentemente invocati nell’Histoire quando si tratta di individuare i momenti e i luoghi in cui emerge o riemerge l’esperienza della sragione: tale dimensione esperienziale è “restata in parte nell’ombra” e si è “conservata sordamente – scrive infatti Foucault – a partire dal Nipote di Rameau fino a Raymond Roussel e ad Antonin Artaud”; essa si afferma radicalmente
nella “grande protesta lirica che si trova nella poesia, da Nerval fino ad Artaud, e che rappresenta uno sforzo per restituire all’esperienza della follia una profondità e un potere di rivelazione che erano stati annientati dall’internamento”[43].
In questo scenario, le opere poetiche e letterarie occupano in effetti un ruolo privilegiato. Danno voce a quelle parole imperfette, senza sintassi fissa, di cui si parla nella Prefazione, che costituiscono, molto spesso, l’intelaiatura fragile, provvisoria e al tempo stesso potente della déraison, rompendo verticalmente il legame tradizionale e apparentemente necessario tra significante e significato. Il significante si autonomizza, all’interno di un movimento che raggiunge alcune volte i limiti più estremi: ad esempio con Artaud e con le sue glossolalie, ma anche con Joyce[44] e con Finnegans Wake…
***

Antonin Artaud
Dopo che nel 1946 Gaston Gallimard gli propone di pubblicare le sue Œuvres complètes, Antonin Artaud (1896-1948), nell’agosto di quello stesso anno, scrive un Préambule. Ma la prima edizione del primo volume delle sue opere vede la luce solo dieci anni dopo, nel giugno del 1956: cinque anni prima dell’uscita di Folie et déraison. Un evento letterario di grande rilievo si situa dunque nel periodo in cui, come si è già visto, l’attenzione di Foucault alla letteratura e alla poesia occupa una posizione di primo piano, soprattutto per la loro capacità di dar voce a questa esperienza-limite, perennemente sospesa tra “l’urgenza dell’essere e la pantomima del non-essere”[45]: una sospensione, una tensione tragica tra presenza e assenza – evidente in Char e in Bonnefoy – che attraversa in profondità tutta la scrittura di Artaud e che nel Préambule assume i contorni di una cifra generale, quasi programmatica. Leggiamo infatti: “Les paroles sont un limon qu’on n’éclaire pas du côté de l’être mais du côté de son agonie”[46]. Le parole sono fango, che viene rischiarato non sul versante dell’essere, ma sul versante della sua agonia. Nelle parole prive di sostegno, ontologicamente incerte, che la letteratura e la poesia hanno continuato e continuano a trasmetterci, vive e trova spazio una singolarità che non coincide con l’individualità: una singolarità impersonale o, se si preferisce, un “impersonale singolare”, come avrebbe detto Deleuze, cioè un terreno in cui “la follia rinasce, ma come scoppio lirico: scoperta che nell’uomo l’interno è anche l’esterno, che l’estremo della soggettività si identifica col fascino immediato dell’oggetto”[47].
La follia rinasce come esperienza della sragione lungo quella “grande linea spezzata che va dalla Nave dei Folli alle ultime parole di Nietzsche e forse fino alle vociferazioni di Artaud”[48]. Su quella stessa linea spezzata, Foucault ritrova quello che potremmo definire un testo-soglia, un testo liminare, Le Neveu de Rameau: in questa celebre opera di Denis Diderot, alla quale Foucault dedica uno dei momenti decisivi di tutta l’Histoire, compare “l’ultimo personaggio” dell’età classica “in cui follia e sragione si riuniscono”, che “è anche quello in cui viene prefigurato il momento della separazione”, che svelerà “i suoi significati filosofici e tragici”, rispetto alla cultura occidentale, “soltanto negli ultimi testi di Nietzsche o in Artaud”[49]. La rottura messa in atto dal Neveu de Rameau – che non fu percepita dai contemporanei – “non poteva essere capìta se non all’epoca di Hegel e di Hölderlin”[50]. L’annotazione di Foucault è molto sintetica, ma del tutto pertinente. In effetti, tra il 1761 e il 1777 Diderot lavorò a questo testo, che rimase inedito in Francia fino al 1823. In possesso di un esemplare manoscritto giunto clandestinamente a Leipzig, Goethe lo tradusse nel 1805 (Rameaus Neffe, Leipzig 1805). Nella Fenomenologia dello spirito Hegel lo citerà utilizzando questa versione tedesca. Sono propenso a credere che Foucault abbia tenuto presente la lettura hegeliana del Neveu, se non altro grazie alla mediazione di Jean Hyppolite – suo riconosciuto punto di riferimento –, che pubblicò la fondamentale monografia sulla Fenomenologia hegeliana nel 1946[51]. Oltre a questa ragione, connessa alla trama delle filiazioni intellettuali, vi è anche, forse, un motivo intrinseco, molto più sostanziale. Il Neveu viene in effetti utilizzato da Hegel come esemplificazione paradigmatica di quello che egli chiama Die Sprache der Zerissenheit: il linguaggio della disgregazione (o disgregatezza)[52], dove la coscienza disgregata – questo io puro che è assolutamente scomposto (Ich selbst ist absolut zersetzt [53]) – coinvolge direttamente il mondo della cultura: “Il linguaggio della disgregazione, invece, è il linguaggio perfetto, è la vera esistenza dello spirito di tutto questo mondo della cultura”[54]. L’espressione “mondo della cultura”, Welt der Bildung, va qui restituita alla sua problematica complessità e contraddittorietà, dove Bildung indica, al tempo stesso, l’orizzonte della libertà e quello dell’estraniazione. La tensione tra polarità contrapposte, la logica dell’ossimoro e questa “confusione chiara a se stessa”[55], come la definisce Hegel, attraversano verticalmente il testo di Diderot, quello di Hegel e quello di Foucault. Il linguaggio della disgregazione, che è poi il linguaggio del Nipote, appartiene alla coscienza frammentata, disgregata, scomposta, che è “coscienza dell’inversione, e precisamente dell’inversione assoluta”. E’ un linguaggio ricco di spirito (Sprache geistreich), che proprio in quanto “inganno universale di sé e degli altri” – un inganno pronunciato con impudenza – “costituisce la verità più alta”[56]: esso ci viene restituito con grande efficacia in un passaggio in cui Hegel, riscrivendo il vaniloquio del Nipote, compendia vari brani del testo diderottiano aggiungendovi alcune espressioni proprie:
“un vaniloquio sospeso tra saggezza e follia, come un miscuglio di garbo e di volgarità, di idee giuste e di idee false, di totale perversione del sentimento, dell’infamia più perfetta e, insieme, della verità più schietta. Non si potrà rinunciare ad attraversare tutti questi toni, a percorrere su e giù l’intera scala dei sentimenti, dal disprezzo e dall’abiezione più profondi fino alla più grande ammirazione e commozione; e con questi ultimi sentimenti verrà a fondersi una venatura di ridicolo che li snaturerà”[57].
Se la “coscienza quieta” e “onesta” si ritrova “nell’uguaglianza dei toni”, la “coscienza disgregata” riconosce, in un vaniloquio sospeso tra saggezza e follia, “la verità più alta”, il profilo più elevato della verità: e questo benché entrambi i livelli, anche se distinti, appartengano a “un’unica e medesima coscienza”[58].
Nel tema di un linguaggio della follia come luogo in cui traspaiono le verità segrete dell’uomo, è possibile cogliere la permanenza di alcuni motivi della Fenomenologia hegeliana, circolati in Francia e presenti in Foucault soprattutto grazie all’influenza di Jean Hyppolite[59].
L’esperienza della sragione, che nell’Histoire – e soprattutto nella Prefazione – viene assimilata “alla indicibilità, al grido di dolore o all’urlo del gesto letterario”, produrrà più tardi, nella transizione dall’archeologia alla genealogia, “il passaggio decisivo dell’idea del differenziale – come è stato detto – dall’esperienza-limite […] a un concetto di esperienza che acquista tutta la positività dell’enunciato, della forza reale e dell’evento antagonista in un campo reale di conflitto”. Lungo questa traiettoria, l’esperienza sarà così – cito ancora Mariapaola Fimiani – “quell’atto etico-politico che avrà trasformato la costante «verticalità della follia» in una «freccia sagittale nel presente» e dunque nell’«ontologia dell’attualità» e nell’«ethos filosofico»”[60]. E’ vero: la verticalità della follia è un motivo costante, che non ha mai smesso di irrompere nella scena dei saperi e dei poteri che hanno preteso, già nell’età classica, di confiscarla, di ridurla al silenzio, di avvolgerla nelle tenebre dell’errore e del non-senso. Un’irruzione discontinua ma costante, al di là delle congiunture storiche, oltre e contro le differenti istanze del dominio: in questo senso il folle, portatore di un antagonismo che sta al di là o al di sotto della storia, è un po’ come il cinico – capace di dire il vero anche a rischio della vita –, che per il Foucault degli anni 80 incarna una categoria trans-storica[61]. Tema, questo, ripreso e approfondito da Judith Butler, che si chiede, commentando Foucault, “se esista una storia della ragione che possa rendere conto dell’emergere di un soggetto trans-storico”[62]. Follia e cinismo, dunque, come categorie trans-storiche.
Le emergenze della follia e l’autonomia delle sue espressioni si configurano come fattori antagonisti, che di volta in volta mettono a nudo gli scacchi, le disfunzioni, le zone di fragilità dei dispositivi destinati a controllarla. Sono i dispositivi della nostra modernità che hanno prodotto le notti della follia, il suo “lungo silenzio classico”, attraverso i “lumi” di un sapere positivo (la nosografia) e attraverso la violenza delle pratiche dell’esclusione (l’internamento, l’ospedale, l’asilo). Tuttavia – già nell’età classica, ad esempio con Diderot, come si è visto, ma soprattutto a partire dal primo ottocento e dall’età romantica – i linguaggi della follia rinascono, si impongono e si ripropongono come esplosione lirica: come esperienza lirica irriducibile – e spesso contrapposta – all’obiettivazione prodotta dal pensiero discorsivo e dai saperi a pretesa di verità che lo sorreggono (prima la medicina e la psichiatria, poi la psicologia e la psicoanalisi). Viene così tematizzato nella Prefazione – e sta qui la sua importanza e la sua potenza euristica – un singolare dualismo che scandisce l’esperienza della follia soprattutto a partire dal tramonto dell’età classica: da un lato il lirismo, dall’altro il pensiero discorsivo. Nel pensiero discorsivo il folle si dà come oggetto di conoscenza; nell’esperienza lirica si presenta come tema di riconoscimento. Da un lato una cosa, una cosa medica. Dall’altro lato un soggetto, che presenta dei temi – dei motivi, dei caratteri, degli assetti identitari – nei quali è possibile riconoscersi. Dall’età manicomiale fino ad oggi, questa tensione, sinergica o conflittuale, tra il lirismo (con i suoi risvolti empatici) e il pensiero discorsivo (con i suoi supporti nosografici e istituzionali), rappresenta l’enigmatica ambivalenza connessa ad ogni intervento clinico radicale attorno alla follia. Volendo utilizzare e risituare – non interpretare! – l’Histoire e la Prefazione nello spazio clinico contemporaneo, è allora necessario ridefinire il concetto di lirismo: non è l’apologia della follia, oppure l’ipostasi acritica di una follia sottratta ad ogni sapere positivo che la consideri un oggetto di conoscenza; è invece una postura empatica – realizzata nel contesto delle cure – capace di riannodare le fila di un dialogo respinto o interrotto tra l’uomo di follia e l’uomo di ragione. In questo dialogo vi è la distinzione, la distanza, la coscienza della differenza e della separazione; ma vi è anche l’incontro, il commercio terapeutico, il riconoscimento, l’Einfühlung, che giunge a Foucault attraverso Husserl e Binswanger. Il folle, perciò, in quanto tema di riconoscimento, non esclude il folle in quanto oggetto di conoscenza. Anzi, lo implica, realizzando una sinergia tra questi due poli. Tale sinergia può essere oggi riproposta, nell’ambito di una ricerca filosofico-clinica[63], come sintesi disgiuntiva tra due momenti eterogenei. Ed è sempre bene ricordare, anche in questo caso, che “l’eterogeneità non costituisce mai un principio di esclusione; o meglio ancora, l’eterogeneità non impedisce in nessun caso la coesistenza, la congiunzione, la connessione”[64].
Cerco di situare a questo livello non il mio impegno esegetico e interpretativo, ma la mia lettura e il mio uso – filosofico e clinico – di Foucault, assumendo in maniera radicale ed estesa quanto egli disse con grande chiarezza nel 1975 a proposito di Nietzsche: “Le persone che amo, le utilizzo. Il solo segno di riconoscimento che si possa testimoniare a un pensiero […] è precisamente di utilizzarlo, di deformarlo, di farlo stridere, gridare. Allora, dicano pure i commentatori se si è o non si è fedeli, ciò non ha alcun interesse”[65].
Anche nel contesto clinico, la postura empatica, resa possibile dal lirismo e da una dialettica del riconoscimento, individua, tra i suoi strumenti peculiari, la poesia e la letteratura. In altri termini, una postura empatica implica uno sguardo poetico sulla follia: una poetica della relazione[66] che diventa, necessariamente, anche un’etica dell’accettazione, del riconoscimento, dell’accoglienza dell’altro e del suo “entour”, come lo chiamava Édouard Glissant. Un’esegesi pedante del pensiero di Foucault considera datata tutta questa problematica. L’attenzione alla poesia e alla letteratura, secondo quest’ottica convenzionale, caratterizzerebbe “il giovane Foucault”, o, quantomeno, il Foucault degli anni 60. Due riferimenti essenziali dovrebbero permetterci di porre il problema in termini diversi.
In Archéologie d’une passion[67] – una lunga intervista del 1983 – Foucault riconduce l’opera letteraria di Raymond Roussel al grande tema della scrittura come lavoro su di sé, e quindi come parte essenziale dei processi di soggettivazione e di costruzione di sé. Afferma infatti:
“Si scrive per essere altro da ciò che si è. Vi è una modificazione del proprio modo di essere a cui si mira attraverso il fatto di scrivere. E’ questa modificazione del proprio modo di essere quella che Roussel osservava e cercava: credeva in essa e ne ha terribilmente sofferto”[68].
L’esperienza letteraria è dunque un potente fattore di cambiamento e di autotrasformazione. Una variabile antagonista, in ultima analisi, come lo sono state la follia, i fenomeni di resistenza ai dispositivi di sapere e potere, la parrēsia cinica, le sue posterità politiche ed estetiche, sia moderne che contemporanee.
Per finire, un’ultima citazione, del 1977[69], dove viene messa a fuoco la presenza della letteratura, nel mondo occidentale, come luogo della trasgressione, dello scandalo e della rivolta:
“La letteratura fa […] parte del grande sistema di costrizione mediante il quale l’Occidente ha obbligato il quotidiano a mettersi in discorso; essa vi occupa però un posto particolare: nel suo accanirsi a cercare il quotidiano al di sotto del quotidiano stesso, a superare i limiti, a svelare brutalmente o insidiosamente i segreti, a spiazzare regole e codici, a far dire l’inconfessabile, essa tenderà a porsi fuori legge o, quanto meno, a farsi carico dello scandalo, della trasgressione o della rivolta. Più che qualunque altra forma di linguaggio, la letteratura rimane il discorso dell’«infamia»: ad essa spetta dire ciò che è più indicibile, peggiore, più segreto, più intollerabile, spudorato”.
.
NOTE
[1] Pensata e scritta in vista di questa prima versione italiana integrale dell’Histoire de la folie, l’Introduzione prende lo spunto dai motivi che ci hanno spinto a ripubblicare la Préface della prima edizione (Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Plon, Paris 1961, nata come thèse), che Foucault aveva preferito eliminare dalla seconda edizione (Gallimard, Paris 1972).
[2] Per tutti questi aspetti, mi sia consentito il rinvio a M. Galzigna, Vanità dell’homo faber, Derive della malinconia, in AA. VV., Derive. Figure della soggettività: percorsi trasversali, a cura di I. Adinolfi e M. Galzigna, Mimesis, Milano 2010, pp. 23-50.
[3] J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica, I (Libro primo), preceduto da Questioni di metodo, trad. di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 74, cit. in sèguito come CRD, I.. La riflessione attorno al problema sollevato da questo passaggio epistolare attraversa tutte le Questioni di metodo (pp.15-140) e viene ripresa e approfondita soprattutto nella monumentale ricerca su Flaubert, considerata dall’autore “la suite” delle Questioni di metodo (J.-P. Sartre, L’idiot de la famille, tre volumi, Nouvelle édition revue et complétée, Gallimard, Paris 1988, cit. in sèguito come IF). Il passaggio della lettera di Engels citato a p.74 era già stato menzionato da Sartre più estesamente (CRD, I, p.33): “…Non è dunque, come vogliono immaginarselo qua e là per pura e semplice comodità, un effetto automatico della situazione economica, sono invece gli uomini che fanno la loro storia da soli, ma in un ambiente dato che li condiziona, sulla base di condizioni reali anteriori, tra le quali le condizioni economiche, per influenzate che possano essere dalle altre condizioni politiche e ideologiche, sono nondimeno, in ultima istanza, le condizioni determinanti, e costituiscono da un capo all’altro il filo rosso che, solo, ci permette di comprendere”.
[4] CRD, I, p.37.
[5] CRD, I, ibidem. Faccio qui riferimento alla lunga e densa nota 14 del primo capitolo delle Questioni di metodo: CRD, I, pp. 37-39.
[6] Per un inquadramento dell’etnopsichiatria e, al suo interno, della figura di Devereux, mi permetto di rinviare a.M. Galzigna (a cura di), Volti dell’identità. Le scienze psichiche, l’altro e lo straniero, Marsilio, Venezia 2001 (si veda in particolar modo il contributo di Tobie Nathan).
[7] C. Geertz, Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna 1990, p.90.
[8] Ivi, p. 98.
[9] Intervista del 18 maggio 1992: http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=92. Nella stessa intervista Clifford Geertz (1926-2006) parla di “un’ansia di natura epistemologica” relativa al grado di certezza delle descrizioni antropologiche quando l’ “osservatore esterno” diventa, per forza di cose, “osservatore partecipe” e “osservatore situato”. La comprensione, in altre parole, implica sempre l’immersione dell’antropologo nel fenomeno sociale e culturale studiato: “è un esercizio fenomenologico ed ermeneutico – afferma Geertz in un’intervista del 2002 –, un tentativo di comprendere le cose dal punto di vista del nativo”, anche se la comprensione non può non svilupparsi “nei nostri termini”, cioè nei termini che appartengono al bagaglio “dell’osservatore” (cfr. C. Geertz, «Non faccio sistemi». Intervista di Arun Micheelsen, in “aut aut”, n. 335, 2007 [L’antropologia interpretativa di Clifford Geertz], p. 29).
[10] F. Faeta, Le ragioni dello sguardo, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p.47 (e pp. 47-49).
[11] K. Marx, Il Capitale, Libro terzo, 3, Edizioni Rinascita, Roma 1956, p.231. I corsivisono miei.
[12] CRD, I, p. 34. I corsivi sono di Sartre.
[13] IF, I, pp. 11-647.
[14] IF, I, pp. 653-1106, e IF, II, pp.1111-1775.
[15] Sul concetto di mode de vie nell’ultimo Foucault, cfr. J. Revel, Identità, natura, vita: tre decostruzioni biopolitiche, in M. Galzigna (a cura di), Foucault, oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 134-149.
[16] IF, III, pp. 771-772.
[17] IF, I, p. 653 e sgg.
[18] Sono questi alcuni dei temi portanti della prefazione a Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique (Plon, Parigi 1961). Per semplificare, ho indicato – e indicherò in séguito – tale testo di Foucault come Prefazione, segnalando tra parentesi, se necessario, il numero di pagina relativo alla presente edizione italiana. Se vorrò citare il testo originale – facendo riferimento alla sua riedizione più recente (M. Foucault, Préface, in Id., Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994, I, pp. 159-167) – lo indicherò come Préface, segnalando il numero di pagina di questa riedizione del 1994. Dits et écrits verrà in sèguito citato con le iniziali, DE, seguite dal numero romano relativo al tomo e dalla numerazione araba relativa alle pagine.
[19] La traduzione italiana – “esperienza, non ancora scissa, della scissura stessa” (p. 41) – mi sembra insoddisfacente: partage è “partizione”, non “scissura”.
[20] Sulla sintesi disgiuntiva mi sia consentito il rinvio ad un mio libro, di prossima pubblicazione presso Bollati Boringhieri: Rivolte del pensiero. Per riaprire il tempo.
[21] Nel 1970: M. Foucault, Theatrum Philosophicum, Introduzione a G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna 1971, p. XIII (il testo citato è del 1970: cfr. DE, II, 75-99).
Nel 1979: M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), a cura di M. Senellart, Hautes Études – Gallimard – Seuil, Paris 2004, p. 44. Cito dalla versione italiana: Nascita della biopolitica, trad. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005, p. 49 (i corsivi sono miei).
[22] Ivi, p. 50.
[23] Prefazione, p. 45 (corsivo mio).La stessa espressione ricorre più avanti (p.15), quando Foucault parla di “questa struttura dell’esperienza della follia che appartiene interamente alla storia, ma che sta ai suoi confini e dove essa si decide”.
[24 M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France. 1982-1983, a cura di F. Gros, Hautes Études – Gallimard – Seuil, Paris 2008, p. 7. Cito dalla versione italiana: Il governo di sé e degli altri, Edizione italiana a cura di M. Galzigna, Feltrinelli, Milano 2009, p. 15. Nel 1984 Foucault riprenderà questa espressione – foyer d’expérience – nella prima redazione dell’introduzione generale alla Storia della sessualità. Cfr. Préface à l’«Histoire de la sexualité», DE, IV, pp. 578-584. Vale la pena rileggere il passaggio specifico in questione: “Rimane il fatto che nella Storia della follia era proprio un foyer d’expérience quello che cercavo di descrivere dal punto di vista della storia del pensiero, anche se il mio uso della parola «esperienza» era assai fluttuante” (p.581). Un uso che rimane tuttavia molto largo ed esteso: tra le “forme di esperienza” – precisa Foucault in questa Préface del 1984 – occorre includere le “pratiche di internamento” e le “procedure mediche”, e quindi, in relazione al Seicento e al Settecento, “la genesi di un sistema di pensiero come materia di esperienze possibili”; e cioè: “formazione di un campo di conoscenze che si costituisce come sapere specifico della malattia mentale; organizzazione di un sistema normativo, che poggia su tutto un apparato tecnico, amministrativo, giuridico e medico; definizione, infine, di un rapporto a sé e agli altri come soggetti possibili di follia” (trad. mia). Sul tema dell’esperienza, tra la Prefazione e i lavori del 1984, e sull’uso della letteratura nelle ricerche che Foucault, a partire dall’Histoire, dedica alla follia, si veda l’importante rassegna di Timothy O’Leary, Foucault, Experience, Literature, in «Foucault Studies», N. 5, January 2008, pp. 5-25.
[25]M. Foucault, La vie: l’expérience et la science, in DE, IV, 763-776. Questo importante testo nasce come introduzione alla traduzione americana del saggio di G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique (On the Normal and the Pathological, D. Reidel, Boston 1978). Poco prima della morte (1984), Foucault ha rivisto e leggermente modificato questa sua introduzione, che verrà edita l’anno successivo con lo stesso titolo nella “Revue de métaphysique et de morale” (n. 1, gennaio-marzo 1985, pp. 3-14). E’ stata questa l’ultima pubblicazione autorizzata da Foucault.
[26] DE, IV, 776 [trad. mia: “un’importanza così decisiva in Francia per tutti coloro che, a partire da punti di vista così differenti, hanno cercato di ripensare la questione del soggetto”]. I corsivi sono miei
[27] DE, IV, 764.
[28] M. Foucault, La folie n’existe que dans un société, DE, I, 167-169. Che io sappia, questa è la prima intervista rilasciata da Michel Foucault, che è stato forse il filosofo più intervistato del Novecento. Le interviste, come aveva ben visto Deleuze, rappresentavano per Foucault vere e proprie linee di attualizzazione del suo pensiero. Vorrei aggiungere che molto spesso l’intervista, per Foucault, era anche un modo per orientare e al tempo stesso per depistare i suoi commentatori: per sfuggire alle acribie disciplinari e ai loro mortificanti rituali, mirati, il più delle volte, a produrre una territorializzazione universitaria e disciplinare dei discorsi.
[29] Ivi, p. 169 (trad. mia).
[30] Sono i primi due versi della poesia “Vrai nom”, di Yves Bonnefoy, pubblicata nella sua prima raccolta, Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953). Non si tratta, come è stato scritto da Mattiussi, di un “fragment non identifié”, che potrebbe, al limite, essere attribuito allo stesso Foucault. E’ invece pertinente, più in generale, l’analisi di Mattiussi relativamente al rifiuto di Foucault di ripubblicare nel 1972 la Préface del 1961: cfr. L. Mattiussi, Michel Foucault et le déni de préface, in Mireille Hilsum (a cura di), La relecture de l’œuvre par ses écrivains mêmes, tome II: Se relire contre l’oubli? XXe siècle, Éditions Kimé, Paris 2007, pp. 169-181. Riporto qui la traduzione – della compianta Diana Grange Fiori – dei due primi versi di “Vrai nom”: Nominerò deserto il castello che fosti, / Notte questa tua voce, assenza il viso, in Y. Bonnefoy, L’opera poetica, Mondadori / I Meridiani, Milano 2010, p. 129. Segnalo la rilettura del ruolo di questi versi nella Préface da parte di Stefano Agosti, che per primo li ha attribuiti a Bonnefoy. Cfr. S. Agosti, Rencontres de Douve, in “L’Herne. Yves Bonnefoy”, Paris 2010, pp. 49-51. Significativo, in questo contributo, il ricordo autobiografico: sei anni dopo l’uscita dell’Histoire, durante un colloquio televisivo dedicato a Les Mots et les Choses, Foucault – sollecitato da Stefano Agosti, che aveva menzionato i due versi di Bonnefoy riportati nella Préface –, completò la citazione ripetendo a memoria i due versi successivi.
[31] “Chiamerò deserto quel castello che tu fosti, notte questa voce, assenza il tuo volto” (p.46).
[32] L’atto e il luogo della poesia, trad. di D. Grange Fiori, in Y. Bonnefoy, ivi, pp. 1185. Sulla tensione presenza-assenza nella poesia di Bonnefoy, si veda ad esempio G. Piroué, Yves Bonnefoy ou l’acte de dégager la présence dans l’absence, “Mercure de France”, 1138, giugno 1958, pp. 365-368.
[33] M. Foucault, Le «non» du père, DE, I, 189-203. Traduzione mia.
[34] DE, I, 202-203. Il passo di Char qui riportato da Foucault, da me tradotto solo parzialmente, fa parte di “Seuil”, cioè di una stanza del Poème pulvérisé (1945-1947), confluito nella raccolta Fureur et mystère. Cfr. R. Char, Fureur et mystère, Gallimard, Paris 1996, p. 181. Un’ulteriore e interessante menzione di Char, e di Fureur et mystère, la si ritrova in uno scritto del 1982 – Pierre Boulez, l’écran traversé (DE, IV, 219-222) – in cui Foucault fa riferimento al rapporto tra Boulez e Char nel contesto dell’amicizia che lo legava al musicista già nei primi anni cinquanta.
[35] T. O’Leary, op. cit., p. 7 (“an epigraph to Foucault’s entire work”).
[36] R. Char, Fureur et mystère, cit., p. 136.
[37] M. Foucault, Theatrum Philosophicum, cit., p. X.
[38] “La vita è infinitamente più ricca delle definizioni razionali e perciò nessuna formula può contenere tutta la pienezza della vita”: P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, a cura di Natalino Valentini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, p. 160. Si veda anche la ricca introduzione, scritta dal curatore, N. Valentini, a P. A. Florenskij, Stupore e dialettica, Quodlibet, Macerata 2011.
[39] Su questa pista, si veda, molto bene, F. Rella, Soglie. L’esperienza del pensiero, Anterem Edizioni, Verona 2011.
[40] Georges Canguilhem, nella sua veste di “rapporteur” della Thèse del 1961, elogiò il lavoro di Foucault, anche per la sua capacità di mettere assieme erudizione e poesia, e definì poi l’Histoire, vista sotto il profilo dei suoi effetti, come autentico avvenimento. A Perugia, durante un convegno del 1985 – cioè dieci anni prima della sua morte e un anno dopo la morte di Foucault – Canguilhem, ricordando con commozione l’«allievo» scomparso, mi ha ribadito questi suoi convincimenti. Mi ha anche ribadito che è stato Jean Hyppolite a spingere Foucault a presentargli il suo lavoro di thèse. Cfr. G. Canguilhem, «Ouverture» a Penser la folie, a cura di E. Roudinesco, Galilée, Paris, 1992, pp. 39-42.
[41] Infra, p. 498. Facciamo sempre riferimento a questa edizione anche quando, nel testo, citiamo l’opera, in forma abbreviata, come Histoire.
[42] Su questo mi permetto di rinviare a M. Galzigna (a cura di), Artaud l’irriducibile. Frammenti inediti dei “Cahiers” con testo francese a fronte (interventi di M. Galzigna, E. Borgna, G. Buongiorno, U. Artioli, M. Dotti), Il Poligrafo, Padova 2012.
[43] M. Foucault, La folie n’existe que dans une société (1961), cit., p. 169.
[44] Su questo accostamento, si veda l’originale approccio di E. Grossman, Artaud / Joyce. Le corps et le texte, Nathan, Paris, 1996.
[45] Infra, p. 502.
[46] Cito dal Préambule, scritto da Artaud nel 1946 come premessa all’edizione Gallimard delle sue opere complete, e uscito per la prima volta solo, come già detto, nel 1956: cfr. A. Artaud, Œuvres complètes, I*, Gallimard, Paris 1984, p. 10.
[47] Infra, p. 712.
[48] Infra, p. 498.
[49] Infra, p. 499.
[50] Infra, p. 503.
[51] J. Hyppolite, Genesi e struttura della «Fenomenologia dello Spirito» di Hegel, La Nuova Italia, Firenze 1972. Per il rinvio al Neveu, cfr. pp. 474-475 e pp. 502-511. Sull’asse Foucault- Hyppolite, si veda: il dibattito del 1965 (DE, I, pp. 448-464), l’omaggio a Hyppolite del 1969 (DE, I, pp. 779-785) e la lezione inaugurale al Collège de France del 1970 (cfr. M. Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972: soprattutto pp.54-60).
[52] Ivi, pp. 502 e sgg. Cfr. Hegel, Fenomenologia dello Spirito. Testo tedesco a fronte, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2008², pp. 693-709.
[53] Ivi, pp. 694-695.
[54] Ivi, pp. 696-697. “Mondo della cultura” traduce qui il tedesco Welt der Bildung.
[55] Ivi, p. 703. Richiamandomi direttamente a Foucault e al concetto di matrice kantiana (e poi deleuziana) di sintesi disgiuntiva, avevo valorizzato, prima, la logica della strategia – intesa come “logica della connessione dell’eterogeneo” – contrapposta alla logica dialettica. Sulla stessa linea, mi sembra, si muove la logica dell’ossimoro, proposta, con grande finezza analitica, da Mariapaola Fimiani come griglia di lettura di tre temi portanti della ricerca foucaultiana: la follia, la malattia e la cura. Cfr. M. Fimiani, La follia. Per una logica dell’ossimoro, Atti del convegno “Bioetica pratica e cause di esclusione sociale”, CIRB, Napoli, 18-19 novembre 2010.
[56] Cfr. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, cit., p.701.
[57] Ivi, p. 703.
[58] Ivi, p. 695.
[59] Cfr. la nota 51. Sulla possibilità di leggere l’etica e la politica di Foucault con gli strumenti concettuali della Fenomenologia dello spirito, si veda M. Fimiani, Erotica e retorica. Foucault e la lotta per il riconoscimento, ombre corte, Verona 2007.
[60] M. Fimiani, La follia. Per una logica dell’ossimoro, cit.
[61] M. Foucault, Le courage de la vérité. Cours au Collège de France 1984, a cura di Frédéric Gros, Gallimard-Seuil, Paris 2009 [Edizione italiana a cura di M. Galzigna, Il coraggio della verità, Feltrinelli, Milano 2011]. Si veda soprattutto la Lezione del 29 febbraio 1984 (prima ora), dove viene affrontato il tema delle “posterità del cinismo”.
[62] J. Butler, Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006, p. 154. Su questo mi permetto il rinvio alla mia Introduzione a: M. Galzigna (a cura di), Foucault, oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 7-27.
[63] Per quanto riguarda la ricerca filosofico-clinica attorno alla psichiatria, mi sia consentito un rinvio a M. Galzigna, Il mondo nella mente. Per un’epistemologia della cura, Marsilio, Venezia 2007.
[64] M. Foucault, Naissance de la biopolitique, cit., ibidem. Cito dalla versione italiana: Nascita della biopolitica, cit., ibidem.
[65] Entretien sur la prison (1975), in DE II, p. 753 (trad. mia).
[66] E. Glissant, Poetica della relazione, Quodlibet, Macerata 2007.
[67] DE, IV, pp. 599-608.
[68] Ivi, p. 605.
[69] M. Foucault, La vita degli uomini infami, trad. di G. Zattoni Nesi, con postfazione di Remo Bodei, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 67-68. Ed. originale: La vie des hommes infâmes, «Les Cahiers du Chemin», N. 29, 1977, pp. 12-29, poi in DE, III, pp. 237-253. Corsivi miei.
.

Michel Foucault
Storia della follia nell’età classica
Nuova edizione a cura di Mario Galzigna
BUR alta fedeltà – Rizzoli, Milano 2011
p. 819, € 12,90

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ho appena finito di leggere tutta la prefazione e -sia da insider che sta bestemmiando perchè questa cosa vuol dire che ho più roba su cui lavorare per la tesi in medicina sugli OPG, sia da appassionata (non è il termine giusto ma non ne trovo di migliori) di Foucault (che per altro mi ha fatto prendere 30 all’esame di psichiatria, mica cazzi!), la trovo meravigliosa.
Considerazione (amara) finale: vista l’iperdiffusione delle neuroscienze e della cosiddetta “psichiatria molecolare” (che, in soldoni, tende a considerare le alterazioni molecolari oggettive alla base delle patologie psichiatriche e sotto questo punto di vista è positiva perchè, appunto, oggettivizza la valutazione psichiatrica) si tenderà, secondo me, sempre di più verso l’idea del folle-oggetto (di studio clinico) accantonando quella del folle-soggetto (persona). A livello terapeutico vuol dire più psicofarmaci (anche se si suppone che diventino specifici e non semplicemente sedativi sui sintomi) e meno analisi sul vissuto del soggetto e su tutti quei dati non semplicemente oggettivi e quantificabili che stanno intorno e dietro alla genesi della patologia. Se non si trova un compromesso tra la necessità di oggettivizzare la psichiatria e quella di considerare NECESSARIAMENTE gli interlocutori come persone, con tutta una storia, con tutto un substrato (questo dovrebbe essere in medicina in genere ma in psichiatria di più), la vedo VERAMENTE nera.
Magari un buon inizio sarebbe far studiare OBBLIGATORIAMENTE Foucault (ma anche Laing che io adoro e Basaglia) nei corsi universitari di psichiatria a medicina (non solo nelle specialistiche), affiancandoli ai mille stracazzi sulla parte funzionale e sulla psicofarmacologia. Non voglio passare per la snob intellettualoide della situazione, ma GIURO che se chiedo ad uno qualunque dei miei colleghi di corso sanno dire tutto su come agiscono gli psicofarmaci ma per l’80% di Storia della Follia non hanno mai sentito parlare, di Laing meno che meno e di Basaglia sanno solo che è “quello che ha fatto chiudere i manicomi”.
Ed è triste.
@ eveblissett
Mi sa che oggi come oggi il “problema” non è l’80% e passa dei tuoi colleghi, ma una come te che, se si sta laureando, dovrebbe essere sotto gli “anta”, e sa chi è Laing (e quindi ti meriti una dedica: http://www.youtube.com/watch?v=mI8dBOIuG9I). Le considerazioni che fai sono appropriate, temo: incrociando questo “primo” Foucault con l’ultimo decennio dei suoi studi e la scoperta delle dinamiche della società del controllo, tra un farmaco i cui risultati sono quantificabili e misurabili, e un prendersi cura in senso umanistico (à la Laing, appunto) dell’altro, la partita, se non è persa in partenza, è quantomeno è truccata.
Un solo appunto: io non tirerei in ballo le neuroscienze in sé, quanto l’aurea di “oggettività scientifica” che pervade la loro diffusione, in un ambiente culturale nel quale si tende sempre più a dimenticare che il dato rilevato è sempre determinato dalle mosse dell’osservatore, quindi soggettivo, o almeno parziale. Questa neo-oggettività è la risposta più semplicistica (ma anche l’unica capace di generare pratiche di controllo e di governance) alla scoperta che il bios, cioè la vita, è qualcosa che ci eccede, che non determiniamo, ma da cui siamo determinati (capitolo finale di Le parole e le cose). Ma qui siamo già OT, temo.
Sono felice. E ancora una volta vi sono riconoscente per aver pubblicato questa splendida introduzione.
Ciascuno di noi ha dei temi prediletti, degli argomenti che provocano slanci e su cui si sono versate a lungo lacrime di passione. La ricompensa a tanto trasporto spesso non è costituita da altro se non dall’imbattersi in pezzi come questo che senza preavviso rinfiammano il desiderio.
Ho letto e seguito il filo del discorso da “esperta” nel senso che tutti coloro a cui si fa riferimento, o soltanto un accenno, sono anche i padri del mio pensiero filosofico e fanno parte di un’unica grande famiglia che amo.
Il punto di osservazione che nelle mie ricerche ho più volte privilegiato è proprio quello che nell’introduzione di Galzigna va sotto il nome di “esperienza-limite” (definizione peraltro ideata da Blanchot), ma che di volta in volta e in accordo con i diversi pensatori assume nomi e inaugura percorsi di pensiero differenti.: Bataille la chiama “esperienza interiore”, Foucault “pensiero del fuori”, Deleuze “esperienza della superficie” ecc. Seppure in maniera peculiare per ciascuno, questa “esperienza” condivisa trascina inevitabilmente con sé una riflessione sul linguaggio e si pone subito come scardinamento del Discorso dialettico. Il pensiero della “differenza” e della “molteplicità dispersa e nomade” promuove infatti un linguaggio che rompe con tutte le abitudini di una retorica basata sullo sviluppo (dialettica hegeliana) e va invece ad abbracciare l’ambiguità, l’eterogeneità e il paradosso. (Da questo punto di vista tutta questa parte della filosofia novecentesca non fa che riconoscere tardivamente il merito ad Eraclito, il quale migliaia di anni prima forse aveva già capito tutto…). Se nella dialettica hegeliana la contraddizione viene superata per sfociare nella rassicurazione dell’uno, in questo nuovo modo di pensare il linguaggio la parola si fa elusiva, restando deliberatamente sul bordo. E’ la parola del folle, ma è anche la parola del poeta, del narratore, dell’uomo di spirito e forse (come sostenuto nella mia tesi) è la parola dell’uomo in quanto tale, a patto che costui ne accetti il rischio e la responsabilità. L’esperienza limite non è soltanto il preludio della follia, ma è quel PRIMA in cui si situa senza veramente situarsi l’io che non è ancora soggetto, la parola che non è ancora stata enunciata, la storia che è ancora al di qua e al di là della storia. “L’oblio mortifero di Orfeo, l’attesa di Ulisse incatenato, sono l’essere stesso del linguaggio” (Michel Foucault, Il pensiero del fuori). In questo paradosso essenziale, che personalmente ravviso in quella sospensione mortifera che è l’enunciazione, è inscritto il segno e il destino dell’uomo e del suo linguaggio, destino di ripetere e di essere ripetuto, ma destino che pure costituisce la sua possibilità fondamentale, cioè quella di creare in tale ripetizione parole e mondi inesauribili.
Esiste un residuo che non svanisce come ciò che si contraddice e il principio di coerenza non basta ad interpretare il mondo. Piuttosto ci si affidi alla “caoerranza” (cfr. Deleuze) per cui l’io, sempre spinto come fuori di sé, rimette continuamente in discussione i propri limiti.
Come già detto, echi e sviluppi di questa matrice di pensiero sono presenti in molti filosofi più o meno contemporanei a Foucault: Blanchot, Deleuze, Bataille, Agamben ecc. Non mi spiego però come tra i debiti che si ravvisano nell’opera di Foucault sia così spesso poco riconosciuto o sottovalutato quello nei confronti di Maurice Blanchot. Conoscendo molto bene la produzione filosofica e letteraria di quest’ultimo le corrispondenze mi sembrano evidenti. (I riferimenti al mormorio, all’ “eterna ripetizione”, a ” l’attesa e l’oblio” sono solo i primi esempi che mi vengono in mente). Lo stesso Foucault scrivendo “Il pensiero del fuori” non fa che omaggiare esplicitamente il collega e amico e l’espressione che dà il titolo al saggio (La pensée du de hors) di fatto viene coniata per descrivere la filosofia, la poetica e lo stile di Maurice Blanchot.
Decido di non andare oltre perché di argomenti ne avrei tanti e rischierei di annoiare i non addetti ai lavori. Ciò non toglie che a chiunque ne avesse curiosità sono pronta a far leggere la mia tesi (che ahimé non ho mai pubblicato come invece desideravo). Qui sopra per esempio vedo un filosofo di cui avere un parere mi farebbe mooolto piacere ;-)
E grazie come sempre Wu Ming.
Decrepito.
Se il potere è l’ordine del discorso, qualsiasi emergenza disortografica è sintomo o preludio di liberazione.
Un ventennio di (contro)cultura ci ha marciato fino a sfornare arti e mestieri della parola sconnessa, che oggi appare appena più dignitosa dei jeans griffati, strappati ad arte sotto il ginocchio o la chiappetta.
Ma se la disortografia e lo spettacolo della critica diventano la merce più ricercata dell’industria culturale, quale sarà il nuovo sintomo di liberazione, se non la richiesta di sintassi e leggibilità, in altre parole una nuova ortodossia?
In questo andirivieni del fare e del disfare, che somiglia fin troppo a un semplice pendolarismo del gusto, forse sarebbe ora di mettere in questione il postulato primario di tutto questo strutturalismo sfinito. Tornare a pensare che l’equiparazione di realtà e testo è l’eroica metafora autunnale dell’uomo gutemberghiano, già moribondo.
E dimenticare Foucault.
@ Valter
“dimenticare Foucault” sarebbe una grandissima idiozia. Come al solito, per tue esigenze polemiche – e come sempre intento alla resa dei conti coi fenomeni che attraversasti superficialmente da ragazzo -, confondi un pensiero con la sua vulgata, e getti il bambino con l’acqua sporca.
L’ultimo Foucault, con le sue riflessioni sull’ascetismo, sulla cura di sé, sull’autodisciplina, sul *dire la verità* di fronte al potere, insomma con la sua *riscoperta del soggetto*, che cazzo c’entra con le cose che scrivi nel tuo commento qui sopra?
Quel Foucault è la negazione del semplicistico ciarpame che evochi, e il suo duro lavoro (anche filologico) sulle fonti classiche greco-romane, sull’etimologia, che c’entra con l’apologia di ogni emergenza disortografica?
Eppure (al contempo) quel Foucault porta a un primo compimento (ma altri non ve ne saranno, perché purtroppo morirà subito dopo) un lungo percorso di elaborazione. Non c’è antinomia o netta coupure tra il “giovane Foucault” e il “tardo Foucault”: prima ha descritto i dispositivi che determinano la nostra soggettività, poi ha iniziato a riflettere in modo nuovo sulle pratiche, sul lavoro su di sé, sui possibili spazi di libertà attingibili dal soggetto.
La tua foga nel gettare in pattumiera tutto ciò che ti ricorda chi eri prima di convertirti comincia ad annoiare, perché riduce tutto agli stereotipi di cui ti ingozzasti da fricchettone. Io mi ostino a pensare che esistano molteplici vie, possibilità, dialoghi, contaminazioni, e che la realtà non sia un bivio al quale devi scegliere tra due soli modelli: il fricchettone che suona il bongo accanto a Valcarenghi e Quattrocchi, o il Savonarola di Busto Garolfo.
Ciao, prima volta che commento qui, e lo faccio all’insegna della pedanteria.
L’equiparazione di realtà e testo di cui parla Binaghi è effettivamente un pericolo serio e una trappola in cui sono caduti in tant*. Immagino che il riferimento sia Derrida, o perlomeno il Derrida della différance degli anni Sessanta/Settanta.
Ecco, nella polemica tra Derrida e Foucault sulla Storia della follia, che il primo aveva criticato mettendo in campo un’errata interpretazione di Descartes, Foucault rispondeva (1971) proprio distruggendo l’quiparazione derridiana tra testo e realtà. Sostanzialmente, Foucault diceva a Derrida: ma come, ho scritto un libro di 900 pagine che parla di fatti *e* di testi di vario tipo (filosofici, letterari, ma anche e soprattutto regolamenti ospedalieri, ingiunzioni legali, protestazioni, ecc.) e tu me lo vuoi demolire in nome di un testo filosofico (citato peraltro in una pagina e mezzo su 900)? Il testo *non è* la realtà, diceva Foucault.
@ Menocchi0
ma infatti, è tipico “tirare per la giacchetta” Foucault e scagliarlo nel mucchio del post-strutturalismo e della “French Theory” con relative vulgate e distorsioni, senza distinguere, fermandosi ai clichés. Colpa, forse, anche di una letteratura “secondaria” su Foucault che lo ha “postmodernizzato” (uso l’etichetta nell’accezione più deteriore) e reso impenetrabile, allontanandone l’immagine dai risvolti più concreti della sua opera e della sua militanza sociale e intellettuale.
@ WuMing1
non potrei essere più d’accordo, e anche se dobbiamo riconoscere che in alcuni casi (pochi) Foucault ha dato una mano a chi lo voleva e lo vuole “postmodernizzare”, presentarlo come uno che crede che i discorsi sono ciò che costruisce la realtà mi sembra assurdo. In fin dei conti, basta guardare un momento al suo vocabolario per accorgersene: tecniche, tecnologie, microfisica, corpi…
@Wu Ming1
“come sempre intento alla resa dei conti coi fenomeni che attraversasti superficialmente da ragazzo”
“la tua foga nel gettare in pattumiera tutto ciò che ti ricorda chi eri prima di convertirti comincia ad annoiare, perché riduce tutto agli stereotipi di cui ti ingozzasti da fricchettone”
“il fricchettone che suona il bongo accanto a Valcarenghi e Quattrocchi, o il Savonarola di Busto Garolfo”
Se non riesci a contestare una tesi (l’equiparazione tra realtà e testo è alla base dello strutturalismo e delle sue filiazioni) senza attaccare la persona che la sostiene (peraltro in modo volgare oltre che inutilmente aggressivo: come se io dicessi che i Wu Ming sono in quattro o cinque perchè nessuno riesce a scrivere un romanzo da solo) io ti lascerei qui volentieri, a giocare con le figurine dei surrealisti insieme ai tuoi amichetti.
Non prima di averti ricordato che la comunicazione filosofica richiede sintesi e disponibilità dialettica più che lenzuolate infarcite di citazioni: l’incapacità o il rifiuto di parlare delle cose (la realtà, il testo) anzichè rimandare ai mille distinguo delle epoche di formazione della teoria (il filosofo prima e dopo la scarlattina), dimostra esattamente che negli ultimi decenni e grazie a cotali maestri ci siamo persi di vista il reale o ne abbiamo fatto solo questione di grammatica. Nietzsche, di cui ci si riempie la bocca, ha scritto decine di libri che – quelli si – hanno rivoltato l’occidente, e gli autori (moderni) che ha citato si contano sulle dita di una mano.
Ma se l’andamento seminariale è il tuo prediletto e chiunque non accetti questo stile viene puntualmente preso a schiaffi o rimandato alla propria biografia, direi che il discorso finisce qui.
Però non farti mai più sentire nei miei paraggi a parlare di dialettica o libera ricerca: io ne avrò avuto un’esperienza superficiale, ma tu nemmeno sai cosa siano.
P.S. – Ho letto la “Storia della follia”, “Le parole e le cose” e “La volontà di sapere” tra il 77 e il 79.
Non ci ho trovato niente di diverso da quello che già Levi Strauss dichiarava come il programma delle scienze umane di metodo strutturalista: non di costituire l’uomo, ma di dissolverlo nella natura. Io invece cercavo parole per descrivere ciò che sperimentavo e sperimento, cioè trascendenza dal presente e libertà.
Così non ho più riletto quei libri e, a dire il vero, per qualche anno ho letto meno libri che potevo.
Provate anche voi, è una cosa che ogni tanto fa bene.
PPS – Per accontentare i seminaristi
“L’opera di M. Foucault Le parole e le cose ci offre (…) l’esempio abbastanza sorprendente di un’opera dallo stile scinntillante, piena di idee impreviste e brillanti, di una eruudizione impressionante (in particolare per la storia della biologia, ciò che non si può dire per la storia della psicologia), ma che dello strutturalismo corrente connserva solo gli aspetti negativi senza che si riesca a diiscernere nella sua «archeologia delle scienze umane» (è il sottotitolo del volume) altro che la ricerca di archeetipi concettuali legati principalmente al linguaggio. Fouucault se la prende soprattutto con l’uomo, e considera le scienze umane come il semplice prodotto momentaneo di queste «mutazioni », «a priori storici» o episteme che si succedono senza ordine nel corso dei tempi; innfatti, nato nel XIX secolo, questo studio scientifico delll’uomo scomparirà di morte naturale senza che si possa prevedere da quale nuova varietà di episteme sarà sostituito.
Una delle ragioni di questa prossima estinzione è curiosamente cercata da Foucault nello strutturalismo stesso, che si schiude «alla possibilità e al compito di purifiicare la vecchia ragione empirica attraverso la costituzione di linguaggi formali, e di esercitare una seconda critica della ragion pura a partire da nuove forme delll’a priori matematico ». Infatti, generalizzando così i poteri del linguaggio stesso, «nel gioco delle sue posssibilità tese al loro punto estremo, si annuncia che l’uomo è ” finito”, e che raggiungendo la cima di ogni parola possibile, egli non perviene al cuore di se stesso, ma all’orlo di ciò che lo limita: ossia nella regione in cui si aggira la morte, in cui il pensiero si spegne, in cui la promessa dell’origine indefinitamente arretra ». Eppure, « lo strutturalismo non è un metodo nuovo, ma la coscienza desta e inquieta del sapere moderno».’
Il servizio peculiare reso dalle epistemologie scettiche sta nel sollevare nuovi problemi scuotendo le posizioni di comodo. Ci auguriamo quindi che Foucault susciti l’arrivo di un futuro Kant che ci conduca a un secondo risveglio dal sonno dogmatico. In particolare, da quest’opera animata da intenzioni rivoluzionarie ci aspetteremmo che l’autore presenti una critica salutare delle scienze dell’uomo, alcune delucidazioni sufficienti sul nuovo concetto di episteme e una giustificazione della concezione restrittiva che egli si dà dello strutturalismo. Ora, su questi tre punti, la nostra aspettativa è destinata a rimanere insoddisfatta, giacché, sotto l’estrema abilità della presentazione, scorgiamo quasi solo innumerevoli affermazioni o omissioni: tocca al lettore trovare le dimostrazioni, effettuando gli accostamenti come può.
Per esempio, non basta dire che le scienze umane sono false scienze, poiché « esse non sono affatto scienze. La configurazione che ne definisce la positività e le fonda nell’episteme moderna, le pone al tempo stesso fuori del campo delle scienze; e se a questo punto ci chiediamo perché hanno assunto tale titolo, basterà ricordare che spetta alla definizione archeologica del loro radicamento il fatto di richiedere e di accogliere la traslazione di modelli desunti da scienze ». Se ora chiediamo le prove di queste affermazioni inattese, troviamo soltanto queste:
l. la« configurazione che ne definisce la positività» è un «triedro» inventato da Foucault, le cui tre diimensioni sono: a) le scienze matematiche e fisiche; b) la biologia, l’economia e la linguistica, che non sono scienze umane; 12 c) la riflessione filosofica.
2. Poiché non rientrano né in a), né in b), né in c), le scienze umane non sono quindi scienze:C.V.D.
3• Se si vuol poi sapere perché esse si credono tali, «la definizione archeologica del loro radicamento» lo spiega facilmente, poiché le « definizioni archeologiche» di Foucault non fanno altro che raccontare a cose fatte l’accaduto, come se avesse potuto essere dedotto a priori dalla conoscenza della loro episteme (infatti «la Storia mostra che tutto ciò che viene pensato lo sarà di nuovo ad opera di un pensiero che non ha ancora visto la luce» ).
In realtà, la critica delle scienze umane di Foucault facilita un po’ il proprio compito dandosi di esse una definizione limitativa che nessuno dei loro rappresentanti potrebbe accettare. Per esempio, la linguistica non è una scienza umana, e « potremo parlare di scienze umane non appena avremo cercato di definire il modo in cui gli individui o i gruppi si rappresentano le parole, ecc. ». La psicologia scientifica è nata « dalle nuove norme che la società industriale ha imposto agli individui» nel corso del XIX secolo (vorremmo sapere quali), e le sue radici biologiche sono risolutamente recise. Di questa psicologia non rimane che l’analisi delle rappresentazioni individuali, di cui nessun psicologo potrebbe accontentarsi, e naturalmente l’inconscio freudiano, di cui Foucault riconosce tanto piu il valore in quanto esso annuncia la fine dell’uomo, nel senso di una dissoluzione della sua coscienza come oggetto di studi abusivamente privilegiato. Solamente, Foucault dimentica qui che l’intera vita cognitiva è solidale con strutture egualmente inconsce, ma il cui funzionamento collega la conoscenza alla vita nel suo insieme.
Tuttavia, nulla di tutto ciò avrebbe troppa importanza se tale critica parziale fosse il prezzo di una scoperta; di primo acchito, la nozione di episteme appare nuova, e sembra comportare una specie di strutturalismo epistemologico che sarebbe il benvenuto. Le episteme non formano un sistema di categorie a priori nel senso kantiano, perché – contrariamente a queste categorie e allo «spirito umano» di Lévi-Strauss, che si impongono con necessità in modo permanente – esse si susseguono nel corso della storia, e perfino in modo imprevedibile. Non si tratta neanche dei sistemi di relazioni osservabili che risulterebbero dalle semplici abitudini intellettuali o da mode coartanti che possono generalizzarsi a un dato momento della storia delle scienze. Si tratta di «a priori storici », condizioni preliminari della conoscenza, come le forme trascendentali, ma che durano solo per un periodo limitato della storia e che cedono il posto ad altre quando la loro vena si è esaurita. Leggendo le analisi di Foucault sulle episteme, che egli distingue successivamente, è difficile non pensare ai «paradigmi» descritti da T. S. Kuhn nella sua celebre opera sulle rivoluzioni scientifiche. Di primo acchito, il tentativo di Foucault sembra anzi piu profondo, perché ha delle ambizioni strutturaliste e perché, se riuscisse, dovrebbe portare alla scoperta di strutture propriamente epistemologiche, che collegano l’uno all’altro i principi fondamentali della scienza di un’epoca, mentre Kuhn si limita alla loro descrizione e all’analisi storica delle crisi che hanno causato i mutamenti. Solamente, per realizzare il progetto di Foucault, occorreva un metodo; annziché chiedersi a quali condizioni preliminari si ha il diritto di considerare effettivamente operante una episteme in senso definito, e con quali criteri si potrà mostrare la falsità di un qualsiasi altro sistema di episteme diverse che chiunque potrebbe costruire secondo i diiversi modi di interpretare la storia delle scienze, Foucault si è fidato delle proprie intuizioni e ha sostituito l’improvvisazione speculativa a ogni metodologia sistematica.
Due pericoli erano allora inevitabili: anzitutto l’arbiitrarietà nei caratteri attribuiti a un’episteme, poiché taluni sono scelti al posto di altri possibili, e altri omessi nonostante la loro importanza; in secondo luogo l’eterogeneità delle proprietà ritenute solidali, ma appartenenti a livelli diversi di pensiero, benché storicamente contemporanee. (…) : sostenere che si tratta qui della stessa episteme con il pretesto che c’è stata sincronizzazione, significa essere vittime della storia in un senso abbastanza miope, mentre Foucault pretende liberarsene grazie alla sua «archeologia» intellettuale, e significa trascurare i livelli, mentre evidentemente ci si trova di fronte a due livelli distinti. Questo problema essenziale dei livelli è totalmente asssente dall’opera di Foucault, poiché è contrario alla sua episteme personale e « archeologica ». Il prezzo di queesta negazione è allora esorbitante: la successione delle episteme diviene pertanto interamente incomprensibile, e questo in modo deliberato: il loro creatore sembra anzi provarne una certa soddisfazione. Infatti, le episteme successive non possono essere dedotte l’una dall’altra, né formalmente, né dialetticamente, e non proocedono l’una dall’altra per filiazione, né genetica, né storica. In altri termini, l’ultima parola di una « archeologia» della ragione è che la ragione si trasforma senza ragione e che le sue strutture appaiono e scompaiono per mutazioni fortuite o emergenze momentanee, nello stesso modo in cui ragionavano i biologi prima dello strutturalismo cibernetico contemporaneo.
Non è quindi esagerato definire lo strutturalismo di Foucault uno strutturalismo senza strutture. Dello strutturalismo statico esso conserva tutti gli aspetti negativi: la svalutazione della storia e della genesi, il discredito delle funzioni e, in un grado finora ineguagliato, la negazione del soggetto stesso, poiché l’uomo sta per scompaarire. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, le sue strutture non sono altro che schemi figurativi, e non sistemi di trasformazioni che si conservano necessariamente grazie alla loro autoregolazione. In questo irraazionalismo finale di Foucault l’unico punto fisso è il ricorso al linguaggio, concepito come qualcosa che domina l’uomo perché esterno agli individui: ma anche «l’essere del linguaggio» rimane volontariamente per lui una specie di mistero, di cui egli si compiace soltanto di sottolineare 1’« insistenza enigmatica ».
L’opera di Foucault ha nondimeno un valore insostituibile per l’acutezza della sua intelligenza dissolvente: essa mostra con ogni evidenza l’impossibilità di raggiungere uno strutturalismo coerente astraendolo da ogni costruttivismo. ”
(Da: Jean Piaget, Lo strutturalismo, Il Saggiatore 1994)
Piaget l’avevamo chiamato a suonare i bonghi con noi, e magari rollare un cannone, ma non è mai venuto.
Peccato, ci piaceva il tipo.
@ Valter
Il testo di Piaget è del 1968. Legittimo, per Piaget, reagire all’attacco portato da Foucault all’ortodossia strutturalista (soprattutto al modo piagetiano di intendere il concetto di “struttura”), altrettanto legittimo (ma col veleno in coda: cosa doveva fare Foucault, scrivere un libro di 2000 pagine?) chiedere chiarimenti su una serie di passaggi che lui (Piaget) sostiene di non vedere. Vent’anni dopo, è chiaro a tutti che Foucault non era, né voleva essere, uno strutturalista; che il suo concetto di episteme stride rispetto a quello di “struttura”; e che Foucault i chiarimenti richiesti li ha forniti non andando all’indietro sul piano logico dell’argomentazione, ma andando avanti sul piano della produttività dei propri concetti. Ma anche questo metodo, che deriva da Nietzsche, è opinabile: e certo Piaget (o Barthes) non l’avrebbero accettato. Del resto, la speranza (retorica, ma neanche troppo) di un “nuovo Kant” è una scelta di campo, davanti a un Foucault che si pone come “nuovo Hume”, nel senso dello scetticismo radicale. [Non sarà stato un fricchettone come me e te, il Piaget, ma ci sono modi e arguzie per modificare pro domo sua la posizione avversa mentre si finge di descriverla che fanno rimpiangere l’ingenuità con la quale sedevamo attorno al fuoco in attesa che Allen Ginzberg cominciasse il reading e – ehi, ma quello non è Peter Brook?!? :-)]
Resta il fatto che da un lato le tue critiche mancano della conoscenza del Foucault dei seminari; ma dall’altro, di Foucault hai capito il disegno di fondo, cioè la dissoluzione dell’umano (meglio: del soggetto). Non nella natura, nella storia piuttosto (anche il concetto di “natura” si dissolve con la scienza del secondo Ottocento) – ma il senso è quello. Foucault ti direbbe che lui non vuole causare, ma descrivere – ma di nuovo, una volta intesi su questo, il senso è quello. Ed è vero che è il modo più perspicuo di portare avanti il programma di Lévi-Strauss, una volta esauritosi lo strutturalismo. Il che per me è un merito (infatti sono tornato a rileggermi Tristi tropici, da qualche tempo), per te un demerito.
E qui siamo ai fondamenti, quelli oltre i quali entrano in gioco questioni che hanno a che fare con il carattere individuale, la fede, la credenza, ecc.: a te questo programma non solo non interessa, ma ti ripugna; a me invece interessa, e molto. Più che chiarirci su questo, non vedo possibilità di confronto (di rispetto reciproco sì, però).
Torno al computer soltanto ora, e dico questo: non ho alcun desiderio di accettare qualsivoglia sfida a cornate da parte di una persona che è venuta qui non con l’intenzione di confrontarsi, bensì con quella di sparare a zero.
Anche perché non è davvero possibile discutere di Foucault con un interlocutore che, nel 2011, copia verbatim e usa come pezza d’appoggio (e ipse dixit) qualche pagina del 1968 (!) dove Piaget rimproverava Foucault di
1) non essere un vero strutturalista pur avendo “ambizioni” in tal senso;
2) di essere solo negativo e “dissolvente”;
3) di limitarsi a dire che “il linguaggio domina l’uomo”, fermandosi di fronte a tale “mistero”.
Nel periodo 1961-68 Foucault era sembrato uno strutturalista, nonostante le sue sempre più frequenti precisazioni su tale equivoco.
All’epoca Foucault – tanto per capirci – non aveva ancora avviato i suoi studi sulle carceri, né aveva scritto molti dei suoi lavori più importanti (es. Sorvegliare e punire, e soprattutto i tre volumi della sghembamente intitolata Storia della sessualità). Last but absolutely not least, non aveva ancora iniziato i corsi al Collège de France, che nel loro complesso compongono il suo vero magnum opus, e la cui trascrizione e pubblicazione negli ultimi vent’anni ha arricchito enormemente la nostra comprensione del suo pensiero.
Inoltre, era iniziata solo da pochissimo la fase del suo attivismo politico e sociale, durata fino alla morte. Attivismo che lo portò a *costruire*, a *fondare*, a *proporre*.
Oggi è chiaro a molti che quella di Foucault è al fondo – e soltanto chi non è andato oltre le vulgate può ritenerlo un paradosso – una filosofia del soggetto, formatasi per vie traverse, tramite la radicale messa in questione di ogni precedente concezione del Soggetto. Soggetto le cui possibilità di libertà *concreta*, i cui spazi di manovra tra i dispositivi sono la principale preoccupazione dell’ultimo Foucault. Questo non è affatto un Foucault “dissolvente”: riflette sulle pratiche possibili, sulla “buona vita”, su stoici ed epicurei, sulla necessità del “parlar franco” e del dire il vero su se stessi, sull’assunzione di responsabilità etc.
Non mi soffermo poi sull’altro colossale equivoco, quello di un Foucault… “textocentrico”, perché ci ha già pensato Menocchi0.
Giudizi superficiali e liquidatori come quelli espressi da Binaghi in questa sede necessiterebbero di basamenti ben più solidi di una conoscenza “orecchiata”, palesemente di seconda o terza mano.
Io e Girolamo abbiamo scritto contemporaneamente, dicendo cose molto simili. Bene.
Bene, non conosco il Foucault dei Seminari, quindi non ho diritto di parola (comunque andiamo già meglio rispetto all’invito a suonare i bonghi). A questo punto chiediamoci per quanti italiani stiamo scrivendo e proponendo post, che vadano oltre il numero di un seminario accademico.
Dopodichè, mentre Girolamo riconosce che il problema è (sempre, direi) riconoscere e semmai discutere i fondamenti di certe posizioni (che non sono quasi mai puramente teologici: la filosofia che uno ha dipende dall’uomo che è o decide di essere, diceva Fichte), per Wu Ming1 io sono qui non per confrontarmi ma per sparare a zero. Il che mi fa pensare che l’unico interlocutore che gli piace è quello che si limita a glossare (positivamente) le prolusioni sue o dei “suoi” autori.
Meglio tornare tutti quanti a scrivere romanzi, se nonostante ripetute dichiarazioni in tal senso, amiamo discutere quanto Berlusconi che manda in giro videocassette con l’ipse dixit. Socrate, a cui discutere piaceva sul serio, non si sceglieva gl’interlocutori solo tra i sodali. Infatti non aveva molti simpatizzanti in Atene, mentre qui mi pare che il comandamento primario sia arruolare o contarsi.
Buona giornata.
…e quando lo sparare a zero non funziona, l’escamotage più consueto è lamentarsi che non ti fanno parlare perché loro vogliono stare tra uguali e tu sei “diverso”, scomodo, indisponibile a intrupparsi etc. etc. Mamma mia, che vita agra! :-(
Binaghi, lasciaci perdere: noi facciamo schifo.
Sarà fatto.
una provocazione….
La filosofia di Marx è già qualcosa di più di una “filosofia del soggetto” e questo a partire dal 1845 e le 11 Tesi.
Voglio dire: 1) «Il difetto principale di ogni materialismo fino ad oggi, compreso quello di Feuerbach, è che l’oggetto (Gegenstand, ciò che sta di fronte), il reale, il sensibile è concepito solo sotto la forma dell’ obietto (Objekt, ciò che è proiettato fuori dal soggetto) o dell’ intuizione; ma non come attività umana sensibile, come prassi, non soggettivamente. È accaduto quindi che il lato attivo è stato sviluppato, in modo astratto e in contrasto col materialismo, dall’idealismo, che naturalmente ignora l’attività reale, sensibile come tale. Feuerbach vuole oggetti sensibili realmente distinti dagli oggetti del pensiero; ma non concepisce l’attività umana stessa come attività oggettiva. Perciò nell’Essenza del cristianesimo egli considera come schiettamente umano solo il modo di procedere teorico, mentre la prassi è concepita e fissata da lui soltanto nella sua raffigurazione sordidamente giudaica. Pertanto egli non comprende l’importanza dell’attività “rivoluzionaria”, dell’attività pratico-critica.»
3)La dottrina materialistica, secondo la quale gli uomini sono prodotti delle circostanze e dell’educazione, dimentica che sono proprio gli uomini che modificano le circostanze e che l’educatore stesso deve essere educato. Essa è perciò costretta a separare la società in due parti, una delle quali sta al di sopra dell’altra. La coincidenza nel variare delle circostanze dell’attività umana, o autotrasformazione, può essere concepita o compresa razionalmente solo come prassi rivoluzionaria.»
Concepire la coincidenza Soggetto-Oggetto nella prassi, facendo fuori il concetto di universale (tesi successive), non vuol dire mostrare i limiti di una filosofia del soggetto?
La libertà idealistica-romantica si dava nel tentativo di scavalcare i limiti oggettivi del mondo. In Hegel il soggetto oltrepassa l’oggetto riconoscendolo dentro sé…. Marx fonda quello che è stato definito giustamente un monismo immanentista radicale (soggetto ed oggetto coincidono senza predominanza di nessuno sull’altro).
Ma la praxis in cui si dà la coincidenza, non è, per farla breve la praxis di un soggetto di tipo “romantico”. È la prassi sociale, l’insieme di ciò viene agito in società. Ciò che poi chiamerà auto-produzione della società (tema della coincidenza Poiesis-Praxis ben spiegato da Balibar). All’interno di questa produzione, agiscono non già soggetti, ma soggettività…. (gruppi sociali e/o classi).
Foucault, per quel poco (ma non pochissimo) che lo frequento è importante perché consapevolmente od inconsapevolmente torna allo studio reale di queste soggettività. E lo fa in termini spesso quasi lukàcsiani: ogni libro o corso universitario è uno strumento di analisi del reale che messo in mano ai membri di quella soggettività di cui si parla diventa una bomba rivoluzionaria. Essi scoprono “se stessi” ed inventano un “che fare”.
E nel fare questo, Foucault, rompe con l’assurda ortodossia tardo-marxista per cui le uniche soggettività che meritino di essere studiate sono la “borghesia” ed il “proletariato”.
La vera categoria assente in Foucault – assente proprio perché vuole essere radicalmente sia anti-hegeliano, sia non-strutturalista – è quella di “totalità”. Ed il concetto si soggetto, privo di una totalità sociale da rivoluzionare, temo (ma conosco troppo poco l’ultimo Foucault) rischi di scivolare verso forme che Lukàcs e Goldmanna avrebbero chiamato “tragiche”.
L’utopia (in senso positivo) di Marx è una soggettività che diventi soggetto (il proletariato). Ma senza la “totalità” ogni filosofia del soggetto può solo raccontare l’anelito alla libertà e la sua nostalgia.
Dunque, non una filosofia dell’oggetto (lo strutturalismo se vogliamo), non una filosofia del soggetto, ma il tentativo pratico (quindi anche filosofico) del comunismo.
«La questione se al pensiero umano appartenga una verità oggettiva non è una questione teoretica, ma pratica. È nella prassi che l’uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non – realtà di un pensiero isolato dalla prassi è una questione puramente scolastica».
[ho scritto di fretta. Perdonate imprecisioni possibili e probabili]
@ Valter
Io scrivo rivolgendomi non solo a chi ha letto i testi dei “Seminari” di Foucault, ma soprattutto a chi ancora non li ha letti, e spero li leggerà. Quanti poi siano, non è un problema, pochi o molti che siano.
Per chi legge il francese, il dibattito su struttura ed episteme tra Foucault e gli strutturalisti è esposto con una certa chiarezza su Wiki.fr, alla voce Les Mots et les Choses: . Per inciso, sono questioni ormai storicizzate, che cominciano a trovare spazio persino nei manuali scolastici (che in genere dedicano pochissimo, e pessimo, spazio al post-strutturalismo).
@ Valter Binaghi
Intervengo sulle questioni che riguardano il blog, dato che su Foucault sono troppo ignorante per formulare qualsivoglia critica. A me pare che tu di risposte nel merito dei tuoi interventi ne abbia avute (io le ho lette). La prima risposta di WM1 ti ha fatto incazzare, ok, ma poi tanto lo stesso WM1 quanto Girolamo hanno aggiunto ben altro.
Provo a ipotizzare che la prima risposta, quella che non ti è piaciuta, sia dovuta al modo liquidatorio in cui hai introdotto la tua argomentazione, dicendo che Foucault è decrepito e da dimenticare, e dicendolo qui, dove Foucault fa capolino spesso. E’ un atteggiamento volutamente provocatorio per il quale ti si conosce, ti si sgama, e a volte te lo si fa anche notare. Dopodiché però, ripeto, le risposte nel merito ci sono state. Non ho le conoscenze per valutarle sul piano dei contenuti, ma nel momento in cui uno replica alle cose che hai scritto, fino a prova contraria sta discutendo con te, non sta arruolando né contando nessuno.
Insomma, è paradossale che tu voglia stigmatizzare questo blog come un luogo in cui non si discute quando da tempo vieni qui a discutere (e a volte anche a cercare zizza, onde poi lamentarti d’averla incontrata) e quando solo in questo thread sei intervenuto cinque volte.
Mi permetto di consigliare un atteggiamento un po’ più adulto. Se hai delle cose da controbattere, bene, la discussione procede. Se non le hai, c’è poco da mandarla in vacca, prendiamo atto della cosa e morta lì.
L’ultima e poi basta.
Il problema dei nomi collettivi è che non esistono stili collettivi. Lo stile di Wu Ming1 non somiglia al tuo nè a quello di Girolamo.
Eileggo il mio primo intervento e non trovo ricerca di zizza, ma una critica forse troppo generalizzata a una metafora di successo. “Dimenticare Foucault” era il titolo di un libro famoso, pensavo si fosse capito. Ammetto che m’interessa la contaminazione, se no non frequenterei altri blog che quello degli amici di Pavel Florenskij
Poi si può rispondere in un modo o in un altro, ma rispondere a quell’intervento con un richiamo ai bonghi che suonavo a vent’anni (ma è falso, già allora preferivo la chitarra) è canagliesco oltre che scomposto.
L’unica nota positiva è che chi legge capirà perchè il socialismo, tolto di mano agli operai e affidato agli intellettuali veri o presunti, non sarà mai capace di vincere neanche una corsa coi sacchi.
Valter, tu qui puoi decidere di discutere e litigare con chi ti pare, dato che vige la totale libertà di scelta dell’interlocutore. Puoi decidere di offenderti per le cose che ha scritto WM1 nel suo primo intervento e andartene sbattendo la porta. Puoi decidere di controbattere nel merito del suo secondo intervento. Puoi decidere di controbattere a Girolamo. Puoi perfino discutere con me – anche se non di Foucault-, come stai facendo adesso. Pensa un po’ che regime real-socialista che abbiamo instaurato noi intellettuali “veri o presunti”…
Mah. La mia critica a Valter non era al suo essere stato fricchettone bensì, al contrario e come sempre, all’eccessiva, iper-ribadita, ormai ossessionante *presa di distanza* dal suo essere stato fricchettone, e dal suo infilare questa presa di distanza in ogni dove, soprattutto quando si tratta di sputtanare cose che conobbe da giovane in una versione stereotipata, volgarizzata da una troppo facile “controcultura”. Quindi Foucault sarebbe “decrepito” etc. etc. perché ai tempi suoi troppa gente (Baudrillard compreso) lo leggeva, citava e/o affrontava a cazzo di cane. Invece a essere decrepita è una certa s/lettura di Foucault. E come pezza d’appoggio tira fuori una critica di quarantatre anni fa, quando la parabola di Foucault era agli inizi e non c’era la visuale completa che abbiamo oggi. Ad avermi stancato è l’eterno ritornello di Valter: “State sbagliando, è tutta merda, io ci sono già passato, di gente che la pensava come voi ne ho conosciuta tanta etc. etc.” Lui ha sempre già vissuto tutto, ha sempre già capito tutto, non c’è discorso o prassi di oggi che egli non abbia già sperimentato e poi scartato quarant’anni or sono. Con un simile approccio, per giunta reiterato ad nauseam, discutere diventa impossibile. E inauspicabile. Io ho già dato, con lui chiudo i contatti, il m’a fracassé les marons. Pace e bene.
@ Wu Ming 1
Questo rientra nella tua libertà di scelta dell’interlocutore. Ciò non toglie che Valter, come chiunque, possa venire qui a discutere con chi altro gli pare, dato che Giap non è uno spazio in cui si discute soltanto in due. Quello che lui individua come un problema, cioè la diversità di stili, in realtà è precisamente la ricchezza di un ambito collettivo.
@Wu Ming1
Lo vedi che non vuoi proprio capire?
Chissenefrega di quel che ho (abbiamo) fatto o letto negli anni ’70? Veramente pensi che uno possa per tutta la vita rimanersela con quello? Rassicurati, ho fatto (e scritto) molto altro. Il punto, se interessa a qualcuno, lo riassumo con le parole di Girolamo più sopra che mi dice:
“di Foucault hai capito il disegno di fondo, cioè la dissoluzione dell’umano (meglio: del soggetto). Non nella natura, nella storia piuttosto (anche il concetto di “natura” si dissolve con la scienza del secondo Ottocento) – ma il senso è quello. Foucault ti direbbe che lui non vuole causare, ma descrivere – ma di nuovo, una volta intesi su questo, il senso è quello. Ed è vero che è il modo più perspicuo di portare avanti il programma di Lévi-Strauss, una volta esauritosi lo strutturalismo. ”
E il punto è non astrattamente epistemologico ma politico: una volta identificato il pilota con il circuito che percorre (e questa secondo me è una sintesi di quella non-psicologia humiana a cui a detta di Girolamo stesso F. s’ispira), è ancora possibile un’etica e una politica?
Guarda che questi dubbi li esprimeva, alla fine e non all’inizio della parabola Foucaultiana, un marxista come Franco Rella, in un libretto intitolato “Il mito dell’Altro” in cui si analizzava la triade Foucault-Deleuze-Lacan (mi piacerebbe sapere se questo librino si trova ancora, è da leggere).
Il mio problema non è dire che tutto è già visto ma sapere perchè si continuano a glossare autori di trent’anni fa che hanno avuto l’effetto di rendere astruso e criptico il linguaggio filosofico, mentre non hanno contribuito a fondare nessuna forma di soggettività politica o narrazione condivisibile che per me è lo stesso.
Dopo di loro Lyotard, la svendita della narrazione e il suicidio morale e politico del narratore.
Ma quale filosofia del soggetto?
Quale comunità riesci a vederci?
Ho trovato significativo l’accostamento, fatto da Girolamo, tra Foucault e Hume. Entrambi, seppur da epoche diverse, hanno fatto risuonare il “clamore” dello scetticismo. UNo scetticismo radicale e pragmatico(ma qui il discorso andrebbe sviluppato…), ontologico che, in entrambi i casi, mette in discussione la peggiore tra le illusioni ontologiche (ovviamente da un certo punto di vista…): quella di “sostanza quale Unità”, alla maniera di Plotino, per intenderci (anche se non era quest’ultimo tra i bersagli espliciti nè di Hume nè di Foucault, ovviamente). Sì, perchè, come ricordò Veyne, che di Foucault fu l’amico e consulente negli anni del “coraggio della verità”, “egli fu soprattutto uno scettico che ritenne troppo banale” la verità quale “adaequatio rei et intellectus”. Declinando tale prospettiva possiamo affermare che il filo conduttore che guida la produzione Foucaultiana è la radicale critica del concetto di “sostanza” quale portato trans-storico (verità a-temporali). L’Histoire è, secondo tale lettura, il primo tassello di una estrema decostruzione dell’idea di Unità soggiacente all’ordine discorsivo che reifica il binomio “parole-cose”, leggendo entrambe quali “quiddità” e non invece quali “ecceità”. Tale percorso, svolto attraverso l’intelligente uso del “grimaldello storiografico”, viene applicato, inizialmente nei confronti del paradigma naturalista vigente nelle scienze a prefisso “psi”, e poi, via via, a diversi ambiti discorsivi: il sapere medico (in senso lato), la giurisprudenza, le scienze umane, la sessualità… Sulla scorta di Hume, Foucault ha sempre avuto chiaro che un’analitica dei “giochi di verità” soggiacenti le relazioni paradigmatiche di questi “sistemi-sociali” passava per lo studio microfisico del concetto di soggetto. L’analitica dei “processi di soggettivazione”, più volte rimarcati da Mario Galzigna quale cifra del lavoro Foucaultiano, cos’è? Mettere in discusione la “ragione” che produce il concetto di soggetto è la via principale per preparare il terreno necessario all’accadere dell’Evento coincidente (secondo il più radicale dettato apocalittico) con “i cieli nuovi e i mondi Altri”(quelli che, ad esempio, non si riconoscono nella ratio economica. E in questo ci troviamo d’accordo con P.A. Amato, intelligente, quanto non scontato lettore e interprete del pensiero di Foucault alla luce dei recenti riots). Gli ultimi studi, quelli fatti nella prospettiva Hadot-Brown (e, in misura minore, Veyne stesso) concludono questo percorso cercando di mostrare quanto la “ragione” che ci abita ci renda ventriloqui e, in una certa misura , “pupazzi abitati” da discorsi che ci precedono e che limitano, o perimetrano, la presunta libertà. L’ascesi necessaria per “raggiungere” la verità è quella del soggetto che cerca, attraverso pratiche ed esercizi spirituali, di mettere in discussione quelle strutture trascendentali (e qui il radicale fraintendimento sulle “pratiche filosofiche” che a differenza di quanto sostiene Dal Lago sono radicalmente politiche) attraverso le quali “produciamo inconsapevolmente” (in buona misura) il mondo. Il soggetto è, quindi, una produzione discorsiva “abitata” che solo l’ascesi può, entro certi limiti, rendere libero di agire. IL paradosso è che il soggetto si dà nel suo negarsi identitario, quindi sostanziale. Proprio come sosteneva Lacan. In tutto questo, lo “strutturalismo” continua ad apparirmi una comoda etichetta per quanti sentono il bisogno di incasellare un pensiero che, lungi dal potersi definire “debole”, è di una radicalità assoluta. E, quindi, non categorizzabile attraverso comode, quanto banali, etichette. Questo, senza mancare di rispetto a nessuno.
Nessun dubbio che da Hume in poi quel che viene de-strutturato è il concetto di ontologico di Sostanza (insieme a quello di Forma e di Soggetto che ne sono l’epifenomeno estetico e psicologico). Il dubbio è che fatto questo si abbia ancora un pensiero e una strategia degne di questo nome.
Ritrovato il librino, ripropongo la questione con le parole di Franco Rella:
“Quando Foucault pone l’accento sull”’insieme di regole secondo le quali si separa il vero dal falso” e “sullo statuto economico-politico della verità”, sembra in effetti ripetere la grande questione freudiana (e, prima ancora nietzscheana), con in piu qualcosa, che nel testo di Freud era per lo piu taciuto: il fatto che la questione della verità è sempre legata alla questione del potere; che “il sapere è fatto per prendere posizione”, e che questa posizione è situata in rapporto al potere. Ma chi sa? Chi prende posizione e contro chi? Con quali strumenti? E come socializzare e controllare questi strumenti? E se le relazioni, nello spazio storico, sono relazioni di potere e non di senso, – se il sapere si produce dal potere e si confronta al potere e non al senso – , in che modo attraversare il senso che pure si produce e si estende opaco, oppure si articola e si diversifica intorno a queste relazioni? Eludere la questione del senso non finisce forse per riproporlo come un vuoto originario al di là, anziché al di qua, delle relazioni di potere? E tale vuoto di senso non finisce per trasformare il mondo in una serie indifferente di giochi senza alcuna posta, in un reticolo di discorsi, che era stato l’orizzonte, il limite, contro cui si erano scontrati i grandi pensa tori della crisi della ragione classica?
Questa è la risposta di Foucault. “Chi lotta contro chi? Noi tutti lottiamo contro tutti. C’è sempre qualcosa in noi che lotta contro qualche altra cosa in noi.”
Infatti non c’è un fuori del potere, e dunque la sua microfisica ci attraversa.
Ma a questo punto, in cui tutto è in tutto, e tutto è equivalente, come è possibile avere un sapere che non sia la pura e semplice registrazione di eventi? Un sapere che possa in qualche modo organizzare e modificare gli eventi, averne ragione?”
(Franco Rella, Il mito dell’Altro, Feltrinelli)
@ Wu Ming 4
ovviamente. Ma siccome io di questo giochino che fa (lo hai scritto anche tu: lo si sgama) mi sono rotto le scatole, scelgo di non assecondarlo più.
Ha scritto degli sfondoni (direttamente o per interposto glossatore ultra-datato), glieli si è fatti notare in due o tre, ma ti risulta che li abbia ammessi? No, perché sfondone o non sfondone, è del tutto indifferente. Non è affatto dire cose corrette o scorrette che gli interessa, ma ogni volta ripropinare la sua lezioncina da convertito. A colpi di generalizzazioni indebite, ovviamente, e “compendi” che sono catene di clichés.
Tempo fa, sempre qui su Giap, aveva scritto, cito a memoria: “A sinistra si è ignorato Heidegger e lo si è considerato un autore maledetto”. La mia risposta fu una domanda, cito anche qui a memoria: “Che mi dici allora dell’uso di Heidegger da parte di Sartre e dell’esistenzialismo francese, che sono senza dubbio parte della storia della sinistra e financo del marxismo occidentale, e non stiamo nemmeno parlando di sdoganamenti recenti?”. E lui? Silenzio. Silenzio… fino alla prossima volta che riproporrà il cliché di Heidegger ignorato a sinistra, roba che la puoi sentire da un Marcello Veneziani qualsiasi.
E il problema siamo noi che continuiamo a ragionare su “autori di trent’anni fa” che hanno contribuito a rendere criptico questo e quello :-/
Ragion per cui, io personalmente scelgo di non rispondere più. Credo che rispondendogli gli si permetta di monopolizzare il thread che di volta in volta sceglie come Hyde Park Corner per le sue geremiadi sempre uguali. Era già accaduto con quello su Fanciullacci, e ci volle del bello e del buono per renderlo fruibile anche da altri/e dopo che i botta-e-risposta con lui (tutte precisazioni superflue ma rese necessarie dalla sua boutade iniziale) lo avevano fatto deragliare. Siccome è principalmente con me che vuole fare a cornate, mi sottraggo e lo lascio a incornare l’aria.
Fantastico. Così eviti di rispondere quando non puoi insultare o pontificare. Un vero cacasotto.
Comunque ci sei riuscito. Tolgo le tende, cancello la tua casina dal blogroll e ti auguro tanta chiacchiera in libertà.
@ Valter Binaghi
Ho già detto di non saperne abbastanza su Foucault per entrare nel merito. Tuttavia una cosa, dall’esterno, vorrei provare a dirla lo stesso.
Tu scrivi:
“Il mio problema non è dire che tutto è già visto ma sapere perché si continuano a glossare autori di trent’anni fa che hanno avuto l’effetto di rendere astruso e criptico il linguaggio filosofico, mentre non hanno contribuito a fondare nessuna forma di soggettività politica o narrazione condivisibile, che per me è lo stesso.”
Ecco questa affermazione non significa niente. Negli ultimi tempi in questo blog si parla o si accenna spesso a Foucault. Oltre ad aver pubblicato almeno due tornate di appunti di WM1 – quelli sulle cronache di Foucault dall’Iran nel ’79 e quelli sull’ipotesi di un parallelo tematico con Pasolini – Foucault è stato spesso citato, tirato in ballo nelle discussioni, etc. Ora abbiamo pubblicato l’introduzione di Galzigna (con il quale WM1 ha già avuto modo di discutere in altra sede sulla figura dell’autore, etc.).
Venirci a dire adesso che è tutto tempo perso perché tanto Foucault ha fatto solo danni o tutt’al più è stato inutile, lascia davvero il tempo che trova. O quello che è stato pubblicato e discusso finora su Giap a proposito di Foucault sono tutte fregnacce e perdite di tempo, altrimenti, fino a prova contraria, Foucault offre ancora spunti di riflessione che qualcuno qui prova a raccogliere. Quindi o si entra nel merito del dibattito *attuale* su Foucault (se alcune sue opere vengono pubblicate o ripubblicate adesso un motivo magari ci sarà), altrimenti spendere un giudizio sommario e lapidario su di lui è davvero soltanto un cercare la zuffa.
Devo anche dire che queste dinamiche maschili, questo maldestro cercare tenzone a tutti i costi (“Sciabola o pistola?”), mi viene a noia. Penso che viste da fuori certe dinamiche rischino di suonare un po’ puerili, sia detto senza offesa. La cosa non riguarda mica solo te, sia chiaro, ci caschiamo in parecchi. E’ per questo che suggerivo un atteggiamento diverso. Soprattutto quando si hanno punti di vista differenti. Altrimenti è inevitabile che le discussioni si risolvano all’ultima stoccata (o all’ultima porta sbattuta).
Cercando di tornare al testo, una premessa: chiamare in causa Rella o Dal Lago quando si parla di Foucault è come chiedere un parere sulla disputa tra Guardiola e Menotti (il Barcellona copia il gioco dell’Argentina del 1978?) non a Trapattoni o Sir Alex Ferguson, ma a un Franco Scoglio qualsiasi, o all’allenatore della Giacomense. Ma tant’è…
C’è un chiarimento da fare sui famosi testi dei Seminari (che sono a tutti gli effetti dei libri, redatti come se dovessero andare a stampa, anche se poi Foucault li leggeva a lezione: non brogliacci informi, insomma). Tra il 1976 (La volontà di piacere) e il 1984 (i due successivi volumi della Storia della sessualità) la critica parla(va) di un lungo silenzio di Foucault, costretto dalla scoperta del materiale greco-romano a ripensare la propria opera (non tutta, ma una certa parte sì). In realtà, questo otto anni sono stati riempiti da corsi annuali, per i quali Foucault ha redatto ogni anno un testo. Si tratta di un vero work in progress, e in ogni caso di un pensiero che non ha cessato di pensare: il silenzio di Fucault era solo editoriale, non certo intellettuale.
Una parte importante di questi seminari è stata dedicata a questioni “politiche”. In particolare, Foucault ha articolato il passaggio dalla “società disciplinare” alla “società del controllo” in modo molto più approfondito e analitico di quanto si potesse pensare leggendo la sintesi estrema che ne ha fatto Deleuze nel suo celebre testo Società del controllo. All’interno di questo sviluppo Foucault approfondisce le tecniche di governance. Ecco: bastasse questo, sarebbe già una risposta all’obiezione del pensiero-debolista Rella (che negli anni Ottanta era marxista tanto quanto io ero guardia alta nei Los Angeles Lakers). Non a caso Foucault sposta il discorso (e lo chiarisce nelle interviste rilasciate negli anni Ottanta, quasi tutte disponibili in italiano nei volumi Feltrinelli) sulle forme di resistenza individuale al potere. Del resto, l’obiezione del sapere come pura registrazione degli eventi l’aveva già sollevata Chomsky, nel dialogo olandese con Foucault (tradotto da derive e approdi, e rinvenibile su YouTube): e Foucault aveva risposto, sottolineando come una critica del potere che non vada a fondo dei meccanismi del potere rischia di riprodurre sotto altre forme lo stesso potere che si contesta. La funzione performativa, e non meramente descrittiva, di un discorso che indaga e scopre tecniche di potere fino a ieri non tematizzate è evidente, per chi vuole davvero occuparsi del potere.
Giusto per chiudere: mi sono imbattuto in questi giorni in un foucaultiano inglese, Stephen J. Ball, ignoto a buona parte dell acritica foucaultiana (anche di quella seria e preparata). Ball ha usato, almeno fino a pochi anni fa (sto ancora ricostruendo la sua bibliografia, di lui in italiano non c’è nulla, anche se i suoi testi sono noti a chi si occupa di “governance della scuola”), le categorie foucaultiane afferenti al campo dei micropoteri e delle micropolitiche per studiare i sistemi educativi (che è il suo campo di specializzazione). Tra Google, Google books e Squibd si trova qualcosa (ad esempio: The teacher’s soul and the terrors of performativity, in pdf). In altri termini, ha messo Foucault al lavoro, ne ha fatto una leva per sollevare questioni critiche su un sistema educativo (quello britannico nello specifico: ma quel che ho letto è estensibile anche al nostro) che tende a diventare sempre più una macchina tecnocratica, manageriale e disciplinare. A me queste cose servono come il pane, e aprono prospettive di ricerca.
@Girolamo. Ma Franco Scoglio è stato un grandissimo allenatore…;-) A parte gli scherzi…Il riferimento a Dal Lago, che tra l’altro si è più volte occupato (a modo suo) di Foucault, era per criticare l’indebito accostamento tra il Foucault della “parresia”, Hadot e le “pratiche filosofiche” oggi tanto di moda…Queste ultime rappresentano un altro tassello nel cammino verso “l’ortopedia della mente”, proprio ciò che Foucault ha sempre messo in discussone, privilegiando una psicologia più umanistica e meno naturalistica. Tutti ricordiamo che, parallelamente all’Histoire, Foucault realizzò lo studio su BInswanger che tanto utile gli fu, come ha mostrato E.Basso, per lo sviluppo degli a-priori storici attraverso la mediazione della Daseinsanalyse
@Walter. L’intervento non era rivolto a te ma visto che sei intervenuto, ti dirò che il problema sulla difficoltà a produrre teorie non è nuovo, come ovviamente sai, vi siamo avvinghiati da quasi un secolo ma, non credo che la soluzione consista nell’eludere la questione quanto di cercarla di sviluppare. Ovviamente come e secondo quali “sentieri” sono altre dimensioni del problema stesso. Ma non possiamo incolpare il pompiere che tenta di spegnere l’incendio se non ci riesce e nemmeno possiamo far finta che il fuoco non ci sia…
Mi introduco in punta di piedi nella discussione, solo per segnalarvi che ho scritto un intervento a riguardo sul blog: http://laborsadegliattrezzi.blogspot.com/2011/09/un-altro-robin-hood-si-ma-senza-re.html Il post si intitola Un altro Robin Hood? Sì, ma senza Re “buoni” (a rompere i coglioni), sembra che non c’entri niente ma c’entra. Ne approfitto anche per salutarvi e ringraziarvi, mi sono goduto la lettura.
riguardo al rapporto individuo/storia che è, sono d’accordo con Girolamo, alla base della critica di Valter a Foucault mi vengono in mente le due meravigliose pagine finali di “Civiltà e imperi del mediterraneo…” di Braudel. Consiglio ovviamente la lettura a chi ha a disposizione il volume, per gli altri riassumo (a memoria, per cui correggetemi se sarò inesatto): dopo avere dedicato circa 1000 pagine su 1400 alla storia di lunghissima durata (rapporto uomo/natura) e a quella di lunga durata (le strutture sociali) lo storico cerca di rispondere a chi gli contesta di avere lasciato poco spazio alla libertà degli individui e dice che è “strutturalista per vocazione” e che “la libertà di Filippo II o di Don Giovanni d’Austria sembra tutto sommato una gabbia angusta”…però anche se un individuo nel suo contesto ha a disposizione “solo due o tre colpi” rimane comunque la questione se li saprà portare, se saranno efficaci o meno, se “saprà capire che sono quelli e non altri i colpi possibili”. Insomma, anche a me affascina molto questo sguardo ampio che, sì, sembra dissolvere l’individuo nella storia. Però non riesco e non pensare sempre a quei “due o tre colpi”.
Certo, trattandosi di storia e non di filosofia la riflessione non giunge alla vertigine concettuale, alla tensione di Deleuze o Foucault, ma proprio per questo mi sembra utile per mettere sul tavolo la questione.