
Nell’album-testamento inciso da David Bowie prima di volarsene per sempre in orbita con il Maggiore Tom, il brano che dà il titolo al disco, Black Star, si apre con una strofa criptica:
In the villa of Ormen, in the villa of Ormen
stands a solitary candle, ah-ah, ah-ah
In the centre of it all, in the centre of it all
Your eyes
Una candela brilla solitaria nella villa di Ormen. Ormen… chi era costui? Non costui, in effetti, perché Ormen non è un tale, ma, nella lingua svedese, un animale carico di simbologia: il serpente. All’indomani della morte di Bowie in effetti i fan si sono lanciati in una gara d’ipotesi esegetiche, in mezzo alla quale qualcuno ha fatto notare che Ormen è anche il titolo del romanzo d’esordio dello scrittore svedese Stig Dagerman, pubblicato nel 1945. In quel romanzo il serpente simboleggia la paura e l’angoscia di vivere che ti morde all’improvviso e ti paralizza.
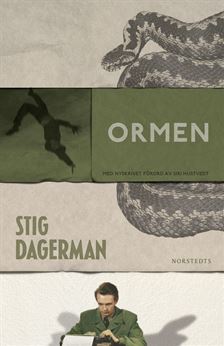 Se Mr. David Robert Jones ha portato via con sé il significato intenzionale di quel verso, nulla può impedirci di leggere l’immagine che ci ha lasciato alla luce del romanzo, pensando anche al momento topico in cui la canzone è stata scritta (Bowie è morto due giorni dopo l’uscita dell’album).
Se Mr. David Robert Jones ha portato via con sé il significato intenzionale di quel verso, nulla può impedirci di leggere l’immagine che ci ha lasciato alla luce del romanzo, pensando anche al momento topico in cui la canzone è stata scritta (Bowie è morto due giorni dopo l’uscita dell’album).
Una candela si erge solitaria nella dimora del serpente, un barlume di luce resiste circondato dal buio angoscioso che può spegnerla in ogni istante. Ecco a voi la condizione umana.
Il romanzo non è mai stato tradotto in Italia, al contrario di altri scritti di Dagerman, autore dalla carriera e dalla vita corta – essendo morto suicida a trentun anni nel 1954 -, ma molto prolifica.
Anarcosindacalista militante, «socialista libertario», come si definiva, da giovanissimo scrisse per testate politiche di area, approdando solo in un secondo tempo alle pagine culturali.
A ventidue anni, a guerra appena finita, pubblicò Ormen, che fece il botto. Diventò uno scrittore famoso, scrisse reportage, articoli, pièces teatrali, racconti e romanzi che lo consacrarono come uno dei giovani autori di maggiore talento della sua generazione.
Dagerman visse questo nuovo status mettendolo in contraddizione con i propri ideali libertari e con il proprio pessimismo, che lo spingevano a essere «il politico dell’impossibile» piuttosto che lo scrittore affermato. Pessimismo e irriducibilità della contraddizione furono la cifra di un’esistenza alla quale Dagerman decise di porre fine in largo anticipo, con l’ostinata coerenza di chi non accetta di accomodarsi nella vita. Una conclusione pratica che dimostra come non si trattasse di una problematicità di maniera, di una posa autocompiaciuta, ma della presa d’atto che «il suicidio è l’unica prova della libertà umana». Dagerman fu uno scrittore militante sui generis – inviso tanto ai conservatori quanto ai marxisti di osservanza sovietica – e continuò fino alla fine a porsi il problema del rapporto conflittuale tra libertà soggettiva e contesto sociale. Aveva introiettato la sconfitta di classe (declinata nel regime “democratico” tanto quanto in quello del socialismo realizzato, in reciproco equilibrio sul filo della guerra fredda) come sconfitta storica dell’umanità, ma proprio per questo era capace di riflettere in maniera nient’affatto narcisistica sul ruolo della letteratura.
Dagerman individua un rischio sempre insito nell’attività dello scrittore: quello di convincersi o farsi convincere (è un concorso di colpa) di essere autore di qualcosa di definitivo, di avere fatto il proprio dovere, di essere arrivato da qualche parte. E’ la hybris che lo porta ad acquisire «una nuova sicurezza, che assomiglia purtroppo alla beatitudine del pensionato». Questo tipo di scrittore diventa presto reazionario, perché
«si è dimenticato che la letteratura va difesa giorno per giorno, momento per momento. Non c’è una difesa definitiva, così come gli attaccanti, i sostenitori dell’ordine più o meno stabilito, non ritengono mai che il loro attacco sia l’ultimo. Se lo scrittore se ne dimentica e si accontenta di scrivere una volta all’anno sugli almanacchi letterari fiacchi resoconti delle più recenti polemiche, si è mandato in pensione da solo. Se va avanti a lavorare come se niente fosse, come se non ci fosse alcuna frizione tra la poesia e la realtà, è perduto anche a una vita da pensionato. Lo scrittore deve sempre partire dal presupposto che la sua è una posizione incerta, che l’esistenza della letteratura è minacciata.»
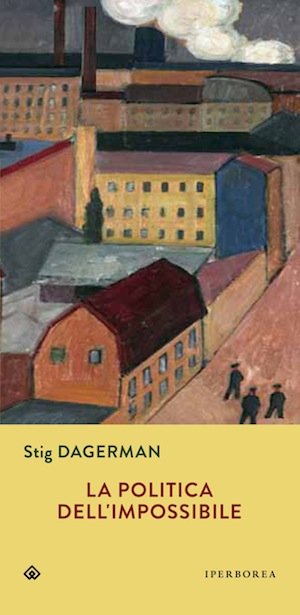 La minaccia ha un fondamento nella qualità effimera della letteratura stessa, la quale non dà pane agli affamati né tetto sulla testa ai diseredati. Lo scrittore deve essere capace di convivere con questo senso di colpa, senza cedere a due opposte tentazioni. Da una parte quella di rifugiarsi tra le braccia dell’ambiente letterario, tra i propri pari, dietro «mura difensive fatte di recensioni, pettegolezzi e reciproca commiserazione»; dall’altra parte quella di abbandonare il campo, di sottrarsi alla letteratura:
La minaccia ha un fondamento nella qualità effimera della letteratura stessa, la quale non dà pane agli affamati né tetto sulla testa ai diseredati. Lo scrittore deve essere capace di convivere con questo senso di colpa, senza cedere a due opposte tentazioni. Da una parte quella di rifugiarsi tra le braccia dell’ambiente letterario, tra i propri pari, dietro «mura difensive fatte di recensioni, pettegolezzi e reciproca commiserazione»; dall’altra parte quella di abbandonare il campo, di sottrarsi alla letteratura:
«Come rinnegato lo scrittore può di certo godere di una certa popolarità tra gli altri traditori, e se questo lo consola buon per lui.»
Se invece lo scrittore è una persona onesta, e ritiene che per qualcuno la letteratura sia una necessità vitale, e quindi di dover «lavorare come se fosse una necessità vitale per tutti», ebbene evita entrambe le tentazioni. Si tiene lontano sia dalla consolazione dell’ambiente letterario sia dal rancore dei rinnegati della letteratura, e si concentra su quale debba essere la propria posizione nel mondo. Anziché rappresentarsi come una figura romantica alla deriva nella società in conflitto, un cavaliere di ventura alla ricerca di una tenzone buona per i suoi denti, accetta il terreno della contraddizione e cerca di orientarsi nel “bosco dei paradossi”, perché quello è il suo posto. Il paradosso che lo vede intento a raccontare storie per gli sfruttati ed essere letto solo da chi ha gli strumenti culturali per farlo. Il paradosso della libertà per la quale la letteratura si batte e deve battersi sempre, sapendo che nessuno, tanto meno lo scrittore, può essere veramente libero, inserito com’è in un dato contesto sociale ed economico.
Prendere posizione, senza fingere di essere soli al mondo. Accettare l’irrisolvibile conflitto tra coscienza sociale e coscienza artistica, senza giustificazioni ideologiche di comodo. Insomma non mettersi alla disperata ricerca di un sentiero che porti fuori dalla selva, ma al contrario trovare «un posto dove accamparsi»:
«Solo quando lo scrittore arriva a stabilirsi davvero nel bosco dei paradossi trova la forza sufficiente per rispondere alle accuse che gli vengono mosse».
Accuse d’essere organico al sistema che vorrebbe scardinare (scarsa coerenza); accuse di non essere abbastanza popolare (troppa coerenza); accuse d’essere criptico (troppa militanza intellettuale) o di essere facile (scarsa militanza intellettuale). E così via.
La risposta non può che essere nelle cose, nel proprio fare, nello schierarsi attraverso una scrittura non già finalistica o ideologica, ma che si fa ponte «da essere umano a essere umano». Si scrive per sentirsi meno soli. Proprio questo fu ciò che non riuscì a Dagerman, che finì a inalare i gas di scarico della propria auto:
«Siccome desidero assicurarmi che la mia vita non sia priva di senso e che io non sia solo sulla terra, raccolgo le parole in un libro e ne faccio dono al mondo. Il mondo mi dà in cambio dei soldi, la fama e il silenzio. Ma che m’importa dei soldi, che m’importa di contribuire a rendere più grande e perfetta la letteratura? L’unica cosa che m’importa è quella che non ottengo mai: l’assicurazione che le mie parole hanno toccato il cuore del mondo. Cos’è allora il mio talento se non una consolazione per la mia solitudine?»
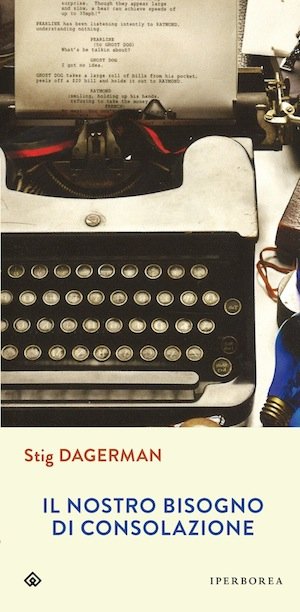 Ecco il punto. Nell’accampamento, in quella radura nel bosco, lo scrittore non deve restare solo. Se mai le sue parole riescono a essere «pietra di paragone della sua sincerità nei confronti della vita», a raccontare un pezzo di verità, allora è possibile una comunità. Quando la scrittura si fa comunità, la vita acquista senso e la morte si allontana, perché – come scriveva il poeta Fortini – «chi ha compagni non morirà».
Ecco il punto. Nell’accampamento, in quella radura nel bosco, lo scrittore non deve restare solo. Se mai le sue parole riescono a essere «pietra di paragone della sua sincerità nei confronti della vita», a raccontare un pezzo di verità, allora è possibile una comunità. Quando la scrittura si fa comunità, la vita acquista senso e la morte si allontana, perché – come scriveva il poeta Fortini – «chi ha compagni non morirà».
Rinunciare ai compagni o smettere di cercarli nel fitto della foresta, significa lasciare l’accampamento e rassegnarsi a una scrittura che è autocontemplazione, spettacolo del sé solipsistico. Significa rassegnarsi alla solitudine. Non già la solitudine tutta retorica del poeta guerriero incompreso, bensì quella del depresso.
Scrivere dunque, per noi che abbiamo scelto di farlo, è rifiutare la schiacciante conclusione di Dagerman e continuare a tracciare sentieri nel bosco. Per salvarsi il culo il più collettivamente possibile. Avanti.
Tutte le citazioni di questo pezzo eccetto una provengono dall’antologia di scritti d’occasione di Stig Dagerman che è stata da poco pubblicata da Iperborea con il titolo La politica dell’impossibile. Il volume verrà presentato domani, venerdì 10 giugno, a Venezia, al festival “I Boreali”, dal traduttore e curatore Fulvio Ferrari (ore 19:00 – Libreria Marco Polo, Dorsoduro, 2899).
Per i cacciatori di simbologie: la Stella Nera è un simbolo anarchico… chissà che Dagerman non c’entri davvero qualcosa con l’ultimo disco di Bowie ;-)

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

E’ fin troppo facile dire che tu di persone (bambini?) nel bosco te ne intendi ;-)
Grazie per avere nuovamente esplicitato la vostra poetica.
Grazie anche per la rilettura del verso di Fortini, per l’ampliamento del senso. Finora avevo inteso “mancherà di morire” come ‘chi resta vivo nel ricordo dei posteri’; invece mi ha fatto bene che mi abbia ricordato che, qui e ora, da vivi, la comunità intorno a te ti accompagna e anche ti sorregge.