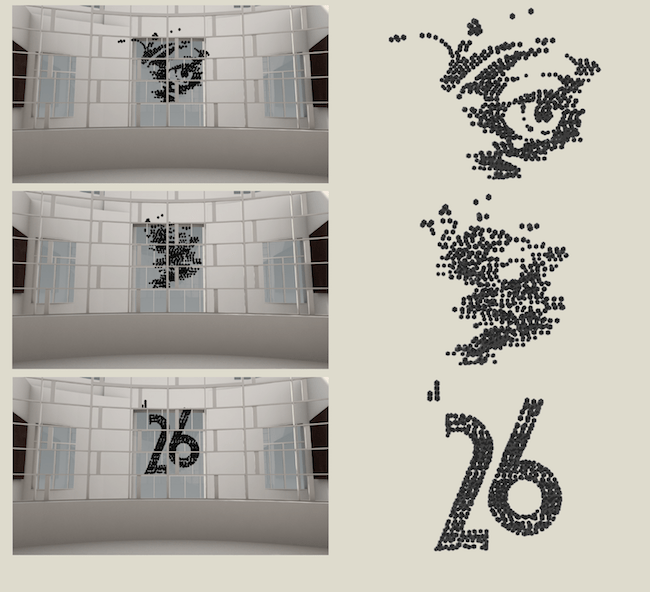
Dettaglio dalle tavole del progetto museografico per l’ex-Casa del Fascio di Predappio: l’«installazione morfica».
Note su Predappio, il progetto di museo nell’ex-Casa del Fascio, i monumenti, la violenza neofascista, la Legge Fiano e altro
di Wu Ming 1
[Se non hai letto le prime due puntate, sono qui: 1 – 2]
INDICE DELLA TERZA PUNTATA
6. Il metodo e il (de)merito
7. Generatore automatico di clichés «post-antifascisti»
- 7a. Genesi della submacchina
- 7b. «Il fascismo è finito settant’anni fa»
- 7c. «Troppo a lungo si è taciuto di…»
- 7d. «Il fascismo ha fatto anche cose buone»
- – Le politiche sociali
- – «Non c’era criminalità»
- – «Le cose funzionavano»
- – La bonifica dell’Agro Pontino
- – Guarda che bella la Casa del Fascio
8. Architettura e monumenti del regime: un dibattito falsato
9. Un progetto museografico ambiguo e sciatto
- 9a. L’importanza di tenere il culo in strada
- 9b. Il mostro della lacuna nera
- 9c. Se c’è qualcosa che non c’entra è la Germania
6. Il metodo e il (de)merito
È orribile doversi occupare dei fascisti, di chi li sdogana, di chi li corteggia, di chi ci beve lo spritz assieme. Si vivrebbe meglio, senza tutti costoro, senza doverne scrivere. Negli anni scorsi, in effetti, molti hanno proposto di ignorarli: non ragioniam di lor ma guarda e passa, «non abbassiamoci al loro livello», «se li contesti gli fai pubblicità» ecc. Una fallacia logica dietro l’altra, per una linea di condotta nefasta.
«Non mi abbasso al loro livello». Come i bimbi che si coprono gli occhi e credono che, così facendo, il mondo intorno scompaia. Mentre non si ragionava di lor, i fascisti suonavano il piffero e si tiravano dietro la gente. Lasciando fare i fascisti — o addirittura isolando chi li contrastava, magari ripetendo, senza capirla minimamente, una frase di Pasolini sul «fascismo degli antifascisti» — si è permesso loro di allargarsi e conquistare spazi.

Anfitrione.
Quanto alla «pubblicità», non gliel’hanno fatta i contestatori. Al contrario, contestando i fascisti si è spesso riusciti a privarli di agibilità, tribune e riflettori, a far saltare iniziative, anche a spingerli verso grottesche figure di merda. Visibilità pure quella, certo, ma non quella che si erano auspicati.
No, a far loro pubblicità, ad amplificarne i messaggi a dismisura, a renderli glamorous è stata la televisione, sono stati i talk show. Quelli di tutte le reti, ma soprattutto quelli de La 7, che negli ultimi anni è diventata un bivacco di manipoli. Bivacco diurno e serale, ospitale e confortevole. A stendere il tappeto sono stati i conduttori criptofascisti, ma anche quelli «democratici», che hanno accolto nei loro salotti duci e ducetti dell’ultradestra, capicenturia del razzismo «civico» organizzato, führer del fascioleghismo, “dialogando” con loro, e mentre “dialogavano”, ogni loro gesto, ogni mossetta, ogni espressione diceva: «Ammiratemi, guardate come sono aperto e liberale, guardate fin dove mi spingo nel confronto democratico», e al tempo stesso: «Non cambiate canale, guardate che razza di freak vi sto mostrando, tra poco dirà qualcosa di oltraggioso, s’alzerà un polverone, stasera faccio uno share della madonna, per commentare usate il solito hashtag».
Ma col tempo i freak sembrano sempre più «normali», e i polveroni non s’alzano più ma gravano sui discorsi e non vanno via, sono perenni, come cappe di smog. Ospitare fascisti diviene consueto, la loro presenza si adagia nella sfera dell’ordinario e così anche i loro discorsi sono potenzialmente accettabili. Ovvero: criticabili, ma legittimi.

Dumini, il capo della squadraccia che uccise Giacomo Matteotti.
E no, questo lugubre spettacolo non può difendersi invocando il «diritto di cronaca», o l’«inchiesta». Se fossero esistiti i talk-show nei giorni del delitto Matteotti, avrebbero invitato Dumini e diviso gli ospiti tra pro e “contro” l’omicidio. Non è «diritto di cronaca», non è giornalismo, è (absit iniuria) teatro. E, da che mondo è mondo, quando a teatro lo spettacolo fa schifo, si lanciano i pomodori. O peggio.
Intanto, fuori da quei salotti, i camerati aggrediscono, accoltellano, talvolta uccidono. Centinaia di aggressioni negli ultimi anni, e sono solo quelle denunciate, quelle che hanno meritato perlomeno un trafiletto, un titolo di giornale locale. Storie che nei talk-show non ci arrivano, e se arrivano, passano fugacemente, in un “servizio”, poi si dà di nuovo la parola al ducetto di turno, assiso in studio, per consentirgli di svicolare, cambiare argomento, imporre la sua agenda.
Non contrastare i fascisti; lasciarli parlare; citare una frase di Voltaire che Voltaire non ha mai scritto… Una linea non solo nefasta, ma gretta, perché da privilegiati, da inabili alla solidarietà: molte persone, infatti, non possono permettersi di «ignorare» il fascismo, perché è il fascismo a non ignorarle, le va a cercare, le colpisce. Soprattutto loro vivrebbero meglio, senza i fascisti e i loro reggimoccolo.
È orribile, è schifoso doversi occupare dei fascisti. Non conosco nessuno che lo faccia volentieri. Se non ci fossero i fascisti, avremmo più tempo, più concentrazione per affrontare altre urgenze. Urgenze enormi, mondiali: lo sconvolgimento climatico già in corso, le siccità e carestie, la crisi idrica globale, l’esaurimento delle risorse, la devastazione del territorio, le guerre e gli esodi che tutto questo provocherà… Tutti disastri causati dal capitalismo, il modo di produzione più cieco, predatorio e di corto respiro che sia mai esistito sul pianeta.
Ma… è proprio questo il punto! Il fascismo è un dispositivo che fabbrica a ciclo continuo falsi problemi — e false soluzioni a quei problemi, quindi false al quadrato. Il fascismo è una «macchina mitologica» che produce bufale diversive, descrive nemici fittizi, addita capri espiatori. Il fascismo intercetta pulsioni ed energie — malcontento, voglia di gridare, di ribellarsi, di organizzarsi, di fare cose insieme — e le incanala in conflitti surrogati, sperperandole, dissipandole. Cos’altro sono le barricate contro l’arrivo in paese di profughi (spesso minorenni), cos’altro sono le mobilitazioni contro la «teoria del gender», il «Piano Kalergi», «le ONG», lo ius soli che avvierà la «sostituzione etnica», i «35 euro al giorno agli immigrati»? Cos’altro sono i demenziali complottismi su Soros (l’ebreo!) che paga tutto e tutti, cos’è tutto questo, se non anticapitalismo deviato e aberrato?
Sempre attuale la massima di August Bebel: «L’antisemitismo è il socialismo degli imbecilli». Il razzismo è l’anticapitalismo di chi è reso imbecille dalla macchina mitologica fascista.
Il fascismo propaganda una falsa rivoluzione: blatera di «mondialismo», di «poteri forti», di «plutocrazie», di oscuri complotti «là in alto», ma — guardacaso — colpisce sempre in basso. Se la prende coi deboli, coi marginali, coi più sfruttati e ricattabili, con le minoranze, i “disturbanti”, gli incollocabili, perché la sua “rivoluzione” è un mascheramento della guerra tra poveri: guerra dei poveri contro i più poveri, dei penultimi contro gli ultimi, del ceto medio pavido d’impoverirsi contro il ceto medio già impoverito, e del ceto medio impoverito contro la working class — che è sempre più multietnica e meticcia, quindi a maggior ragione!
 Il fascismo chiama a una guerra vicaria che impedisca di combattere quella vera, la guerra dal basso verso l’alto. Era così nel 1919, è così adesso e sarà così nel 2019, perché il fascismo serve a quello, da sempre, il sistema capitalistico lo ha generato ad hoc. Il fascismo fu fondato (anche) da ex-rivoluzionari che seppero usare il linguaggio della rivoluzione per fare la controrivoluzione. La stessa parola «fascio» fu rubata al movimento operaio.
Il fascismo chiama a una guerra vicaria che impedisca di combattere quella vera, la guerra dal basso verso l’alto. Era così nel 1919, è così adesso e sarà così nel 2019, perché il fascismo serve a quello, da sempre, il sistema capitalistico lo ha generato ad hoc. Il fascismo fu fondato (anche) da ex-rivoluzionari che seppero usare il linguaggio della rivoluzione per fare la controrivoluzione. La stessa parola «fascio» fu rubata al movimento operaio.
Riempiendosi la bocca di “rivoluzione”, i fascisti distrussero ogni organizzazione rivoluzionaria, uccidendone i membri o costringendoli all’esilio, facendo piazza pulita per conto dei poteri costituiti. Parlando del «popolo lavoratore» e ostentando pose “antiborghesi”, si fecero pagare dalla grande borghesia per colpire, sovente uccidere, i rappresentanti dei lavoratori. Cialtroni in ogni fibra del loro essere, continuarono a baloccarsi con vuoti proclami “anticapitalistici” anche molto dopo la presa del potere, a regime consolidato, quando il fascismo era ormai la forma politica del capitalismo italiano e il braccio politico di Confindustria. Lo ha raccontato nel modo migliore non un marxista, ma un liberale, Ernesto Rossi, nel suo classico I padroni del vapore. La collaborazione fascismo-Confindustria durante il ventennio (1955, ripubblicato da Kaos nel 2001).
Il fascismo è un fascio di false soluzioni a problemi veri falsificati. False soluzioni che retroagiscono sui problemi veri, aggravandoli.
È necessario capire come funziona la macchina mitologica fascista, sfatando gli equivoci che la circondano e smontando le narrazioni tossiche che produce. Bisogna imparare a contrastarla sempre meglio, per impedire o almeno rendere più difficile la cattura di energie conflittuali e il loro dirottamento su lotte surrogate, lotte che separano il «noi» dal «loro» in modi truffaldini e malati, lotte che dividono chi dovrebbe invece unirsi, che fanno perdere tempo prezioso.
Per quanto sia controintuitivo, non ci si può occupare al meglio di cambiamento climatico, o di lotta alle grandi opere inutili, o di lotte nel mondo del lavoro, se non ci si occupa anche del fascismo. Contrastare il fascismo non è occuparsi di un diversivo, ma della macchina che produce i diversivi, per distruggerla.
Non può esserci anticapitalismo senza antifascismo.
La querelle su Predappio e l’eventuale museo del fascismo, con tutto il demerito dell’operazione e i demeriti dei suoi propagandisti, ha il merito di offrirci una sintesi di quasi tutti i clichés e gli elementi narratossici prodotti dalla macchina mitologica. È un utilissimo “studio di caso”. Analizzandolo, si vede come le fallacie logiche, le aporìe, i paralogismi tipici del discorso fascista influenzino anche i discorsi di chi fascista non è, ma — ed è il minimo che si possa dire — ha tenuto la guardia bassa nei confronti del «post-antifascismo».
Il museo del fascismo di Predappio, prima ancora di esistere, è già a suo buon diritto una submacchina mitologica. Che genere di submacchina? Beh, è un…
7. Generatore automatico di clichés «post-antifascisti»

«Personally, I find it is significant that the Predappio question has in a way inverted the order of the issues to be addressed, by forcing us to discuss the location of the museum before even discussing the reasons for establishing such a museum […]» Giulia Albanese, The Memory of Fascism Beyond Predappio
7a. Genesi della submacchina
Al principio, anche qui, si è sostituito un problema con un falso problema. Che non sarebbe stato falso in assoluto, ma era un problema locale, da affrontare in subordine, non per primo. Mettendolo in cima alla lista delle priorità, lo si è reso un falso problema.
Il problema del neofascismo, del quale la situazione a Predappio è un epifenomeno, è stato sostituito dal problema minore del che fare a Predappio e per i predappiesi.
Un dilemma che è principalmente di Frassineti e dei suoi elettori — «come smarcarci dai commerci neri senza perdere i soldi che fanno arrivare in paese?» — è stato presentato come un’urgenza di tutti noi, da affrontare al più presto con pubbliche iniezioni di milioni di euro.
In certe perorazioni, il focus si è ulteriormente ristretto. Ad esempio, si è giustificato lo stanziamento di quei milioni citando le esigenze di imprecisati «storici romagnoli». Nel cantare a priori le lodi del progetto in quanto grande occasione per la public history italiana, lo storico Serge Noiret ha scritto:
«Parlando con molti amici storici romagnoli, si capisce quanto sia importante per loro fare in modo di potere contribuire in prima persona e sul loro territorio a mantenere viva la conoscenza del passato traumatico del fascismo.»
Un puntello alquanto debole, per una supposta emergenza di portata nazionale e dimensione epocale. E debole due volte, perché svariati storici romagnoli, col passare del tempo, hanno maturato una sincera avversità al progetto.

Serge Noiret
Ma, in effetti, forse sono altri storici, non gli amici di Noiret, quelli dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena che pochi giorni fa hanno diffuso un certo comunicato; un testo che, per nettezza e asperità di giudizio nei confronti anche dell’Istituto Parri di Bologna, ha pochi precedenti nel network ex-INSMLI. Il comunicato è firmato anche da Fondazione Lewin, Associazione Mazziniana Italiana, ANPI Forlì-Cesena, CGIL Forlì, Associazione Luciano Lama e Unione degli Universitari. Ne cito alcuni estratti, sottolineature mie:
«[…] Sono stati nominati un comitato scientifico e un gruppo di lavoro, dove non hanno voce, in nessun modo, le realtà associative, culturali e sociali, del territorio forlivese e romagnolo […]
Rileviamo che l’intera operazione è stata portata avanti con una impronta dirigista da un pugno di persone, senza che si aprisse un confronto costruttivo con il territorio, sull’impostazione e i contenuti del “museo” e sul contesto, particolarmente delicato, in cui esso sorgerà.
Pochi giorni fa, il 28 ottobre, circa 2.000 fascisti, la maggior parte in camicia nera, hanno sfilato per Predappio, riempiendo poi tutti i ristoranti della vallata. Appare grave la noncuranza con cui amministratori e progettisti continuano ad affrontare il problema del contesto in cui il “museo” nascerà.
In queste condizioni, il progetto di Centro di documentazione, anziché essere una risorsa per lo sviluppo culturale e sociale del Forlivese e della Romagna, una opportunità di crescita per studenti e ricercatori italiani e stranieri, rischia di essere un clamoroso autogoal servito su un piatto d’argento a un turismo di nostalgici e di “curiosi”.
Le realtà associative e culturali firmatarie di questo comunicato avrebbero potuto e voluto dare suggerimenti e indicazioni, porre in evidenza criticità e contraddizioni, se ci fosse stato un confronto democratico e plurale. Ma così non è stato, e non abbiamo quindi intenzione di sostenere, o avallare con il silenzio, una condotta che non ci convince e che troviamo pericolosa.»
Male impostata sin dall’inizio, la faccenda non poteva che ingarbugliarsi. A una martellante campagna mediatica incentrata sul personaggio Frassineti «solo contro tutti» — quando semmai è male accompagnato contro molti — non poteva che corrispondere un metodo opaco e verticistico.
Nel mentre, i portentosi sfondoni che punteggiavano la propaganda pro museo hanno dato adito a ogni sorta di fraintendimento.
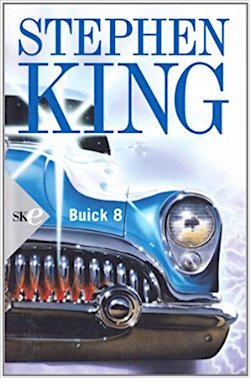 Scusatemi se ricorro ad allegorie, ma sono uno scrittore: il vortice di discorsi, espedienti, benaltrismi, svicolamenti, tatticismi, aspettative esagerate, intrecci di secondi e terzi fini, ragionamenti fallati intorno al progetto forma quella che — ispirandomi a Furio Jesi — chiamo una «submacchina mitologica», un dispositivo retorico che dipende dal funzionamento della macchina mitologica fascista, e opera sputando a getto continuo clichés post-antifascisti.
Scusatemi se ricorro ad allegorie, ma sono uno scrittore: il vortice di discorsi, espedienti, benaltrismi, svicolamenti, tatticismi, aspettative esagerate, intrecci di secondi e terzi fini, ragionamenti fallati intorno al progetto forma quella che — ispirandomi a Furio Jesi — chiamo una «submacchina mitologica», un dispositivo retorico che dipende dal funzionamento della macchina mitologica fascista, e opera sputando a getto continuo clichés post-antifascisti.
[Il mio amico Tuco l’ha paragonata alla Buick 8 dell’omonimo romanzo di Stephen King. Ci sta. Facciamo che la submacchina è l’automobile di Bennywise, lo spirito del luogo.]
Alla base del dibattito sul museo ritroviamo, espressi direttamente o con perifrasi, i *tre sintagmi tossici* imprescindibili se si vuole attivare il frame post-antifascista.
Il primo, che ho già esposto in quanto preconcetto e fornendo alcuni esempi, è…
7b. «Il fascismo è finito settant’anni fa.»
La retorica del «current year» e del «passato che non torna» si esprime in forme più o meno dirette, anche sfumate, come quando Giovanni Gozzini dice:
«I ragazzi di oggi hanno viaggiato molto più di noi, sono abituati a non conoscere le frontiere, quindi per loro istintivamente ogni chiusura nazionalistica è qualcosa di innaturale.»
È, come minimo, una generalizzazione indebita: non tutti i ragazzi viaggiano «più di noi» (noi chi?); molti fanno un solo viaggio, quello con cui emigrano per andare a fare un lavoro forse di merda, ma sempre meglio della mancanza di prospettive in cui sono costretti a crogiolarsi qui; altri non viaggiano affatto; ma soprattutto, non tutti sono immuni al nazionalismo, prova ne sia che il corpo militante dei neofascismi è composto principalmente da giovani.
Talvolta si nota, nelle perorazioni, una certa consapevolezza che questa del «siamo ormai vaccinati» è un’argomentazione fragile e, direbbe Benjamin, antifilosofica. Tuttavia, i peroranti non possono fare a meno di riproporla: è una delle premesse di tutto il discorso e del progetto di museo. Si adotta allora il compromesso di inserire nelle frasi “paletti”, precisazioni e buffe… “clausole di sicurezza”, che in realtà sono pleonasmi. Come quando, nella relazione sul progetto, il fascismo è definito (occhio all’inciso):
«fenomeno che ha segnato profondamente e drammaticamente, come peraltro il comunismo, l’intera storia del XX secolo, ma che si è concluso e che — come tale — non può più tornare.»
È del tutto ovvio che il fascismo non possa tornare «come tale». Chi ha mai lanciato l’allarme su un possibile ritorno al potere del duce resuscitato, del PNF e dei militi col fez? Perché si possa parlare di fascismo e fascisti serve per forza rivedere nelle piazze i Figli della lupa e nelle edicole Il Popolo d’Italia?
Di recente, la giornalista del Guardian Rachel Shabi ha proposto il quesito: «Se il fascismo arrivasse domani, lo riconosceremmo?»
Se ce lo aspettiamo con le braghe alla zuava, probabilmente no.
E ora il secondo sintagma tossico, cioè…
7c. «Troppo a lungo si è taciuto su…»
Sulle prime, mi ha lasciato molto perplesso il bizzarro ricorso, nelle perorazioni del museo e nella relazione sul progetto, all’espressione damnatio memoriae.
«A Predappio riapre la Casa del Fascio
Domani la presentazione del museo alla casa del fascio di Predappio. Il sindaco del Pd: “No alla damnatio memoriae”» *«Siamo a un punto di svolta col progetto e io vado avanti, non posso permettere di fare di un edificio del genere una vittima della damnatio memoriae» **
Mi sono chiesto: ma damnatio memoriae in che senso?
Nella relazione, sorprendentemente, si legge:
«Si deve raccontare il totalitarismo soprattutto per sfatare la convinzione diffusa secondo la quale solo la damnatio memoriae verso un regime basato sulla violenza politica e “razziale”, sulla sopraffazione politica […] possa non solo risarcire le vittime, ma prosciugare l’acqua nel quale potrebbe risorgere. Questa damnatio, professata per decenni come unica condizione per sollecitare una memoria vigile […] non ha funzionato […]»
En passant: perché apporre le virgolette a «razziale»? Ma passo oltre e vado al punto: che senso può mai avere un simile passaggio?
Damnatio memoriae significa «condanna del ricordo». «Del ricordo» è un complemento di specificazione oggettiva, cioè: l’oggetto della condanna è il ricordo stesso. Divieto di ricordare.
Nell’antica Roma, consisteva nel rimuovere ogni traccia fisica e mnemonica della vita di un personaggio pubblico, come se non fosse mai esistito. Era anche proibito pronunciarne il nome, che non veniva nemmeno tramandato ai discendenti.
In Italia c’è stata forse damnatio memoriae per Mussolini e per il fascismo? Assolutamente no. Al contrario, parlerei di superfetatio memoriae, di un’abnorme escrescenza di memorie, per quanto deteriori e distorte.
 Non solo il nome «Mussolini» è ricordato, ma fa fischiare le orecchie ogni giorno.
Non solo il nome «Mussolini» è ricordato, ma fa fischiare le orecchie ogni giorno.
Non solo il nome «Mussolini» è stato tramandato, ma una Mussolini è stata per anni in parlamento ed è in tv un giorno sì e l’altro pure, mentre un’altra Mussolini — a dispetto di certe boutades vittimistiche sul pericolo che le «cancellino» il cognome, bum! — è stata sindaca di un comune romagnolo e va in giro per l’Italia col sindaco di Predappio.
Non solo abbondano tracce e vestigia del passaggio di Mussolini in questa landa ovunque si giri lo sguardo — bassorilievi, dipinti e scritte DVX che lo celebrano — ma, fin dai primi giorni del dopoguerra, una certa cultura di massa ha lavorato a lungo per ottenere — come ha scritto lo storico Mimmo Franzinelli — un «Mussolini revisionato e pronto per l’uso».
Proprio a Predappio, dove secondo Frassineti ci sarebbe un rischio di damnatio memoriae, si vede quella che nel mondo latino era l’esatto opposto della damnatio, cioè l’apotheosis, la santificazione post mortem.
A proposito di apoteosi, come ha ricordato di recente sul New Yorker la storica Ruth Ben Ghiat:
«Nel 2014 l’allora presidente del consiglio Matteo Renzi, di centrosinistra, ha annunciato che Roma si sarebbe candidata a ospitare le Olimpiadi del 2024 al Foro italico, proprio davanti all’Apoteosi del fascismo, un dipinto che nel 1944 era stato coperto dagli alleati perché rappresenta il duce come un semidio. Sarebbe difficile immaginare Angela Merkel in piedi davanti a un quadro di Hitler in un’occasione simile.»
Non c’è stata alcuna damnatio memoriae sul fascismo. C’è stata semmai, e continua a esserci, una diffusa ignoranza sulla vastità dei suoi crimini, sulla profondità del suo razzismo, sull’impunità di cui godettero dopo la guerra i suoi protagonisti, sulla continuità della presenza fascista negli apparati dello stato. Ma questo non c’entra con la damnatio memoriae, anzi, ha a che fare con la retrospezione rosea, l’edulcorazione del ricordo del fascismo.
Ho un sospetto. Un sospetto che si rafforza leggendo, sempre nella relazione, che la damnatio memoriae sul fascismo avrebbe «finito inevitabilmente per favorire l’oblio […]».
La damnatio memoriae è l’oblio.
Uhm…
Forse il sindaco e gli autori della relazione scambiano il complemento di specificazione oggettiva per complemento di specificazione soggettiva. In parole povere, dicono «condanna del ricordo» come si direbbe «l’amore della madre» o «la luce del sole». Il ricordo non è più l’oggetto della frase, ciò che viene condannato, ma il suo soggetto: è un ricordo che condanna, un ricordo del fascismo tutto negativo. E allora proviamo a tradurre il brano già citato:
«Questo museo va fatto soprattutto per sfatare la convinzione diffusa che di un regime tirannico e violento si debba parlare solo male. Parlarne solo male non ha funzionato.»
Se il senso è questo, viene da chiedersi quando mai, in questo Paese, del fascismo si sia parlato solo male… Ma prima di seguire questo spunto, voglio prendere in esame uno strano paralogismo di Frassineti:
«Il fatto di avere avuto paura di parlare di Mussolini, e lo dico da uomo di sinistra, ha avuto il risultato di delegare ai commercianti la narrazione di Mussolini, con l’effetto di avere un’immagine deteriorata di Predappio.»
In Italia si è avuto «paura di parlare di Mussolini»? No, anzi, si è parlato e si parla di lui ossessivamente. Quindi che intende dire il sindaco di Predappio?
Queste bizzarre esternazioni mi riportano alla mente un certo corpus giornalistico-letterario, un insieme di opere — di spiccata impronta destrorsa — nelle quali si denuncia una «congiura del silenzio» su eventi tragici del XX secolo di reale o pretesa importanza.
Un caso esemplare: «le foibe».
Ogni volta che si parla del nostro confine orientale e delle vicende che lo insanguinarono, si sorvola su tutto quel che accadde dal 1915 al 1945 — la violenta spinta verso est dell’imperialismo italiano, l’annessione di territori dell’ex-Impero Austro-Ungarico, la persecuzione delle minoranze etniche incorporate nel Regno d’Italia, l’invasione nazifascista della Jugoslavia, i crimini di guerra fascisti nei Balcani — per poi denunciare un presunto «lungo silenzio» sulle foibe durato dal 1945 «a oggi» (si dice «oggi» ormai da vent’anni).
«Per anni è stato imposto il silenzio!», si esclama, e di ciò si incolpano la «sinistra», i comunisti, Togliatti ecc.
In realtà, in Friuli-Venezia Giulia di foibe si è sempre parlato molto, e gli archivi di giornali e periodici dimostrano che il tema è periodicamente affiorato nel mainstream nazionale. Di foibe si parlò molto, ad esempio, nel 1953-1954, subito prima del ritorno di Trieste all’Italia. La stampa di destra, poi, se ne è sempre occupata.
I supposti diktat del PCI sono fantasticherie. Nel 1948 Togliatti ruppe ogni rapporto con la Jugoslavia di Tito — definito tout court «fascista» — e non aveva particolare interesse a difendere i «titini».
No, se l’argomento rimase a lungo confinato all’estremo Nordest e ai media di una sola corrente politico-culturale, fu per ragioni diverse, anzi, opposte. Come spiega Federico Tenca Montini nel suo Fenomenologia di un martirologio mediatico. Le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni Novanta ad oggi (KappaVu, 2014),
«[…] le foibe non poterono entrare a buon diritto nell’autobiografia della nazione perché troppo legate ai crimini di quel fascismo che la nuova stagione politica voleva dimenticare a tutti i costi, e se anche l’Italia avesse deciso di agitarne comunque il vessillo, la Jugoslavia avrebbe reagito semplicemente rispolverando la lista dei criminali fascisti richiesti ma mai estradati.
Considerazioni di questo genere sono da preferirsi alla tesi, ultimamente alla moda, dell’inopportunità di sollevare l’argomento per il disturbo che questo avrebbe arrecato al PCI […] il monopolio del silenzio è stato piuttosto gestito dalla DC per la quale mettere in difficoltà una Jugoslavia sostenuta dal blocco occidentale avrebbe significato contrariare gli Stati Uniti.»
Mentre l’establishment preferiva non svegliare il can che dormiva, delle foibe si occupavano, toh!, storici di sinistra. Lo ha ricordato Maurizio Fogar, figlio del grande storico triestino Galliano Fogar (1921 – 2011), nel suo discorso alle esequie del padre:
«Mio padre quella storia l’aveva sviscerata sin dai primi anni del Dopoguerra, l’aveva scritta e riscritta, e questi politici che negli anni Ottanta hanno riscoperto il bisogno di dire: “una storia mai scritta”… Non era la storia a non essere mai stata scritta: era la loro ignoranza, la loro incultura, la loro non-conoscenza a far sì che tutte quelle cose, quelle ricerche [fossero ignorate]… Lui si incazzava come una bestia quando sentiva dei politici, anche dello schieramento a cui lui dava il voto, “riscoprire” la vicenda delle foibe e dire “finalmente se ne parla”, “una verità negata”… No, non era la verità negata: era la cultura negata di questi politici…»
Qui dò la parola a Wu Ming 2: — La «congiura del silenzio» è una classica strategia retorica, esempio di vittimismo, ma anche di presentismo, di quell’eterno ripartire da «oggi» che non ci fa capire come quell’oggi si è prodotto. Quando uscì Il sangue dei vinti di Pansa, Ernesto Galli della Loggia scrisse sul Corriere un articolo intitolato «I padroni della memoria» dove affermava:
«Per molti decenni a quanto è accaduto dal 1943 al 1945 fu vietato dare il nome che gli spettava, il nome cioè di guerra civile… per le uccisioni indiscriminate di fascisti e non, commesse dai partigiani dopo il 25 aprile… è valsa fino ad oggi la regola che bisognava negare che quelle uccisioni fossero avvenute… finché con il recente libro di un noto e bravo giornalista di sinistra, Giampaolo Pansa, il divieto è stato tolto, sicché ora siamo tutti finalmente autorizzati a conoscere e a discutere liberamente gli avvenimenti di quei terribili giorni».
Eppure il concetto di «guerra civile» era stato già usato in saggi importanti e discussi, e i «regolamenti di conti» avevano occupato le pagine dei quotidiani per tutto il lungo Dopoguerra, riemergendo puntualmente in occasione di nuovi processi, amnistie, ritorni di espatriati, nuove testimonianze ecc.
 WM1: — Basti dire che l’opera capitale, il saggio più ambizioso sulla Resistenza italiana, l’esplorazione più vasta del suo elemento soggettivo si intitola Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Ne è autore Claudio Pavone, guardacaso il decano di quegli «storici di sinistra» che secondo pansiani, revisionisti e fasci avrebbero taciuto in blocco sulla natura di guerra civile del conflitto 1943-45. La prima edizione del libro è del 1991 (più di un decennio prima che uscisse quello di Pansa), ma l’autore lavorava a quell’opera capitale dagli anni Settanta, e ne aveva esposto il nucleo concettuale nell’aprile 1980, a Torino, durante un seminario intitolato «Etica e politica» curato da Norberto Bobbio.
WM1: — Basti dire che l’opera capitale, il saggio più ambizioso sulla Resistenza italiana, l’esplorazione più vasta del suo elemento soggettivo si intitola Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Ne è autore Claudio Pavone, guardacaso il decano di quegli «storici di sinistra» che secondo pansiani, revisionisti e fasci avrebbero taciuto in blocco sulla natura di guerra civile del conflitto 1943-45. La prima edizione del libro è del 1991 (più di un decennio prima che uscisse quello di Pansa), ma l’autore lavorava a quell’opera capitale dagli anni Settanta, e ne aveva esposto il nucleo concettuale nell’aprile 1980, a Torino, durante un seminario intitolato «Etica e politica» curato da Norberto Bobbio.
WM2: — È sempre così: si scambia per censura la propria ignoranza, o per oblio il fatto che un’ovvietà non venga ribadita, quindi si grida contro i «padroni della memoria», e quando questi presunti “padroni”, infastiditi, decidono che con te non ci vogliono parlare, allora, cazzo!, vedi che avevo ragione! Bastardi omertosi, censori, congiura del silenzio…
Questo excursus era necessario per capire in quale frame si inserisca lo strano paralogismo di Frassineti: il frame del «lungo silenzio».
A mettere a fuoco ci aiuta l’inciso: «e lo dico da uomo di sinistra».
Il senso del discorso è: «Per anni a sinistra non si è potuto dire che…»
Che cosa?
Eccoci finalmente al terzo sintagma tossico. Parlare solo male del fascismo non ha funzionato perché (rullo di tamburi)… Per anni a sinistra non si è potuto dire che (prosegue il rullo di tamburi)…
7d. «Il fascismo ha fatto anche cose buone.»
«Certamente! Anche il mostro di Firenze avrà detto “buongiorno” a qualcuno, qualche volta!», ribatté molti anni fa Roberto Benigni.
Qui va ripresa la già citata frase di Frassineti sul «fascismo che ha avuto tante facce, non solo quella tremenda degli ultimi anni».
Gli storici seri mettono in guardia contro la «metonimia storiografica». Volendo essere più precisi, si tratta di sineddoche, il descrivere la parte come se fosse il tutto. Nella storia d’Italia non c’è periodo più “metonimizzato” del ventennio fascista. Anna Foa ha spiegato:
«Andrebbe evitata la formula “il fascismo ha fatto bene, il fascismo ha fatto male, perché significa che, in fondo, il fascismo non ha fatto così male […] Porsi la domanda se il fascismo sia stato buono, così così, cattivo, cattivissimo vuol dire finire in una trappola in cui si cominciano a dare i voti alle iniziative del fascismo..».
In un’altra occasione, Gianni Saporetti della Fondazione Lewin ha raccontato:
«Sgarbi viene in una scuola di Forlì per esaltare l’alto valore educativo dei mosaici che inneggiano alle imprese dell’aviazione italiana in Grecia e per dire, fra frizzi e lazzi, che l’elenco delle cose buone del fascismo è lungo e va “oltre le leggi razziali, perché il decreto sui beni culturali di Bottai è del ’39”. Una frase anche ineccepibile in sé, ma che dà la sensazione che le leggi razziali siano un decreto fra gli altri, che non merita più neanche l’aggettivo “ignobile”, ripetuto da tutti, anche da chi, poi, vuol minimizzarne la responsabilità italiana. Insomma, si fa un elenco di decreti, alcuni buoni altri cattivi: uno riguarda i beni degli ebrei, il lavoro, la casa, la cittadinanza, finanche la vita loro e dei loro figli, l’altro i beni culturali dell’Italia. […] un sistema totalitario, per sua natura, non può non fare anche cose buone […] Possiamo fare il paragone con la mafia che è un sistema, a suo modo, totalitario: raccoglie consenso attorno a sé? In parte sì, perché dà lavoro e sicurezza, in parte incute timore, impone rispetto e sottomissione.»
Le «parti» usate più spesso per rappresentare — e riabilitare — il «tutto» sono cinque:
1. Le politiche sociali e di assistenza, a volte reali ma non esclusive del fascismo — si tratta di riforme implementate in molti paesi nel periodo tra le due guerre —, molto più spesso esagerate o addirittura immaginarie.
2. «C’era meno criminalità, la gente non si suicidava, la famiglia era sacra». Tutto falso. Durante il ventennio c’erano molti più omicidi di adesso (tre volte tanti: 1166 omicidi nel 1939 contro i soli 397 del 2016), c’erano rapine, i ragazzi si suicidavano, le famiglie “scoppiavano” e il femminicidio («delitto d’onore») era all’ordine del giorno. Solo che la stampa non poteva scriverne. Dal 1926 — anno delle «leggi fascistissime» e della grande stretta sulla società italiana — una tempesta di circolari e direttive investì le redazioni. Il 9 gennaio 1926 Mussolini scrisse di proprio pugno ai prefetti:
«Bisogna sollecitare i grandi giornali a ridurre sempre più fino a farla scomparire la rubrica dei cosiddetti “stanchi della vita” perché la pubblicità clamorosa e romantica è una pericolosa suggestione per gli spiriti deboli o indeboliti. Altrettanto dicesi per le tragedie passionali a coppie. Bisogna insomma smobilitare anche la cronaca nera.»
 Una circolare dell’1 marzo 1927 dice espressamente che le notizie di crimini costituirebbero «materiale sfruttabile dalla stampa internazionale ostile al Regime.» Come racconta lo storico Paolo Murialdi nel suo La stampa del regime fascista (Laterza, 1980, riedito nel 2008):
Una circolare dell’1 marzo 1927 dice espressamente che le notizie di crimini costituirebbero «materiale sfruttabile dalla stampa internazionale ostile al Regime.» Come racconta lo storico Paolo Murialdi nel suo La stampa del regime fascista (Laterza, 1980, riedito nel 2008):
«Le circolari si susseguono. Una proibisce di dare notizia dei minorenni che si tolgono la vita. Tale divieto verrà presto esteso in modo da cancellare dai giornali la parola suicidio e dando così inizio a grottesche versioni sui suicidi camuffati da incidenti casuali. La versione più frequente sarà basata sul “pulendo una pistola inavvertitamente è partito un colpo che…”. Un’altra circolare proibisce la pubblicazione delle fotografie dei delinquenti, degli omicidi e degli adulteri.»
3. «Le cose funzionavano». Bisogna vedere quali e, soprattutto, per chi.
Come? «I treni arrivavano in orario»? Anche i pacchetti di Amazon Prime, se è per questo, ma andiamo a vedere in che condizioni lavorano magazzinieri e autisti. Durante il ventennio la categoria dei ferrovieri, particolarmente riottosa, fu epurata politicamente (circa 50.000 licenziati nel biennio 1923-24), sottoposta a una stretta vigilanza con l’istituzione della Milizia ferroviaria, privata dei diritti sindacali, sottoposta ad aumenti di straordinari e tagli di salari. Come ricorda lo storico Stefano Maggi nel suo Le ferrovie (Il Mulino, 2003), il fascismo impose:
«un nuovo trattamento economico del personale, tagliando gli scatti di anzianità nel numero e negli importi, ma soprattutto riducendo gli stipendi fissi dei bassi gradi per aumentare quelli dei funzionari. Per esempio, lo stipendio minimo annuo di un alto dirigente come il caposervizio veniva aumentato da 21.000 a 27.500 lire. Il salario minimo di un macchinista passava da 9.900 lire a 7.400, quello di un conduttore da 6.600 a 5000, quello di un operaio da 7.650 a 5000.»

Alfonso rulez.
4. La bonifica dell’Agro Pontino, regolarmente estrapolata dalla storia d’Italia. In Italia si sono fatte grandi bonifiche dagli anni Settanta del XVI secolo agli anni Settanta del XX. Io vengo dal basso ferrarese, territorio in larga parte strappato alle acque, dove nel torneo delle bonifiche il duce arriva terzo. Al primo posto c’è Alfonso II d’Este, al secondo la Democrazia Cristiana.
5. Soprattutto negli ultimi tempi, il focus riabilitante è su urbanistica e architettura. Guarda che bella la Casa del Fascio, che belle le città di fondazione, che belli i monumenti, l’Eur, il Foro Italico, che bello lo stile razionalista del ventennio, come gonfia i polmoni il monumentalismo di Piacentini… Altroché la brutta edilizia popolare degli «architetti comunisti»!
È quest’ultima «parte per il tutto» a riguardare direttamente Predappio, ed è questa retorica che dobbiamo demistificare.
8. Architetture e monumenti: un dibattito falsato
Le polemiche sull’architettura e i monumenti del ventennio sono sempre più frequenti e ravvicinate. Tali “sfoghi” sono certamente sintomi della cattiva coscienza — e cattiva memoria — nazionale, ma sono anche parte di un processo di ridefinizione post-novecentesca e post-coloniale della memoria che sta investendo tutto l’occidente.
In Sudafrica e nel Regno Unito, ad esempio, c’è stata la campagna Rhodes Must Fall per la rimozione dei monumenti al colonizzatore razzista Cecil Rhodes.
Negli USA si rimuovono dagli spazi pubblici i monumenti «confederati», cioè commemorativi della causa sudista nella guerra civile americana. Monumenti spesso nemmeno d’epoca, ma eretti nel ventesimo secolo e alcuni addirittura nel ventunesimo, dunque meramente revanscisti, apologie della schiavitù e simboli del perdurante razzismo contro i neri. Come tali, vengono difesi manu militari da neonazisti e suprematisti bianchi di varie tendenze. Gli scontri di Charlottesville, Virginia, dell’11 agosto 2017, culminati nell’assassinio della manifestante antirazzista Heather D. Heyer, furono scatenati dall’estrema destra per impedire la rimozione di una statua del generale Robert E. Lee.
In Italia, data la monumentalità insita in molte realizzazioni architettoniche e addirittura urbanistiche del fascismo, è difficile distinguere tra architettura e monumenti. I monumenti al fascismo non sono semplici statue, almeno non più.
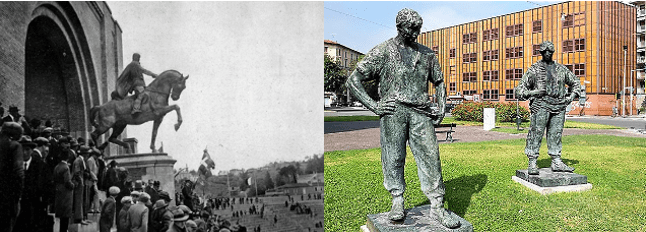
Bologna. Sette tonnellate di bronzo, prima e dopo. A sinistra: 27 ottobre 1929, inaugurazione della statua equestre del duce al Littoriale. Realizzata dallo scultore modenese Giuseppe Graziosi con il bronzo di alcuni cannoni abbandonati in città dagli Austriaci nel 1848, la statua era alta cinque metri e lunga sei. A destra: il prato di Porta Lame oggi. Il Monumento al partigiano e alla partigiana (quella con mitra e cartucciera è una donna) fu realizzato nel 1947 dallo scultore bolognese Luciano Minguzzi, per commemorare la Battaglia di Porta Lame.
Di statue del duce e dei gerarchi ce n’erano a bizzeffe, ma molte — purtroppo non tutte — furono distrutte già all’epoca, alcune dopo la caduta del duce, altre dopo la Liberazione. A Bologna, ad esempio, la grande statua equestre del duce al Littoriale (oggi Stadio Dall’Ara) venne decapitata dalla folla la sera del 25 luglio 1943. Dopo la Liberazione venne fusa, e col suo bronzo furono realizzate le statue di partigiani che oggi presidiano Porta Lame.
Statue di fascisti ne esistono ancora, ma in generale i monumenti fascisti sopravvissuti fino a oggi sono edifici.
 Scalpellati via — ma nemmeno sempre — i simboli più vistosamente legati all’ideologia del regime (come i fasci littori), quegli edifici oggi sono parte delle nostre città e della nostra vita quotidiana. Solo che la maggior parte degli italiani non ne conosce la storia o, peggio, la conosce in modo parziale, distorto, encomiastico: «Guarda lì, il duce sì che costruiva bei palazzi!» Appunto: il fascismo ha fatto anche cose buone.
Scalpellati via — ma nemmeno sempre — i simboli più vistosamente legati all’ideologia del regime (come i fasci littori), quegli edifici oggi sono parte delle nostre città e della nostra vita quotidiana. Solo che la maggior parte degli italiani non ne conosce la storia o, peggio, la conosce in modo parziale, distorto, encomiastico: «Guarda lì, il duce sì che costruiva bei palazzi!» Appunto: il fascismo ha fatto anche cose buone.
Sfruttando questa percezione, i partiti «post»-fascisti e neofascisti usano sempre più quegli edifici per le loro campagne politiche. Come quando a Roma, nel 2015, Fratelli d’Italia ha proposto un paragone del tutto improprio col Foro Italico per chiedere la demolizione del “serpentone” di Corviale.
E così, grazie al nostro mancato fare i conti col fascismo, quei monumenti tornano a essere — se mai smisero di esserlo — propaganda nel presente e per il presente.
La storica Ruth Ben Ghiat ha provato a dire esattamente questo in un articolo pubblicato dal New Yorker poche settimane fa e in seguito tradotto da Internazionale. Articolo subito frainteso come istigazione a demolire quei monumenti, e accolto in Italia con un fuoco di sbarramento degno di un’invasione militare. Fuoco proveniente, of course, dall’incendio di decine di migliaia di code di paglia.
Ruth Ben Ghiat è un’esperta non solo di fascismo, ma anche di architettura razionalista (ha fatto la tesi di dottorato su Giuseppe Terragni) e figura tra i nomi del comitato scientifico per Predappio. Ergo, è quantomeno assurdo ritenerla ostile a priori agli edifici del ventennio. Cionondimeno, è stata criticata a sproposito dai nostri “illustri” e come sempre ignorantissimi opinionisti, insultata per giorni e giorni sui social network, paragonata ai talebani che fecero saltare in aria i Buddha di Bamyan, chiamata «fanatica» o peggio, esortata a «farsi i cazzi suoi», accusata — per il solo fatto di essere americana — di complicità con le guerre USA in Medio Oriente e, ovviamente, di essere a libro paga di SOROS!!!1!!1
«Il New Yorker attacca l’Italia», ha sobriamente titolato un quotidiano romano.
Una reazione da ubriachi fradici, come ha fatto notare Andrea Coccia su Linkiesta:
Ruth Ben Ghiat
«è come se la studiosa americana, vedendo che qui in Italia beviamo alcool a qualsiasi ora del giorno, ci avesse chiesto: Non è che avete problemi con l’alcool? E noi, invece di sorriderle bonariamente e spiegarle che vino, grappa, liquori e birra, sono parte integrante della nostra cultura — come d’altronde l’architettura razionalista — le abbiamo iniziato a sbraitare davanti. “No, che cazzo dici?”, “Sei una mentecatta a pensare una cosa del genere!”, “Ma guardati te!”, “Pensa ai vostri problemi con le armi!”. E forse a questo punto se fossimo in lei, indietreggiando, predicando pace e calma e abbozzando una specie di sorriso, ce ne andremmo pensando che sì, qualche problemino con l’alcool questi ce l’hanno, e pure grosso.»
Che in Italia quel nervo sia scoperto lo dimostrano le bufale diffuse a getto continuo sulla volontà di questo o quell’esponente della sinistra — quasi sempre Laura Boldrini — di demolire il tal o il tal altro monumento. Bufale periodicamente riproposte da siti e giornali di destra: «Ecco i capolavori fascisti che Boldrini vorrebbe abbattere», titolava tempo fa il Secolo d’Italia, in cima a un articolo dove si paventava il rischio che Boldrini riducesse l’Italia a «una città [sic] post-atomica, praticamente un rudere con macerie in ogni angolo delle principali città italiane».
Simili bufale si “viralizzano” e scatenano le solite reazioni violente, facendo crescere la sensazione che di quest’argomento in particolare non sia possibile discutere in modo minimamente sensato.
Al netto delle bufale, a essere sbagliato è il frame, la cornice che inquadra tutti questi discorsi. Per disattivare il frame, dobbiamo porci una domanda, anzi, la domanda: l’«architettura fascista» è davvero fascista?
L’ho chiesto a un amico architetto, docente, saggista e scrittore.

Gianni Biondillo
Gianni Biondillo: — Non esiste una architettura fascista tout court. Esiste un’architettura prodotta sotto il fascismo, spesso da architetti in assoluto contrasto coi dettami di classicità spinti dal regime. Ti faccio un esempio clamoroso: nel 1931, alla IIa Esposizione di architettura razionale, gli architetti legati al movimento moderno presentano un collage che chiamano «Tavola degli orrori», dove mostrano architetture contemporanee che aborriscono, comprese quelle dello “Speer” italiano, Marcello Piacentini. Mussolini “sopportava” il razionalismo (soprattutto se prodotto in provincia, lontano da Roma, ad esempio a Como) perché voleva dare un colpo al cerchio e uno alla botte, dovendo tenere a bada il “fascismo di sinistra”, che ancora vagheggiava rivoluzioni artistiche futuriste, ma personalmente spingeva per uno stile aulico.
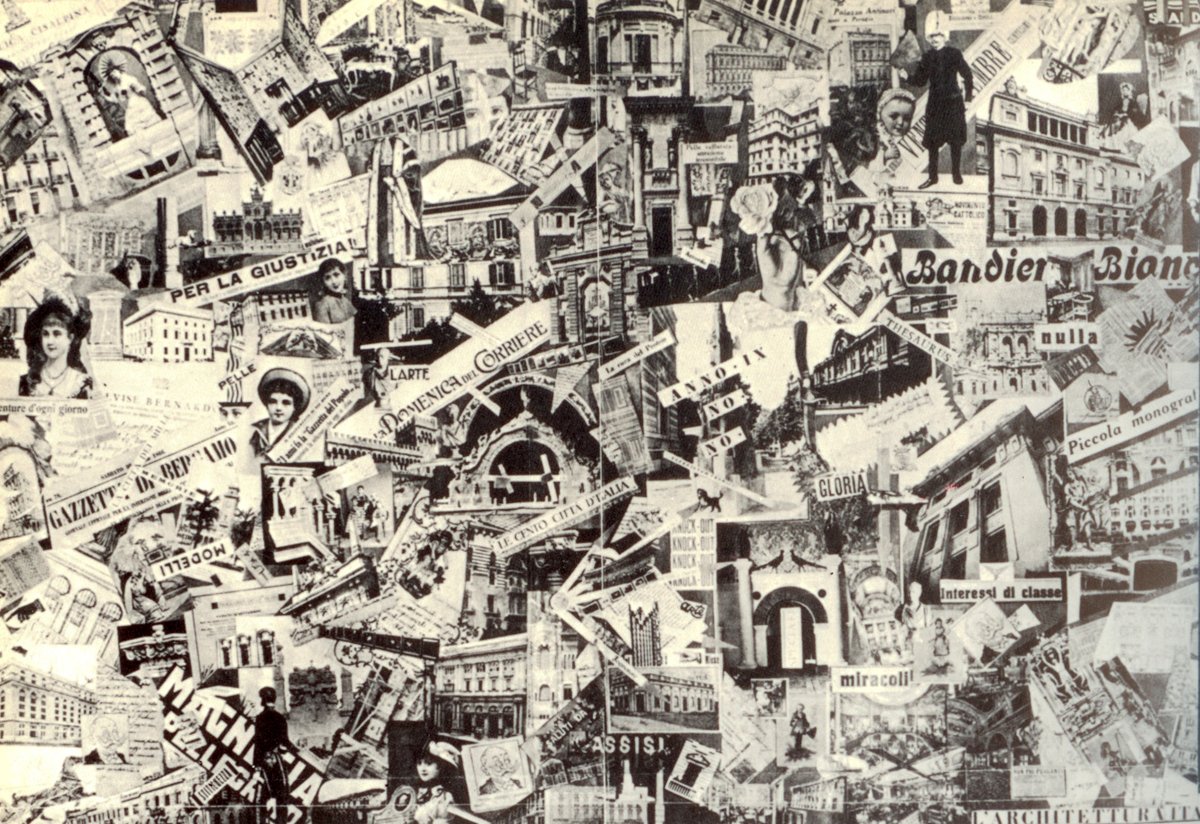
La «Tavola degli orrori», realizzata da Pier Maria Bardi ed esposta alla IIa Esposizione universale di architettura razionale, 1931.
Nessuna di queste due spinte contrastanti — la neoclassica/monumentale e la razionalista — fu esclusivamente italiana, men che meno fascista.
Il razionalismo rientra nel più vasto Movimento moderno in architettura, che si sviluppò in tutto l’Occidente tra le due guerre. Il razionalismo italiano ha «cugini» in molti paesi, basti guardare gli edifici realizzati dal Bauhaus, a partire dalla sede della scuola a Dessau (1925); la Ville Savoye di Le Corbusier poco fuori Parigi (1928); la Tabakfabrik a Linz (1929), e tante altre realizzazioni dell’epoca.

Ville Savoye a Poissy, Île-de-France. Progettata da Le Corbusier, realizzata tra il 1928 e il 1931.
Quanto al neoclassicismo e monumentalismo, li ritroviamo in altri paesi europei e addirittura nella Washington del New Deal. Si pensi al palazzo della Federal Reserve, costruito nel 1935-1937: è il tempio del dollaro, dell’occhio sulla piramide, eppure ha un aspetto incredibilmente “fascista”.
Si tratta di un’architettura per mezzo della quale lo Stato — ogni Stato — voleva essere fortemente assertivo, soprattutto in reazione alla crisi del 1929. Reazione politicamente trasversale, che andò dalla Francia del Fronte Popolare alla Svezia, passando per gli USA e la Finlandia. Il Palazzo del Parlamento di Helsinki, l’Eduskuntatalo, fu ultimato nel 1931 e potrebbe essere trasportato di peso all’Eur senza sembrare minimamente fuori contesto.

Eccles Building, Washington DC, sede della Federal Reserve (Banca centrale degli USA). Progettato da Paul Philippe Cret, realizzato tra il 1935 e il 1937.
I neofascisti che si vantano dell’«architettura fascista» non solo danno l’ennesima dimostrazione di provincialismo e limitatezza di orizzonti, ma attribuiscono al regime “meriti” e tendenze che lo trascendono di gran lunga.
Ecco come si disinnesca la metonimia storica: sprovincializzando i termini del dibattito. Quel che di “buono” o “bello” fece il fascismo, lo fece perché non poteva non farlo: la fase storica lo richiedeva ovunque, e lo Stato “keynesiano” dell’epoca — dittatoriale o democratico che fosse — ovunque lo realizzò. Vale per le politiche sociali, il welfare state, le opere pubbliche.
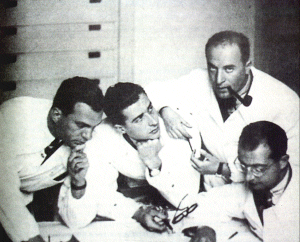
Lo studio di architettura BBPR nel 1935. Da sinistra: Enrico Peressutti, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Ernesto Nathan Rogers e Gian Luigi Banfi. Nel 1938-39 aderirono tutti a Giustizia e Libertà. Fecero la Resistenza, e tre su quattro furono deportati in lager nazisti. Uno di loro, Banfi, morì nel campo di Gusen.
Va poi fatto notare che diversi tra i migliori architetti del ventennio scelsero l’antifascismo, e ben prima del 25 luglio o dell’8 settembre 1943.
Come i quattro dello studio BBPR di Milano, autori anche del Palazzo delle Poste, Telegrafi e Te.Ti, all’Eur:
– Gian Luigi Banfi fu partigiano di Giustizia e Libertà e morì nel lager nazista di Gusen;
– Ernesto Nathan Rogers, colpito dalle leggi razziali, fu partigiano di Giustizia e Libertà, anch’egli deportato a Gusen, ma sopravvisse;
– Lodovico Barbiano di Belgiojoso aderì a Giustizia e Libertà nel 1938, fu deportato nei campi di Gusen e Mauthausen, sopravvisse;
– Enrico Peressutti aderì a Giustizia e Libertà nel 1939, poi fece parte del comando militare del CLN, e dopo la Liberazione si iscrisse al partito socialista.
O come Giovanni Michelucci, uno degli autori della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze.
O come l’istriano Giuseppe Pagano (italianizzazione di Pogatschnig), autore dell’istituto di Fisica della Sapienza a Roma. Fu dapprima ardente fascista, ma divenne oppositore del regime già nel 1942, si dedicò all’attività antifascista clandestina ancora prima del 25 luglio 1943, fu arrestato due volte, torturato dalla banda Koch e infine deportato a Mauthausen, dove morì.
Quasi ogni volta che si parla di architettura italiana degli anni Trenta lo si fa denunciando una sorta di “censura” che si starebbe sfidando, quale audacia! Si evoca una sorta di dittatura culturale di sinistra che sarebbe durata sessanta o settant’anni e avrebbe impedito un «sereno giudizio» su quelle realizzazioni. È ancora una volta il frame del «lungo silenzio». Ad esempio, intervistato da Il Tempo nell’agosto 2015, l’architetto Massimo Zammerini ha denunciato
«la damnatio memoriae [aridaje, N.dR.] di una architettura, quella fascista, che, al di là delle considerazioni politiche fu un vero e proprio stile, molto studiato. All’estero»
L’impressione è quella di una disobbedienza civile retroattiva contro interdizioni che non risulta siano esistite. E infatti…
Gianni Biondillo: — Dopo la guerra, sostanzialmente, tutti gli architetti del ventennio continuarono a lavorare. Persino Piacentini, settuagenario, con commissioni di rilevo, e pubbliche! Altro caso esemplare: Luigi Moretti. Grande razionalista metafisico. Non ha mai nascosto le sue inclinazioni di destra, e nel dopoguerra ha lavorato moltissimo. Il Watergate, quello dello scandalo, è suo.
Del resto, se non si faceva l’epurazione per i funzionari statali, perchè si sarebbe dovuta fare per gli architetti?
— E la critica, — ho chiesto a Gianni, — la storia dell’architettura? È vero che c’è stata damnatio memoriae? Che l’architettura “fascista” è stata studiata solo all’estero?
Gianni Biondillo: — Assolutamente no. Già nel 1968 Bruno Zevi, ebreo e antifascista, dedica un omaggio a Giuseppe Terragni, considerato insieme a Piacentini l’architetto “di regime” per eccellenza. E per tornare a Moretti, il più autorevole critico marxista – Manfredo Tafuri – non lo “epura” affatto nella sua fondamentale Storia dell’architettura italiana 1944-1985, che esce a metà degli anni Ottanta.
Nel suo documentario La forma della città, che è del 1974, il comunista Pasolini già scinde regime fascista e architettura del ventennio. Parlando di Sabaudia, città di fondazione sul litorale pontino, dopo averla definita «incantevole» spiega:
«Sabaudia è stata creata dal regime, non c’è dubbio, però non ha niente di fascista, in realtà, se non alcuni caratteri esteriori […] Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l’ha ordinata, ma in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire.»
Dalle mie parti, all’improvviso e come dal nulla, nella pianura spuntano città di fondazione e colonie rurali risalenti al fascismo. L’esempio più noto è Tresigallo, borgo natìo del gerarca Edmondo Rossoni, che negli anni Trenta lo fece trasformare radicalmente.
Di Tresigallo il giornalista di viaggi Folco Quilici ha detto: «In tutti gli anni che sono venuto a Ferrara, nessuno mi ha mai portato a vedere Tresigallo. C’era una specie di barriera.»
Io, che a Tresigallo sono stato molte volte senza accorgermi di alcuna “barriera”, mi chiedo: perché Quilici, un uomo che ha esplorato l’intero orbe terracqueo, a Tresigallo non ci è andato sua sponte? Perché inventarsi interdizioni?

Architettura razionalista a Tresigallo (FE). Gli ex bagni pubblici e l’ex-Casa della GIL.
A conti fatti, dunque, che fare degli edifici e monumenti del ventennio?
Io credo esistano tre strade.
1. Nel caso di quelli meno “carichi” ideologicamente e meno direttamente veicolanti il mito fascista, è sufficiente raccontarne la storia, stando bene attenti a discernere tra architettura coeva al regime e architettura del regime, spiegando l’iter sovente accidentato di quelle opere, raccontando il rapporto spesso contraddittorio o addirittura conflittuale di quegli architetti con il regime.
2. Nel caso dei monumenti più “carichi” e celebrativi, bisogna agire per risemantizzarli, aggiungervi nuovi significati, incorporare alla loro immagine la critica al significato originario e al loro committente.
In Italia esiste una città-laboratorio dove da tempo si conducono esperimenti di questo tipo. Si tratta di Bolzano/Bozen, dove i monumenti del ventennio sono comunemente chiamati «relitti fascisti» (in tedesco faschistische Relikte). Lo ha raccontato su Giap Flavio Pintarelli già nel 2013. Nel frattempo, la situazione si è ulteriormente evoluta.
Il percorso che ha portato alla musealizzazione del Monumento alla Vittoria può essere di grande ispirazione, ed è di pochi giorni fa l’avvio della nuova installazione che risemantizza uno dei più ingombranti monumenti fascisti d’Italia, il fregio marmoreo di Hans Piffrader col duce a cavallo, di cui ho scritto anche su Internazionale. Oggi sul grande bassorilievo appare, tradotta nelle principali tre lingue dell’Alto Adige/Südtirol, la massima di Hannah Arendt: «Nessuno ha il diritto di obbedire».

Bolzano, Piazza Tribunale. Il fregio di Hans Piffrader “coperto” dalla scritta di luce «Nessuno ha il diritto di obbedire». Il motto è di Hannah Arendt e appare in ladino, tedesco e italiano. L’installazione è stata proposta da Arnold Holzkecht e Michele Bernardi.
Una soluzione bella e suggestiva, forse un po’ criptica. E troppo facilmente reversibile: basta spegnere l’installazione. Basta che alle prossime elezioni vinca un’amministrazione ostile a quel percorso e faccia un’ordinanza per pigiare il bottone. La pietra è durevole, la luce no.
Intanto, però, quella luce ha fatto imbufalire i neofascisti: «Bolzano, i nuovi talebani tentano di oscurare il bassorilievo di Mussolini», ha titolato Il Primato Nazionale, quotidiano on line di CasaPound. È la conferma che si sta seguendo una buona strada.
Bolzano/Bozen è al momento la realtà dove il dibattito è più avanzato. Ciò avviene, sia chiaro, per via di peculiarità non riproducibili altrove, prodotte dalla coesistenza di due comunità distinte, quasi due mondi accostati uno all’altro. Per semplificare al massimo: gli eredi degli invasori e gli eredi degli invasi. Tale situazione rende impossibile a chiunque blaterare con superficialità di «memoria condivisa». Nell’impossibilità di smussare, appianare, edulcorare, si è dunque spinti a cercare nuove soluzioni, in quella che noi Wu Ming chiamiamo da sempre «mediazione al rialzo».
3. Poi c’è la terza via, che è demolire.
Demolire va considerato l’extrema ratio, certo, ma non può essere un tabù. Ad esempio, siamo tutti d’accordo sul fatto che vadano demoliti i monumenti fascisti del tutto indifendibili, quelli nemmeno d’epoca, come il monumento al macellaio Graziani eretto nel 2012 ad Affile. Siamo d’accordo, giusto? Quella roba va demolita col tritolo, e sulle macerie va sparso il sale da lavastoviglie.
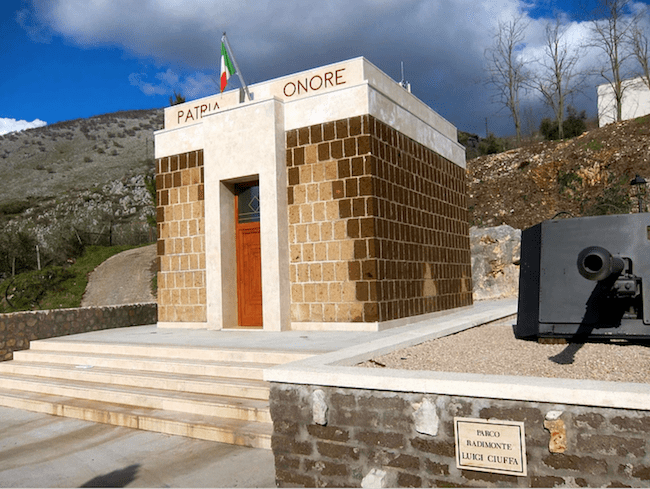
Affile, provincia di Frosinone. Il «Vespasiano» dedicato alla memoria del criminale fascista Rodolfo Graziani, costruito nel 2012 con fondi regionali chiesti per altra finalità. Pochi giorni fa, il Tribunale di Tivoli ha condannato per apologia di fascismo il sindaco di Affile Ercole Viri e due suoi assessori. Su Giap ci occupammo di questa porcheria in tempo reale, clicca sulla foto per leggere il post Affile, Grazianilandia. L’eredità razzista e il mausoleo delle sfighe
Ebbene, non dev’essere ritenuto impensabile nemmeno demolire relitti fascisti d’epoca. Non tutto quel che è durato fino ad oggi merita per forza di durare ancora. Durare non è di per sé una virtù, un manufatto può durare per tanti motivi, per indifferenza, per forza d’inerzia, per ignavia, o per ostinazione dei pubblici poteri.
Ci sono monumenti fascisti che furono imposti a un territorio, veri e propri schiaffi in faccia alla comunità che ci viveva, e diventarono simboli negativi da colpire. È il caso del Monumento all’Alpino di Brunico/Bruneck, eretto per celebrare in un colpo solo la guerra d’Etiopia e l’italianizzazione del Südtirol. Italianizzazione fittizia, s’intende: ancora oggi gli abitanti germanofoni sono il 70% nella provincia autonoma di Bolzano, e l’80% in Val Pusteria, dove si trova Brunico.
 L’Alpino fu abbattuto dalla popolazione dopo l’8 settembre 1943, ricollocato al suo posto nel 1951, fatto saltare in aria nel 1966, ricostruito e reinstallato nel 1968, di nuovo distrutto nel 1979, rimesso sul piedistallo nel 1980. È stato preso di mira con azioni più o meno simboliche anche negli ultimi anni.
L’Alpino fu abbattuto dalla popolazione dopo l’8 settembre 1943, ricollocato al suo posto nel 1951, fatto saltare in aria nel 1966, ricostruito e reinstallato nel 1968, di nuovo distrutto nel 1979, rimesso sul piedistallo nel 1980. È stato preso di mira con azioni più o meno simboliche anche negli ultimi anni.
In pratica, la storia della statua è la storia dei tentativi di sbarazzarsene. C’è molto più genius loci negli attentati che nel monumento, corpo estraneo che pervicacemente lo Stato italiano torna a imporre. Si potrebbe dire, con Simon Levis Sullam sulla scia di Foucault, che si è fatto il «processo al monumento», facendone quindi un documento.
Ancora: un anno fa il comune austriaco di Braunau am Inn, dove nacque Hitler, ha deciso di demolire la sua casa natale. Subito, dall’Italia, Frassineti si è dichiarato contrario. Lo stesso sindaco che risponde – testualmente – di «farsi i cazzi propri» a chi, da non predappiese, scrive di Predappio in un modo che non gli va a genio, poi non ha remore a intervenire, criticando e dando lezioni di memoria, su una decisione presa in Austria. Forse teme che qualcuno proponga di demolire l’ex-Casa del Fascio e dell’Ospitalità? Si tranquillizzi: nessuno pensa che sia quella la strada.
A coloro che, certamente, reagiranno scandalizzati alla mia ipotesi che qualcosa di fascista si possa demolire, a coloro che chiamano «talebano» chi ce l’ha con lo scempio di Affile e persino chi accende una scritta su un bassorilievo perché «è arte», vorrei chiedere: avevate di questi mal di pancia quando nei paesi dell’est buttarono giù le statue di Lenin? Io ricordo che la destra festeggiò. Non erano «arte» quelle statue? Ed eravate così indignati quando nel 2003 avete visto cadere le statue di Saddam Hussein?
— Eh, ma quello era a caldo, durante rivolte e guerre, mica a freddo!
— «A caldo»? Perché, nel 1989 Lenin era vivo?
— No, ma il regime che veniva rovesciato aveva riempito le città di sue statue, buttarle giù era colpire il regime!
— Lo vedi? «Caldo» e «freddo» non dipendono da quanti anni sono passati. Dipendono da cosa significano quei monumenti per chi vive oggi. Negli USA stanno rimuovendo i monumenti del razzismo confederato adesso, ma non certo «a freddo», tant’è che la polemica è rovente. Li rimuovono per il ruolo e il peso che hanno nel presente.
Dopo aver fatto — almeno spero — un po’ di chiarezza sulla questione «architettura e monumenti fascisti», torniamo a Predappio, e all’attitudine: «Non si può demonizzare tutto quel che fece il fascismo, guarda com’è bella la Casa del Fascio!»
9. Un progetto museografico ambiguo e sciatto
9a. L’importanza di tenere il culo in strada

Caserma dei Carabinieri di Predappio. Foto di Jadel Andreetto. Clicca per ingrandire.
Delle architetture razionaliste di Predappio viene fatto un uso ricattatorio, reso agevole dall’impostazione di un falso problema al posto di quello vero.
Ogni volta che viene criticato il progetto di Frassineti, il sindaco stesso o qualcuno dei peroranti ribatte: «E allora che ne facciamo di quegli edifici, eh? Li buttiamo giù? Cosa ne facciamo dell’ex-Casa del Fascio, un bene di interesse culturale che sta lì a marcire?»
Possibilità ce ne sarebbero. Si potrebbe avviare un percorso simile a quello di Bolzano, solo che entrerebbe in rotta di collisione coi negozi di ciarpame fascista, che nessuno ha interesse a far chiudere. Come ho già fatto notare, lo stesso Frassineti ha dichiarato più volte che quei negozi non devono chiudere. Non chiuderanno nemmeno se passa definitivamente la Legge Fiano. Serve che restino lì. E finché ci restano, saranno loro e la tomba del duce a influenzare tutto il resto.
Per capirlo, basta mettersi nei panni di un insegnante che accompagni una scolaresca al futuro museo di Predappio, come ha invitato a fare la Fondazione Lewin.
«Pensate possibile, innocua, la convivenza fra un museo che si spera frequentato da scolaresche in gita di educazione civica con la presenza, a cento metri di distanza, di supermarket le cui vetrine trasudano violenza e odio, in cui si vendono manganelli con su scritto “me ne frego” o magliette da motociclisti con su scritto “basta morire, adesso uccideremo noi”?»
Anna Foa si è chiesta: «Siamo sicuri che il pellegrinaggio non verrà potenziato dal museo? Cosa succede se i ragazzi vorranno andare a visitare la cripta?».
Ha provato a spiegarlo Gianni Saporetti:
«L’insegnante potrà dire di no trasformandosi in un censore e alimentando così, fra l’altro, la curiosità dei ragazzi? Ma se il malcapitato dirà di sì allora dovrà accompagnare i ragazzi in posti orribili come i negozi, dove si vendono manganelli con su scritto “boia chi molla” e “me ne frego”, o come la tomba, dove nel libro presenze si può leggere ogni tipo di schifezza, anche razzista, e le pareti sono tappezzate da targhe inneggianti a camerati morti.»
Nello stesso intervento, Saporetti ha fatto notare che c’è persino un’eventualità peggiore, quella che dentro al museo
«un insegnante e i suoi ragazzi si trovino a fianco di visitatori in maglietta nera, casomai attratti dalle olografie: se questi parleranno a sproposito a voce alta cosa deve succedere? Se l’insegnante volesse far lezione, seduta stante, ai suoi ragazzi dovrebbe mettersi a questionare e forse a “fare a botte”, ma “per dovere” dovrà far finta di niente e invitare i suoi ragazzi a venir via. Allora, ed è incredibile, avremmo fatto provare ai ragazzi realmente, altro che con olografie, quella che è una delle scene chiave di ogni fascismo: l’umiliazione dei padri dabbene, che non amano e non insegnano la prepotenza. Ma ci avete pensato? L’abbiamo chiesto a uno degli ideatori del progetto e la risposta è stata: “Certo, questo è un problema, ma lo affronteremo dopo”. Ecco, forse è preferibile affrontarlo prima.»
Il punto è che gente abituata a vivere nella teoria, nell’astrazione, nel metadiscorso, gente che da molti anni affronta solo problemi da mondo accademico, beghe interne alla professione, rogne burocratiche e corporative, in parole povere gente che non ha il culo in strada, non solo non è più in grado di rispondere a obiezioni pratiche come queste, ma non è nemmeno più in grado di capirle. Lo si è visto benissimo in questi tre anni e passa di botte e risposte, di obiezioni e risposte a obiezioni-fantoccio.
Persino l’autore de Il corpo del duce, Sergio Luzzatto, storico avveduto e non certo avulso dalla realtà, ha mostrato di non capire le obiezioni riguardanti il contesto quando ha scritto che
«[non può] esistere confusione tra un luogo serio di interpretazione scientifica, di rappresentazione museale, e di restituzione narrativa del Ventennio, e le stanche ritualità dei neofascisti in camicia nera che salutano romanamente presso la tomba di Mussolini»
Infatti il problema non è la confusione, semmai il suo opposto: la stridente giustapposizione di due cornici narrative, due mondi, due modi di pensare Predappio e pensarsi a Predappio.
La Predappio delle ritualità neofasciste è concreta, corporea e tutt’altro che «stanca», anzi, è in crescita e ha la forza di imporsi, di permeare la realtà intorno e addirittura determinare l’economia del luogo; di contro, la Predappio del «luogo serio di interpretazione scientifica» auspicata dagli accademici “possibilisti” è wishful thinking, un luogo solo vagheggiato, l’incerto esito di quella che per i peroranti è «una sfida da vincere», «una scommessa»… Sempre questo linguaggio da gioco d’azzardo, da ludopati, in definitiva da irresponsabili, brevimiranti che rispondono alla segnalazione di un problema-chiave dicendo «lo affronteremo dopo», e intanto partecipano a un progetto il cui fine non è mai stato, come diceva in giro Frassineti Lato A, contrastare le ritualità e i commerci neofascisti ma, come spiegato da Frassineti Lato B, affiancarsi a essi, affinché Predappio possa avere il cerchio e anche la botte.
 E anche se il fine fosse contrastare il neofascismo, cosa potrebbe la «rappresentazione museale», alla quale gli storici in buona fede si affidano illuministicamente, di fronte alla suggestione, al sonnambulismo, alla fascinazione del mito di morte del fascismo?
E anche se il fine fosse contrastare il neofascismo, cosa potrebbe la «rappresentazione museale», alla quale gli storici in buona fede si affidano illuministicamente, di fronte alla suggestione, al sonnambulismo, alla fascinazione del mito di morte del fascismo?
È sempre la convinzione che si possa «non pensare all’elefante», è sempre il non porsi il problema della cornice. E invece, andrebbe per prima cosa cambiata la cornice.
Innanzitutto, andrebbe compreso che i pellegrini neri non sono semplici «nostalgici» e che il neofascismo è un problema reale e di adesso.
Tale chiarezza di vedute aiuterebbe a farsi venire buone idee per scoraggiare i pellegrini neri e nel caso respingerli, come si faceva un tempo. Chiaro che non potrebbero farlo i predappiesi da soli: andrebbero aiutati. Questa mobilitazione dovrebbe inserirsi nel quadro di una più vasta mobilitazione antifascista, robusta e decisa, da imporre a livello nazionale.
Reso il luogo inospitale per i pellegrini, si ridimensionerebbe sempre più il giro d’affari dei pusher di scorie tossiche fasciste.
Senza i pusher, si potrebbe risemantizzare il paesaggio urbano, come si sta cercando di fare, un passo alla volta, a Bolzano.
Davanti al cimitero si potrebbe montare un’installazione permanente sui crimini del fascismo e sugli aspetti squallidi del regime. Si potrebbero mostrare, ad esempio, le foto del duce scartate da lui stesso perché ridicole e sconvenienti (le ha raccolte e commentate Franzinelli in un suo libro del 2003), i telegrammi coi quali il duce ordinava bombardamenti chimici in Etiopia e si compiaceva delle stragi ecc.
Solo a quel punto, forse, si potrebbe pensare a un museo nell’ex-Casa del Fascio. Tenendo però conto che la sua architettura trasmette messaggi ben precisi, che forse andrebbero disattivati con modifiche strutturali, ad esempio quelle proposte da ANPI Londra ed esposte da Alfio Bernabei in questo video.
Ma siamo sempre lì: Predappio è disposta a rinunciare all’«indotto», alle ricadute “positive” dei commerci neri?
Nonostante il contesto a dir poco sfavorevole e nonostante i limiti e le evidenti contraddizioni dell’approccio frassinetiano, molti osservatori rimangono possibilisti. Pensano che un museo a Predappio, se fatto bene, sarà comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale, e potrà contrastare almeno un poco la visione del fascismo spacciata a cento metri di distanza dai vari Ferlandia, Morosini, Pompignoli.
Basta leggerlo, il progetto, per rendersi conto che non sarà così. O quantomeno, che si è partiti molto male.
9b. Il mostro della lacuna nera

Clicca sulla copertina e scarica il progetto museografico per l’Ex-Casa del Fascio di Predappio (cartella zippata con relazione, tavole e quadro economico).
Il progetto museografico è stato preparato da un gruppo di lavoro capeggiato da Flores e De Bernardi, avallato — almeno così dovrebbe essere — dal comitato scientifico e caricato sul sito dell’Unione dei comuni della Romagna Forlivese, insieme a tutta la documentazione della gara d’appalto per l’ex-Casa del Fascio, in una cartella zippata dal nome «Progetto Istituto Parri».
Nella cartella ci sono tre pdf:
— la relazione del progetto, con descrizione dei contenuti, delle scelte d’allestimento e delle tecnologie necessarie;
— una carrellata di tavole e rendering degli allestimenti;
— il «quadro economico», cioè l’indicazione della somma necessaria per realizzare gli allestimenti, in tutto 1.917.000 euro (un milione e novecentodiciassettemila).
La pagina da cui si poteva scaricare il progetto (insieme ad altri 36 file) era intitolata «Appalto per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell’Ospitalità di Predappio».
Scrivo «si poteva» ed «era» perché la pagina, dopo essere rimasta on line circa un mese, è stata cancellata senza spiegazioni. È accaduto la settimana scorsa. Almeno fino alle 9:02 del 2 novembre c’era, come testimonia la cache di Google; il 6 novembre non c’era più.
Al momento, però, i 37 file sono ancora sul server. Dalla versione della pagina archiviata nella cache potete cliccare e scaricarli.
La relazione è una lettura che lascia basiti. So, per averne discusso con diversi storici e addetti ai lavori, che ha lasciato basiti anche loro, solo che non si sono ancora espressi in pubblico. Li invito a farlo, Giap è a loro disposizione. Intanto, comincio io.
Ci troviamo di fronte a un documento rabberciato e confuso, pieno di passaggi scritti in fretta e irrisolti, e privo persino dei numeri di pagina (sono 26 pagine). È stato pubblicato on line senza nemmeno rileggerlo, altrimenti qualcuno se ne sarebbe accorto, che era crivellato di refusi. Molti di questi riguardano la concordanza di numero o genere, segno che si sono cambiati dei vocaboli senza ricontrollare le frasi in cui erano inseriti: «prestati da altri istituzioni»; «gli orientamento»; «tutti i regimi totalitarie»; «le organizzazione del fascismo»; «esso sono il warfare»…
Della relazione ho già citato la frase sul fascismo che «come tale» non può tornare e la tirata basata su un fraintendimento del concetto di damnatio memoriae, ma c’è ben di peggio.
Il progetto di museo, scrivono gli estensori, si inserisce in un contesto europeo:
«in Germania, Russia, Polonia, Portogallo, per non citare che alcuni paesi, si sta verificando un percorso analogo, nel quale la costruzione di luoghi di interpretazione e di ricerca svolge il ruolo di attivatore di una memoria consapevole, come antidoto a ogni nostalgia e a ogni incertezza sul giudizio che una comunità democratica debba dare su quel passato.»
Un elenco alla rinfusa, nel quale è straniante vedere accomunate due situazioni diversissime come quella tedesca e quella polacca. Mentre in Germania si è tematizzata la colpa, nella Polonia ultrasciovinista di Kaczyński si impone di tematizzare la “discolpa”: si nega l’esistenza di un collaborazionismo polacco, si rilegge ogni aspetto del passato in chiave nazionalistica, si chiudono musei sgraditi e se ne aprono di celebrativi, soffocanti interferenze rendono sempre più difficile praticare una public history sganciata dalla propaganda di stato.
A quale dei due percorsi è «analogo» quello immaginato per Predappio? A quello tedesco o a quello polacco? Inoltre, non conosco la situazione in Portogallo, ma posso immaginare che sia piuttosto differente da quella russa.
È dunque un elenco che, invece di chiarire, annebbia.
Ho letto più volte la relazione, ho osservato le tavole, i rendering, le planimetrie, e credo di avere una buona idea di massima della forma, proporzione, disposizione e successione dei vari box. Diverso il discorso per quanto riguarda il loro contenuto, che è indicato in modo troppo vago.
Il percorso partirebbe su per arrivare giù: primo piano, piano terra, seminterrato. Secondo la metafora concettuale alto-basso, è come dire che si parte bene e si finisce male. Infatti, si legge nella sezione intitolata L’allestimento museale, il passaggio dal piano terra al seminterrato dovrebbe «far precipitare il visitatore direttamente nell’orrore della seconda guerra mondiale, seguita nel suo andamento cronologico e geografico, in un senso continuo di oppressione a cui contribuisce anche la scarsa altezza utile del piano».
Che sia finita male è poco ma sicuro, ma era partita bene?
Al primo piano, dopo un box introduttivo dedicato alla Grande guerra, si passa a un altro dedicato alla «presa del potere». Un setto è dedicato a «Lo squadrismo e la violenza fascista», un altro alla Marcia su Roma, il terzo al delitto Matteotti, poi c’è un setto grande descritto così: «Setto 1 grande: l’antifascismo: i socialisti e i liberali, i comunisti e i repubblicani.»
Segue una descrizione, che però non contiene il minimo accenno a cosa verrà mostrato di tutto questo. Sempre nella sezione L’allestimento museale si trovano precisazioni tecniche, si parla di standard e formati, di caratteristiche delle proiezioni video, di storici che appariranno in ologramma grazie alla tecnica del «fantasma di Pepper» e si metteranno a spiegare. Quindi so che l’allestimento sarà multimediale e ad altissima tecnologia, so che «all’avvicinarsi del visitatore, lo storico inizia la narrazione, presentando i contenuti utilizzando un linguaggio deittico e ricco di riferimenti al contesto», ma non mi si dà un’idea, nemmeno orientativa, a spanne, di cosa verrà mostrato.
Stiamo parlando di come il fascismo distrusse il movimento operaio e bracciantile, di come prese il potere, di come impose la dittatura. Va fatto capire che lo squadrismo era terrorismo. Per rendere l’idea di quanti morti fece, basti dire che in due anni ne fece più di tutti i gruppi armati — rossi e neri, e stragi comprese — attivi per tutti gli anni Settanta, che pure sarebbero gli «anni di piombo». È da come mi mostri e racconti questa fase che capisco dove vuoi andare a parare.
Tra i lavoratori del settore culturale con cui ho discusso il progetto c’è Tommaso Baldo, operatore didattico presso il Museo storico del Trentino.
TB. — La questione è: quali saranno i documenti usati? Ovvero: vedremo i volti dei braccianti uccisi dagli squadristi? Sentiremo la relazione di Matteotti sullo squadrismo? Pongo questo punto perché anche sui manuali scolastici la violenza fascista è edulcorata: lo squadrismo è sempre rappresentato tramite qualche innocua immagine di roghi di bandiere rosse e ritratti di Marx, è molto raro vedere i volti delle vittime, sapere del peggioramento delle condizioni di vita dei braccianti dopo la distruzione delle loro organizzazioni politiche e sindacali. Ecco, non sarebbe il caso di mostrare finalmente un grafico sulla povertà assoluta degli italiani nel corso del Novecento? È un dato semplice che mostra a colpo d’occhio quanto il fascismo, nel giro di pochi anni, abbia peggiorato le condizioni di vita della gente comune.
Da operatore didattico dico che non basta parlare di una cosa, il problema è cosa si mostra o si fa ascoltare per narrare un argomento. Le violenze fasciste gli italiani in realtà non le hanno mai viste, non le hanno mai associate a una storia, a situazioni concrete, a un nome, se non a quello di pochi personaggi “esemplari” come Matteotti, dei quali però non si racconta mai nulla dal punto di vista umano. Se alla base non c’è consapevolezza di questo, difficilmente ci sarà l’intenzione di mostrare documenti davvero di impatto, senza i quali la narrazione storica non lascerà il segno sui visitatori.
Credo che uno dei motivi per cui oggi la propaganda neofascista è efficace è perché, come nel caso Giuseppina Ghersi fa leva, il più delle volte attraverso menzogne, sulle storie individuali, mentre la narrazione storica scolastica o accademica spesso dimentica sia a livello macro che a livello micro la concretezza delle vita delle persone, e in questo modo non riesce a coinvolgere.
Chi vuole quel museo proprio a Predappio, per non coprire e fornire alibi al contesto di apologia del fascismo in cui si trova, dovrebbe sin dal progetto dire che intende «far vedere, far toccare con mano» gli orrori mai raccontati del fascismo italiano. Al momento, però, non si è letto nulla di simile.
È vero, nelle arti e discipline che mobilitano primariamente la vista — e la museografia è una di queste — quel che si mostra arriva prima di quel che si spiega, influenza preventivamente la spiegazione e determina cosa rimarrà dell’esperienza. Da questo punto di vista, la lettura del progetto non fa granché sperare.
Infatti, dopo questi primi box c’è un box circolare dove viene riprodotta — nel senso di riallestita virtualmente — la famigerata «Mostra della Rivoluzione Fascista» del 1932, con cui il regime marcò il decennale della propria ascesa al potere. Questo è il primo allestimento del quale riusciamo a farci un’idea, ed è un allestimento realizzato dal regime stesso a scopo autocelebrativo.
Prima di scendere al piano terra, possiamo visitare un soppalco dove ci vengono mostrate le realizzazioni ed eccellenze artistiche, architettoniche e scientifiche dell’epoca, e dove possiamo calarci nella «proiezione immersiva» di scene del cinema dei telefoni bianchi. Dopodiché possiamo divertirci un poco suonando una riproduzione dell’Intonarumori di Luigi Russolo:
«La riproduzione dell’Intonarumori si compone di sette elementi formati ognuno da un parallelepipedo in legno e da un altoparlante in metallo per amplificare i suoni; un software sviluppato ad hoc consente la riproduzione di un’infinita gamma di suoni che il visitatore potrà riprodurre utilizzando controlli analogici posti sui parallelepipedi.»
Costo dell’installazione: 18.000 euro.
Infine, dopo questa suonatina…
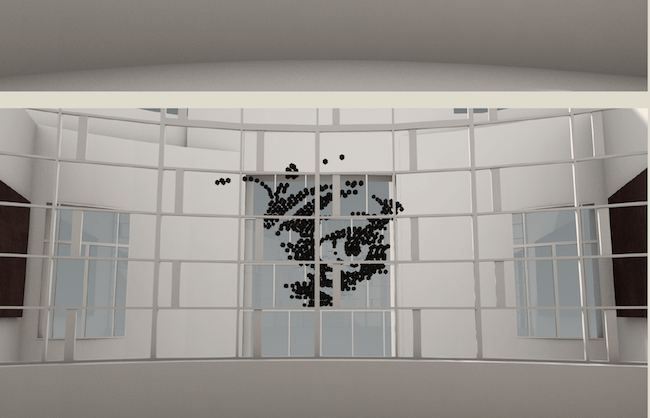
«…il visitatore si trova davanti alla controfacciata in ferro e vetro, uno dei punti privilegiati in cui si svela il gioco prospettico della grande installazione cinetica sospesa nel doppio volume dell’atrio di ingresso. Mediante il movimento randomico di circa 700 elementi icosaedri posizionati su cavi in nylon trasparente controllati da un software realizzato che consente di posizionare gli icosaedri in modo da comporre le varie figure, l’installazione rappresenta in modo letterale una serie di occhi e di date significative (ad esempio l’occhio di Gramsci seguito dalla data ‘26, anno in cui fu incarcerato; oppure l’occhio di alcuni dei padri costituenti, seguiti dalla data ‘46, secondo infinite possibilità di combinazioni di figure e numeri, rendendo il concept flessibile ed incrementale nei contenuti), uno “sguardo” sul fascismo italiano, come a voler introdurre il visitatore alla storia di quegli anni attraverso gli occhi di chi quel regime lo ha vissuto, subito e combattuto.»
Ho guardato a lungo il rendering e… trovo questa «installazione morfica» di una vacuità e inutilità da lasciare interdetti. Non trasmette conoscenze né emozioni, e se fa riflettere su qualcosa, è sull’utilizzo di una tecnologia per il solo gusto di utilizzarla.
Costo dell’installazione?
120.000 euro.
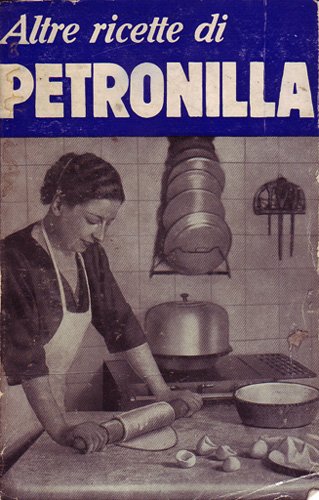 Stordito, discendo «l’evocativa scala centrale dalla forte valenza scenografica e teatrale» e giungo al piano terra, dove un box è dedicato alla «fascistizzazione della gioventù» e alla «società degli anni ’30». Il fine, dice la relazione, è raccontare l’Italia «della quotidianità, della scuola, del lavoro, dello svago, dell’alimentazione, dello sport, della radio», e al tempo stesso mostrare che «fascistizzare la società» significa «costringere i cittadini attraverso uno spietato controllo sociale a identificarsi sempre di più con l’ideologia e i progetti del regime».
Stordito, discendo «l’evocativa scala centrale dalla forte valenza scenografica e teatrale» e giungo al piano terra, dove un box è dedicato alla «fascistizzazione della gioventù» e alla «società degli anni ’30». Il fine, dice la relazione, è raccontare l’Italia «della quotidianità, della scuola, del lavoro, dello svago, dell’alimentazione, dello sport, della radio», e al tempo stesso mostrare che «fascistizzare la società» significa «costringere i cittadini attraverso uno spietato controllo sociale a identificarsi sempre di più con l’ideologia e i progetti del regime».
Un setto del box sarà dedicato alla Gioventù Italiana del Littorio, un altro a «I viaggi, le vacanze, il Touring», un altro ancora a «L’alimentazione, le ricette di Petronilla, la “Cucina italiana”, le patatine San Carlo, i Baci Perugina» (a proposito di «cose buone»), ed ecco poi «il tempo libero e lo sport per i giovani».
Nella scheda del box si spiega: «la cucina ha un ruolo importante perché e [sic] tra le due guerre che nasce una cucina italiana e perché la fascistizzazione degli italiani passa anche dalla definizione di una “dieta” alimentare, fatta di sobrietà, di rifiuto degli sprechi e poi di adesione al prodotto “italiano” nel quadro dell’autarchia.»
In linea di principio, non ho nulla da eccepire sul mostrare usi e costumi della società italiana degli anni Trenta. Non so se la cucina italiana sia tout court «nata tra le due guerre», non me ne intendo, ma può darsi sia così. In ogni caso, in un allestimento sull’Italia fascista può starci la cucina, può starci la moda, possono starci le barzellette, l’Intonarumori, Amedeo Nazzari e Doris Duranti, può starci qualunque cosa… a condizione di mettere precisi paletti contro la retrospezione rosea. Paletti precisi e ben pensati. E in museografia, non può trattarsi di semplici caveat, ma va scelto bene cosa mostrare, come mostrarlo e in quale successione.
Ora, se ho capito bene, questo box viene subito dopo quello dedicato a «Ovra, tribunale speciale, repressione», dove il visitatore ha appena visto una sedia:
«Avvicinandosi alla sedia, il visitatore entra in un cono sonoro da cui ascolta l’audio di un vero interrogatorio. Durante l’ascolto, sulle pareti opposte rispetto alla sedia, vengono illuminate a turno immagini relative ai contenuti dell’interrogatorio. Il sistema permette infinite possibilità di combinazioni di immagini, video e suoni, rendendo il concept flessibile ed incrementale nei contenuti. Sul fondo della sala è collocato un grande schermo che proietta il testo dell’interrogatorio trascritto in modo dinamico e sincronizzato con il procedere dell’interrogatorio: più il visitatore si avvicina allo schermo, più il testo si cancella come in un atto di censura.»
Il che, nell’intenzione degli ideatori, dovrebbe risultare very angosciante. Ma la descrizione è spettacolarmente vaga, e fredda, incentrata com’è sulla strumentazione tecnica, e priva di contenuti o esempi. Non aiuta a farsi un’idea dell’effetto. Chi è l’interrogato? Perché lo hanno arrestato? Cosa vogliono da lui? E chi leggerà la trascrizione dell’interrogatorio? Un attore? E perché mai la scomparsa dallo schermo del testo dell’interrogatorio dovrebbe farmi pensare a un atto di censura, se è lo stesso interrogatorio che sto ascoltando e basta fare un passo indietro per vederlo riapparire? Che razza di censura sarebbe?
Costo dell’installazione?
60.000 euro.
Sarà una sedia Luigi XIV originale con cuciture in oro…
Ricapitoliamo: prima ti mostro qualcosa sul confino, sui processi sommari, sulla prigione, sulla censura, ti faccio vedere una seggiola e sentire l’audio di un terzo grado… poi ti faccio vedere la gente che fa sport, va in vacanza, assapora i baci Perugina, come se un po’ di repressione fosse stata lo spiacevole prezzo da pagare per garantire il benessere. Non sarebbe stato meglio il contrario? Prima gli svaghi, le patatine e la magnàza, e poi l’osceno di tutto questo (letteralmente, il «fuori scena»)?
Anche gli estensori devono aver avuto qualche dubbio, perché hanno inserito nella relazione questa excusatio non petita:
«Deve essere ben chiaro che questo “viaggio in Italia” non è condotto per edulcorare la durezza spietata della dittatura — basta fare riferimento alla dominazione coloniale per averne una manifestazione esemplare — in una sorta di rievocazione bonaria di un comune “come eravamo”, quanto piuttosto per penetrare i meccanismi profondi della fascistizzazione della società italiana […]»
No, che non basta «fare riferimento alla dominazione coloniale»: bisogna vedere che tipo di riferimento, come lo si fa, quante volte, quanto peso e memorabilità hanno tali riferimenti, che spazio ha la «durezza spietata della dittatura» nell’economia complessiva dell’allestimento.
Ancora più importante è capire cosa viene lasciato fuori. E purtroppo le lacune di questo progetto sono enormi. Provo a elencare le maggiori.
 § Nella relazione non c’è il minimo accenno al «fascismo di confine», è totalmente assente la persecuzione delle minoranze slovena, croata e tedesca, non viene scritta una parola sull’italianizzazione forzata dei confini settentrionale e orientale.
§ Nella relazione non c’è il minimo accenno al «fascismo di confine», è totalmente assente la persecuzione delle minoranze slovena, croata e tedesca, non viene scritta una parola sull’italianizzazione forzata dei confini settentrionale e orientale.
Con tutto il rilievo che nella relazione si dà alla Grande guerra — definita «luogo di incubazione del fascismo e, in realtà, di tutti i totalitarismi» — gli ideatori si sono scordati che quella guerra si era fatta per «Trento e Trieste».
Quel che accadde a «Trento e Trieste» — cioè nelle terre annesse: Trentino, Alto Adige e «Venezia Giulia», quest’ultima comprendente l’Istria — dopo il 1918 contribuì a definire i tratti del fascismo, e continua a definire quelli del neofascismo cent’anni dopo. L’incendio del Narodni Dom di Trieste (13 luglio 1920) fu definito da Renzo De Felice «il battesimo del fuoco dello squadrismo»; oggi tra gli elementi irrinunciabili dell’identità neofascista vi sono il revanscismo contro il Trattato di pace del 1947, la recriminazione sulla perdita di «Istria e Dalmazia» e il martirologio sulle foibe.
Si tratta dunque di una rimozione grave, che infatti ha conseguenze sul resto: non avendo preso in considerazione l’antislavismo, gli estensori scrivono che solo negli anni Trenta il razzismo diventò «una delle spine dorsali» dell’ideologia fascista, quando invece era dagli albori un tratto precipuo del fascismo di confine, e la prima legislazione razzista (antislava) fu fatta per la «Venezia Giulia», dove dalla metà degli anni Venti ebbe luogo una vera e propria pulizia etnica.
 § La «riconquista» della Libia fu la prima guerra imperialista del regime, durante la quale sorse la stella di uno dei più celebri protagonisti militari del regime, Rodolfo Graziani.
§ La «riconquista» della Libia fu la prima guerra imperialista del regime, durante la quale sorse la stella di uno dei più celebri protagonisti militari del regime, Rodolfo Graziani.
Quella che fu de facto la seconda guerra di Libia, molto più duratura e cruenta della prima, fu anche il primo «laboratorio» del fascismo come macchina di morte massificata, e un momento di forte innovazione militare, tecnologica e nel controllo del territorio.
Eppure quella guerra non è trattata autonomamente, ma dentro un box dedicato ai «secondi anni Venti». Che in realtà è sbagliato, perché l’apertura dei campi di concentramento nella Sirtica, le deportazioni di massa dalla Cirenaica, il genocidio compiuto sul Gebel Achdar, tutto questo avviene nel biennio 1930-1931.
Stupefacente è che la Libia non meriti nemmeno uno spazio espositivo autonomo dentro il box: sta in un setto doppio il cui contenuto è indicato così: «Le colonie italiane, Cirenaica e Tripolitania, l’accordo con Haile Selassie, il diario del reduce».
Nella scheda che segue all’elenco dei setti si legge: «Si racconterà anche [bontà loro, N.d.R.] la politica coloniale dei secondi anni ’20, la riconquista e la riaffermata presenza in Cirenaica e Tripolitania».
«Riaffermata presenza» è un’espressione alquanto tenue, per descrivere un genocidio finalizzato al land grabbing.
Ma le lacune più impressionanti riguardano il periodo 1943-45.
§ Quando lo faccio notare, l’interlocutore di turno fatica a crederci, ma è proprio così: la Repubblica Sociale Italiana non ha un box tutto suo.
Sì, le viene dedicata una parete, ma come parte del box dedicato a tutta la seconda guerra mondiale. Per capirci: mentre al fascismo del ventennio è dedicato l’intero edificio, al fascismo repubblicano — da cui nasce il neofascismo postbellico in tutte le sue varianti, fino alle correnti odierne — è dedicata una parete. Come se, meccanicamente, si fosse tradotto il calendario in metratura.
Per giunta, la parete è «in coabitazione», perché il contenuto è indicato come «La RSI e la Resistenza».
Già questa titolazione solleva perplessità: fa pensare a un’accentuazione del carattere di guerra civile della Resistenza, a scapito degli altri aspetti sviscerati da Pavone (guerra di liberazione e guerra di classe); ma il problema vero è la sproporzione, che sembra fare di quel densissimo anno e mezzo, del collaborazionismo italiano, del regime criminale di Salò, una mera “coda” del fascismo, un suo ultimo lembo. Da lì a rappresentarlo come una “degenerazione”, il passo è molto breve. In Italia è troppo diffuso il cliché sul fascismo che «fece bene» finché il duce non si alleò con Hitler, e un allestimento sbilanciato sul “prima” non contribuisce certo a disinnescarlo.
Invece quell’anno e mezzo ci mostra un fascismo con pochi freni e privo di contrappesi istituzionali, un fascismo che chiude il cerchio tornando al terrorismo dei primi anni con addirittura più violenza, e al contempo riscopre parte dell’antico vocabolario sansepolcrista, accentua le pose “rivoluzionarie”, estremizza ogni elemento del proprio stile in direzione di un più nero — ma non meno cialtronesco — culto della morte. Quello di Salò è un fascismo iperrealistico, più fascista del fascismo-regime, a destra di se stesso. Un museo del fascismo dovrebbe farlo capire. Salò non merita meno spazio del «come eravamo», e certamente merita più spazio dell’«installazione morfica».
§ Il periodo successivo alla Liberazione è raccontato nell’ultima sala, dove — cito dalla sezione L’allestimento museale — «si confrontano due pareti multimediali che descrivono il dopoguerra: le rovine e la distruzione del paesaggio e delle coscienze causate dal fascismo e la rinascita verso la libertà e la democrazia.»
Nella sezione I contenuti del museo non viene detto molto di più:
«1) Stragi e distruzioni: immagini di bombardamenti, distruzione fisica, di stragi
2) Libertà e democrazia: immagini di libertà, le elezioni del 2 giugno 1946 per l’Assemblea Costituente e il referendum per la Repubblica, voci di costituenti su alcuni valori antitetici al fascismo (libertà d’espressione, multipartitismo, diritto di sciopero, ripudio della guerra, ecc), la promulgazione della Costituzione nel 1948»
Dunque niente sulle storture dell’amnistia Togliatti, sulla mancata epurazione, sulla mancata estradizione dei criminali di guerra, sulla continuità tra stato fascista e stato democratico, sul rifiuto di fare i conti con la pesante eredità del colonialismo italiano.
Se si pensa che il fascismo sia «finito settant’anni fa» e i ragazzi di oggi siano «immuni al nazionalismo» perché viaggiano, non si può che finire l’allestimento con un happy ending. Animo, è tutta acqua passata.
Dal che si capisce come delle esperienze museali tedesche, più volte indicate a modello nel corso degli anni, si sia capito ben poco.
9c. Se c’è qualcosa che non c’entra è la Germania
L’«esempio tedesco» è stato più volte evocato. Secondo Serge Noiret, ad esempio, il progetto sarebbe stato «sulla falsariga» del recente NS-Dokuzentrum di Monaco.
La riga, in effetti, è falsa: sia il Centro di documentazione sul Nazionalsocialismo a Monaco sia Topografia del Terrore a Berlino — che ho visitato nel luglio scorso — includono dettagliate sezioni sui processi per collaborazionismo, sui criminali nazisti in fuga e le complicità che ne permisero la fuga, sul reintegro di molto personale nazista nei ranghi dello stato, e in generale sul retaggio del nazismo e sul fatto che, per dirla con Bertolt Brecht, «il grembo da cui nacque è ancor fecondo».
Nel progetto per Predappio testé recensito, invece, non c’è nulla, nulla, nulla di minimamente paragonabile.
In compenso ci sono ologrammi, fantasmagoriche installazioni, «proiezioni immersive», castagnole e tricche tracche. Tricche tracche costosissimi.
A Topografia del Terrore non trovi niente del genere.
Ma del resto, Topografia del Terrore non è in una Casa del Fascio.

Topografia del Terrore, Berlino.
Frassineti e i peroranti hanno evocato spesso Monaco, ma nominato Berlino il meno possibile. Non è un caso: Berlino offrirebbe esempi controproducenti, come appunto Topografia del Terrore, che sorge sull’assenza.
Dove ora c’è l’esposizione permanente, un tempo c’erano la sede centrale della Gestapo, la direzione e il servizio sicurezza delle SS — quindi anche l’ufficio di Himmler — e l’ufficio principale della sicurezza del Reich. Il complesso edilizio fu semidistrutto dai bombardamenti, e nel dopoguerra fu demolito.
In quegli uffici erano stati pianificati la Shoah e il Porajmos. Per questo la mostra si chiama Topographie des Terrors: non è una generica mostra sul nazismo, ma sul funzionamento del grande marchingegno nazista del terrore e dello sterminio. Più precisamente, sulle conseguenze delle decisioni che venivano prese tra quelle mura.
Mura che oggi non ci sono più. Non ci sono nemmeno più le rovine.
E l’esposizione non è stata calata dall’alto, ma è sorta dal basso grazie al pluriennale impegno di associazioni e cittadini, che l’hanno voluta precisamente in quel luogo.
Qui, nel quartiere di Kreuzberg, al numero 9 della Niederkirchnerstraße, davvero non potremmo essere più lontani dalle pastoie di Predappio, dall’uso ricattatorio dell’architettura, dalla submacchina.
Ma, a parte Topografia, è tutto il «modello Berlino» a essere antitetico al percorso intrapreso a Predappio. Nel corso degli anni la città è diventata — tra le mille cose contraddittorie che Berlino è: cantiere edilizio permanente, capitale europea de facto e quindi simbolo dell’ordoliberismo della Trojka ecc. — una sorta di grande ipertesto della memoria. Come ha scritto Igiaba Scego,
«La città parla. Berlino non è muta. Troviamo i nomi dei campi di concentramento quasi in ogni angolo della città. E lo stesso vale per le targhe e gli omaggi alle vittime di quella barbarie novecentesca chiamata nazismo. Ogni sinagoga distrutta, ogni oltraggio subìto è marcato da un segno, da una pietra di inciampo, dal nome di una via […] quella di Berlino non è solo espiazione, ma anche costruzione di un futuro senza più ombre. Berlino ci prova. A volte viene accusata di parlare troppo, di esagerare con il senso di colpa. Ma la città sembra non curarsi di noi, sa che quel cancro è sempre in agguato, può riemergere, in Germania come altrove.
C’è chi se lo vuole dimenticare. C’è chi incendia i centri dove vengono accolti oggi i rifugiati siriani. Chi manifesta contro la presenza dei musulmani. Ma la città parla. Ammonisce. Ricorda. E anche se i problemi ci saranno sempre e forse nel futuro saranno ancora più acuti, il lavoro sulla memoria che è stato fatto comunque ha dato i suoi frutti.»
Ma sono fallaci anche i paragoni con Monaco. Per via del contesto, prima ancora che dell’impietoso — anzi, improponibile — paragone tra il lavoro museografico che si è fatto là e quello descritto nella relazione del progetto Predappio.
Monaco di Baviera è una metropoli importante e ricca di storia, e fu la città di partenza del nazismo, il luogo dei suoi primi exploit, compreso il putsch che portò in galera Hitler. Eppure, Monaco non è meta di pellegrinaggi sacri neonazisti. È vero, il ventre molle della società bavarese coltiva una memoria ambigua e reticente nei confronti del passato nazista, nondimeno scene come quelle che si vedono da noi sarebbero inconcepibili.
Cosa sia Predappio oggi, invece, lo abbiamo già visto.
E lo vedremo ancora.
…
Esausto, chiudo questa lunga carrellata. Nelle prossime settimane Giap ospiterà interventi e contributi di storici, pubblicisti, insegnanti, operatori didattici e museali, non solo su Predappio e sul progetto di museo, ma su tutti i temi affrontati in queste tre puntate. Grazie di avermi seguito fino a qui. Il viaggio continua.
I commenti a questo post saranno attivati 72 ore dopo la pubblicazione, per consentire una lettura ragionata e – nel caso – interventi meditati (ma soprattutto, pertinenti).





 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)


Da architetto, e quindi da una posizione privilegiata che dovrebbe saper pesare il valore di un Terragni, o di un Moretti (per citare un caso emblematico), ho trovato le conclusioni del punto 8 equilibrate e anche rispettose della “disciplina”. Trovo perfettamente centrate le tre soluzioni proposte e la progressività delle soluzioni previste.
Ha perfettamente ragione Biondillo nel dire che nelle facoltà di architettura la produzione architettonica sotto il fascismo la si studia e la si studia “generalmente” bene, ma da un po’ di anni di quel che producono e scrivono gli architetti (seri) non interessa più nessuno (e forse a ragione…).
Anche io da architetto trovo il paragrafo sull’architettura sia molto equilibrato. Concordo che l’opzione della demolizione non deve essere un tabù (di fatto è uno degli strumenti base della costruzione fisica del territorio, costruire, demolire, conservare, modficare)seppure occorra soppesarla con attenzione (come d’altronde qualsiasi altra opzione).
Il fatto che l’architettura fascista – e/o come precisa correttamente Gianni Biondillo, tra l’altro uno dei pochi capaci di parlare efficacemente della nostra disciplina al di fuori del suo recinto professional-accademico, l'”architettura sotto il fascismo” – in Italia sia stata in qualche modo condannata all’oblio è una colossale fandonia. Tonnellate di bibliografia sul tema, scritta in grandissima parte da autori di sinistra, quando non marxisti tout court, e decine di lezioni, seminari, corsi monografici, convegni sul tema stanno lì a dimostrare il contrario. Io stesso ho partecipato all’organizzazione di un seminario monografico su architettura e politica tra le due guerre, nel quale gli studenti studiarono a approfonditamente (oltre a USA e CCCP) l’architettura fascista, ma anche quella nazista (Speer), come d’altronde credo che fosse doveroso fare. Giudico anche molto pertinente il riferimento alla Topografia del terrore, che nell’intreccio scientifico di rigore etico, storico e architettonico è davvero esemplare (e per parte mia la considero, pur essendo forse la meno nota tra le architetture della memoria berlinesi, la più riuscita, più del Museo Ebraico di Libeskind e del Memoriale dell’Olocausto di Eisenman, tanto per capirsi). Il confronto con la baracconata di Predappio è davvero impietoso. Infine mi permetto di notare che il pezzo di Pier Paolo Tamburelli (architetto, progettista con il collettivo Baukuh della Casa della memoria di Milano), al di là dell’avventata fiducia per Frassineti&Co da voi citata in una delle puntate precedenti di PTWB, sia sostanzialmente condivisibile http://www.doppiozero.com/materiali/storia-e-memoria/una-strategia-generale-sui-centri-di-documentazione-del-fascismo
Grazie a entrambi, mi fa molto piacere – e trovo appropriatissimo – che i primi a intervenire in questo spazio commenti siano stati due architetti.
È difficile commentare questa lunga inchiesta su Predappio.
E vorrei scrivere innanzitutto che meno male che abbiamo “il cinese” ;-) a scrivere per noi quello che almeno io non riuscirei mai a esprimere con tanta lucidità, eleganza e maestria.
Io credo fermamente che questo paese abbia bisogno di un museo non sul fascismo, ma sugli orrori della dittatura fascista, sulla Resistenza e sulla Seconda Guerra Mondiale.
Un museo del genere sarebbe dovuto sorgere decenni fa e assolutamente non a Predappio.
Curato nel tempo, arricchito, ma soprattutto collegato ad una rete di interventi istituzionali, discussioni, insegnamenti che avrebbero contribuito a modellare una memoria storica collettiva molto diversa da quella che ci ritroviamo oggi.
Credo anche che Predappio sia un enorme errore storico (uno dei tanti commessi intorno al fascismo) cui oggi è difficilissimo riparare. Mi sembra un vicolo cieco, senza uscita.
Mussolini avrebbe dovuto essere portato via, sepolto in luogo ignoto.
La casa avrebbe dovuto essere riutilizzata subito, resa irriconoscibile, o demolita.
Era necessario che le istituzioni prevedessero la carica simbolica della città di Mussolini (che pena anche solo scriverlo) e facessero di tutto per disinnescarla.
E certo questo è un discorso inutile: la tomba di Mussolini è lì, nulla si è fatto all’epoca, a che serve ripeterselo?
È che trovo molto frustrante mettermi a parlare di Predappio senza “fare” niente a riguardo. Non riesco a slegare la discussione dall’immediato impulso ad agire.
Ma che fare?
Ha ragione Tommaso Baldo, uno dei maggiori problemi quando si insegna la storia del ventennio, ma anche quando si tenta di parlarne in altri contesti, è che si astrae, andando a sragionare intorno alle piccole e grandi fandonie che avete messo bene a fuoco: il welfare, la bonifica, le “cose che funzionavano”.
Invece bisognerebbe opporre la semplice, cruda realtà delle storie personali.
Le storie di gente molto meno nota di Gramsci o Matteotti, ma non meno protagonista, la gente che conobbe sulla propria pelle la violenza dello squadrismo fascista, l’orrore delle leggi fasciste, e delle invasioni coloniali.
Dovremmo ricominciare a raccontarla, questa diversa memoria collettiva.
E intanto come bloccare Predappio e Frassineti? Come depotenziarli, ridicolizzarli?
Perché non occultare le vetrine dei negozi con le foto di chi quell’olio di ricino l’ha dovuto bere a forza, dopo essere stato picchiato con quegli stessi manganelli in vendita?
Perché non riempire il libro delle visite alla tomba di Mussolini con ricordi di persecuzioni, confini e uccisioni di parenti che semplicemente si rifiutarono di dichiararsi fascisti?
Perché non affiggere su ogni muro della casa del fascio le foto della gente che viveva in miseria, perseguitata dalla fame, mentre i fascisti facevano le parate in nero?
Sarà un’ingenuità, anzi lo è sicuramente. Perdonate la mia totale mancanza di preparazione seria sull’argomento, cui supplisco solo con la drammaticità delle storie di famiglia, raccontate di generazione in generazione, che forse lasciano il tempo che trovano. Ma bisognerà pur fare qualcosa! (semicit.)
Grazie, Ofelia. Io sono convinto che la situazione a Predappio sia un sintomo, e che si debba primariamente lavorare sul male, però è chiaro che pure a Predappio qualcosa va fatto.
Il non fare ulteriori disastri sarebbe una precondizione per tutto il resto. Rendere sempre più persone edotte dell’assurdità e pericolosità di questo progetto sarebbe già un passo avanti.
La cosa giusta sarebbe non realizzare il museo.
Se cambiassero il progetto come risultato di una campagna d’opinione e di una pressione dal basso, farlo sarebbe sbagliato comunque, perché l’errore è a monte, però sarebbe un segnale da valutare.
E quand’anche dovessero realizzarlo pari pari com’è descritto adesso, almeno che ne siano chiari i gravi difetti, che lo facciano in un’atmosfera di dissenso, con un po’ di palloncini già forati, e avendo intorno gente consapevole, indisposta ad assecondare certe logiche.
Tuttavia, è evidente che tutto questo riguarda il “non fare”, e bisogna anche fare.
Nel post parlo anche del fare, in linea però molto generale, perché finché la scena è dominata dai Frassineti, intervenire in modo sensato è difficile. Qui posso provare a inserire qualche dettaglio in più, per far vedere che ragionarci sopra non è difficile.
Bisognerebbe scoraggiare e se possibile tout court respingere i pellegrini neofascisti, con una mobilitazione dal basso, e allo stesso tempo – come istituzioni, associazionismo e movimenti – incentivare e proporre sempre più iniziative antifasciste a Predappio. Purtroppo, invece, da anni si fa l’esatto contrario: con la motivazione dei «problemi di ordine pubblico» Frassineti non concede l’uso del suolo pubblico per iniziative antifasciste (ho un bel po’ di documenti al riguardo, che mi ha spedito un contatto forlivese e in un prossimo futuro userò), e l’amministrazione agevola lo svolgersi delle manifestazioni fasciste. Ad esempio il 29 ottobre scorso, come riporta una testimonianza, «c’è stato un “salto di qualità” […] si è bloccata tutta la statale, si è fatto divieto di parcheggio e si sono rimossi i cassonetti. Gli scorsi anni si bloccava solo metà carreggiata.»
Ci sarebbero tanti possibili modi per rendere l’atmosfera inospitale ai pellegrini, ma ci vuole la volontà politica di farlo. E non solo la volontà politica: serve anche il coraggio di sputare nel piatto dove si mangia.
Si sarebbe potuto investire in un percorso di memoria completamente diverso nell’approccio, se non opposto. La Rocca delle Caminate, dove si riunì per la prima volta il governo collaborazionista di Salò e dove si torturarono e uccisero partigiani, sarebbe potuta diventare un centro di documentazione sugli orrori del fascismo.
La cripta dei Mussolini, al cimitero di S. Cassiano, poteva – e io credo possa ancora essere – “depotenziata” cambiandole la cornice intorno. Anche lì, l’ideale idealissimo sarebbe sfrattare il Salmone, ma nell’impossibilità di farlo (almeno per il momento), risemantizzare il tragitto che porta al camposanto, con iscrizioni, esposizioni e installazioni, ispirandosi a Bolzano con un tocco di Berlino, potrebbe avere una certa efficacia.
E invece di limitarsi a dire ai turisti, come fa adesso, «ooooh, che belle le nostre architetture del ventennio», il comune potrebbe raccontare il lato oscuro, quello che le sontuose facciate lasciano in ombra: raccontare come i fascisti si imposero nel forlivese, raccontare del sindaco socialista Ciro Farneti che fu picchiato a morte dalle camicie nere, raccontare di come, nonostante tutto, Predappio e i suoi dintorni abbiano dato molti partigiani alla Resistenza.
Qui Frassineti potrebbe dire: «Ma io l’ho ricordato diverse volte!» No, non si tratta di riferimenti en passant o dell’occasionale presentazione di libro, bisogna scrivere queste cose sulle targhe, predisporre un percorso della memoria completamente diverso da quello che ora c’è sul sito del comune ecc. ecc.
E al contempo, perché – la butto lì! – non andarci noi a Predappio, negli anniversari della Marcia su Roma, per commemorare – con una marcia antifa e con iniziative, convegni, una giornata di studi – le vittime dello squadrismo? Scadenza nazionale, convergenza dai quattro angoli del Paese. Non ci danno l’autorizzazione? Ce la si prende. Se vogliamo, possiamo essere ben più dei duemila fasci che c’erano il 29 ottobre. È solo un esempio, tante altre idee possono venire.
“Rovinata” la cornice per i fascisti, i commerci neri avrebbero un progressivo calo di presenze e di fatturato. Del resto, ci sarebbero tanti modi per intervenire anche su quelli, volendolo.
Come ho scritto nel post qui sopra, solo a quel punto si dovrebbe ragionare su cosa fare dell’ex-Casa del Fascio, non prima di tutto il resto, come ha imposto Frassineti. E di sicuro non bisognerebbe farci quel che si auspicano lui e la dirigenza renziana del Parri di Bologna.
Sono completamente d’accordo, grazie a te per l’ulteriore discussione. Organizzare una serie di eventi, parlare, se necessario gli spazi prenderseli da soli. Magari partendo da Bologna questo dicembre, esploriamo sistemi per non lasciare respiro a Frassineti & co, mettiamoli all’angolo. E se forze antifasciste dovessero convergere a Predappio il 29 ottobre, io ci sarò!
All’IStorReCoFC e agli altri estensori del comunicato sul museo di #Predappio è giunto questo messaggio:
Cari amici,
la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano (CDEC) condivide in pieno le preoccupazioni espresse nella lettera che avete voluto inviarci. La necessaria istituzione di un museo sul fascismo in Italia che da molti anni andiamo proponendo e che condividiamo con numerose altre istituzioni e singoli studiosi, non può non prevedere un’attenta condivisione dei progetti e delle attività ad essi connesse. Questo a maggior ragione in un luogo come Predappio, così carico di una memoria storica lacerante e luogo di ricorrenti manifestazioni neofasciste verso le quali le istituzioni hanno da sempre dimostrato fin troppa tolleranza, non rilevandone l’intrinseca pericolosità per la fragile democrazia italiana.
Un cordiale saluto
Gadi Luzzatto Voghera
Direttore Fondazione CDEC
A proposito di demolizione dei relitti fascisti e sfida ai tabù, ecco cos’è successo ad Amburgo pochi giorni fa.
The city of Hamburg just destroyed a giant swastika with bulldozers and jackhammers.
[…] legga, avendo in mente il Fico, la terza puntata dell’inchiesta di Wu Ming 1 sul progettato museo di Predappio: il parco farinettiano e il […]
Ho già raccontato di quando, l’anno scorso, il sindaco Frassineti andò fino a Sanremo per partecipare a un’iniziativa timbrata Lealtà Azione. In quell’occasione, il network di ultradestra era rappresentato dalle associazioni «Ex Ventis Adversis» e «Memento». Durante la serata, Frassineti presentò un libro su Rachele Mussolini insieme all’autrice (una nipote del duce) e alla giornalista fascista Emma Moriconi. Il tutto culminò in un concerto del cantautore fascista Skoll, il Povia di Casapound. I dettagli sono nella seconda puntata di PTWB.
In quella a dir poco discutibile cornice, Frassineti «lato B» (il lato meno frequentato dai media «democratici» mainstream e dalla stampa internazionale) presentò il progetto di museo per l’ex-Casa del Fascio di Predappio.
E uno si chiede: che senso ha discutere di quel progetto con conclamati neofascisti, addirittura di matrice neonazista? Lealtà Azione è un’evoluzione di Hammerskin e il suo mito politico è Léon Degrelle, rappresentato sulle sue locandine in divisa delle SS.
Io la mia analisi l’ho fatta e motivata nell’inchiesta, ma ciascun* si faccia la propria idea e tragga le proprie conclusioni.
Ora c’è una novità sul collegamento tra Lealtà Azione e il territorio di Predappio: una delle associazioni che avevano invitato Frassineti, «Memento», non solo si è insediata anche in Romagna, ma da ieri cura la «manutenzione e riordino» della cripta dei Mussolini al cimitero di San Cassiano.
Nel frattempo anche RaiStoria si sta muovendo interessata dall’architettura razionalista. Michela Ponzani non ha fatto in tempo a recarsi a Predappio ma crede “sia importante dare vita ad un museo che tolga terreno a certi rigurgiti nostalgici” vabbè linko articolo https://pbs.twimg.com/media/DQITRIWWsAA41Xe.jpg:large
Eccerto. Le analisi, le obiezioni argomentate, le prese di posizione di svariati tra i migliori storici italiani sono «polemiche inutili e sterili».
È poi fantastico come tutti continuino a definire i fascisti «nostalgici», quindi sbagliando clamorosamente bersaglio e lettura della fase, nonché a descrivere, senza la minima pezza d’appoggio, il museo come una mossa contro i neofascisti.
Se è una mossa contro i neofascisti, dovrebbero spiegarci come mai i neofascisti ne sono entusiasti, e come mai neofascisti invitano Frassineti a presentare il progetto.
E, già che ci sono, dovrebbero spiegarci come possa essere una mossa contro i neofascisti, se non è accompagnata da alcuna politica per disincentivare pellegrinaggi, commerci e rituali neofascisti.
A proposito di monumenti e guerriglia, una storia dalla Germania, fresca fresca.
A Bornhagen, in Turingia, il gruppo di artisti ZPS (Zentrum für Politische Schönheit = Centro per la Bellezza Politica) ha compiuto un blitz nel cortile della villa di Björn Höcke, presidente del partito di estrema destra AfD, e in un battibaleno, col calcestruzzo, gli ha costruito davanti a casa una replica/estensione del Memoriale per gli Ebrei Assassinati d’Europa.
Il memoriale è uno dei monumenti più noti di Berlino, e nel gennaio scorso Höcke lo aveva definito «un monumento alla vergogna». La performance risale a mercoledì scorso, 29 novembre.
Die Zeit ha dedicato uno speciale alla vicenda.
Alcuni fascisti, due giorni dopo, hanno aggredito e cercato di accoltellare membri dello ZPS (ecco un video su questi ultimi sviluppi).
«Il museo di #Predappio sarà come #FICO, con la memoria del fascismo al posto del cibo.»
Intervista a Wu Ming 1 su Radio Città Fujiko di #Bologna.
L’ANPI nazionale prende una posizione netta contro il progetto di museo nella Casa del Fascio di #Predappio.
Ieri, sul sito di MicroMega, è apparso un editoriale a firma del direttore Paolo Flores d’Arcais in cui si chiede lo scioglimento di tutti i gruppi apertamente neofascisti presenti in Italia. Il casus è ovviamente il blitz di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica a Roma. Flores d’Arcais denuncia la connivenza tanto del governo in carica quanto di quelli di destra che lo hanno preceduto, e li accusa di aver contribuito alla rilegittimazione dei fascisti presso l’opinione pubblica, complici i media che hanno dato loro spazio nei talk show e sui giornali. Contro questo stato di cose, l’editoriale chiama a una rivolta morale nel Paese e propone una soluzione politica: una legge che imponga alla magistratura un’interpretazione rigorosa del reato di apologia del fascismo. Un’interpretazione autentica delle disposizioni già vigenti, si precisa, e non nuove leggi che lasciano il tempo che trovano”: il riferimento, anche se non esplicito, è ovviamente alla Legge Fiano. Qui sta, a mio parere, l’aporia della tesi Di Flores d’Arcais.
Precisiamo un punto: una cosa è lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, previsto dall’art. 3 della Legge Scelba (a cui è da aggiungere quello dell’art. 7 della Legge Mancino per le organizzazioni che incitano all’odio razziale, etnico, religioso etc.), un’altra cosa è l’apologia del fascismo. Lo scioglimento è un atto del governo, e può essere teoricamente disposto anche senza che sia mai stata emanata una sola sentenza di condanna per apologia del fascismo: i presupposti sono altri. Fatta questa distinzione, torniamo alla proposta dell’editoriale di MicroMega. Come ho scritto nella nota giuridica alla prima puntata di “Predappio Toxic Waste Blues”, la magistratura interpreta la legge Scelba nel modo giustamente criticato da Flores d’Arcais, perché manca del tutto, a prescindere dai casi singoli, una cultura specifica sul fascismo vecchio e nuovo, sulle strategie e sulle tattiche delle formazioni della destra radicale, sul significato della simbologia che adottano, su quali siano i canali di finanziamento e di reclutamento… Bene fa l’ANPI, in questo senso, a chiedere che vengano istituiti corsi di formazione ad hoc per i magistrati. Aggiungo: anche il potere giudiziario, come quello esecutivo, rivela ancora oggi le tracce della mancata epurazione del personale fascista dopo il 1945. Le strutture di pensiero sopravvivono alle epoche, soprattutto quando si continua a non volerci fare i conti. È così che il rimosso ritorna. Fino a quando non si vorrà colmare questo vuoto culturale, nessuna legge d’interpretazione autentica cambierà mai davvero le cose. Anche le leggi d’interpretazione autentica vengono a loro volta interpretate: il giudice i>bouche de la loi era un’illusione illuministica che non faceva i conti con la realtà del diritto. Se non cambia il modo di pensare dell’interprete, il circolo vizioso non s’interrompe.
Detto per inciso, la Legge Fiano *è* in parte una legge d’interpretazione autentica, dal momento che ribadisce e specifica meglio – almeno nell’intento dei suoi estensori – la condotta di apologia del fascismo. La proposta di Flores d’Arcais non è quindi molto diversa dal disegno di legge a cui si contrappone.
Stupisce, tra l’altro, che a invocare la soluzione “di forza” del legislatore sia proprio uno di coloro che in questi anni, dai girotondi in avanti, sono stati tra i più strenui assertori della rigida separazione dei poteri, contro le ingerenze di politici inetti o interessati solo all’impunità dei propri reati. In questa contraddizione secondo me è evidente il problema della posizione di Flores d’Arcais, ossia il rifiuto di riconoscere che la magistratura non è fatta a immagine e somiglianza dell’idea che lui ne ha e che per decenni ha cantato, a sostituto di un’opposizione politica al berlusconismo.
La gestione di tutta questa faccenda da parte di Frassineti e del Parri è talmente avventuristica, scriteriata e forzosa che persino l’assessore regionale alla cultura Mezzetti – pur ribadendo il sostegno al progetto – comincia a fare critiche e distinguo.
«Purtroppo gli organizzatori non si sono premurati di concordare per tempo con la Regione tempi e modi dell’iniziativa [la presentazione della mostra sul progetto, N.d.R.] e questo mi impedirà di prendervi parte […] non possiamo permetterci nessuna ambiguità […] L’ho più volte ripetuto: è mia convinzione che la parte espositiva multimediale (volutamente bandisco la parola “museo”) deve essere il supporto e non il cuore del progetto, come al contrario oggi sembra ancora essere. Inoltre, bisogna fare molta attenzione al percorso che deve portarci a quella meta. Un percorso in cui i simboli sono sostanza […] Per questo ho molte riserve sul luogo scelto per l’esposizione del progetto -aggiunge l’assessore -. Non doveva essere la casa natale di Mussolini ad ospitare la mostra perché la scelta si presta a molti equivoci e le reazioni negative di queste ore, come quella dell’Anpi nazionale, stanno a dimostrare quanta accortezza richiede questo percorso. Fino ad oggi la Regione ha accompagnato il cammino dell’amministrazione di Predappio ed è disposta a farlo in futuro a condizione che si tenga conto di queste valutazioni e si consideri il progetto una proposta ancora aperta al contributo di quanti vorranno arricchirla, a partire dai soggetti culturali e associativi più direttamente coinvolti e interessati.»
Antifascismo y anticapitalismo en la Italia de hoy. Notas sobre el conflicto sucedáneo y el verdadero.
Traduzione in castigliano di parte del capitolo 6 di quest’inchiesta.
Intervistato dal «manifesto», lo storico Filippo Focardi – uno dei cinquanta che l’anno scorso firmarono l’appello pro Frassineti – prende le distanze dal progetto.
Per questo può servire un museo storico sul fascismo? A Predappio?
«Io penso sia necessario un museo importante sul fascismo, ma a Roma che è la città dov’è andato al potere o a Milano dove è nato. A Predappio il museo si presta più alla nostalgia che alla memoria. Fare di Predappio il luogo della visione critica del fascismo è una sfida che può essere persa e non possiamo permettercelo.»
https://ilmanifesto.it/piu-nazisti-che-fascisti-ma-attenti-allallarmismo-strumentale/
«Per sapere se il budino è buono bisogna assaggiarlo.»
Questo pare abbia detto De Bernardi a #Predappio sabato scorso, all’inaugurazione della mostra sul progetto di museo.
Un budino da cinque milioni?
Ok, assaggiamolo. E se poi fa cagare?
Tanto più che la ricetta l’abbiamo già letta, e le perplessità su ingredienti e dosaggi, nonché sullo stato igienico della cucina, le abbiamo spiegate.
«Per sapere se il budino è buono bisogna assaggiarlo.»
Più o meno con la stessa “argomentazione” costui spingeva, l’anno scorso, per il Sì alla riforma costituzionale Renzi-Boschi.
Questo è uno storico, eh.
[…] Nel novembre scorso Wu Ming 1 ha dedicato a tale leggenda un capitolo della sua inchiesta Predappio Toxic Waste Blues. Lo riproponiamo, da solo, per chi non lo avesse ancora […]
Esemplari, come sempre, per completezza e chiarezza dell’argomentare. Incrocio il vostro contributo all’indomani della programmazione del documentario (28/12/2017) de La Grande Storia, che ancora peraltro devo guardare in differita, ma a suo tempo avevo letto l’originale dell’articolo della professoressa Ben-Ghiat, cogliendo soprattutto l’invito ad applicare uno sguardo storicamente più critico alle numerose testimonianze artistiche, architettoniche e simboliche che ci circondano, rendendo oggettivamente più complessa la nostra relazione con un passato tanto tragico. Rileggendo ora le traduzioni italiane e i commenti, in molti casi sguaiati e davvero provinciali, mi viene da riflettere sull’eventualità che la stessa autrice e la rivista possano aver lasciato aperto uno spiraglio di ambiguità nei loro intenti, vuoi a causa di un titolo che nell’originale è in forma interrogativa diretta “Why Are So Many Fascist Monuments Still Standing in Italy?” (che potrebbe portarci a pensare che la reale domanda sia “Perché ne avete lasciati tanti ancora in piedi?”); vuoi per la genericità di un termine come “monument”. A proposito dell'”Apoteosi” del Montanarini, sembra quasi che l’opera ricoperta dagli Alleati nel 1944 sia stata immediatamente riesposta nel dopoguerra, mentre il panno che l’aveva oscurata è stato rimosso mezzo secolo dopo, su esplicita proposta di Walter Veltroni, ministro dei Beni Culturali per Prodi. Detto questo, le polemiche contro un articolo ben documentato e più che motivato sul piano storico e politico sono inaccettabili e ben ha fatto Giap a inquadrare la questione in un contesto così ampio e ineccepibile, dal punto di vista storico ed estetico. Precauzione essenziale se vogliamo centrare anche un obiettivo di minima come la pronta distruzione del vergognoso “sacrario” di Affile.
«L’orrido semita Biondillo».
Nella #Giornatadellamemoria2018, cade a pennello quest’esempio non solo di come i camerati siano incapaci di controbattere nel merito di quanto scritto da WM1, ma soprattutto di quanta difficoltà abbiano a controllare certi riflessi.
La rivista Limes pubblicò parecchi anni(15?) fa diversi racconti dello scrittore Antonio Pennacchi sulle “città fondate” durante il ventennio.
Al tempo,decisamente ignaro sia della materia che delle implicazioni apprezzai il “taglio” originale delle vicende narrate da Pennacchi.
Mi divertivano gli aneddoti,il “registro” da lui usato e così conobbi:Carbonia,Latina,Sabaudia e Tresigallo etc.
In seguito lessi solo un suo romanzo che divenne un film.
Smisi di leggere Limes.
Non acquistai il libro di Laterza dove A.P. recensì tutte le città(147 leggo sul sommario) di fondazione fascista da lui (ri)scoperte.
Non lessi neanche “Canale Mussolini”.
Vorrei chiedere a WM1 la ragione (ove fosse) di non aver tenuto presente l apporto del Pennacchi alla ricostruzione storica dell architettura del ventennio.
Alcune cose non mi convinsero e com l occasione spero di chiarirmi le idee
Con sincera stima.
:)
Saranno stati divertenti gli aneddoti e brillante lo stile (scrive bene, su questo non ci sono dubbi), ma per quanto riguarda interpretazione e ideologia, in quel libro non c’è quasi nulla che non si potesse già leggere durante il ventennio. Ci sono tutti gli stereotipi sulla “socializzazione” fascista, sul fascismo come regime anticapitalista (!) e «terza via tra socialdemocrazia e bolscevismo», sull’«assalto al latifondo», sull’originalità dell’architettura “fascista”, sulle bonifiche pontine come straordinaria epopea. Quando poi si sposta sul confine orientale, ci sono tutte le consuete bufale sulle foibe, e le pezze d’appoggio sono Petacco e addirittura Papo. In pratica, tutto quello che in quest’inchiesta e nel lavoro di anni – nostro e di Nicoletta Bourbaki – stiamo lavorando a smontare. Ma non c’era bisogno di citare proprio quel libro, perché appunto il suo contenuto è “patrimonio” diffuso, inoltre non mi interessano le polemiche dirette tra scrittori.
Aggiungo che proprio la storia del basso ferrarese / Delta del Po, che sto ricostruendo per il mio prossimo progetto geografico-letterario (dopo il romanzo che sto scrivendo e uscirà nel 2019) mostra la realtà delle politiche agrarie fasciste – e la continuità delle bonifiche fasciste con tutte le bonifiche precedenti – dietro la vuota retorica sulla «terra ai contadini» e sulle grandi opere di “socializzazione”.
Innanzitutto, mostra non solo che in Italia le bonifiche si sono sempre fatte, ma che proprio nella zona dove la bonifica è stata più estesa ed estrema (il basso ferrarese è sotto il livello del mare ed è un territorio interamente artificiale), quelle del fascismo sono poca roba. Nonostante quel che si vede nei cinegiornali Luce, nel basso ferrarese il ventennio fascista fu il periodo in cui si bonificò di meno: soltanto 20.000 ettari, contro i 30.000 di Alfonso II nel XVI secolo (con le inesistenti tecnologie dell’epoca!), i 68.000 di fine XIX secolo e i 27.000 dopo il 1945.
I pochi appoderamenti del periodo fascista hanno lasciato tracce identificabili, ma spiccano, a riprova che sono rare. Le “possessioni” degli anni Trenta, costruite seguendo i dettami dell’architettura rurale del periodo, si contano sulle dita, mentre le cosiddette “case dell’Ente” (gli appoderamenti della riforma agraria del dopoguerra) sono ovunque.
La colonizzazione rurale fascista veniva annunciata con le fanfare, ma era di facciata. Nelle zone della bonifica ferrarese continuò a dominare il latifondo. Nell’immediato dopoguerra, 22 grandi proprietari possedevano 71.900 ettari di terra. Il fascismo la «terra ai contadini» si guardò bene dal darla.
E non vale il discorso: il fascismo non ha avuto il tempo di disgregare il latifondo, e se non ci fosse stata la guerra ecc. ecc. Questa è solo una variante della pseudoargomentazione «che bello sarebbe stato il fascismo se non avesse fatto le leggi razziali e la guerra». Se non avesse fatto le leggi razziali e la guerra, non sarebbe stato il fascismo. Infatti la guerra ha cominciato a farla subito (“riconquista della Libia”, 1923-1931, con annessi lager e genocidio) e altrettanto presto ha cominciato a fare leggi razziali (italianizzazione forzata di Venezia Giulia e Alto Adige, e anche le leggi razziali nelle colonie africane precedono quelle del ’38 contro gli ebrei).
Sulle bonifiche (pre-Mussolini) fatte in Italia nel periodo che precede di poco l’avvento del fascismo, è molto interessante il romanzo-trilogia di Valerio Evangelisti *Il Sol dell’avvenire*. Qui i dettagli:
https://www.ibs.it/vivere-lavorando-o-morire-combattendo-libro-valerio-evangelisti/e/9788804644088
[…] cecità intermittente. Se il presidente del parlamento europeo Tajani sfida il buon senso ripetendo la fesseria su Mussolini che avrebbe fatto “anche cose buone” la vergogna da parte italiana è quasi assente. Nelle sedi europee si chiedono le sue dimissioni, […]
[…] Tu in Cent’anni a Nordest, e anche in articoli più recenti, parli molto della necessità di ricontestualizzare i segni fisici del passato fascista – l’architettura, le statue del regime… Cosa fare con questo materiale? È una […]
[…] 6. Il metodo e il (de)merito 7. Generatore automatico di clichés «post-antifascisti» […]