
[Negli anni dal 2001 al 2008, in aggiunta a Giap, curavamo una newsletter semestrale, che spedivamo a giugno e a dicembre, cripticamente battezzata Nandropausa. Era un bollettino interamente composto da recensioni; parlavamo, insomma, dei libri che ci erano piaciuti nei mesi precedenti.
Andrea Camilleri fu uno dei nomi più ricorrenti. Tra il 2003 e il 2007 recensimmo La presa di Macallè, Privo di titolo, Le pecore e il pastore, Maruzza Musumeci, Voi non sapete e la lunga monografia curata da Gianni Bonina Il carico da undici, poi ripubblicata col titolo Tutto Camilleri.
Programmaticamente, non recensivamo – anzi, nemmeno leggevamo – i romanzi della serie di Montalbano, perché, allora come oggi, pensavamo che il Camilleri interessante fosse quello dell’altra produzione.
Come tributo all’esimio collega appena scomparso, abbiamo raccolto quelle recensioni, e le riproponiamo qui sotto. Buone letture. WM]
Da Nandropausa n. 5, 3 dicembre 2003:
 Andrea Camilleri, La presa di Macallè, Sellerio, Palermo 2003
Andrea Camilleri, La presa di Macallè, Sellerio, Palermo 2003
Questo è il libro di Camilleri più frainteso da critica e pubblico, nondimeno è il suo capolavoro. Premetto che di Camilleri mi piacciono molto i romanzi storici, vale a dire quelli senza Montalbano – come La concessione del telefono, La mossa del cavallo, La scomparsa di Patò, Il re di Girgenti… –, mentre accolgo con freddezza i vari ladri di merendine etc. che trovo zuppi del peggior “sbirrobuonismo”.
Posso capire perché La presa di Macallè non stia piacendo granché ai fans del commissario: qui di buonismo ce n’è poco. Quanto ai critici, questo romanzo comunica alcune verità talmente disturbanti da mettere in crisi qualunque professionista dell’informazione – ancorché “culturale” –, perché brucia decametri di coda di paglia. Difficile recensire con lucidità mentre hai il fuoco al culo.
Durante un’avventura imperialista del nostro paese, che i funzionari di regime seguono piantando bandierine sulla carta geografica, capita che i perfidi colonizzandi accoppino un po’ di aspiranti colonizzatori. A casa, la notizia suscita stupore, e produce un’orgia di retorica stracciona sulla Patria, propaganda sulla nostra «missione», cerimonie e coreografie demenziali, una delle quali viene appropriatamente definita «una minchiata sullenne» dal padre di un caduto. In quest’opera di mistificazione si distinguono diversi esponenti del clero, che giustificano l’ideologia guerrafondaia ammantandola dei simboli della fede cristiana, in una perfetta sovrapponibilità di Chiesa e Regime.
Vi ricorda qualcosa?
Il culto dei «caduti per la Patria», servito a botta calda, è sempre un tentativo di ri-creare un’immagine idealizzata della guerra dopo che quest’ultima ha mostrato il suo vero volto e ha prodotto dei lutti. Il culto dei caduti interviene dopo che la realtà ha smentito la propaganda, serve a riconciliare i due aspetti scissi dell’esperienza della guerra, l’aspetto fru-fru e irresponsabile della retorica «civilizzatrice» – «andremo a fare del bene»; «non ci sono pericoli per i nostri ragazzi»; «bisogna contribuire a ricostruire il paese» – e l’aspetto sangue e merda.
È comunque un equilibrio precario, una miscela instabile: col passare del tempo, l’aspetto sangue e merda prevale, aumentano le famiglie direttamente colpite dai lutti, e il culto dei caduti si rovescia e trasforma in aperto rifiuto della guerra, come accadde con la seconda guerra mondiale e con la guerra in Vietnam, e come sta accadendo negli USA della «guerra preventiva». Negli States è talmenta alta la probabilità che un funerale di stato si trasformi in cassa di risonanza per il dissenso, che le esequie si tengono in camera caritatis, con divieto d’accesso ai giornalisti.
Camilleri ha scritto il suo romanzo diversi mesi prima dell’attentato di Nassiryah, ma l’invasione dell’Iraq era già iniziata. Tutti i romanzi “storici” parlano dell’oggi, è cosa risaputa. Sovente la cosa non è intenzionale: è che mentre raccontano, gli scrittori assorbono ciò che accade intorno a loro, lo rielaborano e ce lo restituiscono sotto un’altra forma.
La presa di Macallè, tragicomica storia di un piccolo balilla inconsapevole della propria nerchia gigante, si svolge nel 1935 (a cavallo degli anni XII e XIII dell’Era Fascista) e narra la cialtronaggine, il conformismo, l’immensa idiozia di un regime di ominicchi. Michelino viene sballottato qua e là da una propaganda contraddittoria e una catechesi che sarebbe eufemistico definire squallida, impara a odiare i comunisti senza nemmeno sapere che siano – «sono come animali» , gli viene detto –, è circondato da apparati di repressione sessuale che pervertono il desiderio, assiste più volte alla «scena primaria» freudiana (padre e madre che chiavano) senza capirci niente, lo prende nel culo da un educatore pensando si tratti di un «rito spartano» (e «gli spartani erano i fascisti dell’antichità»)… Insomma, viene inesorabilmente trasformato in una macchina assassina, senza che nessun adulto si renda davvero conto dell’influenza terribile che sta avendo su di lui. L’indottrinamento avrà inattesi effetti boomerang. Un romanzo de-va-stan-te. Unica avvertenza: non leggete il testo nel risvolto prima di leggere il libro: sembra concepito per indorare la pillola ai montalbaniani, e dice al contempo troppo e troppo poco. (WM1)
L’ultimo titolo dell’autore italiano vivente forse più letto e amato è destinato a suscitare controversie, perché è tutt’altro che un libro facile o in qualche modo consolatorio. Stigmatizza anzi con ferocia i caratteri ipocriti e mostruosi che la società italiana trascina con sé da lunghissimi decenni. Non c’è nessuna oleografia: la Sicilia dell’epoca è un luogo irredimibile, così come dovette apparire agli occhi di Camilleri bambino, un inferno in cui fascismo e cattolicesimo sono assolutamente sovrapponibili, sono la stessa cosa. Mio padre, classe 1930, mi racconta sempre che, intorno ai sette-otto anni, la sua percezione e quella dei coetanei era che il fascismo fosse sempre esistito. Qui la durezza totalitaria, selvaggia del fascismo balza agli occhi in tutta la sua stupida ferocia: i bambini credevano che Mussolini fosse un essere più che umano e che il fascismo fosse sempre esistito, quale condizione naturale della società. Un libro grottesco, duro, amaro e, purtroppo, preveggente. L’atmosfera mefitica della Vigata del ventennio è troppo simile a quella che grava sull’intero paese in questi tempi infausti. (WM5)
Io non ce l’ho con Montalbano. Non mi piacciono gli sbirri buoni, certo, ma non mi piacciono neppure i lettori snob. È solo che Camilleri – come Massimo Carlotto in Arrivederci amore ciao –non appena si prende una vacanza dal suo personaggio seriale finisce col regalarti un capolavoro. Senza mezzi termini. Un capolavoro si riconosce dal suo essere inimitabile e un romanzo così, in Italia, non poteva che scriverlo Camilleri.
Così come? Così: con la solita voce da cantastorie siculo, la consueta ironia, le situazioni da sganasciarsi, il tono leggero eppure con contenuti durissimi, radicali, neri come in nessuno degli strombazzatissimi noir degli ultimi tempi. Per i veri amanti del genere, tra Macallè e Montalbano, non ci può essere storia. Un romanzo implacabile sul potere disumano – anti-umano verrebbe da dire – di un certo cristianesimo, sugli orrori della propaganda, sullo schifo dello scontro di civiltà, l’abiezione dell’indottrinamento, la mania di infilarsi l’elmetto e dimenticarsi fuori il cervello. E tutto questo senza mai abbandonare quello strano sorriso, a volte carnascialesco, a volte sardonico, a volte sarcastico. Ma sempre, e comunque, impeccabile. (WM2)
⁂
Da Nandropausa n.8, 21 giugno 2005:
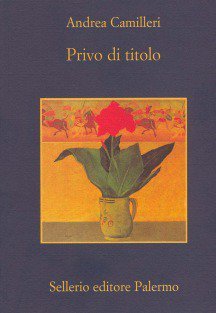 Andrea Camilleri, Privo di titolo, Sellerio, Palermo 2005
Andrea Camilleri, Privo di titolo, Sellerio, Palermo 2005
Su Nandropausa #5, sfidando l’opinione di molti, definimmo La presa di Macallè il miglior romanzo di Camilleri. In realtà no, lo definimmo «capolavoro», ma nel frattempo è diventata parola-tabù, pare non sia fine dire che un romanzo italiano è «la migliore opera di un artista» (Zingarelli, def. 1), «opera eccellente nel suo genere» (Zingarelli def. 2), «manufatto eseguito da un operaio o da un artigiano per dimostrare il grado di abilità raggiunto […]» (Zingarelli, def. 3).
Perdipiù, a tanti quel libro non piacque: troppo duro, nero nero, scabroso, scritto in una lingua irta di spuntoni. Libro acre, di un maturo che pareva acerbo, e ai lati della lingua sentivi pizzicore. Metteva insieme fascismo e sessualità dei bambini, fallocrazia e pedagogia “spartana”, carne e metallo (come nel ciclo western di Evangelisti)… Reich e Collodi.
Il cazzo duro di Michilino è un rovesciamento del naso lungo di Pinocchio: è enfio delle bugie altrui, corpo cavernoso irrorato col sangue sparso dal regime, non a caso Michilino si eccita della propria fede fascistissima e ha nerbute erezioni ascoltando i discorsi del Duce alla radio. Delle donne gli frega quel poco, si chiava la cugina più grande ma non sente quasi niente. Intanto, lo prende nel culo dal precettore. Il tutto sullo sfondo della guerra d’Etiopia, quella degli attacchi coi gas tossici, degli sterminii. Chiaro che ‘sta roba sia parsa eccessiva agli spettatori delle fiction montalbaniane con Zingaretti.
Molti, poi, non hanno capito che quel romanzo parlava di oggi. Usare la narrativa per strappare o almeno smagliare il tessuto di balle e mezze verità dei poteri, dare sepoltura ai miti marciti in terra sconsacrata.
Privo di titolo – romanzo che ha fatto incazzare diversi esponenti di AN – è il capitolo successivo, l’indagine continua.
Negli ultimi decenni, l’immagine del fascismo come figlio dell’Italietta che tira a campare, regimetto velleitario in fondo meno peggio di altri che gli furono coevi, e a tratti persino meritevole di gratitudine – le bonifiche ecc. – è servita a rendere opaco il quadro, a sminuire i crimini contro l’umanità perpetrati da Mussolini e i suoi scherani. Se il fascismo era ridicolo e kitsch, con quella mania dell’antica romanità, suvvìa, non poteva essere tanto pericoloso, questa è materia da barzellette. Il Duce era soprattutto uno che gli piaceva la gnocca e aveva trovato un modo per farsene a vagoni, poi ha dato retta a Hitler e s’è fatto strascinare in una cosa più grande di lui, ma vabbe’, chi è senza peccato scagli la prima pietra, c’era mica bisogno d’infierire a quel modo, in Piazzale Loreto…
Camilleri ha la capacità di infilare la penna nelle pieghe della quotidianità fascista, e dimostrare in modo impietoso che queste sono abnormi cazzate. La cialtroneria e il velleitarismo, il kitsch e la mancanza di senso del ridicolo sono elementi tipici di ogni regime, e più in generale del populismo all’italiana. È la nostra borghesia a essere cialtrona, ignorante, velleitaria e kitsch. Tutto ciò non ridimensiona affatto le vessazioni, i soprusi, la violenza criminale: rende anzi il tutto più odioso.
Quale migliore esempio del culto per il «primo martire fascista» Gattuso/Grattuso? La turpe realtà di una spedizione squadristica viene rovesciata nella costruzione mitica a cui partecipano tutti i poteri costituiti, l’aggressore diventa vittima, la vera vittima diventa capro espiatorio, e parte l’orgia kitsch di processioni, parate, vaneggiamenti toponomastici, monumenti inaugurati.
La vicenda s’incrocia con quella di Mussolinia, città mai esistita se non in fotomontaggi, della quale il Duce posa la prima – e unica – pietra, durante una visita in Sicilia fatta in prescia e di malavoglia. In realtà Achille St@race – segretario del PNF e definito dallo stesso Duce «un cretino ubbidiente» – raccomandava alla stampa di non usare mai l’espressione «la posa della prima pietra», tipica dell’Italia prefascista: il fascismo non posa la prima pietra, ma dà «il primo colpo di piccone: annunzio dinamico e concreto» (disposizione del 24 settembre 1938).
Bene, ecco il nostro annunzio dinamico e concreto: questo di Camilleri è un gran bel colpo di piccone, e da solo manda in pezzi l’edificio del «martirio fascista». [WM1]
Non credevo che Camilleri sarebbe riuscito a fare un bis altrettanto potente. Invece dopo La presa di Macallè ci regala un altro squarcio sulla Sicilia degli anni Venti/Trenta, se possibile ancor più esilarante e violento. Ripescare storie di quella terra e di quel periodo – il fascismo colto alle origini, nel passaggio da movimento a partito, e dall’opposizione al governo – ha un senso ben preciso ed evidente. Quella terra quasi africana, dove iniziano le carriere di gerarchetti ridicoli e arraffoni, pronti alla scalata ai ranghi del regime, non è altro che l’Italia di oggi. Una nazione da operetta con il finale tragico (ma non serio), fottuta da un tipetto pelato e dalla sua corte di scherani cialtroni, con la stolta complicità di mezzo paese e forse più. E’ la storia che si ripete in farsa.
Leggendo Privo di titolo è facile ridere forte e ridere amaro. Ma soprattutto si volta l’ultima pagina con la sensazione che per impedire certe coazioni a ripetere c’è ancora uno sforzo improbo da compiere. Qualcosa di talmente radicale da estirpare appunto una radice antica e profonda, ben salda nel dna culturale di questo paese. Ci vuole il coraggio di voltarsi indietro e da quel baratro riesumare storie dimenticate, piccole o grandi, che sbattano in faccia al presente la sua miseria. Camilleri è uno di quelli che ci riesce, con una leggerezza e un’ironia rare, soprattutto perché sono tempi in cui è difficile mantenere l’una e l’altra. E regolarmente ci lascia con la voglia di leggere il suo prossimo romanzo. [WM4]
Per non lasciarmi andare a lodi sperticate dirò subito quello che non mi è piaciuto del tutto nell’ultimo Camilleri. Mentre La presa di Macallè piegava la lingua camilleriana a esigenze introspettive, psicanalitiche, profonde e carnali, e rendeva alla perfezione una delle preoccupazioni del libro – il ghetto dell’universo infantile, che è costruzione ideologica degli adulti, è un luogo eminentemente tragico –, il metasiciliano di queste pagine appare alle volte limitato, quasi stereotipato. Ma queste sono stantìe preoccupazioni da addetto ai lavori: è che la vicenda di Privo di Titolo è tutta pubblica, e Camilleri è in grado come sempre di inanellare una sfilza di caratteri e personaggi vividi ed esemplari. Nella notte del senso che questo paese sta attraversando, le scelte dell’ultimo Camilleri appaiono in netta controtendenza. L’idiozia, la violenza, la mistificazione che regnano sovrane nella Sicilia del ventennio parlano, ancora una volta e con tutta evidenza, dell’oggi. [WM5]
⁂
Da Nandropausa n.13, 13 dicembre 2007:
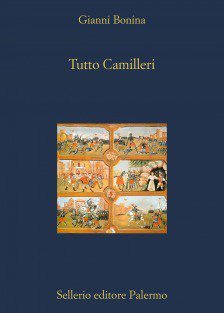 Andrea Camilleri, Maruzza Musumeci, Sellerio, 2007
Andrea Camilleri, Maruzza Musumeci, Sellerio, 2007
+ Gianni Bonina, Il carico da undici, Barbera, 2007
Andrea Camilleri, Le pecore e il pastore, Sellerio, 2007
Andrea Camilleri, Voi non sapete, Mondadori, 2007
Qualche sera fa leggevo il gigantico saggio su Camilleri scritto da Gianni Bonina, Il carico da undici. Le carte di Andrea Camilleri [poi ripubblicato come Tutto Camilleri, N.d.R.], acquisto obbligato per chiunque sia interessato all’opera dell’autore di Porto Empedocle. La sezione centrale del libro è occupata da una lunga, lunghissima intervista a Camilleri. A un certo punto si giunge a parlare de La presa di Macallè, e il maestro dice:
«Qualcuno l’ha preso per un romanzetto erotico, anzi c’è stato chi l’ha addirittura classificato come pornografico. Una cantonata inspiegabile o troppo facilmente spiegabile. Ne sono rimasto, lo confesso, profondamente offeso. Per fortuna altri, sebbene pochi, l’hanno letto nel modo giusto: i Wu Ming, Grimaldi…» (p. 385)
E’ una grossa soddisfazione vedere che Camilleri ritiene il nostro il “modo giusto” di leggere uno dei suoi libri più importanti, forse il meno compreso, o compreso fin troppo bene e dunque scuncicato.
Camilleri è un autore necessario. Presto o tardi, chiunque in Italia si occupi di narrazione con serietà – ergo non-seriosità – dovrà fare i conti con quanto Camilleri ha realizzato: dedicarsi alla sperimentazione – anche dura – nella lingua e nella struttura narrativa ottenendo però un enorme, quasi osceno, priapesco successo di vendite, per giunta trattando temi incomodi, politicamente incandescenti.
Sono d’accordo con Bonina: nello sperimentare, Camilleri – «a stare ai risultati utili» – è andato «oltre il Gruppo 63». Di fronte al paragone – che può stupire, anzi, sicuramente stupirà chi non abbia presente il corpus delle opere camilleriane – il maestro si schermisce tanticchia – lo fa spesso, lungo il corso dell’intervista – e precisa:
«Piano, piano. Io ai lettori ci tengo e non faccio niente che non capiscano. Il massimo mio azzardo – e sapevo che avrebbe avuto reazioni negative – è stato La presa di Macallè, ma riguardava i contenuti e non il linguaggio.» (p. 460).
Affermazione curiosa, da parte di uno scrittore che ne La mossa del cavallo scatena flussi di coscienza in un genovese impervio e stretto, senza fornire al lettore il minimo appiglio; ne Il re di Girgenti crea impasti lessicali siculo-ispanici e seicenteschi; ne La scomparsa di Patò trascina grafica e impaginazione all’interno della sintassi del testo, come elementi passibili di analisi logica; in Privo di titolo tratta alcuni capitoli come fossero filmati visti alla moviola; infine, proprio ne La presa di Macallè, percuote e catamina l’italo-agrigentino, lo arrisacca fino a renderlo quasi inintelligibile. Quasi.
Da notare che non ho nominato nessuno dei romanzi con protagonista Montalbano. Ritengo che i libri di Camilleri più interessanti siano quelli esterni alla serie. Montalbano, col suo grande appeal commerciale, svolge il compito di garante della pubblicazione degli altri libri, che a loro volta entrano in classifica, e a buon diritto. Lo ha già detto qualcuno: con Montalbano Camilleri fa solo sesso, cose vastase; con gli altri libri è vero amore.
Il 2007 è stato un anno di intensa prisenza camilleriana nelle top charts e nelle polemiche. Oltre ai tre libri di cui sto per parlare – e al già citato lavoro critico di Bonina – sono usciti il Montalbano de La pista di sabbia, l’apocrifo caravaggesco Il colore del sole e un’antologia di Pirandello a cura di. Un’offensiva militare su larga scala con cinque (sei) libri che più diversi non potrebbero essere. Un’impresa che nessun altro autore sarebbe libero non dico di tentare, ma nemmeno di pensare. Noialtri WM nel 2008 avremo quattro uscite in libreria, ma al confronto di Camilleri siam poveri dilettanti.
 ■ Nel marzo scorso il «saggio narrato» Le pecore e il pastore ha mandato su tutte le furie Santa Romana Chiesa, piazzando la lente d’ingrandimento sopra un certo fatterello, rivelando che appena ieri (1945) membri del clero regolare di questo paese organizzarono un sacrificio umano, nel caso specifico un suicidio collettivo. Le suore di un convento di clausura chiesero e credettero di ottenere da Dio uno scambio: anziché prendersi la vita di un VIP della gerarchia ecclesiastica, il Padreterno fu persuaso ad “accontentarsi” delle vite di dieci monache, assistite fino alla morte in un digiuno a oltranza, niente cibo né acqua. Il personaggio da salvare era il vescovo di Agrigento Giovanni Battista Peruzzo, in agonia dopo un attentato, e ignaro dell’iniziativa delle suore.
■ Nel marzo scorso il «saggio narrato» Le pecore e il pastore ha mandato su tutte le furie Santa Romana Chiesa, piazzando la lente d’ingrandimento sopra un certo fatterello, rivelando che appena ieri (1945) membri del clero regolare di questo paese organizzarono un sacrificio umano, nel caso specifico un suicidio collettivo. Le suore di un convento di clausura chiesero e credettero di ottenere da Dio uno scambio: anziché prendersi la vita di un VIP della gerarchia ecclesiastica, il Padreterno fu persuaso ad “accontentarsi” delle vite di dieci monache, assistite fino alla morte in un digiuno a oltranza, niente cibo né acqua. Il personaggio da salvare era il vescovo di Agrigento Giovanni Battista Peruzzo, in agonia dopo un attentato, e ignaro dell’iniziativa delle suore.
Quante anime di femmine servono per il controvalore di quella di un maschio? Il rapporto è di dieci a uno, come nelle rappresaglie naziste. L’orrido episodio incapsula e illumina l’ipocrisia, l’ignoranza superstiziosa, la tracotanza ideologica e il cancrenoso sessismo del clericalismo di ieri e di oggi. Camilleri ha scritto il libro nei giorni della persecuzione congiunta Stato/Chiesa nei confronti di Piergiorgio Welby, con tutte le ramanzine sulla «santità della vita», sul fatto che «nessuno è padrone della propria morte», sul «laicismo che pretende di sostituirsi a Dio» etc.
Chiaro, un libro da solo non cambia nulla, ma è stato bello vedere i ratzisti aggiarniare, scantarsi, sdunare e acchianari mura lisci pur di negare l’accaduto.
Pochi mesi più tardi, lo storico Sergio Luzzatto ha mandato in libreria la sua inchiesta storica su Padre Pio (a.k.a. l’uomo dell’acido fenico) e lo spettacolino di cabaret inquisitorio si è trasformato in una Woodstock di isteria, sputazza e minacce di morte.
Bisogna continuare, infilare non un dito ma entrambe le mani nelle piaghe della devastazione culturale operata in Italia da stregoni, baciapile e comitati di catto-affari. La protervia di costoro ha da tempo ri-superato ogni livello di guardia.
 ■ Dopo l’estate è arrivato in libreria Voi non sapete, vocabolario ragionato dei pizzini di Bernardo Provenzano.
■ Dopo l’estate è arrivato in libreria Voi non sapete, vocabolario ragionato dei pizzini di Bernardo Provenzano.
Camilleri ha già dimostrato diverse volte di saper trarre il meglio dall’ordine alfabetico (cfr. il glossario in appendice a Un filo di fumo; la raccolta di proverbi Il gioco della mosca; il dizionario di aneddoti teatrali Le parole raccontate). Tra epifanie, sparizioni, allusioni stratificate, morti finte, malattie vere, degenze clandestine e costruzioni sintattiche di ultra-avanguardia – in realtà di estrema retroguardia ma è la stessa cosa, basta invertire la direzione –, in Voi non sapete Camilleri ricostruisce il mondo di Provenzano, contesto socio-linguistico in cui l’esortazione «Ditemi se andiamo incontro a un Santo Natale» ha un obliquo significato di minaccia.
Quella dei «portapizzini» è una rete di comunicazione intricata e sofisticata, intercettabile a fatica, inoltre ciascun biglietto da o verso Provenzano è linkato per vie dirette o traverse a tutti gli altri, è un grande ipertesto cartaceo, un wiki mafioso i cui autori sono nascosti dietro cifre ancora misteriose. Camilleri riprende le intuizioni e analisi di Palazzolo e Prestipino, autori del saggio Il codice Provenzano (Laterza, 2007), e le rielabora inserendo arregordi personali, piccole arguzie e stratagemmi da grande divulgatore e narratore popolare. Preso da solo, Voi non sapete non è certo uno dei Camilleri imprescindibili, eppure nel contesto della sua opera svolge un ruolo preciso e ha una collocazione meno periferica di quel che sembra.
Nemmeno qui mancano stoccate al clero: Camilleri ricorda che il cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo dal 1946 al 1967, sostenne più volte che la mafia non esisteva ed era soltanto una malvagia invenzione dei comunisti. Compaiono macari preti e frati: confessano i latitanti e talora li nascondono, coprono le fughe, cancellano le tracce. Per approfondimenti rimando alle voci «Gesù Cristo», «Preti» e «Religiosità».
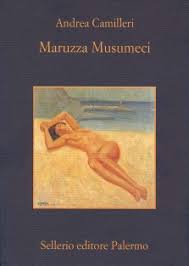 ■ Con Maruzza Musumeci, l’ex-regista teatrale e televisivo propone ai lettori una delle sue operazioni più estreme sotto gli aspetti stilistico, linguistico e macari tematico, un convinto sfondamento nel visionario, nel mitologico e nel soprannaturale.
■ Con Maruzza Musumeci, l’ex-regista teatrale e televisivo propone ai lettori una delle sue operazioni più estreme sotto gli aspetti stilistico, linguistico e macari tematico, un convinto sfondamento nel visionario, nel mitologico e nel soprannaturale.
In una lingua agrigentina carica di arcaismi, Camilleri racconta la storia di Gnazio Manisco, emigrante a New York che torna a Vigàta a fine Ottocento e compra un terreno, lingua di terra che si protende nel mare e si chiama Contrada Ninfa. Lì si mette di buona lena: rende la terra coltivabile, compra animali e, davanti a un ulivo millenario, si costruisce d’intuito una casa che sarà per lunghi anni un work in progress, fatta di cammare cubiche di tri metri per tri accostate o sovrapposte l’una all’altra. La casa dà le spalle al mare, e anche gli arboli del campo ammucciano la vista del mare. Il mare è a pochi metri ma non si vede. Perfetto, perché Gnazio è talassofobico, lo scanta l’acqua salata, e anche quando ha attraversato l’Atlantico – andata e ritorno – non è mai uscito da sottocoperta.
Viene il giorno che, passati da un pezzo i quaranta, Gnazio decide di prender moglie. Poiché non canosce fimmine, si rivolge alla Gna’ Pina, guaritrice che ambula con un sacco pieno d’erbe e rimedi naturali. Grazie a questa mezzanìa, Gnazio canoscerà la bellissima Maruzza Musumeci e la sua inquietante bisnonna, Minica, anzianissima eppure atletica e dalla voce arrapante.
Maruzza e Minica hanno sembianza di donne ma sono creature anfibie, il loro lignaggio è quello delle sirene che incantarono Ulisse, tra loro parlano con versi dell’Odissea. Per perpetuare la loro specie, le sirene scelgono come sposi uomini che non vadano per mare, non abbiano interesse per il mare, non impazziscano sentendo il loro canto. Uomini che, come Gnazio, siano l’esatto contrario di Ulisse.
Gnazio non canoscerà mai fino in fondo i segreti di Maruzza, né gli interessa scoprirli. Accetta la sua donna per quel che è, con tutte le sue strane abitudini, perché gli basta il grande amore che li lega. La coppia troverà un modus vivendi e avrà dei figli. Figli che…
Libro piccolo di grande poesia, Maruzza Musumeci abita un loco che «non appartenni né alla terra né al mari, è il loco indove ponno capitare tanto le cose che capitano ‘n terra quanto le cose che capitano ‘n mari.»
L’ho letto assittato su una panchina degli Upper Barrakka Gardens, La Valletta, Malta, un’altra lingua di terra protesa nel mare, un azzurro pomeriggio di dicembre, la copertina del libro rivolta all’Europa.
Subito di fronte a me, la distesa del Mediterraneo.
Contrada Ninfa era là, cento miglia a nord-ovest, appena oltre l’orizzonte.
Caravaggio aveva coperto la distanza in dieci giorni, quattrocent’anni prima.
Ma questo è già un altro libro di Camilleri, e non l’ho ancora letto. [WM1]

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
