
[In questo «Friday for Future», vogliamo ricordare che in Italia c’è una lotta ambientale, quella No Tav, che ha pagato – e sta pagando – la propria coerenza e radicalità con quasi duemila indagati, valanghe di arresti e misure restrittive (ad esempio i fogli di via) e centinaia di anni di carcere irrogati in decine e decine di processi.
Processi, va sempre fatto notare, istruiti e giunti a sentenza in pochi mesi, mentre i procedimenti aperti per le violenze delle forze dell’ordine si perdevano in un porto delle nebbie, come si vede nel documentario Archiviato narrato da Elio Germano.
L’ultimissimo, paradigmatico sviluppo in ordine di tempo: l’attivista Luca Abbà, raggiunto da una condanna per un episodio di poco conto risalente a dieci anni prima, è stato preso dai carabinieri e portato al carcere torinese delle Vallette. La richiesta di affidamento ai servizi sociali è stata respinta con motivazioni scritte che “scansionano” e giudicano il suo stile di vita, le sue idee politiche, le sue frequentazioni.
Xenia Chiaramonte si occupa di diritto e criminologia e studia da anni l’impatto tra movimenti sociali e macchina giudiziaria. Al caso No Tav ha appena dedicato un libro importante, Governare il conflitto (Meltemi, 2019). La sua tesi, corroborata da un’enorme mole di materiale documentario, è che con la repressione della lotta in Valsusa si sia imposto un nuovo modello di criminalizzazione tramite il diritto penale. Un modello che lei chiama «neopositivistico», perché risuona con teorie d’antan come quelle, famigerate ma mai davvero cadute in disuso, di Cesare Lombroso.
Con questo meccanismo potrebbero presto dover fare i conti i nuovi movimenti che agiscono dentro la crisi climatica. Anche per questo è importante capire come funziona. Abbiamo dunque chiesto a Xenia di commentare per Giap quel che sta accadendo a Luca. Buona lettura. WM]
di Xenia Chiaramonte
Torino, 4 settembre 2019: quattro giudici scansionano la forma di vita di Luca Abbà, militante No Tav, per “motivare” il regime di semilibertà cui lo sottopongono e negargli l’affidamento in prova ai servizi sociali. In altre parole, garantirgli il carcere ed escludere che meriti di vivere – così scrivono – «lontano da ogni possibilità di controllo».
È chiamata «misura alternativa al carcere», la semilibertà, ma l’aggettivo è quanto meno improprio, visto che il soggetto è comunque internato: «I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti […] e indossano abiti civili» – leggiamo nell’ordinamento penitenziario (Art.48 comma 3).
Con la condanna a solo un anno per resistenza a pubblico ufficiale, episodio risalente a dieci anni fa ,e l’assenza di precedenti penali o di processi pendenti, chiedere l’affidamento in prova – come ha fatto l’avvocato difensore Claudio Novaro –, è prassi. Per ottenerlo serve un comportamento del soggetto che lasci supporre l’utilità della misura al reinserimento sociale e l’esclusione del pericolo di recidiva; per questa valutazione va osservata la sua personalità e la condotta dopo la commissione del reato. Spesso per le decisioni favorevoli è determinante che il soggetto abbia anche un lavoro di cui vivere.
Luca Abbà risponde a tutti questi requisiti. Ma non è abbastanza, perché l’intento è quello di spulciarne la vita affettiva, controllarne i movimenti, minarne la militanza.
Il soggetto è noto. Questa è la prima cosa che leggiamo nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza torinese. Luca Abbà sarebbe un «noto esponente del» (meno noto) «movimento anarco-insurrezionalista» e «uno dei leader del movimento» (senza leader) No Tav, che è «salito alla ribalta della cronaca» – tono spregiativo evidente – nel 2012 ,per un’azione di protesta che gli stava costando la vita, le cui immagini hanno fatto il giro di tutti i media. È noto perché ce lo dicono «le informazioni inviate dalla FF.OO»: soggetto noto alle forze dell’ordine. Non ha processi in corso e nemmeno precedenti, però un motivo per punire, a ben vedere, lo si trova sempre: ha un po’ di denunce e manco troppo rassicuranti circa il rispetto dell’autorità, come un oltraggio a pubblico ufficiale.
Non basta, il sondaggio deve proseguire: sul soggetto noto va esercitata un’indiscreta volontà di sapere. Non è sufficiente quel che risulta da queste denunce, bisogna scavare nella sua vita privata per cercare gli indicatori, gli indizi di una delinquenza tale che, al minimo, necessiti di un raddrizzamento in regime di semilibertà. «Il soggetto vive con la moglie» che ha «anche lei precedenti di polizia»; e poi – atroce dubbio del giudice – avrà o meno una condizione familiare adeguata, rispettabile, pacifica? Come stanno marito e moglie? Come funziona il regime della loro «abitazione coniugale»? Il figlio come lo mantengono?
Il condannato ha un lavoro? Ma che lavoro è quello di uno che «ricava ortaggi, foraggio e legna» che poi vende al mercato? Non va bene per un affidamento, ci vuole al minimo la semilibertà.
Il diritto penale si fonderebbe sulle azioni compiute dai soggetti, non sulla loro forma di vita o sulle loro idee. Non si punisce uno perché sogna di uccidere un altro, ma se e quando lo fa o tenta di farlo. La civiltà giuridica si basa su questo equilibro fra la libertà delle persone e l’autorità che detiene il potere punitivo. Non si può punire a piacimento.
Luca ha un’attività lavorativa, e questo fino a un certo punto va bene; è apprezzabile che un soggetto noto per condurre una vita di questo tipo non sia un perfetto sfaticato – si nota nell’ordinanza. Ma non basta, perché «lo stile di vita» del soggetto non può comunque andare bene. Pensate un po’, c’è scritto che il suo stile di vita «pur caratterizzato dallo svolgimento di attività di lavoro, pare contrassegnato dalla attiva adesione a movimenti ideologici che propugnano le loro convinzioni con mezzi e modalità non sempre leciti e pacifici».
Il domicilio di Luca Abbà è in Val di Susa ed è troppo vicino al cantiere in Val Clarea, quindi a potenziali scontri, ad azioni di lotta, al pericolo che le frequentazioni del condannato siano pericolose. Tornerebbe a frequentare amici inadatti, che delinquono, o che potenzialmente possono farlo, in un ambiente favorevole: una rieducazione sembra difficile e il pericolo che commetta ancora reati è elevato. Neanche la detenzione domiciliare è pensabile. Sarebbe sempre troppo poco per un soggetto che non dà avvisaglie di redenzione.
Insomma, il risultato è che per un reato del 2009, che nulla c’entra col movimento No Tav, si punisce un soggetto pericoloso con una misura “alternativa” alla detenzione, resa necessaria dalla sua partecipazione convinta e attiva al movimento No Tav.
Per di più le denunce che seguono a quel 2009 darebbero la prova che il soggetto appartiene alle «frange estremiste» del movimento. Dovrebbe tagliare i ponti con gli altri militanti e con la lotta stessa, se volesse meritarsi una misura meno afflittiva. Sta di fatto che «non ha mai rescisso il suo legame con i personaggi e con l’ideologia all’origine della sua condotta illecita».
L’unica soluzione possibile, allora, è la misura della semilibertà – scrivono questi giudici – perché
«[prevede] in modo preciso le ore da dedicare all’attività di lavoro (controllabile attraverso l’uso del cellulare e della geolocalizzazione) e quelle eventualmente da dedicare alla coltivazione delle relazioni familiari (…) inserendo specifici divieti in ordine alla possibilità di movimento dall’abitazione durante le giornate non lavorative o in occasione di manifestazioni, cortei e proteste».
Proviamo a capire cosa c’è in ballo in una decisione giudiziale di questo tenore.
Innanzitutto, neanche un liberale riuscirebbe a trovarvi indizi di imparzialità. Si fa sempre più chiaro che a essere ideologica è proprio questa magistratura che si ammanta di imparzialità. È del tutto ideologico – oltre che aberrante – dire che qualcuno va punito per la sua ideologia e al contempo imporgliene, con la violenza di una maggiore restrizione, un’altra, basata sul controllo del corpo, il lavoro, e pure il divieto di manifestare.
Il controllo sul corpo è un elemento che, in certo senso, torna sempre nei casi di restrizione della libertà, anche se è evidente dal passaggio sulla geolocalizzazione, che qui si tratta di usare ogni mezzo necessario a raffinare l’intento punitivo. Nelle società di controllo non si butta via niente, quindi bisogna spiare per sapere davvero dove sei e se davvero stai facendo il tuo lavoro nel preciso orario, stabilito nel programma della semilibertà. In due parole: sorvegliare e faticare.
Ma il divieto di manifestare?
Un attivista conosce perfettamente la possibilità di andare incontro a una denuncia e di vedere sanzionate le sue azioni di protesta. Lo mette in conto. Ma questo non rende ammissibile che gli si vieti di manifestare, mediante l’equazione che manifestare è uguale a delinquere. Il passaggio è cruciale.
Allora, nell’ordine: i giudici ci dicono che una misura meno afflittiva Luca Abbà non se la merita, perché non lo reinserirebbe socialmente e soprattutto non escluderebbe la recidiva, cioè la commissione di altri reati. Sul primo punto ci dicono che tanto rimane in valle, dove è già ben inserito in frequentazioni sbagliate – altri soggetti pericolosi – e quindi l’affidamento o i domiciliari sarebbero tempo perso. Il secondo punto è più sottile: ci dicono che c’è bisogno della misura più gravosa perché il soggetto protesterebbe coi No Tav, se fosse – come con le altre misure – «lontano da ogni possibilità di controllo». I giudici sostituiscono protestare con delinquere e giustificano una restrizione maggiore sulla base di questa illegittima equazione.
Persino un liberale farebbe ricorso a un puro e semplice esercizio di memoria: la Costituzione non ci garantisce ancora il diritto di riunione (art.17)?
Inoltre, non c’è un dovere di fedeltà nei confronti dell’autorità che esercita il potere punitivo.
Dal lato di chi punisce, invece, c’è la convinzione che sia legittimo obbligare alla fedeltà. Il diritto penale è usato come un’arma nella lotta che, attraverso il codice, si può condurre contro chi non rispetta non tanto le norme, quanto una silenziosa logica sottostante.
Oggi vale più di quando Foucault lo scriveva che «il problema non è tanto quello dell’obbedienza dei giudici a ciò che il potere dice: è piuttosto quello della loro conformità a ciò che il potere tace» (M. Foucault 2009 [1979b], 108).
La trasformazione della penalità, sempre più penetrante, è stata decrittata da Romano Canosa, che riguardo al concetto di ordine pubblico e di fedeltà ci avvisava quarant’anni fa:
«Ad un certo punto alla nozione paleo-liberale di ordine pubblico neutra e avalutativa comincia ad affiancarsene una alquanto diversa, non neutra, valutativa, che nel suo seno porta non solo l’elemento tradizionale del rispetto dello status quo, ma anche quella della fedeltà del cittadino al regime in cui gli accade di vivere e di partecipazione alla visione del mondo di cui questo regime è portatore. La storia del secondo dopoguerra è piena di interventi propositivi in tal senso con clausole di fedeltà implicite o esplicite, generali o particolari in quasi tutti i paesi […]. La nozione di fedeltà trascende il campo dell’ordine pubblico fino a divenire una «clausola» sottintesa a tutto l’ordinamento giuridico considerato nella sua integrità. (R. Canosa, 1981, 200)»
Penetrare nella vita delle persone è diventata prassi: le “segnalazioni” all’autorità giudiziaria sono sempre anticipate dalle «note scheda persona», in cui si descrive il «soggetto noto alle forze dell’ordine». Di I.T., ad esempio, si legge che
«mira a definire la propria ideologia, qualificandosi come “amante della libertà”, ed identificandosi nell’anarchico in continua lotta contro lo Stato e le prepotenze dei politicanti.»
Di M.M. si dice che:
«è solito partecipare attivamente alle pubbliche manifestazioni indette dal movimento anarchico anche in ambito nazionale, in occasione delle stesse è solito mostrare la propria insofferenza verso gli operatori delle forze di polizia, verso i quali rivolge insulti e gesti provocatori e tesi al dileggio.»
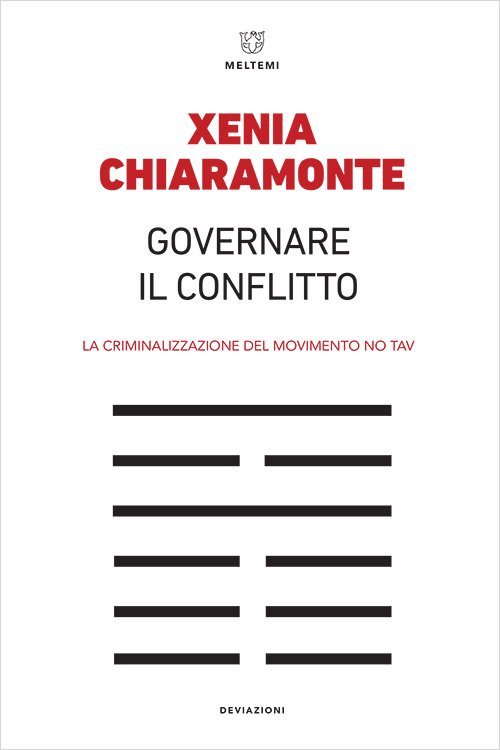 Il caso di Luca Abbà, benché singolare, non è affatto un caso singolo. Ho esplorato le dinamiche della giustizia politica, precisamente occupandomi della più cruciale criminalizzazione degli ultimi decenni, quella a carico del movimento No Tav, in un lungo lavoro di ricerca: Governare il conflitto. Lì ho mostrato la diffusione spaventosa di questo modo di fare con la legge, e cioè usarla come se fosse il manganello. Nel farlo i magistrati non sentono affatto di abusare del loro compito.
Il caso di Luca Abbà, benché singolare, non è affatto un caso singolo. Ho esplorato le dinamiche della giustizia politica, precisamente occupandomi della più cruciale criminalizzazione degli ultimi decenni, quella a carico del movimento No Tav, in un lungo lavoro di ricerca: Governare il conflitto. Lì ho mostrato la diffusione spaventosa di questo modo di fare con la legge, e cioè usarla come se fosse il manganello. Nel farlo i magistrati non sentono affatto di abusare del loro compito.
Al contrario, come colse perfettamente Claudio Novaro nell’udienza di uno dei 51 processi ai No Tav:
«tutti i soggetti interpellati hanno consapevolezza o credono di aver fatto correttamente il proprio lavoro, interpretando il proprio lavoro come contenimento, lotta e contrasto non con chi ha commesso dei reati ma contro il movimento No Tav, individuati come “persone particolarmente pericolose”. Mi sembra che questo sia in contrasto formidabile con lo statuto del diritto penale… Quello che conta non è più quello che si è fatto ma quello che si è. Sei un anarchico? Allora ti prendi 6 anni, al di là delle recidive, quello che conta è questo dato di appartenenza, del tutto incongruo rispetto alla prassi dell’attività giudiziaria (Avv. Novaro, ud. 20.01.2015).»
Questo diritto, imbracciato come fosse un’arma, non è più soltanto proprio della magistratura inquirente, dei pubblici ministeri, perché la profonda trasformazione cui stiamo assistendo fa sì che anche la magistratura giudicante veda il proprio ruolo come un ruolo di lotta, valorizzando e approvando le modalità tipiche dei pubblici ministeri.
Nel diritto penale di lotta non si tratta più di rispondere a un’azione specifica commessa personalmente da un individuo (art. 27.1 Cost.). La responsabilità penale non è più personale. Non può rimanere tale, quando l’obiettivo diventa punire il fenomeno, e non le singole azioni, come vorrebbe il diritto penale liberale.
Ho dato a questo fenomeno il nome di «neopositivismo penale». Il problema della recidiva, del soggetto pericoloso, di cui prevenire il compimento di nuovi reati, era il problema dei positivisti, Lombroso, Ferri, Garofalo… Il diritto penale assumeva una vera e propria funzione sociale. Bisognava difendere la società da questi soggetti e al contempo esercitare attraverso la pena inflitta ad alcuni un forte deterrente per gli altri, potenziali sovversivi. La recidiva era soprattutto pensata per i militanti, per coloro che si macchiavano di reati politici. Lombroso e Laschi hanno scritto un malloppo sul delitto politico, mentre Lombroso da solo si era dedicato a Gli Anarchici.
Questo diritto come lotta nasce col positivismo penale, che mette al centro della punizione proprio il soggetto delinquente, non le sue azioni, ed è per questo che ha bisogno di scandagliarne corpo e anima. Questo vale sia al singolare – sarai colpevole sempre più per ciò che sei, che incarni, che non per ciò che fai, per le tue azioni – ma vale tanto più al plurale.
L’anarchico da solo poteva di certo compiere il più grave dei delitti politici, il regicidio. Ma la verità è che, preso un anarchico, ne rimanevano comunque altri mille in giro. Allora, i giuristi positivisti, a cui servivano maglie larghe per governare il conflitto sociale, si adoperarono per trovare una soluzione giuridica al problema. Non c’era nessun intento puramente conoscitivo, c’era un progetto governamentale. Sighele si mise a lavorare alla Folla delinquente per capire come punire i gesti collettivi, che rimanevano scartati col principio della personalità della responsabilità penale di matrice liberale. Ne venne fuori un trattato in cui si sosteneva la legittimità della responsabilità collettiva.
È l’odierno concorso di persone nel reato, quello che sta alla base di tutto l’impianto del più grosso processo a carico del movimento No Tav (53 imputati), e che la Cassazione, dopo due gradi di giudizio, ha definito giuridicamente inconcepibile; sotto mentite spoglie non è nient’altro che il ritorno alla responsabilità collettiva. Il processo è tutto da rifare.
Ci troviamo davanti al monitoraggio dei comportamenti irregolari, anche se al posto del vecchio positivismo, ossessionato dalla anormalità, qui si indaga la forma di vita. Non si cercano nei crani le ragioni della delinquenza, ma nei corpi, nelle attitudini, nelle frequentazioni. Si spulcia nella storia affettiva e nella vita activa per trovare mezzi che, se non possono raddrizzare, limitino almeno le risorse principali di quella forma di vita: la libertà.
Ma questo è solo un progetto, a cui le nostre pratiche possono togliere qualunque chance di successo.

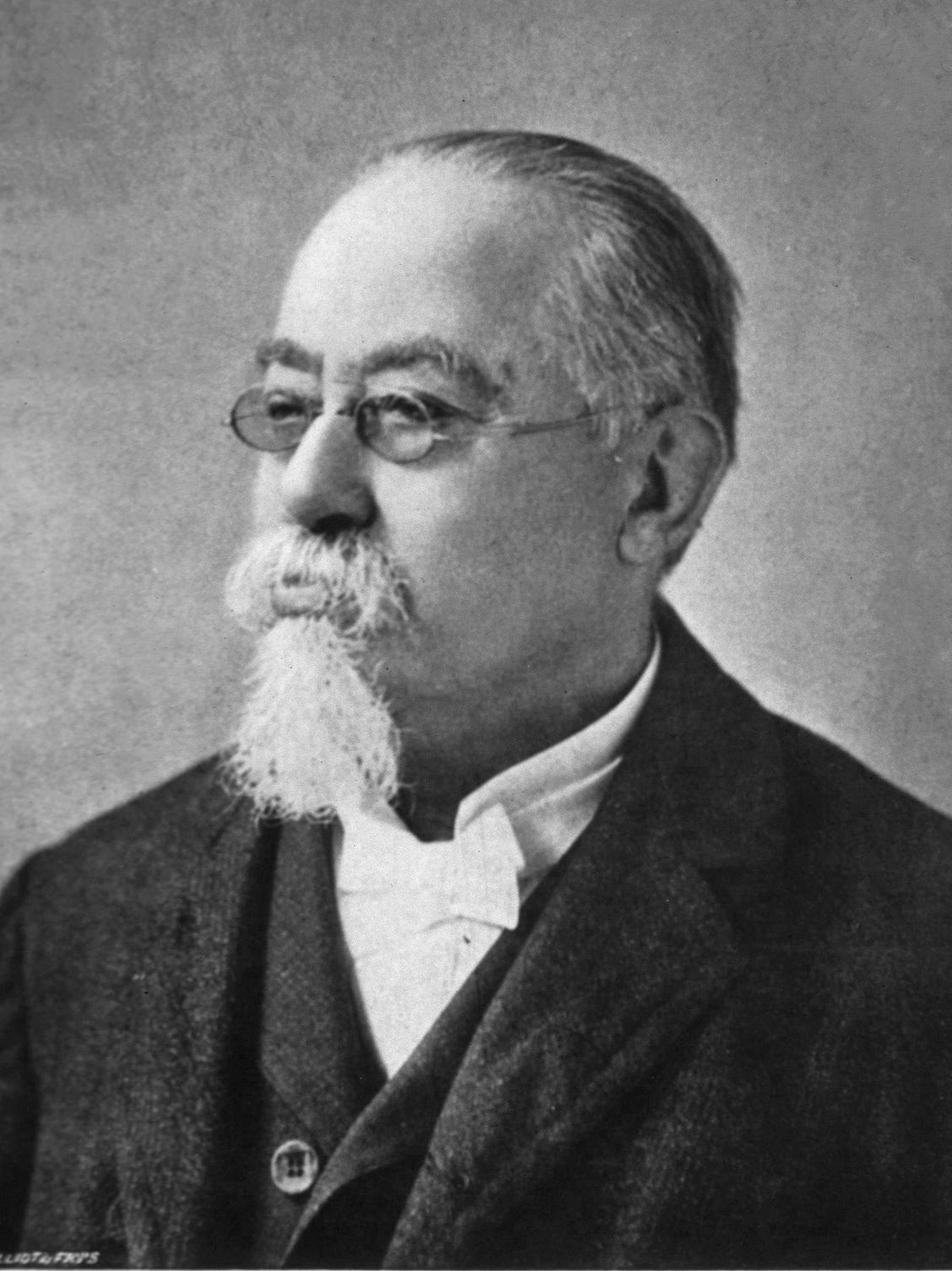
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Un aggiornamento da Luca Abbà: respinta la richiesta di sospensione, l’accanimento continua.
Scrivo queste righe per mettervi a conoscenza sugli sviluppi della mia assurda vicenda giudiziaria. Sono venuto a conoscenza del rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza della richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena che avevo presentato nell’attesa del pronunciamento della Cassazione in merito alla legittimità dell’ordinanza che mi ha “concesso” la semilibertà. Detto pronunciamento verrà fissato in tempi indefiniti di alcuni mesi e, seppur dall’esito non scontato, potrebbe costringere il TdS a riformulare le condizioni in cui io dovrei scontare la mia condanna di un anno ormai famosa. Non conosco le motivazioni del respingimento visto che non ho ancora ricevuto la notifica formale. Intanto si va avanti così per lo meno fino all’inizio 2020.
Non è che io abbia avuto mai grande fiducia nel potere giudiziario di uno stato [gli ultimi fatti che mi riguardano confermano ciò], ma la mia vicenda mette bene in mostra, oggi come allora, qui come altrove, come vengono trattati i dissidenti politico-sociali, ovvero coloro che disturbano i manovratori del sistema economico che governa il mondo.
Oltre ad essere una evidente forzatura giudiziaria, l’aspetto assurdo del provvedimento attuato nei miei confronti è evidente al semplice ed onesto cittadino chiunque e rappresenta un affronto alle normali regole
di buon senso.
In ogni caso, sto continuando il mio pendolarismo carcerario a testa alta, con la dignità che ha sempre accompagnato le mie scelte di vita. Tutto ciò con il sostegno di numerose persone che stanno contribuendo ad alleviare le mie fatiche del momento con varie forme di appoggio.
Ritengo che sarà necessario al più presto immaginare iniziative e mobilitazioni per denunciare la mia incredibile condizione vessatoria che, se diventa prassi consolidata, rischia di essere applicata anche ad altri valsusini nei prossimi anni, vista la presenza di cantieri e conseguenti forme di contrasto sempre più probabili nel futuro della val di Susa.
Ogni tanto mi viene da dire e da pensare: ne abbiamo viste tante, non le abbiamo viste tutte.
Luca Abbà, NO TAV semilibero, 7 ottobre 2019
Ordine di carcerazione per Nicoletta Dosio e altri #notav.
«Ma che cosa pensano di fare con i loro muri e le loro manette? E che ne sanno di questa nostra vita che con un colpo d’ala sa liberarsi dalle loro trappole che si chiamano resa e rassegnazione?»