
«I versi che seguono furono sollecitati dalla relazione di una delle spedizioni antartiche […]: vi si riferiva che il gruppo degli esploratori, allo stremo, aveva costantemente l’illusione che ci fosse una persona in più di quelle che in realtà si potevano contare.» (T.S. Eliot, nota a The Waste Land, 359-365)
«Chi è il terzo che ti cammina sempre accanto? / Quando conto, ci siamo solo io e te insieme / Ma quando guardo avanti, lungo la strada bianca / C’è sempre un altro che cammina accanto a te / Scivola, avvolto in un bruno mantello, incappucciato / Non so se uomo o donna / – Ma chi è quello dall’altra parte di te?» (T.S. Eliot, The Waste Land, 359-365, traduzione nostra)
INDICE DELLA SECONDA PUNTATA
[La prima è qui.]
3. Stare su Twitter: il perché e il percome
3a. Perché Twitter?
3b. Twitter, Giap e la Wu Ming Foundation
3c. Alcune regole della nostra netiquette su Twitter
4. Campagne, esperimenti, performances
4a. «nervi #saldi» in Val Clarea
4b. #Guerrieri contro Enel
4c. #TifiamoAsteroide
4d. #Renziscappa
4e. Inchieste: #LaparolaconlaF e «CasaP(oun)D»
5. Stare su Twitter? La lunga crisi
5a. Twitter cambia a colpi di default power
5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap
5c. L’ultima performance: attacco psichico!
6. Per una cartografia della nostra presenza in rete / 2
6a. La rivoluzione innanzitutto e sempre
6b. Uno spazio di calma dentro l’urgenza
3. Stare su Twitter: il perché e il percome
3a. Perché Twitter?
Se Facebook fin dall’inizio ci sembra non avere margini di manovra né intercapedini e nemmeno fessure, su Twitter qualche spazio ci pare di scorgerlo.
Sia chiaro: non ci aggiriamo a caso per la rete, sperduti e ingenui come al zanìn dal lùni. Nel 2009 ci è già chiaro da un pezzo che «se non capisci quale sia il prodotto, cucù, il prodotto sei tu!»
Twitter non ha un solido modello di business, l’azienda è ancora lontana dall’essere quotata in borsa… Nondimeno, è già un network commerciale, lo sappiamo. Però ci sono spazi per muoversi.
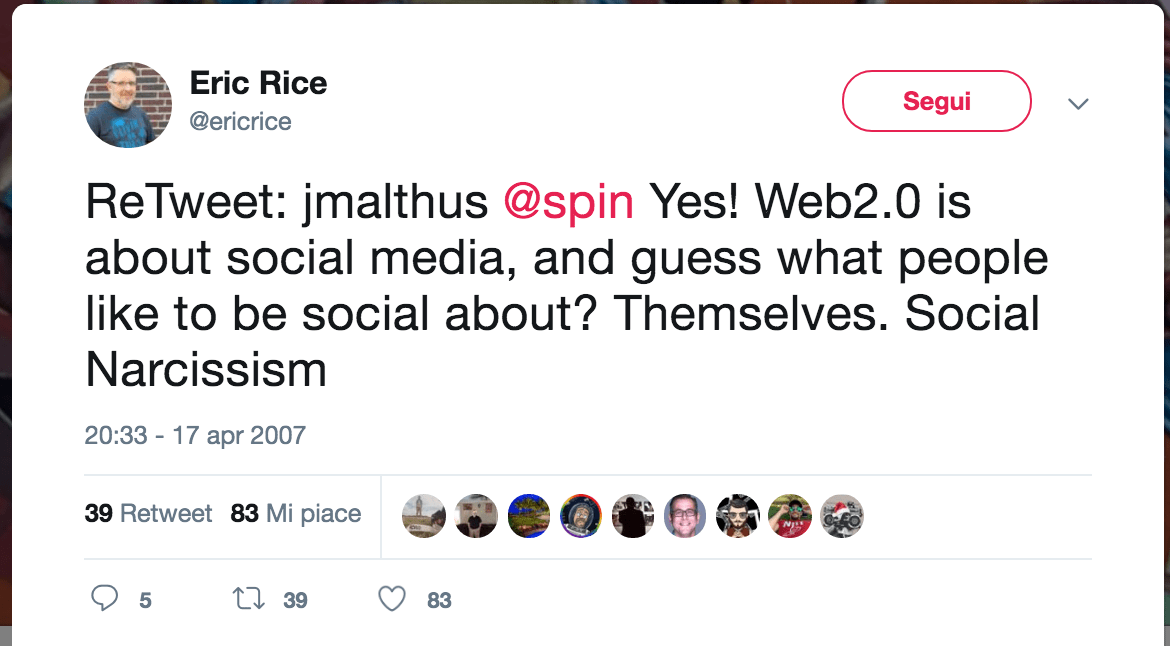
17 aprile 2007, il primo retweet della storia. Curiosamente, contiene già una previsione sull’andazzo a venire. Ben presto «ReTweet» verrà abbreviato in RT. Solo due anni dopo arriverà il bottone apposito.
■ Il mezzo è ancora limitato, molte funzioni che lo caratterizzeranno nel decennio a venire devono ancora essere pensate. Soltanto da poco si può ritwittare cliccando su un “bottone”: prima del novembre 2009, se volevi condividere un tweet copiavi il testo, lo incollavi nella tua finestrella, ci scrivevi davanti «RT» e spedivi. E il retweet è una pratica sorta dal basso, un’invenzione della community, come del resto l’hashtag (usare il cancelletto per indicare una tematica) e la mention (usare la chiocciola per rivolgersi a un altro utente). Tutto è nuovo, si respira potenzialità. Twitter permette a programmatori indipendenti di pistolare con l’API e sviluppare tutte le applicazioni e client che vogliono: Tweetdeck, Tweetie, Twitterrific…
In realtà questa fase ha i mesi contati, ma nessun utente può immaginarlo.
■ In continuità con la migliore tradizione della rete, su Twitter si usano pseudonimi e si gioca con le personalità, senza alcuna ingiunzione a una «trasparenza» identitaria, a far coincidere profilo e “autenticità” anagrafica. Nessuna imperiosa spinta alla coerenza narrativa e men che meno alla pornografia emotiva.
■ A riprova di ciò, su Twitter non si diventa pelosamente «amici» ma si «segue» qualcuno, anzi, il più delle volte qualcosa: contenuti, flussi di notizie su argomenti a scelta, fino a comporsi una “dieta” informativa quotidiana.
■ Il limite di 140 caratteri, mutuato dai primi SMS, scoraggia a fare lunghe discussioni direttamente su Twitter. Ogni contrainte pone il problema di come aggirarla creativamente, e i 140 caratteri sono uno sprone a inventarsi modalità di interazione. Soprattutto, sono un invito a proporre e seguire link, a navigare e vivere la rete e a fare dibattiti altrove, ovunque ma non lì.
■ Anche per questo, mentre Facebook è già intento a cooptare e contenere tutto, offrendo al proprio interno sempre più risorse e strumenti – “note”, mail e messaggi, video, gruppi di discussione – e disincentivando il più possibile il ricorso a link esterni, Twitter si presenta come “estroflesso”, centrifugo, proteso oltre se stesso.
■ Sempre a proposito di estroflessione: noi cerchiamo modi di mettere in risonanza lavoro in rete e lavoro in strada, e Twitter ci pare congeniale. Ne è riprova il suo frequente utilizzo per cronache in tempo reale da manifestazioni, blocchi, sommosse, assemblee e ogni sorta di eventi dal vivo. Tanto che si affermerà il pernicioso equivoco sulle rivolte del 2011 scoppiate «grazie a Twitter». Ma di questo diremo poi.

Il miliardario e guru “anarcocapitalista” Peter Thiel, tra i primissimi finanziatori di Facebook e dal 2004 membro del suo consiglio d’amministrazione.
■ Non risultano contiguità né dirette continuità tra Twitter e la cricca di guru ultraliberisti noti con vari nomi, tra i quali «anarcocapitalisti» e «libertarians» (da non confondere con l’accezione “europea” del termine). Gente che accusa Milton Friedman di essere «statalista», per capirci, e che fin da subito ha avuto le mani in pasta dentro Facebook. Tra i finanziatori e dirigenti di Twitter non c’è nessun Peter Thiel. *
Si scoprirà poi che Facebook ha tentato di comprare Twitter, ottenendo un secco rifiuto, motivato anche dal fatto che per «quelli di Facebook» i fondatori di Twitter non hanno alcuna simpatia: «I don’t use Facebook», ha scritto in un memo interno Evan Williams, co-fondatore di Twitter insieme a Jack Dorsey. «And I have many concerns about their people and how they do business». Era l’ottobre del 2008.
Twitter non sta in una sezione di capitale «buona», non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che i due modelli, Twitter e Facebook, erano ancora molto distanti tra loro. Erano distanti tra loro anche i rispettivi fondatori.
Su Twitter, in definitiva, pensiamo di poter fare esperimenti e di avere una ragionevole quantità di tempo per farli prima di eventuali degenerazioni. Da qui le parole del nostro tweet d’esordio.
3b. Twitter, Giap e la Wu Ming Foundation
Per il primo anno ci muoviamo a tentoni, finché, nel gennaio 2011, non facciamo partire una campagna, quella contro il «Rogo di libri» in Veneto. Si tratta di difendere noi stessi e altre scrittrici e scrittori da un odioso tentativo di censura fascioleghista. Una roba abominevole, ma snobbata da quegli stessi media mainstream e opinionisti pseudo-liberal che anni dopo impartiranno lezioni di antifascismo, antisalvinismo, “sardinismo” e quant’altro.
La campagna si irradia da Giap e altri blog e prosegue in strada, ma per la prima volta in vita nostra lanciamo anche un hashtag su Twitter, #rogodilibri, che ha un certo riscontro e ci dà un bell’abbrivio.
In quella circostanza si vince, i nostri libri non verranno rimossi dalle biblioteche pubbliche del Veneto, ma la vicenda contiene in nuce un futuro merdoso.
Il 3 luglio 2011 facciamo l’esperimento di détournement «Nervi #saldi» per informare sulla violenza poliziesca in Valsusa (vedi sotto).
Due settimane dopo, realizziamo una performance che fa apparire su centinaia di profili Twitter il volto del partigiano Bruno Fanciullacci.
Con questo doppio exploit sentiamo che c’è stato un “salto di livello”, così decidiamo di lanciare un hashtag – #TwitterisnotFB – utile a fare inchiesta sul mezzo e capire come usarlo meglio. Parte una vasta discussione. Ne trae un bello storify Alessandro Gazoia aka Jumpinshark…
…ma Storify chiuderà i battenti nel maggio 2018 e tutti i suoi post svaniranno. Nemmeno archive.org potrà mostrarli integri: ne salverà solo la prima schermata e non si potrà andare oltre, per colpa di un codicillo incompatibile con l’archiviazione. Un patrimonio di “riassunti” di discussioni andrà perduto, forse per sempre.
L’inchiesta serve anche a chiarirci le idee in previsione di un’intervista che deve farci Loredana Lipperini. Quando esce, ci sembra riuscita bene.
Ad affermarsi come principale peculiarità del nostro utilizzo di Twitter saranno i commenti di Giap twittati in automatico. All’inizio segnaliamo a mano i commenti più interessanti, ma nel 2012 agganciamo al profilo il feed RSS. Coi commenti non l’abbiamo mai visto fare a nessuno. Con gli articoli sì, è prassi diffusa, ma coi commenti no.
A essere precisi, viene twittata l’anteprima di ciascun commento: una card che include l’incipit, l’immagine principale del post commentato, la descrizione del post e il permalink del commento. Cliccando sulla card, si entra nella discussione in corso esattamente in quel punto. Quando un thread è molto partecipato, decine di tweet avvisano chi sta su Twitter:
– Ehi, di là si sta discutendo fitto, magari ti interessa!
Per diversi anni questo “rimbalzo” funziona bene, crea circoli virtuosi e fa evolvere Giap. Leggi le prime parole di un commento e, se ti incuriosisce, clicchi il link, vieni sul blog, e se hai voglia dici la tua. Repetita iuvant: è ancora l’epoca in cui nessuno ritiene sensato fare discussioni lunghe su Twitter, e quasi nessuno ci prova.
Sull’appiccicosissimo Facebook, la trovata non funzionerebbe. Là, il più delle volte, si leggono le righe d’anteprima e si commentano quelle, seduta stante, senza cliccare il link. Sulle pagine FB di giornali e riviste sono frequentissimi lunghi thread dove non si commenta l’articolo di volta in volta segnalato, ma solo le righe che appaiono nell’anteprima e, a seguire, i commenti degli altri utenti. Cliccare sul link? Giammai! Tutto pur di non uscire da Facebook, fuori ci sono correnti d’aria, potrei prendermi un malanno… Pochi minuti, ed eccoti avviluppato in un metadiscorso sempre più lontano dal contenuto dell’articolo.
Circoli virtuosi, dicevamo.
■ Si scrive un commento su Giap sapendo che l’incipit arriverà su Twitter. Spesso la prima frase è già il punto, la prolessi della tesi, scritta con buona breviloquenza.
■ I giapster usano Twitter per monitorare la discussione sul blog, raro esempio di metadiscorso che non finisce OT.
■ Da un certo momento in avanti i titoli di Giap contengono già hashtag. Questo attira a discutere su Giap potenzialmente chiunque sia interessato a un dato argomento.
■ Si usano alcuni tweet come ballons d’essai per eventuali articoli su Giap, e infatti svariati post nascono da thread su Twitter. Gli ultimi prima del nostro abbandono saranno quello sui partigiani migranti e quello su elezioni europee 2019 e astensionismo.
 Dalla nostra presenza su Twitter trae giovamento la Wu Ming Foundation, che si estende e si consolida anche grazie alla sinergia Giap-Twitter. Su Twitter conosciamo diverse persone che animeranno progetti come Nicoletta Bourbaki e Alpinismo Molotov. Il primo titolo di Quinto Tipo, Diario di Zona di Luigi Chiarella (Yamunin), è scritto in rete a puntate partendo da appunti presi su Twitter girando per Torino da lavoratore precario (lettore di contatori dell’acqua).
Dalla nostra presenza su Twitter trae giovamento la Wu Ming Foundation, che si estende e si consolida anche grazie alla sinergia Giap-Twitter. Su Twitter conosciamo diverse persone che animeranno progetti come Nicoletta Bourbaki e Alpinismo Molotov. Il primo titolo di Quinto Tipo, Diario di Zona di Luigi Chiarella (Yamunin), è scritto in rete a puntate partendo da appunti presi su Twitter girando per Torino da lavoratore precario (lettore di contatori dell’acqua).
La rete e la strada.
3c. Alcune regole della nostra netiquette su Twitter
Tanto per cambiare, stabiliamo delle contraintes. Costrizioni, regole di condotta da osservare con rigore. Alcune le fissiamo subito, altre le aggiungeremo man mano. A sarà düra, ma riusciremo quasi sempre a rispettarle.
■ Usare sempre la prima persona plurale.
È importante rimarcare la collettività dell’account e la dimensione conviviale che ci sta dietro. Su Twitter c’è Wu Ming. La voce dell’account è collettiva anche senza bisogno di assemblee per decidere ogni tweet. Noi ci riuniamo, scriviamo, militiamo e viaggiamo insieme da oltre un quarto di secolo. Quel «noi» – nuèter, nuàltar, 我们 – è imprescindibile:
«La convivialità implica l’esistenza di un “noi” stabile, o quantomeno in grado di narrare la propria storia, di rappresentarsi e prendersi cura di sé, costruendo spazi collettivi e vivendo momenti comuni» (Ippolita, Nell’acquario di Facebook, cit.)
Col tempo, l’arrivo su Twitter di VIP permalosi e l’afflusso di utenti comuni abituati a Facebook importano l’aspettativa del «nome vero» in un network che non l’ha mai conosciuta.
A un certo punto, ci accorgiamo del ricorrere di un automatismo. Inter nos lo battezziamo «Legge di Riotta»: se uno scambio di tweet con un interlocutore sgodevole – tipo uno senza argomenti ma che deve tenere la parte, o uno che gli stavamo sui maroni già prima, oppure uno che «Lei non sa chi sono io!» – si spinge oltre il terzo botta-e-risposta, puoi star certo che al quarto arriverà la domanda:
«Chi di voi sta twittando in questo momento?! Voglio sapere con chi sto parlando!»
Quesito assurdo quant’altri mai: cosa ti cambia sapere se ti sta scrivendo un Wu Ming o quell’altro, dato che l’account è collettivo? Ovviamente, intorno a una simile, inane pretesa aleggia la solita nebbiolina: i clichés sull’«anonimato», l’allusione alle vie legali…
Tra l’altro, noi mica siamo anonimi. I nomi dei membri di Wu Ming sono sempre stati pubblici e disponibili.
A proposito, per cose che scriviamo su Twitter ci minacciano di querela tante volte, annunciandolo anche in pompa magna, a volte dichiarando perfino cosa faranno coi soldi che dovremo sganciare. Sempre beneficenza, sia chiaro: tutti filantropi, tutti brave persone. Ma can che abbaia non morsica: di querele non ne arriverà mai nessuna.
■ Corollario: non parlare di fatti nostri individuali.
In generale, non solo su Twitter, le questioni personali di un singolo membro del collettivo rimangono personali, a meno che un cenno autobiografico non sia utile ad altro, in quanto elemento necessario di una narrazione, parte integrante di un discorso che trascende il privato.
Una variante della Legge di Riotta è: «Guarda che, se ho capito chi è che twitta, ci conosciamo benissimo!». Sottinteso: a me non me la fate con ‘sta storia del collettivo. Anche su Twitter, benché con minore frequenza rispetto a Facebook, sempre più utenti cominciano a pretendere coerenza narrativa tra account sui social e singola persona, tra un profilo e la persona che hai conosciuto fuori da lì.
■ Non citare mai il nostro numero di follower.
Per capirci, mai fatti tweet del genere: «Oggi abbiamo superato i 50.000 follower, grazie a tutte e tutti voi che ci seguite!» Ancora una volta per una questione di stile, ma anche perché… non sappiamo quanti follower abbiamo. Non lo sappiamo, perché il numero che appare sul profilo è del tutto inaffidabile.
– Orpo, e come mai?
– Per via dei fakebot.
– I fakebot? E cosa sono?
– Finti utenti, profili farlocchi generati da un software che ti si appiccicano al profilo. Se superi una certa soglia di popolarità, stai sicuro che arrivano a frotte. Ti seguono, poi ti spammano roba o ti mandano dei link che se li clicchi ti viene la rogna, ma spesso non fanno proprio niente, stanno solo lì a inquinarti le statistiche. Molti vagano su Twitter come zombie, da anni, e s’incollano al primo che vedono, così, senza senso. Noialtri ne abbiamo migliaia.
Nel 2015 proviamo un servizio anti-fake, il quale opera un vero e proprio “rastrellamento”, identificando e bloccando più o meno cinquemila profili che ci seguivano. Il problema è che adotta parametri troppo rigidi, e scambia per fake anche centinaia di profili genuini, solo perché poco o per niente attivi. Un sacco di gente sta su Twitter solo per leggere roba, ma basta che un account twitti col contagocce e viene considerato tout court falso.
Bel malippo, non c’è che dire. Passiamo settimane a rispondere a mail di gente che giustamente chiede: «Io vi seguivo, vi leggevo ma non vi ho mai detto beo, perché m’avete bloccato?!». Mail così le riceveremo a lungo, perché mica tutti se ne accorgono subito, di essere stati bloccati. E via a spiegare, e sbloccare. Pazienza, rinunciamo all’app schizzinosa e non ne cerchiamo altre. Ci limiteremo a non citare il nostro numero di follower, perché il dato è evidentemente drogato.
Ogni tanto arriva uno dei nostri “fan al contrario”, parte di quell’accozzaglia di hater ossessionati da noialtri, che credendosi furbissimo usa uno di quei siti tipo TwitterAudit e dice: «Ho scoperto che i wuminchia hanno un sacco di follower falsi, ahahahaha!» Ma a parte questi momenti trash, i fakebot non danno così fastidio.
Però quell’«87.900 follower» campeggiante nel nostro profilo al momento del nostro addio è una cifra disonesta, e dà potenziali appigli ad altri mentecatti, ignari di come funzionino queste cose, per far credere che quei follower falsi li abbiamo comprati o qualcosa del genere. Se incappate in uno così, linkategli questa spiegazione.
■ Non commentare programmi tv.
Abbiamo sempre cercato di non assecondare l’utilizzo di Twitter come mezzo subordinato alla «TV-realtà», ai talk show, ai talent show, agli show sulla roba da mangiare ecc.
L’egemonia culturale della televisione comincia a imporsi su Twitter molto presto, tramite gli hashtag coi nomi dei programmi – che intasano subito la lista dei Trending Topic – e il chiacchiericcio in tempo reale su trasmissioni che se uno avesse voluto vederle le avrebbe guardate in the first place, o no?
Su questo tema c’è un commento del giugno 2011, vale la pena riproporne alcuni estratti:
«La rete stessa oggi [è] pervasa di logiche “televisive”, di sintassi televisiva, di antropologia del telespettatore […] la TV stessa oggi [è] in rete. Centinaia di migliaia di persone i cui sguardi convergono sul talk-show di Santoro ieri sera – propagandato come grande evento “della rete”, in alternativa alla TV del duopolio etc. e in realtà del tutto televisivo nel formato, nella sintassi, nella concezione, e tra l’altro trasmesso anche su canali televisivi – e che commentano su FB e Twitter “Grande Travaglio!”, “LOL”, “Applausone!”, “Questa non si può sentire”, “rotfl”… Questa non è “rete vs. TV”, questa è convergenza rete-TV […] Twitter e FB sono, durante l’evento o mega-evento televisivo, un modo di fruire la TV.
In apparenza, può sembrare che questo sia un altro livello, una conversazione orizzontale tra spettatori-non-più-tali che democraticamente si confrontano sui contenuti di ciò che viene trasmesso in quel momento. E a volte può pure succedere, sia chiaro. [In realtà] quella conversazione [è] inevitabilmente subordinata a quanto viene trasmesso, e fatta nella maggior parte dei casi di plauso o di facile “Buuuuu” verso il cattivo di turno, di risposte prevedibili e pre-determinate, anche pavloviane.
La rete, in queste occasioni (che non sono affatto rare, si ripetono ogni giorno), non è affatto alternativa al linguaggio televisivo: ne viene pervasa. Tanto che alcuni programmi hanno incorporato quella “conversazione”, a volte tecnicamente (di fianco allo schermo dello streaming c’è la colonna coi commenti), a volte solo retoricamente (durante la trasmissione spesso si comunica il numero di tweet collezionati dall’evento, si saluta “chi ci segue su Facebook” etc.)»
 Ci siamo espressi più volte sul ruolo nefasto e nefando dei talk show televisivi. Fin dai primi anni Novanta, quel format ha funzionato da acceleratore di ogni loop vizioso e venefico, incluso il progressivo sdoganamento di neofascismi e umori razzisti, grazie alle tribune generosamente offerte a freak e propagatori d’odio.
Ci siamo espressi più volte sul ruolo nefasto e nefando dei talk show televisivi. Fin dai primi anni Novanta, quel format ha funzionato da acceleratore di ogni loop vizioso e venefico, incluso il progressivo sdoganamento di neofascismi e umori razzisti, grazie alle tribune generosamente offerte a freak e propagatori d’odio.
Quando il conduttore di un talk show “democratico” si incaponisce nel fare del proprio programma il più pervicace e subdolo dispositivo di “normalizzazione” del neofascismo, proponiamo di silenziare il relativo hashtag. Un’azione di mera testimonianza, sia chiaro, priva della minima conseguenza pratica.
■ Non fare «necrotweet».
Quasi ogni giorno muore una celebrità o presunta tale, e Twitter diventa una camera ardente sovraffollata dove vaste masse di improvvisate prefiche si disperano in modi poco convincenti.
Se muore uno scrittore preclaro e onusto di gloria, all’improvviso tutte e tutti han letto i suoi libri, dei quali propongono stralci arguti o strappalacrime. Ci vuol poco a constatare che, in realtà, quello scrittore aveva forse un centinaio di lettori in tutta Italia, e per quelle frasi si è ravanato in fretta e furia – quando va bene – su Wikiquote. Perché succede?
Per pura FOMO, per farsi vedere alle esequie. Magari a quelle sbagliate, come Fantozzi e Filini al funerale della vedova Ricci, anzi, no, del tenente Gambardella.
Ben presto decidiamo di ignorare i decessi illustri. Le volte che parliamo di un morto è solo ed esclusivamente perché abbiamo qualcosa di interessante da dire e c’è modo di dirlo creando rimbalzi tra Twitter e Giap. Magari partendo proprio dai necrotweet, come quando, in morte di Paolo Villaggio, proviamo a mettere il puntino sulla i di Potëmkin.
 ■ Non rispondere solo con un meme o, peggio, con una gif animata.
■ Non rispondere solo con un meme o, peggio, con una gif animata.
«Not sure what to say? Reply with a Gif!»
È lo slogan di uno dei tanti siti creati ad hoc per chi non trova le parole. Ed è un circolo vizioso, perché di parole ne troverai sempre meno se smetti di cercarle e le sostituisci con immaginette “simpatiche”, “ironiche”, “ficcanti” ecc.
E dopo che mi hai risposto con una gif, cosa dovrei dirti? Siamo già nell’entropia. Non a caso, rispondere con gif o memi o comunque immagini senza commento è diventato uno degli atti aggressivi per eccellenza, volti a mettere a tacere l’interlocutore, a delegittimarlo, a trattarlo da nemico.
Dopo averlo visto imperversare sui social, ci occupiamo di un meme che viene usato proprio in questo modo: quello su Pier Paolo Pasolini che critica «l’antifascismo rabbioso». Una ciozza assoluta, inventata da rossobruni nel 2017. Per contrastare la falsificazione del pensiero e della biografia di Pasolini, proponiamo l’uso di «antimemi», come il meme rossobruno solcato dalla scritta rossa «BUFALA», oppure frasi di Pasolini autentiche ma spiazzanti per chi lo cita senza conoscerlo (scaricabili qui).
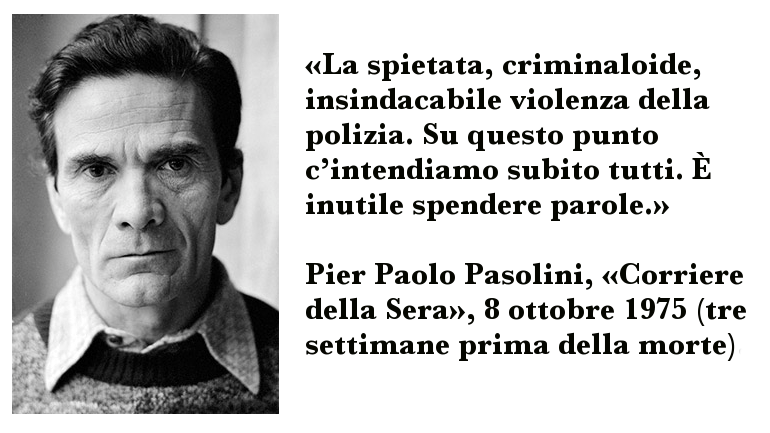
Antimeme.
4. Campagne, esperimenti, performances
L’accenno agli antimemi è il gancio ideale per passare dalla netiquette al resoconto di alcune campagne, mobilitazioni e performances legate al nostro uso di Twitter.
4a. «Nervi #saldi» in Val Clarea
Il 3 giugno 2011, nei pressi di Chiomonte – alta Valsusa, per la precisione Val Clarea – migliaia di No Tav cingono d’assedio il cantiere-fortino insediatosi sul terreno della Libera Repubblica della Maddalena, sgomberata una settimana prima.
Le forze dell’ordine rispondono in modo violentissimo, con un ricorso spropositato ai gas CS – migliaia di candelotti, spesso sparati ad altezza d’uomo – e l’utilizzo più volte documentato di armi improprie. I fatti di questa giornata saranno oggetto del famoso «maxiprocesso» contro i No Tav.
Per un approfondimento su queste vicende, rimandiamo al libro di Wu Ming 1 Un viaggio che non promettiamo breve. Qui ci interessa quanto accadde su Twitter in quelle ore.

Chiomonte, 3 luglio 2011. Il momento della “presa in custodia” del manifestante Fabiano Di Berardino. Già pestato a sangue, nelle ore a seguire subisce ogni sorta di angherie e violenze psicologiche. Semisvenuto e lasciato al sole per ore, viene persino “annaffiato” di piscio prima che qualcuno si decida a portarlo all’ospedale. Nessuno dei responsabili sarà mai individuato e perseguito: nel 2012 la denuncia di Fabiano verrà archiviata, principalmente grazie a una “collaborazione” tra Digos e giornalismo locale.
Dalla Val Clarea, avvolti da nubi di lacrimogeno, decine di attivisti twittano usando l’hashtag #notav: informano, si coordinano tra loro per quanto possibile, avvisano se un sentiero è bloccato dalle guardie, chiedono soccorso al personale medico del movimento ecc.
Anche chi è lontano usa l’hashtag: sostiene, commenta, condivide, dà consigli.
Ben presto #notav compare in migliaia di tweet, eppure non fa mai capolino nella lista dei Trending Topic, dove più persone potrebbero accorgersi di cosa sta accadendo.
Al primo posto di quella lista spicca #sticazzi. Al secondo c’è #saldi. Nessun complotto o “filtro” politico: #notav era stato nei TT pochi giorni prima, spiega qualcuno, e l’algoritmo di Twitter fa in modo che gli ingressi si alternino e rimangano variegati.
Non è ancora il tempo in cui #buongiorno sarà in TT ogni – fottuta – mattina.
Verso mezzogiorno ci viene un’idea e la proponiamo:
«Nei prossimi tweet oltre a #notav scrivete anche: “nervi #saldi” :-)»
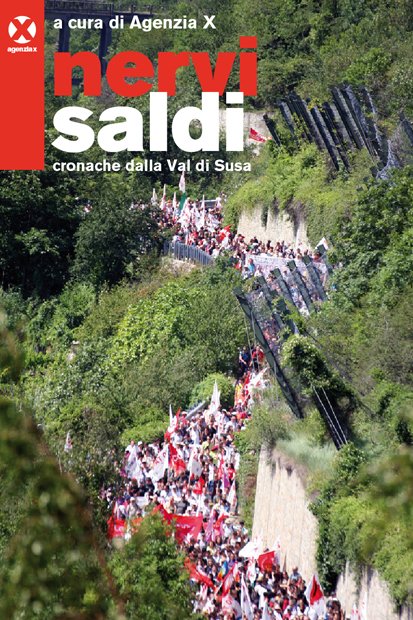
Nervi saldi, l’instant-book sui fatti del 3 luglio 2011 che prende il titolo dalla mossa di hashtag hijacking.
Come riassumerà Flavio Pintarelli, «in poco tempo l’hashtag #saldi viene dirottato e si trasforma in un canale alternativo di notizie sulla manifestazione […] C’è chi cercava vestiti ed ha trovato un manganello, come recitava uno dei molti tweet della giornata.»
Per tutto il pomeriggio centinaia di persone usano #saldi per informare sulla lotta No Tav, denunciare la repressione, fare le pulci alla malainformazione mainstream.
Verso sera pubblichiamo un post su Giap, «Nervi #saldi in Val di Sherwood: cronaca di una giornata #notav», dove linkiamo un paio di rassegne commentate di tweet: una curata da Pintarelli, l’altra da Francesco Spè. Anche in questo caso la scelta dello strumento per raccogliere i tweet, Storify, si rivelerà improvvida – ma in questo momento nessuno può saperlo.
Nervi saldi diventerà anche il titolo di un instant-book gratuito edito di lì a poco da Agenzia X.
Intendiamoci: è il varo di una zattera in un bicchier d’acqua, perché in Italia Twitter è ancora un social di nicchia, ma l’esperimento colpisce molto e se ne scriverà a lungo. È il preludio a campagne meno estemporanee…
4b. #Guerrieri contro Enel
…come, nel settembre 2013, il détournement della campagna #Guerrieri di Enel.
È la fase in cui si registrano i primi, goffi tentativi di campagne social da parte di grandi corporation italiane. Enel mira in alto: si rivolge alla multinazionale della pubblicità Saatchi & Saatchi e voilà, ecco #Guerrieri, una campagna di storytelling aziendale (quant’è figa l’Enel!) a fini di greenwashing (quant’è ecologista l’Enel!) che titilli il narcisismo di massa (quanto sono figo io che partecipo a questa campagna dell’Enel!).
Il concept è: raccontatevi, voi gente comune che si sbatte ogni giorno, tra mille difficoltà, e fa grande il nostro Belpaese! Voi siete i #guerrieri!

Detta prosaicamente, è un concorso. Devi scrivere la tua storia di #guerriero – sul lavoro, a scuola, ovunque – e pubblicarla su un’apposita piattaforma per poi spammarla sui social usando l’hashtag. In palio ci sono cinque biciclette elettriche del valore di 954 euro.
– Uhm… E se arrivano poche storie?
– Tranquillo, ci sono agenzie apposta! Mai sentito parlare di buzz marketing?
Saatchi & Saatchi + i social + una base sicura di passaparola prezzolato. What could possibly go wrong?
 Praticamente tutto. Per un committente così, una campagna del genere è roba da kamikaze. Il minimo che si possa dire è che l’Enel non ispira grande simpatia, non tanto o non solo perché tocca pagarle la bolletta, ma per:
Praticamente tutto. Per un committente così, una campagna del genere è roba da kamikaze. Il minimo che si possa dire è che l’Enel non ispira grande simpatia, non tanto o non solo perché tocca pagarle la bolletta, ma per:
■ l’inquinamento e le emissioni delle sue centrali a carbone in Italia e nel mondo (nel 2019, a dispetto dei grandi annunci green, ancora non se n’è liberata);
■ le azioni legali – e addirittura una finta manifestazione – contro Greenpeace;
■ la rappresaglia contro il regista Mimmo Calopresti, reo di aver girato il cortometraggio Uno al giorno;
■ il divieto legale di mostrare il marchio ENEL in materiali di controinformazione sull’azienda;
■ megaprogetti impattanti e neocoloniali nel Sud del mondo, come il sistema di dighe Hydroaisén nella Patagonia cilena (progetto approvato nel 2011, duramente contestato da ambientalisti e Mapuche e infine fermato nel 2014 grazie alle mobilitazioni).
Tutte cose accadute da poco, e di cui si è parlato. Con un simile “curriculum” e una tempistica tanto sfavorevole, che greenwashing pensi di fare?
La campagna parte ai primi di settembre. Fin da subito la troviamo grottesca, e siamo in buona e crescente compagnia: sbertucciamenti e sfanculamenti cominciano subito, ma la situazione resta tranquilla, perché sui social #Guerrieri non decolla.
Il 24 settembre, però, vediamo che Enel ha comprato lo spazio in cima ai TT, e pensiamo: una narrazione tossica si combatte raccontando mille storie diverse. Così facciamo una proposta:
«La cosa più sensata è usare l’hashtag #guerrieri x veicolare controinformazione, controinchieste, link sulle lotte contro @enelsharing».
Il dirottamento ha immediato successo. Per molti giorni la controinformazione si impadronisce dell’hashtag. Il flusso di tweet indesiderati irrompe anche sul sito ufficiale di Enel, nel box dedicato alla campagna (box che verrà subito rimosso). E mentre la campagna di Enel titillava un certo individualismo auto-ero(t)icizzante, la risposta dal basso è spiccatamente comunitaria.
Nel giro di 24 ore già si parla di «epic fail». Citiamo da un articolo uscito su Il Fatto Quotidiano il 25 settembre e intitolato «Enel, la pubblicità diventa boomerang: “epic fail” di #guerrieri su Twitter»:
«L’iniziativa di Enel si è trasformata in una débacle. L’hashtag #guerrieri ha dato modo agli utenti di sferrare un attacco senza precedenti all’azienda, anziché partecipare al concorso: sul social network, le accuse, gli sfottò, le contestazioni si sono sprecate. Paradossalmente, l’effetto è stato amplificato dalla stessa azienda, che ha comprato il top trend di Twitter, attirando l’attenzione di migliaia di utenti […] nella giornata di martedì sono stati 2.500 gli utenti che hanno parlato della campagna pubblicitaria. E ne hanno parlato male […] Gli utenti, in chiara polemica contro l’operatore elettrico, definiscono guerrieri “quelli che ogni giorno, nei territori, si battono contro le centrali a carbone di Enel”, oppure “quelli che devono pagare la bolletta più cara d’Europa e sono in cassa integrazione”. E c’è chi ricorda le manifestazioni contro Greenpeace, apparentemente portate avanti da operai Enel e invece orchestrate dall’azienda.»
Enel si trova in un loop dal quale, per quanto si dibatta, non può uscire. Lo facciamo notare il 30 settembre:
«Enel si è infilata nel più classico circolo vizioso: per non far vedere che sui social network la campagna non decollava – e in particolare su Twitter incontrava la resistenza di migliaia di utenti fino a subire un’autentica disfatta modello battaglia di Teutoburgo – Enel ha pompato al massimo la pubblicità su giornali e TV; la sta tuttora pompando, lo spot di #Guerrieri è ovunque. Il risultato è quello di pubblicizzare l’hashtag, e quando la gente va su Twitter a cliccare l’hashtag, vede l’ecatombe.»
In quei giorni, se cerchi su Google «ENEL Guerrieri», i primi risultati sono tutti di questo tenore.
Il fallimento della campagna di Saatchi & Saatchi – «figura da incapaatchi», scrive qualcuno – risuona forte nei mondi del marketing e della comunicazione digitale, ne scrivono svariati addetti ai lavori. Per Vittorio Bucci, ad esempio, #Guerrieri è «un’occasione mancata», mentre l’hijack avvenuto su Twitter è «una tra le più grandi controcampagne degli ultimi anni».
A tenere i fili di quello che viene scritto – e delle reazioni a tratti scomposte del management Enel – è soprattutto @Detta_Lalla, solo che Storify non c’è più e quindi ecc. ecc.
Nel leggere alcune delle storie di #Guerrieri, Lalla riscontra toni forzati ed è la prima a sospettare che di autentico ci sia poco. Stretto giro di verifiche, e spunta lo zampino di Zzub.
ZZub è un marchio di proprietà di Eikon Strategic Consulting. Si presenta come «community di consumatori attivi e consapevoli che amano esprimere opinioni online su prodotti e servizi, condividere l’esperienza d’uso con la propria rete di conoscenze e avere un rapporto diretto con i brand». Tale rapporto diretto, il più delle volte, consiste nell’avere prodotti gratis e in anteprima. In teoria non c’è alcun obbligo di parlarne bene, ma se ne parli bene e dimostri di averlo fatto guadagni dei punti, i quali, come scrive una zzuber, «vanno a formare il nostro karma: più punti abbiamo, più probabilità ci sono di essere invitati alle future campagne!».
Ecco la differenza: mentre le storie raccontate nella controcampagna sono storie di lotta vere, quelle della campagna sono storie di “lotta” farlocche o mezze farlocche scritte dietro un incentivo, per quanto «non monetario» (ma certamente mercantile). Per approfondimenti su questo aspetto, si legga la dettagliata analisi di Matteo G. P. Flora. Qui ne riportiamo solo le conclusioni:
«Se, quindi, lo scopo della campagna era quello di generare awareness tramite Twitter, direi che il risultato non solamente non è stato raggiunto, ma che nella fattualità delle numeriche i vincitori incontrastati sono stati i fautori della contro-campagna. Il discredito portato a Enel è sicuramente superiore del valore generato da Twitter.
Se lo scopo finale era, invece, quello di raccogliere “storie reali” come dichiarato da Cirullo rimane da capire quanto “reali” possiamo considerare delle storie così fortemente incentivate, ricordandoci però che la letteratura scientifica lega non proprio positivamente la correlazione tra “spontaneità” e “incentivo non monetario”.»
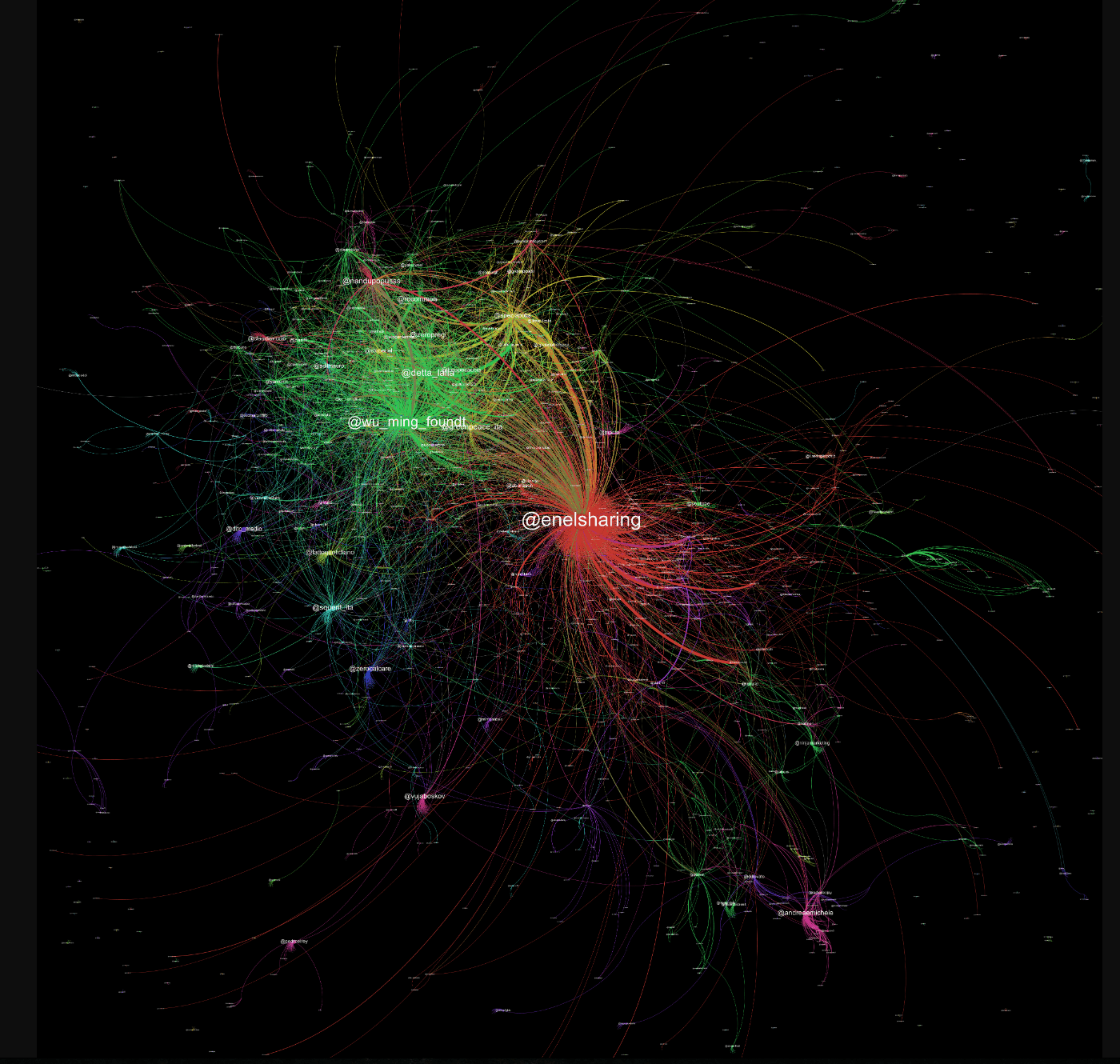
Collisione di mondi. Lo scontro su Twitter tra la campagna (in rosso) e la controcampagna (in verde). Infografica di Matteo G. P. Flora, 30 settembre 2013. Clicca per vederla in alta definizione.
La campagna #Guerrieri dimostra però che l’ingiunzione a raccontarsi non rimarrà prerogativa di Facebook. Facebook non fa che amplificare e distorcere ulteriormente una tendenza già in atto da tempo, quella del consumismo personalizzato: dimmi chi sei e ti dirò cosa desideri. Il cosiddetto «marketing 2.0» è tutto basato sul «raccontami la tua storia». Il dirottamento di #Guerrieri dimostra che ci sono resistenze, che almeno su Twitter la trippa per gatti è ancora poca… Ma è solo questione di tempo.
Intanto, grazie alla campagna su Twitter entriamo in contatto con l’associazione Re:Common. Dalla collaborazione con loro nascerà, tra le altre cose, il progetto GODIImenti.
4c. #Tifiamoasteroide
Torniamo indietro di qualche mese. Il 30 aprile 2013 si insedia in Italia il governo delle «larghe intese», meglio ricordato come «governo Letta». Centrodestra e centrosinistra insieme, alla buon’ora in modo aperto ed esplicito, ché tanto hanno sempre avuto più o meno lo stesso programma ed erano in maggioranza insieme da fine 2011, in appoggio alla macelleria sociale del governo Monti.
L’esecutivo guidato da Letta è annunciato come «governo di scopo»: facciamo alcune urgenti «riforme» che «ci chiede l’Europa», poi si vedrà. Nella tarda primavera, però, il premier avanza l’ipotesi di una durata più lunga. Per questo, il 6 giugno 2013, verso l’una di notte, Alberto Biraghi scrive un tweet fatidico:
«Il governo per le riforme con fascisti e mafiosi che dura tutta la legislatura? Serve un meteorite che li annienti.»
La mattina, leggendolo, ci viene un’idea e rilanciamo:
«Compagn*, scatta il contest: scrivete racconti di fantascienza dove un grande meteorite colpisce il governo Letta, e facciamo il free ebook!»
E nel tweet successivo:
«Nominiamo ufficialmente e a sua insaputa @maurovanetti collettore dei racconti per l’ebook #tifiamoasteroide».
Il titolo è scelto: per pura eufonia il meteorite diviene asteroide, ed è il debutto di un hashtag che avrà fortuna.
A breve giro, stabiliamo una scadenza di consegna – le 16:00 di domenica 16 giugno 2013 – e stavolta è Mauro a proporre una contrainte: tutti i racconti dovranno avere lo stesso finale. Questo:
«Dopo il boato assordante, con le orecchie che fischiavano, sentivamo ancora quella musica.
Dove fino a un istante prima si trovava Enrico Letta, capo del governo di larghe intese, si apriva una spaventosa voragine. Dall’enorme cratere si levavano nubi di fumo nero.»
Mauro si mette al lavoro e… viene sommerso di racconti. Nelle prime 72 ore, gliene arrivano ben trentasette. Alla scadenza, sono un centinaio tondo tondo. Tutta gente mossa dall’amore per il governo e il suo premier.
Nel frattempo, su Twitter, l’hashtag #tifiamoasteroide ha trasceso l’operazione editoriale: impazza nelle TL, e per anni verrà usato come sfogo, auspicio, sberleffo, commento a ogni nefandezza del potere, ma anche esorcismo contro l’apocalisse. Una community lasca ma perseverante continuerà a tener d’occhio i bollettini sui passaggi di asteroidi vicino alla Terra, e a condividere le notizie di “mancata per un pelo”.
Ci vogliono due mesi di editing e impaginazione, e finalmente rilasciamo Tifiamo asteroide. Cento racconti sulla fine catastrofica del governo Letta, con un’introduzione di Mauro e una postilla nostra, in tempo per la Notte di San Lorenzo, 10 agosto 2013.
Complice, forse, la stagione di slow news, ne parlano diversi giornali: Repubblica (pagine bolognesi e pagine politiche nazionali), Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto…
Nelle prime 24 ore, Tifiamo asteroide viene scaricato 65.764 volte in pdf e 4602 in epub. Di quest’exploit scrive perfino Il Sole 24 Ore.
La formula «Tifiamo…» ispirerà altri due progetti di scrittura collettiva coordinati tra Giap e Twitter: Tifiamo 4. 34 fotoracconti sull’acqua e Tifiamo ScaRamouche. Storie di guerra di classe scaturite da L’Armata dei Sonnambuli.
Il governo Letta finirà nel febbraio 2014. Passerà alla storia solo come prius logico e antropologico del governo Renzi: a un premier del PD ex-giovane democristiano ne succede un altro; alle larghe intese tra PD e Berlusconi segue il «patto del Nazzareno» tra PD e Berlusconi; le «riforme» sempre da fare – cioè le controriforme, i tagli al welfare, l’«austerity», più laissez-faire cementizio ecc. – rimangono le stesse.
Tanto che nel novembre 2014 Giuseppe «Nexus» Gatti lascia su Giap questo commento:
«Quando mi hanno chiesto di usare #TifiamoAsteroide per un reading, ho detto: basta sostituire “Letta” con “Renzi”. E funziona benissimo.»
Quanto a noi, al governo Renzi stiamo già dedicando un altro progetto: #Renziscappa.
4d. #Renziscappa
L’hashtag #Renziscappa non siamo noi a coniarlo, ma certamente siamo noi a lanciarlo. Quando @danffi ce lo segnala, il 4 novembre 2014, è stato usato solo 7 volte – sì, sette volte: cinque dita più due dell’altra mano – in circa sei mesi. Il primo utilizzo risale al 26 febbraio.
Quando lo lanciamo per mappare le fughe di Renzi – cioè i pacchi che il premier tira in giro per l’Italia per schivare contestazioni –, l’hashtag prende subito piede: da quel momento lo useranno migliaia di persone.
Raccontare l’avvio del progetto non è difficile, basta citare da un articolo del Fatto Quotidiano uscito il 14/11/2014 e intitolato «#Renziscappa, gli scrittori di Wu Ming raccontano tutte le fughe del premier»:
«Prima l’hashtag #Renziscappa, poi la mappa interattiva on line con tutti i luoghi, motivi e frequenza con cui l’attuale premier fugge dagli incontri ufficiali in cui è atteso.
L’idea è nata sul profilo Twitter dei Wu Ming il 4 novembre scorso, quando retwittando l’hasthag giratogli da un altro utente, @danffi, il collettivo di scrittura bolognese ha cominciato ad enumerare date, città e giorni in cui Renzi è letteralmente fuggito dall’incontro pubblico previsto. “Perché quando il gioco si fa duro lui scompare, tira pacchi, se la svigna, delega ad altri, tace. Riappare su Twitter gradasso e maldestro”, scrivono i Wu Ming partendo dalla fuga di quel giorno, quella di Bagnoli per presentare il decreto Sblocca Italia, annullata in extremis quando erano già state organizzate proteste dei comitati civici dell’area occidentale.
[…] Ma è solo l’inizio di un elenco di fuggifuggi […] “Summit di #Torino, luglio 2014: disdetto in extremis. Visita in Val Susa, settembre 2014: pacco all’ultimo minuto […] Accoglienza imprevista a #Brescia: via di corsa”, “Ottobre 2014: paura fischi, #Renziscappa dall’alluvione di #Genova… e i fischi li becca a #Bergamo”, “#Treviso, febbraio 2014: #Renziscappa dall’uscita posteriore del Municipio”.
[…] In poche ore l’hashtag#Renziscappa si moltiplica in rete tanto che il materiale viene sistematizzato definitivamente in una mappa interattiva che mostra una cartina dell’Italia con dei cerchi blu [poi diventarono rossi, N.d.R.] sulle singole città teatro di fughe che via via si ampliano a seconda di quante il presidente del consiglio ne ha effettuate, se c’è stata contestazione, il motivo del “pacco” e da quale soggetto il premier è fuggito.
[…] “[Il renzismo] mostra crepe perché in questi giorni ha avuto a che fare direttamente col conflitto sociale, stress test a cui non era preparato”, scrivono gli scrittori come possibile giustificazione alla fuga sempre dal loro profilo Twitter […]»
L’informazione ufficiale tiene separati i singoli episodi (le volte che ne parla), evitando in ogni modo di unire i puntini. L’idea è: uniamoli noi. Usiamo un hashtag per ricomporre il quadro, per rendere visibili quegli episodi come momenti di un unico fenomeno.
La mappa interattiva la crea @figuredisfondo, che la correda con vari grafici e non si limita a mappare le fughe di Renzi ma anche quelle dei suoi ministri, sodali e stretti collaboratori, come Maria Elena Boschi, Giuliano Poletti, Marianna Madia… E Oscar Farinetti, che nel 2014 è ancora un poster boy del renzismo nel mondo dell’impresa.
Il 21 novembre, a Bologna, durante le proteste per una visita di Renzi in città, appare lo striscione «#RENZISCAPPA TOUR». Sono tempi in cui non è ancora così comune vedere un hashtag su uno striscione. La rete e la strada.
Nelle settimane seguenti, il numero delle contestazioni e dei pacchi tirati continua ad aumentare. Ben presto Renzi non è più in grado di parlare in alcun luogo all’aperto. Cosa che, per un capo di governo, ci pare senza precedenti.
A dicembre la mappa – pois rossi su sfondo bianco – somiglia sempre più alla Pimpa, così su Twitter lanciamo #avatarpimpa, proponendo alla comunità di mettersi come immagine del profilo il personaggio di Altan. Per qualche giorno la simpatica cana scorrazza nelle timeline, arf! arf!
In questa circostanza il disegnatore Alessandro Caligaris, già nostro complice in precedenti sortite, dona alla campagna un paio di disegni. Qui ne riproponiamo uno: Armando che aizza la Pimpa contro Renzi.
Alessandro ci lascerà il 30 ottobre 2018 a soli 37 anni. A lui verrà dedicato La macchina del vento di Wu Ming 1.
Ormai Renzi può fare comparsate solo al chiuso, in teatri o sale congressi, davanti a pubblici selezionati. Le volte in cui riesce a parlare all’aperto, lo fa dietro fittissime schiere di celerini, che spesso manganellano i contestatori. Come avviene il 3 maggio alla Festa dell’Unità di Bologna, dove rimangono ferite tre persone, in particolare un’insegnante, a cui viene spezzato un braccio. Diventa virale una foto che la mostra bloccata a terra, dolorante, ai piedi di un celerino. La porterà via un’ambulanza.
Negli ultimi giorni di luglio fa notizia un’altra Festa dell’Unità: quella di Roma, disertata da Renzi all’ultimo minuto. Niente comizio di chiusura, per paura di eventuali fischi. Noi ospitiamo su Giap una riflessione di Christian Raimo che si conclude così:
«Non si capisce se sia una strategia comunicativa o l’assecondare un lato caratteriale allergico al conflitto. Quel che è certo però è che c’è molto di antidemocratico in tutto questo. Oltre a mostrare una debolezza che non riguarda più la sua persona soltanto ma anche il suo ruolo.
Un leader deve rispondere del suo operato, deve sapere affrontare le contestazioni, deve saper rispondere alle critiche, e deve saperlo fare anche in piazza. Non solo in modo unidirezionale, attraverso Twitter, le newsletter e la stampa a lui favorevole.»
La nostra impressione è che, tra la crisi post-2008, la fine della “Seconda Repubblica” e il crescente parossismo della consumer culture, il ciclo di logoramento del politicante usa-e-getta si sia fatto più rapido, e la qualità del prodotto più scarsa. Lo abbiamo scritto su Twitter già a novembre, definendo il renzismo «marcio».
Solo che alla disfatta referendaria del dicembre 2016 mancano ancora due anni, e i fan di Renzi vivono in una filter bubble, avulsi da qualunque conflitto reale. Ottusi e brevimiranti, dicono che #Renziscappa è un’idiozia, che a contestare sono «solo quattro gatti» ecc. Fidandosi dei sondaggisti e di una cronaca politica autoreferenziale, credono Renzi fortissimo e destinato a governare molto a lungo. «Alle Europee ha preso il 40%», ripetono, senza rendersi conto che il dato era dopato dall’astensione, che contro Renzi e le sue «riforme» sta montando un rancore trasversale, che il loro beniamino sta andando a spataccarsi contro un muro.
Nel mentre, @figuredisfondo supera se stesso, producendo una bellissima storymap di #Renziscappa, quasi un webdocumentario che mette in fila – con descrizioni, foto e video – i pacchi tirati da Renzi e dai suoi, le piazze disertate, le fughe dalla gattaiola per evitare incontri sgraditi.
Renzi arriva al referendum costituzionale dopo aver collezionato ben 132 punti rossi sulla mappa.
E perde malamente.
E scappa.
N.B. Per analogia, da #Renziscappa è derivato #Salviniscappa. La sua primissima apparizione è datata 8 novembre 2014.
4e. Inchieste: #LaparolaconlaF e «CasaP(oun)D»

Il 20 gennaio 2015 leggiamo un titolo di Repubblica nel quale l’antifascista cremonese Emilio Visigalli risulta essere stato aggredito non da cinquanta fascisti ma da cinquanta «estremisti di Casapound». Viene da pensare che esistano «moderati di Casapound»… Al volo twittiamo:
«La parola proibita inizia con F. Non si può dire né scrivere. Se si usa il nome tocca ammettere che esiste la cosa.»
Da quel momento l’espressione «la parola con la F» – ironico calco dall’inglese «the F word», cioè Fuck – è usata da diversi commentatori per riferirsi al termine “maledetto”, quello che giornali, tv ed esponenti politici nascondono a forza di eufemismi, perifrasi e stratagemmi vari. Nell’informazione italiana gli squadristi diventano «balordi», «tifosi» o «movida violenta», le aggressioni fasciste sono «risse», gli atti di intimidazione razzista sono «bravate», i tentativi di pogrom sono azioni di «cittadini esasperati» ecc.
Amedeo Mancini, che ha ucciso a cazzotti Emmanuel Chidi Namdi ed era un noto frequentatore di Casapound, è sempre chiamato «ultrà della Fermana». E Gianluca Casseri, autore della strage di Piazza Dalmazia a Firenze, ideologo di ultradestra e anche lui frequentatore di Casapound? Soltanto un pazzo solitario. Nel 2011 sul suo raid omicida si sono scritti centinaia di articoli, e praticamente in nessuno era chiamato «fascista».
Nell’aprile 2017, in collaborazione con Selene Pascarella, lanciamo l’hashtag #laparolaconlaF. Serve a segnalare e raccogliere esempi di giravolte, piroette e acrobazie eseguite dai media pur di non chiamare «fascisti» i fascisti. Perché c’è del virtuosismo: in un’occasione, pur di non chiamare «fascisti» due fascisti, Repubblica-Bologna li chiama «Bonnie e Clyde».
In Italia la narrazione mainstream è sempre stata quella degli «opposti estremismi», ma a partire dagli anni Novanta le cose sono peggiorate. Si sono sdoganati spezzoni di «postfascismo» sempre meno «post» e sempre più fascismo: prima quelli che han fatto la presunta «Svolta di Fiuggi» (AN); poi quelli che l’hanno fatta ma si sono pentiti (Fratelli d’Italia); infine, quelli che nemmeno l’hanno fatta (Casapound et similia). Intanto la Lega, che già era un partito pervaso di razzismo, nel passaggio dall’era Bossi all’era Salvini si rivela sempre più esplicitamente di estrema destra.
Mentre accade tutto questo, il centrosinistra prima e il PD poi si baloccano con idee paracule e tossiche come la «memoria condivisa», cedimento culturale che apre un fontanazzo dopo l’altro nel malconcio «argine antifascista», e hai voglia a correre di qua e di là per metterci sopra sacchi di sabbia, siamo in pochi!
Lungo quasi tutto lo spettro dell’offerta mediatica e politica, il linguaggio si adegua a quello che Sergio Luzzatto ha chiamato «nuovo senso comune post-antifascista». Chi segnala il ricorrere di imboscate, pestaggi e scorribande neofasciste è trattato con fastidio e sarcasmo, si sente dire che il suo è «antifascismo in assenza di fascismo» – perché «il fascismo è finito nel 1945!» – e si becca citazioni a raffica – decontestualizzate o del tutto fake – di Voltaire, Churchill, Flaiano, Pasolini…
Il lancio dell’hashtag #LaparolaconlaF aiuta Selene a scrivere un’inchiesta che riteniamo cruciale. Esce su Giap il 24 aprile col titolo: «Il format con la F. L’omicidio di #Alatri e la violenza fascista che i media preferiscono ignorare».
Al centro della trattazione c’è uno dei più recenti episodi di “negazionismo”: intorno alla morte del giovane Emanuele Morganti – pestato a sangue la sera del 24 marzo di fronte al club Mirò di Alatri, provincia di Frosinone – sono vistose le tracce di subcultura fascista, in una variante borderline a cavallo tra violenza nera e fascinazione per il crimine organizzato. Sono vistose, eppure sono apparse nelle cronache solo a sprazzi, per esser quasi subito rimosse dal quadro. Reinserendole, esplorandole e collegandole ad altri fatti messi in fila grazie a #LaparolaconlaF, Selene scrive un pezzo a tutt’oggi fondamentale, uno dei più intensi mai apparsi su questo blog.
A dicembre dello stesso anno, mentre si avvicinano le elezioni politiche del 2018, chi appoggia il bigio governo Gentiloni ha bisogno di una “causa” che scaldi i cuori infreddoliti. Quando, nel giro di pochi giorni, Veneto Fronte Skinhead irrompe in un’assemblea antirazzista a Como e Forza Nuova fa un presidio con fumogeni sotto la sede romana di Repubblica/Espresso, all’improvviso scompare ogni pudore o reticenza: ecco comparire, come per magia, la parola con la F.
A ‘sto punto ce lo tirano proprio fuori dai polpastrelli, il pezzo che pubblichiamo su Giap col titolo: «Toh, i fascisti! Tra allarmi tardivi e inviti all’ammucchiata, con le elezioni dietro l’angolo».
⁂
In quell’articolo, tra le altre cose, ricordiamo alcuni dei (numerosi) episodi di collaborazione, concordia e corrispondenza d’amorosi sensi tra esponenti del PD anche illustri – politici e amministratori di rilievo – e neofascisti di CPI, Forza Nuova e Lealtà Azione (più qualche cane sciolto). Ospitate reciproche, cerimonie fatte insieme, aperitivi, selfie con abbracci e sorrisi, sale concesse da sindaci PD per eventi antisemiti…

Calembour e immagine non sono nostri, ma non ricordiamo più dove li trovammo. Fatevi avanti e vi metteremo nei creditz.
Su questo fenomeno, insieme al gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki, curiamo da tempo un’ampia rassegna intitolata «CasaP(oun)D», anche in questo caso grazie a Twitter e a una vasta comunità di persone. Abbiamo cominciato raccogliendo notizie in un lunghissimo thread su Twitter, poi abbiamo fatto uno storify linkato da Giap. Ci siamo già fatti capire: anche in questo caso, la morte di Storify fa perdere una bella fetta di informazione.
Avendo tempo, la rassegna si potrebbe ricostruire: quasi ogni suo elemento è ancora disponibile. Molte storie erano uscite sui giornali. Purtroppo, però, c’erano anche nostri testi di accompagnamento, con brevi riflessioni sulla «memoria condivisa», su cos’è stato il renzismo e quant’altro. Quelle parti andrebbero riscritte da capo.
Ad ogni modo, anche senza la rassegna, c’è un sacco di materiale facilmente segnalabile. L’inchiesta, durata un paio d’anni, è stata ripresa su alcuni giornali, ha generato interviste e discussioni, è stata integrata da commenti in giro per la rete…
■ Il 31 agosto 2017 Radio Popolare intervista Wu Ming 1 su «CasaP(ound)D», mettendogli di fronte un imbarazzato Emanuele Fiano. All’inizio del programma, Chiara Ronzani legge una sfilza di episodi tratta dallo storify.
–
■ La radio ci contatta perché abbiamo appena creato grattacapi al PD nazionale, facendo notare che il PD abruzzese ha qualche problema. Certi suoi amministratori, infatti, risultano in amichevoli rapporti con Forza Nuova e con un gruppo neonazi chiamato “Nuove Sintesi”.
Siamo partiti da un episodio accaduto a Nereto, nel teramano, poi abbiamo allargato il raggio e scoperto che l’affaire è più grosso e la situazione più incancrenita. Citiamo da un nostro post di approfondimento:
«Nuove Sintesi e Forza Nuova hanno ottenuto più volte pure la sala consiliare del comune limitrofo, Bellante, anch’esso amministrato dal PD. Si trovano parecchie delibere di concessione dal 2015 a oggi – ecco le 8 dell’ultimo anno – per iniziative nettamente caratterizzate (basta vedere certe locandine). Nella sala consiliare si sono presentati saggi con titoli come “Logiche olocaustiche. I protocolli dei Savi Anziani goym”.
Si trova addirittura una foto di gruppo risalente al 2012: sindaco e assessora alla cultura in posa, sorridenti, accanto ai neofascisti.»

Foto di gruppo risalente al 2012: sindaco e assessora alla cultura del comune di Bellante (TE) in posa, sorridenti, accanto a esponenti di Forza Nuova e dell’associazione Nuove Sintesi, oggi parte del network neonazista Lealtà Azione. Il luogo è la sala del consiglio comunale, più volte concessa ai neofascisti per una loro iniziativa.
■ Una delle parti più apprezzate di Giap è il box «Hanno detto di noi». Scorrendo il pot-pourri di frasi gentili sul nostro conto, si trova un’intemerata dell’oggi ex-sindaco di Predappio Giorgio Frassineti (PD). Frassineti, gradito ospite a un convegno co-organizzato da due associazioni del network Lealtà Azione, non ha gradito il fatto che ce ne siamo accorti e abbiamo fatto uscire la notizia.
■ All’inchiesta «CasaP(oun)D» dedica un articolo panoramico anche il settimanale Left.
■ Nonostante il PD, per fare opposizione al governo «gialloverde», ricorra a una retorica blandamente antifascista, nel 2018 l’andazzo prosegue. In ottobre segnaliamo su Twitter che Gero Grassi, ex-deputato PD e membro della segreteria nazionale del partito, è stato ospite di Casapound Piacenza il 29 settembre. Il giorno dopo, a Roma, il PD ha manifestato «contro tutti i fascismi».
Passano pochi giorni ed Ermete Realacci, ex-deputato PD e presidente onorario di Legambiente, è relatore a un convegno organizzato a Roma da Casapound.
«CasaP(oun)D» è un’inchiesta che senza Twitter non sarebbe esistita. Tutto materiale reperito e segnalato dalla community. Ma in questo periodo noi stiamo già annaspando. Usare Twitter ci costa sempre più fatica.
5. Stare su Twitter? La lunga crisi
5a. Twitter cambia a colpi di default power
Nel corso degli anni Dieci Twitter cambia gradualmente. O meglio, cambia a scossoni, ma inavvertiti dai più. Uno sciame sismico reso normale dal default power. Come scrive il gruppo di ricerca Ippolita, quest’ultimo è
«il potere di cambiare la vita online di milioni di utenti cambiando pochi parametri […] Al prossimo login, il nostro profilo online potrebbe essere molto diverso da come lo conosciamo: un po’ come se, rientrando a casa, scoprissimo che l’arredamento è cambiato, le cose non stanno più al loro posto. Questo è il presupposto che dovremmo sempre tenere presente quando parliamo di reti di massa: nessuno di noi vuole essere parte della massa, ma quando usiamo queste reti, siamo la massa. E la massa è soggetta al default power.»

Dick Costolo
Nel settembre 2009 Dick Costolo diventa direttore generale di Twitter. Costolo ha lavorato a Google, e il modello di business che ha in mente per Twitter è in buona sostanza quello che ha fatto le fortune dell’azienda di Mountain View: pubblicità personalizzata e “micropersonalizzata” grazie al data mining.
Per far passare del tutto quel modello, Costolo dovrebbe essere il CEO, l’amministratore delegato, mentre è “solo” il COO, Chief Operating Officer. In questa fase, il CEO di Twitter è il già citato Evan Williams. Ad ogni modo, già dalla sua posizione Costolo inizia a smuovere le acque. Anzi, a scaldarle.
A partire dal marzo 2010, è possibile aggiungere ai propri tweet la geolocalizzazione. Che è di dubbia utilità per chi scrive, ma è preziosa per il data mining.
Nell’aprile 2010 Twitter compra il già citato Tweetie, client creato dal poco più che ventenne Loren Brichter. Brichter è l’inventore della funzione pull-to-refresh [Fai scorrere per aggiornare], che Twitter aggiunge alla propria app mobile ufficiale.
Le conseguenze a lungo termine saranno enormi: il gesto del pull-to-refresh è lo stesso del giocatore che aziona la slot machine, è pura gamification. Il segreto sta nella «ricompensa variabile intermittente»: quando muovo il dito per aggiornare, non so cosa apparirà sullo schermo. Potrebbe essere roba noiosa, insignificante, oppure una novità eccitante. È questo non-sapere, questa curiosità a tenermi agganciato, a dare dipendenza. Intervistato dal Guardian nel 2017, Brichter si dirà
«perplesso per la longevità [del pull-to-refresh]. In un’era di notifiche push, le app possono aggiornare il contenuto in automatico, senza che l’utente debba far niente […] Invece sembra avere una funzione psicologica: dopotutto, le slot machine sarebbero meno intossicanti se i giocatori non tirassero la leva di persona. Brichter preferisce un altro paragone: è come il ridondante tasto “Close door” in alcuni ascensori le cui porte si chiudono da sole. “Alla gente piace pigiarlo” […] “Il pull-to-refresh dà dipendenza. Twitter dà dipendenza. Non va bene. Quando ci lavoravo sopra, non ero abbastanza maturo per rifletterci sopra. Non dico di essere maturo oggi, ma un po’ più di allora sì, e mi rammarico per i lati negativi”.»
Il 14 settembre 2010 un campione random di utenti si trova di fronte una nuova interfaccia, che l’azienda chiama «New Twitter». Non è solo una questione estetica ed ergonomica, ci sono svariate nuove funzioni. Ad esempio, puoi vedere foto e video direttamente nel tweet che li linka. Prima vedevi un URL di Twitpic o di YouTube, e dovevi cliccarlo. Dopo il test, «New Twitter» diventa la nuova interfaccia.
Nell’ottobre 2010, Dick Costolo diventa amministratore delegato. Lo stesso mese, Twitter comincia a proporre agli utenti i «promoted accounts».
Dal maggio 2011 si possono caricare i video direttamente su Twitter. È stato avviato, all’insaputa della maggior parte degli utenti, un processo di centralizzazione e monetizzazione della piattaforma.
In che senso centralizzazione? Nel senso che occorre una stretta: basta coi client esterni, con l’accesso all’API da parte di smanettoni terzi. Bisogna riportare tutto sulla piattaforma, perché è lì che vanno visualizzati gli annunci pubblicitari, lì che va implementata l’estrazione di dati.
Nel 2012 Twitter “congela” la propria API per gli sviluppatori esterni. Vale a dire: non permetterà loro di accedere alle nuove funzioni che saranno via via introdotte. È un modo di scoraggiare la community, che infatti, frustrata, pian piano si dilegua. Svariate app terze legate a Twitter moriranno di morte più o meno lenta, come Twitpic nel 2014.
Nell’agosto 2013 viene introdotta la linea verticale azzurra che connette i tweet evidenziando le conversazioni. Il messaggio è chiaro: non è più come una volta, ormai Twitter è un forum, discutete. Il mezzo si fa sempre meno estroflesso, ogni decisione è imposta in un’ottica avvolgente e cooptante.
Nell’ottobre 2013 un nuovo annuncio: le timeline saranno «more visual», maggiormente incentrate su foto e anteprime di video.
Il 7 novembre 2013, Twitter esordisce come società quotata in borsa. Quel giorno, Dorsey e Williams diventano miliardari.
Alla fine di agosto del 2014 l’annuncio più clamoroso: la timeline di ciascun utente non sarà più disposta in ordine meramente cronologico, com’è stato dall’inizio, ma in ordine «algoritmico», cioè filtrato e personalizzato, ufficialmente «to increase the relevance for users».
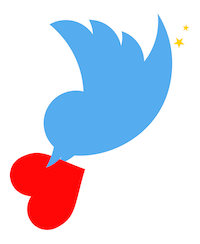 Nel marzo 2015, ancora default power: la stellina dei «Preferiti», che l’utente poteva usare in almeno due modi – segno d’apprezzamento o semplice segnalibro – viene sostituita da un cuoricino rosso, chiamato esplicitamente «like»: «We’ll be calling them likes». In realtà, è addirittura un «love», è ancora più connotato.
Nel marzo 2015, ancora default power: la stellina dei «Preferiti», che l’utente poteva usare in almeno due modi – segno d’apprezzamento o semplice segnalibro – viene sostituita da un cuoricino rosso, chiamato esplicitamente «like»: «We’ll be calling them likes». In realtà, è addirittura un «love», è ancora più connotato.
In una sorta di excusatio non petita, Twitter dichiara: «puoi dire molte cose con un cuore». Ma l’impoverimento semantico è evidente. In linea di principio nulla impedisce di usare il cuore come segnalibro, ma chi viene “cuorato” non potrà che interpretarlo come un like.
Gran buridone, proteste diffuse. La risposta «keep star» vince ogni sondaggio sulla piattaforma. Moltissimi utenti denunciano la «facebookizzazione» e dichiarano che non useranno mai la nuova feature. Ma col tempo si abitueranno.
Il termine «facebookizzazione» genera un paradosso, perché è stato Facebook a copiare molte features da Twitter: gli hashtag, per dirne una sola. Ora la direzione sembra essersi invertita.
E il “bello” è che tutto ciò non si dimostra nemmeno redditizio. Forse c’è qualcosa nell’architettura di Twitter, nel suo nocciolo concettuale, che resiste alla monetizzazione, perché le cose non vanno granché bene. Costolo subisce pressioni dagli azionisti, entra in conflitto con il resto del consiglio d’amministrazione, e nel giugno 2015 rassegna le dimissioni. Al suo posto rientra Dorsey, che però, almeno per il momento, non imprime alcuna svolta. Le implementazioni procedono nel solco di prima.
Nel novembre 2017, un nuovo shock: si passa da 140 a 280 caratteri, sempre per rendere più agevole il discutere. Ma su Twitter discutere non sarà mai agevole. L’irruenza e la caoticità del flusso non possono che rendere ogni discussione ricorsiva, vale a dire: continua ad arrivare nuova gente, ripercorrere thread lunghi e ramificati è una rottura di balle, perciò si interviene senza aver letto, costringendo chi stava discutendo a ripetere le premesse, col risultato che si resta tutti bloccati sull’ABC. È una danza immobile.
Anche quando cerchi di costruire con pazienza un thread, molti replicano prima che il filo abbia terminato di dipanarsi, spezzando la continuità del discorso, creando una sottodiscussione basata su una premessa incompleta, pregiudicando la comprensione del ragionamento per chi usa quell’entry point. Oppure, anche a thread già completato, si legge solo il primo tweet e si parte per la tangente. Più o meno come su Facebook.

Chris Wetherell
Anche la condivisione si fa sempre più compulsiva e frettolosa. E qui si affaccia un altro “pentito”, Chris Wetherell. Faceva parte del team che creò il bottone del Retweet. L’articolo di Buzzfeed che riporta la sua autocritica contiene anche molte scempiaggini snob e luogocomunismi, roba da Augias o Michele Serra, ma non c’è troppo da scavare per trovare il punto della questione:
«Dovendo copiare e incollare, la gente dava un’occhiata a quello che condivideva, e ci pensava sopra, almeno per un momento. Quando arrivò il bottone Retweet, quell’attrito diminuì. L’impulso scavalcò quel livello minimo di riflessione che prima era parte del condividere.»
Con la fretta fottuta, ovviamente, aumentano le incomprensioni e aumenta l’hate speech, fomentato da Trump in giù. Perché in questa merda Trump ci sguazza. E se persino il politico più potente della terra non è altro che un troll di Twitter, perché dovrei comportarmi io in modo responsabile?
È così che, nel periodo 2016-2018, Twitter – anche in questo accomunato a Facebook – subisce sempre più critiche per l’incapacità o non-volontà di sradicare dalla piattaforma notizie false e propaganda d’odio.
Nella twittersfera italiana un tale andazzo, rafforzato dall’egemonia televisiva di cui si parlava prima – cioè dal fatto che la community di Twitter si fa dettare l’agenda dalla tv mainstream, importando tutto ormai senza filtri, dal gossip più demente al «sovranismo» più nauseabondo –, un tale andazzo scatena ogni sorta di riterritorializzazioni identitarie. Accanto ai nomi di sempre più utonti appaiono bandiere nazionali: ecco il tricolore: 🇮🇹! Io sono questo, sono italiano, prima quelli come me! Con me o contro di me! Non basta un tricolore? Ne metto tre! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹Anzi, ne metto sette! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Ma sì, fai vedere che abbondiamo! Abbondandis in abbondandum! Ah, sì? Allora io vi rispondo con la bandiera dell’UE! 🇪🇺 Io invece non voglio lasciare il tricolore ai sovranisti, metto quello e anche la bandiera dell’UE! 🇮🇹🇪🇺
Siamo ormai all’asilo Mariuccia, ma in versione Signore delle mosche.

Putrefazioni identitarie.
Nel 2019 lo stesso Jack Dorsey sembra rendersi conto che l’evoluzione di Twitter negli anni Dieci ha “snaturato” il mezzo e creato più problemi che vantaggi, e sembra correre tardivamente ai ripari, riaprendo l’API agli sviluppatori indipendenti e annunciando un futuro “ri-decentramento” di Twitter. Il progetto si chiama BlueSky. Riaprire la stalla dopo che i buoi sono morti asfissiati?
L’annuncio di Dorsey è accolto con scetticismo da chi si occupa di network decentrati.
⁂
E noi, nel frattempo?
Nel gennaio 2012 abbiamo un momento di sconforto e tentiamo di andarcene da Twitter, o meglio, di ridurre al minimo le interazioni.
Succede dopo l’affaire NoTav/#Bobbio, un’esplosione di isteria di massa contro i No Tav, basata su una notizia falsa diffusa senza la minima verifica: «i No Tav hanno profanato la memoria di Norberto Bobbio!!!1!!! Hanno scritto sui muri “BOBBIO SERVO”!!!1!»
Una vera e propria canea incitata per ore da due “influencer” dichiaratamente del PD: il torinese Enrico Sola aka @suzukimaruti e il romano Filippo Sensi aka @nomfup. Quest’ultimo ha esortato le masse indignate a mandare nei TT l’hashtag #Bobbio, per denunciare l’inaudita violenza No Tav.
Due anni dopo, Sensi diverrà portavoce di Renzi, e nel 2018 deputato del PD.
Un episodio che sembra “minore”, ma è una piccola pietra miliare nella storia dei social italiani, una delle prime “pagine nere” di Twitter.
Non siamo gli unici a notare che da qualche tempo la situazione su Twitter è peggiorata: sono aumentati i flame e c’è grande disponibilità al linciaggio. Su Giap riassumiamo l’ultima vicenda e facciamo alcune considerazioni:
«C’è chi ha detto che un social network come Twitter è solo lo specchio della società. La metafora ci sembra inappropriata: uno specchio non accelera la tendenza all’entropia della realtà che riflette. Con la sua forsennata, ansiogena pulsione all’immediatezza degli scambi, un mezzo come Twitter, se usato assecondandone in toto la logica anziché contrastandola con l’autodisciplina e la creatività, diventa peggiorativo della realtà che trova, ne amplifica i tratti più retrivi. Se la parola fugge in avanti prima che si formi il pensiero, se quel che conta è l’iper-velocità nel rispondere, fatalmente si tira fuori il peggio.»
L’idea è quella di usare Twitter solo per segnalare link, e spostare le interazioni su un’altra piattaforma di microblogging, Identi.ca. Ma, per varie ragioni, l’esperimento non funziona. Senza proclami, torniamo a interagire su Twitter.
Passano gli anni. Noi continuiamo a fare esperimenti, ma il default power impone le trasformazioni appena passate in rassegna. Su alcune riflettiamo, su altre no: ne capiremo l’impatto soltanto anni dopo.
Intanto, siamo sempre meno bravi. Meno bravi a resistere alla pressione, alla spinta inerziale degli algoritmi.
In parole povere, ci ritroviamo sempre più spesso a discutere direttamente su Twitter.
Il che, alla lunga, impoverisce Giap.
 5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap
5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap
Ormai molti potenziali post rimangono in forma di thread su Twitter. Questi sono solo alcuni dell’ultimo anno:
■ La critica al “clicktivism” e all’operazione di marketing politico dietro l’hashtag renziano #Facciamorete.
■ Un’analisi delle dichiarazioni rese da Cesare Battisti il 23 e 24 marzo 2019, basata sulla lettura dei verbali dei due interrogatori. Thread preceduto da un altro dove ricapitolavamo e ribadivamo la nostra posizione sul caso Battisti, mai cambiata dal 2004.
■ I denti di Salvini. Riflessione sul mito dei «grandi comunicatori». Quei tweet vengono aggregati e proposti in forma più leggibile da Giulio Cavalli, ma potevano tranquillamente diventare un post di Giap.
■ Di un thread lungo e frastagliato sulla decontestualizzazione e demonizzazione di Piazzale Loreto, risalente al novembre 2018, ci eravamo addirittura scordati. Grazie ad Andrea Meloni per avercelo ricordato e averlo composto in un unico testo.
Seguire le nostre regole di sempre non basta più, i paletti vengono scalzati. I follower sono aumentati a dismisura, e se consideriamo che non ci interpellano solo i follower… Menzioni, menzioni, menzioni. Veniamo bombardati di menzioni.
Ci proviamo, a mettere paletti nuovi: nel 2018 imponiamo una stretta draconiana alle notifiche, ma nemmeno quello basta. Ci rendiamo conto che continuare a “spazzolare contropelo” la logica del mezzo equivarrebbe a ottenere risultati minimi col massimo sforzo. Continuare divorerebbe sempre più tempo ed energie.
Tempo ed energie che non abbiamo. Il nostro mestiere non è stare su Twitter. Noi siamo scrittori di libri. Scrittori di libri che girano per l’Italia, fanno presentazioni, conferenze, corsi, seminari. E hanno un blog che si chiama Giap. Un blog sul quale vogliono tornare a lavorare come meglio possono.
Non abbiamo mai voluto prendere un social media manager, un po’ perché non avremmo la pilla per pagarlo, ma soprattutto perché non avrebbe senso, non saremmo noi, nuèter, nuàltar, 我们.
Per tutto il 2019, il burnout è sempre dietro l’angolo.
A un certo punto, basta, decidiamo di staccare.
Perché l’amore è fortissimo, ma il corpo no.
♫ Sappiamo ingoiare tutti i malanni tutti gli sgarbi tutti i guai e i dolori e i vecchi rancori che arrugginiscono queste ossa fatte di gesso…
♫ L’amore è fortissimo sa sopportare occasioni mancate disperazione e offese e una lacrima che a volte s’infrange su questa terra dove passa un’onda…
♫ L’amore è fortissimo, il corpo no.
♫ L’amore è fortissimo, il corpo no.
♫ L’amore è fortissimo, il corpo no.
5c. L’ultima performance: Attacco psichico!
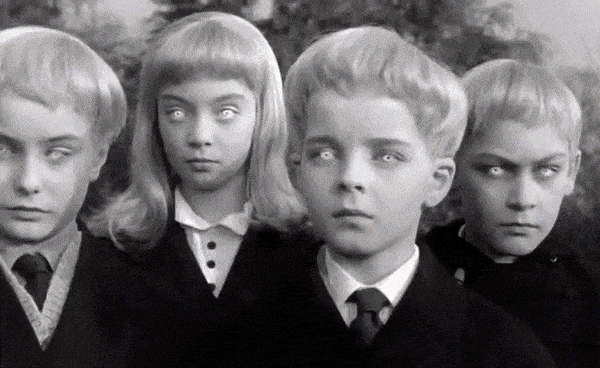
«Una ventina di secondi a caso di attacco psichico», 19 agosto 2019.
La nostra ultima performance è un addio e un seppuku, come ai tempi del Luther Blissett Project. È proprio a una vecchia tattica blissettiana che ci ispiriamo, e il 9 agosto parte l’«Attacco psichico con destinatario implicito». Per il momento, non lanciamo alcun hashtag.
Tutte e tutti hanno in mente chi sia, quel destinatario, ma approvano il tacito patto di non nominarlo. I riferimenti a quanto sta accadendo in Italia in quei giorni sono comprensibili senza bisogno di spiegazioni. Qualunque spiegazione rovinerebbe la performance.
Il 14 agosto, tweet dopo tweet, cominciamo a comporre un racconto. Inizia in medias res ed è narrato da un futuro imprecisato.
«Al sesto giorno di attacco psichico, per il destinatario implicito fu l’inizio della fine. Telepaticamente, tutte e tutti si spronarono a continuare. L’onda mentale crebbe.
Era la vigilia di Ferragosto, e nelle menti degli psychics apparve a grandi lettere una parola: BUON ANNO. – Ma sono due parole… – obiettò qualcuno. – Perché l’Uno diventa Due. – fu la risposta. L’onda mentale era squassante.
Il giorno dopo, l’onda mentale si era fatta ambiente. L’attacco psichico era l’andazzo delle cose, e tutte e tutti – volenti o nolenti – sembravano parteciparvi. Nondimeno, gli psychics si dissero (o meglio, si pensarono): – Continuiamo.»
Su Twitter c’è ormai più disgregazione che aggregazione, ma l’attacco psichico aggrega. Centinaia di persone, che in pochi giorni diventano migliaia, partecipano a un gioioso détournement di gran parte della cultura di massa (almeno) dell’ultimo secolo. Migliaia di immagini – solo qui ce n’è mezzo migliaio in un’unica schermata – trasformate in convogliatori di energia malevola accompagnano lo svolgersi di una farsesca crisi di governo.
«L’attacco psichico sembrava trascinare nel proprio flusso l’intera cultura; riemergevano dal passato segni, memorie, riferimenti; ogni cosa – il titolo di un libro o di un film, o il dettaglio di un quadro – suonava allusiva e diretta al bersaglio.
Ogni cosa era un nuovo possibile: appariva nel mondo ed esisteva come parte del flusso, conseguenza dell’onda mentale. Parole e gesti. La nuova fase sembrava coincidere con l’attacco psichico […]
Il destinatario implicito, che fino a una settimana prima tutti descrivevano come invincibile, era sempre più in difficoltà. Film, fumetti, serie tv, romanzi, videogame, ogni riferimento era percussivo e lo scuoteva. I pensieri degli psychics correvano verso la scena madre.»
Il 20 agosto, #attaccopsichico irrompe nei TT al primo posto.
A settembre, smettiamo di usare Twitter.
6. Per una cartografia della nostra presenza in rete / 2
6a. La rivoluzione innanzitutto e sempre
In questi tre mesi molte persone, incontrandoci, ci hanno detto: «Mi viene ancora da taggarvi», oppure: «Ho sempre l’istinto di chiedervi qualcosa»… «Automaticamente, vado ancora a vedere il vostro profilo»… «Devo ancora abituarmi a non trovarvi più lì»…
L’abbiamo presa lunga ma eccolo, il secondo motivo per cui tre mesi fa abbiamo staccato la spina e solo adesso stiamo spiegando il perché: occorreva spezzare la dipendenza nostra e altrui, il vecchio habit di trovarci su Twitter.
Tre mesi di riposo, meditazione e scrittura non sono poi tanti, prima di rendere pubblico il resoconto di una spedizione lunga un decennio. Specialmente se, giunti alla meta, avete visto un lago vorticoso pieno di occhi, occhi che sorvegliavano dati, e sulla via del ritorno, stanchissimi, non sapevate nemmeno più quanti eravate. Chi era la presenza in più che non risultava mai, che non trovava mai corpo? Un fakebot? Il Grande Altro?
Qualcuno ci ha chiesto: perché non chiudete l’account?
Perché sono dieci anni di lavoro. Se cancellassimo l’account, distruggeremmo un colossale, variegatissimo ipertesto creato da noi e da tutti quelli che hanno interagito con noi. I nostri tweet, esperimenti e racconti sparirebbero, spezzando migliaia di scambi, centinaia di discussioni. Discussioni che, per quanto apparentemente concluse, sono ancora in divenire: chiunque può trovarle e trarne qualcosa, anche solo un po’ di ispirazione.
E adesso, come si riconfigura la nostra presenza in rete?
Sarà un caso, ma ogni volta che ci siamo posti questa domanda, tutt’intorno c’era un bordello della madonna: manifestazioni, scioperi, rivolte, rivoluzioni…
■ Tra 1999 e 2001, mentre chiudevamo il Luther Blissett Project, rinunciavamo al nome col quale avevamo firmato Q, fondavamo Wu Ming, aprivamo il sito, inauguravamo la newsletter e lavoravamo a prolungare il solco del «romanzo neostorico italiano», mentre facevamo tutto questo si alzava una marea planetaria di lotte non tanto contro la globalizzazione – «no global» lo dicevano detrattori e gonzi – ma contro la governance neoliberista della globalizzazione. Contro il comando capitalistico, insomma. A Seattle si innescò una reazione a catena, e nel nostro piccolo pure noi ne fummo parte: nel 2000 a Bologna contro l’Ocse e a Praga contro il Fmi, nel 2001 a Québec contro l’Alca e a Genova contro il G8, nel 2002 a Firenze per il Forum Sociale Europeo, nel 2003 a Roma contro la guerra in Iraq…

30 novembre 1999, «The Battle of Seattle».
■ Tra 2009 e 2011, mentre chiudevamo la newsletter, cancellavamo un indirizzario di oltre 12.000 iscritt*, aprivamo questo blog, cominciavamo a fare esperimenti su Twitter, pigiavamo sull’acceleratore degli «oggetti narrativi non-identificati» e ci gettavamo nella scrittura de L’Armata dei Sonnambuli, mentre facevamo tutto questo, intorno c’erano l’Onda studentesca (che usava anche nostri libri come scudi), vaste lotte anti-austerity in Francia e Gran Bretagna, grandi scioperi in Wisconsin – i Dropkick Murphys ne scrissero l’inno ufficioso, Take ‘Em Down – e a catena vennero le primavere arabe, le «acampadas» del movimento 15-M in Spagna, Occupy Wall Street…

Madrid, 18 maggio 2011: «Acampada Sol».
Che nel mondo nordafricano e mediorientale stesse ribollendo qualcosa ce n’eravamo accorti con mesi d’anticipo, grazie alle segnalazioni di Alain Bertho, antropologo francese specializzato in sommosse. Il 3 gennaio 2011 scrivemmo su Giap che quello appena iniziato sarebbe stato un anno di rivolte. Quando poi le rivolte scoppiarono, e in troppi presero a raccontarle in chiave tecnoentusiasta e socialmediacentrica, ci mettemmo d’impegno a smontare tali narrazioni. Ad aprile, in un intervento alla Duke University, Wu Ming 2 disse:
«Le narrazioni tecnofile – nel caso del Nord Africa – hanno avuto come effetto quello di rassicurare chi le ascoltava, di rendere la violazione della quotidianità meno dirompente. Se diciamo che in Tunisia si è sviluppata una “twitter revolution” ci sentiamo più a nostro agio che raccontando una rivolta dura, lontana dalle nostre abitudini, con gente che si brucia viva o si ribella contro il prezzo del pane e dell’olio da frittura […] Twitter e Facebook sono in un certo senso i Lawrence d’Arabia del ventunesimo secolo: porre l’accento sui social network ci dà la piacevole sensazione che queste rivolte “per la democrazia” siano un sotto-prodotto di Internet, lo strumento democratico e partecipativo per antonomasia, il quale è a sua volta un prodotto dell’Occidente. Dunque, ci diciamo, se l’Egitto si è rivoltato grazie a Internet, allora in fondo si è rivoltato grazie a noi, e tendiamo a dimenticare così che il luogo simbolo di quella rivolta è una piazza, non il cyberspazio.»

Ascolta La rivoluzione (non sarà trasmessa su YouTube) nella versione a quattro voci (Wu Ming Foundation Mix).
Qualche anno dopo ribadimmo il concetto in forma di canzone: La rivoluzione (non sarà trasmessa su YouTube), contenuta nel primo album del Wu Ming Contingent.
In Italia, il 2011 lo associamo soprattutto alla Libera Repubblica della Maddalena. Quando la cortina fumogena della propaganda anti-NoTav si sarà dissipata e la miseranda politichetta politicata non ipotecherà più i discorsi, si capirà che quella è stata una delle esperienze più importanti nella storia dei movimenti europei, e sarà storicizzata come merita.
■ Ora che, nuovamente in un passaggio di decennio, cambiamo strategia e imbocchiamo nuovi sentieri, intorno a noi il pianeta è in rivolta, e lo è da almeno un anno. Prima i Gilets Jaunes, poi Hong Kong, Cile, Haiti, Ecuador, Catalunya, Libano, Colombia, Iraq, Iran, di nuovo la Francia, e di sicuro non li abbiamo detti tutti. È la più estesa sollevazione di sempre, anche più vasta di quella del 2011. Una sorta di intifada planetaria, che si sta unendo in una tempesta perfetta alle grandi sollevazioni del nuovo femminismo globale e del nuovo attivismo climatico.

Santiago del Cile, 25 ottobre 2019, manifestazione contro il governo Piñera, la più grande nella storia del Paese.
Negli ultimi anni il populismo – in Italia nelle sue varianti grillina, renziana e fascioleghista – ha messo in scena movimenti finti, fatti di «Popoli» che in realtà erano conteggi di like sui social, accozzaglie di hashtag, percentuali in sondaggi d’opinione o procedure di voto su piattaforme sdozze di supposta «democrazia diretta». Il caudillo di turno evocava le piazze, ma erano piazze svuotate del loro senso, ridotte a scenografie, fondali per foto e video, sempre in campo stretto per farle sembrare piene, ma bastava allargare per vederle deserte, e le volte che si riempivano davvero, lo facevano per contestare e cacciare il caudillo.
Giuliano Santoro l’ha chiamata «guerra civile simulata», concetto più utile di «campagna elettorale permanente», perché nelle elezioni si è avversari, mentre nelle guerre si è nemici, e noi assistiamo ogni giorno alla produzione e riproduzione del Nemico. «Guerra civile», dunque, ma combattuta – scriveva Giuliano già nel 2013 – da un «esercito liquido», pseudo-maggioranza che da «silenziosa» è divenuta «virtuale». E che trova la sua kryptonite nella rivolta vera.
«I combattenti digitali della “guerra civile simulata” temono le strade, che hanno smesso di essere il luogo dell’incontro e dello scontro e si limitano al più a ospitare i comizi del Capo o le rappresentazioni itineranti dei suoi adepti. Quando gli capita di avere a che fare con la complessità ruvida e materiale delle piazze e delle proteste senza format, scompaiono in dissolvenza dai teleschermi.»
La rivolta vera avviene in luoghi ed è fatta di corpi, non di clicktivism. La rivoluzione non sarà condivisa sui social.
6b. Uno spazio di calma dentro l’urgenza
Forse perché galvanizzati e ispirati dalle lotte, in questi passaggi di fase abbiamo fatto ogni volta mosse controintuitive, all’apparenza autolesioniste: cambiare nome dopo un successo internazionale come Q, uccidere una newsletter ricevuta da dodicimila persone… Ma ogni volta l’energia del reset ci ha spinti avanti.
Anche uscire da Twitter è una di quelle mosse.
Ascoltando l’ultima assemblea nazionale di Non Una di Meno abbiamo sentito un’espressione molto bella: «uno spazio di calma dentro l’urgenza».
Stiamo nell’urgenza, nella temperie, nel conflitto, ma ci stiamo dalla nostra postazione, situati. Il nostro sito è questo, è Giap. Abbiamo necessità e voglia di ripartire da qui, di avviare una nuova fase di discussioni sul blog, magari a cominciare proprio dallo spazio qui sotto. È un invito a lasciare i vostri commenti, senza remore. Dopo aver letto tutto, s’intende. E lentamente.
Nel frattempo, è in corso una nuova impollinazione anemofila, diversa da quella di dieci anni fa, perché stavolta gli esperimenti riguardano in prevalenza strumenti decentrati, indipendenti, sorti dal basso.
Stiamo usando Mastodon, senza battere il tamburo, guardandoci intorno con tutta calma. Bassa intensità, vedremo come va. Siamo sull’istanza Bida, che sarebbe un’istanza bolognese ma c’è anche un tot di gente da altre parti d’Italia. Cos’è Mastodon? In cosa è diverso da Twitter? Cos’è un’«istanza»? Chi volesse saperlo, può cominciare dalla start page. Grazie a Ca_Gi, senza di lui avremmo fatto molta più fatica a orientarci nel nuovo ambiente.
 Alcuni appunti dopo i primi mesi:
Alcuni appunti dopo i primi mesi:
■ Cos’è un social network se non è un social network commerciale? Se consideriamo “lordo” un social network commerciale, una volta tolta la tara, cos’è esattamente il netto? Cosa lo definisce? A quale bisogno risponde?
■ Forse un “social” non commerciale lo chiamiamo «social» come chiamiamo «latte» il “latte” di riso, ché se lo chiamassimo in un altro modo – «bevanda» di riso, «succo» di riso… – non colmerebbe il vuoto lasciato dal latte.
■ Addestrati all’oversharing e alla pornografia emotiva, ricadiamo in certi habit e automatismi anche su una piattaforma che non ha moventi di lucro per incitarli. Disintossicarsi richiede tempo. E aiuto. Mutuo appoggio.
■ Molte e molti vivono Mastodon come il metadone dopo anni a farsi pere di Twitter. Occhio ché il metadone è comunque un oppioide.
■ È probabile che i flame, le provocazioni, il sarcasmo, il tono passivo-aggressivo, insomma le «passioni tristi» siano connaturate al concetto stesso di «social network». Concetto che si è definito e precisato sotto l’azione incessante di Facebook, Twitter, Instagram e altre macchine gamificate. Non esiste un’idea iperuranica di «Social Network», esistono solo i social network reali. La questione non è ontologica, ma fenomenologica.
■ Detto ciò, dobbiamo resistere alla tentazione di definire «pornografia emotiva» qualunque frivolezza, pausa cazzeggio o momento in cui si abbassa la guardia. Fanno tutti parte della vita. Scottati dall’oversharing intorno a noi, rischiamo di non riconoscere il semplice voler comunicare qualcosa di sé. Prassi che va depurata dopo anni di abuso pesante e continuo, ma non inibita. Condivisione disinteressata ed empatia sono irrinunciabili, pena il diventare «comunità terribile».
Su Mastodon risponderemo a chi ci interpella ma non parteciperemo a discussioni lunghe. Per quelle, come s’è detto, rimettiamo mano a Giap.
Sul nostro profilo non ci saranno bot. Per le notifiche dei post di Giap c’è un profilo a parte, Giap – Rss Bot. Non l’abbiamo aperto noi e precede addirittura il nostro arrivo in quelle lande, ma tenere i due flussi separati ci è parsa una buona idea.
Per novità, aggiornamenti e appuntamenti, come detto nella prima puntata, la cosa migliore è seguire il nostro canale Telegram.
Abbiamo ancora un canale YouTube, che abbiamo sempre usato con parsimonia, ma abbiamo appena aperto un account su Peertube, piattaforma video che gira su Mastodon, quindi a sua volta decentrata. Il primo video caricato è più che altro uno scherzo, un teaser di questo stesso post.
Coi nostri tempi, vorremmo liberarci per quanto possibile del digitale delle corporation, ridurre le occasioni in cui ci vengono ciucciati dati e vengono ciucciati a voi mentre state su Giap. Siti come Facebook, Twitter e YouTube ciucciano dati già solo seguendo link che portano là. Facebook è in grado di tracciarti anche se non hai un account. Tutti questi dati servono solo a gamificare e peggiorare le nostre interazioni e le nostre stesse vite, a farci raggiungere da pubblicità sempre più molecolari e subdole, a migliorare le prestazioni del capitalismo della sorveglianza.
Una cosa che stiamo facendo da un po’ di tempo, sia su Mastodon sia qui, è evitare di linkare direttamente YouTube. Passiamo attraverso Invidio.us, un frontend – un’interfaccia utente – per vedere gli stessi video di YouTube ma senza pubblicità, senza tracking, senza riproduzioni automatiche, senza playlist eterodirette, senza consigli tossici dell’algoritmo, senza restrizioni per paese ecc. Non è l’unica opzione, ci sono altri frontend che fanno questo lavoro, ecco una lista di risorse (grazie a xenwan per la segnalazione).
Come avrete notato, abbiamo scritto un lungo resoconto della nostra attività su Twitter senza mai linkare Twitter. Abbiamo usato screenshot oppure siamo passati attraverso Nitter. Nitter fa per Twitter quello che Invidio.us fa per YouTube: ti fa vedere i tweet e le discussioni senza che Twitter possa tracciarti, senza Javascript ecc.
Al momento le notifiche via email di nuovi post su Giap arrivano via Feedburner, che è di Google. Nel 2020 cambieremo servizio, siamo in cerca di un’alternativa non commerciale. Tranquill*, stavolta non cancelliamo l’indirizzario, lo esportiamo.
A proposito di Google, come browser consigliamo di non usare Chrome. Se può interessare, quasi tutta la navigazione necessaria a scrivere questo testo l’abbiamo fatta usando come browser Brave [ma è un progetto che presenta alcuni problemi, vedi i commenti in calce al post, N.d.R.] e come motore di ricerca DuckDuckGo. Per alcune faccende abbiamo invece usato Tor.
Per le donazioni, nel 2020 vorremmo trovare un’alternativa a PayPal, che è il fiore all’occhiello e la success story n.1 della cricca «anarcocapitalista». Basti dire che tra i fondatori di PayPal ci sono Peter Thiel ed Elon Musk…
Già che ci siamo: se qualcuno di voi vuole chiudere il proprio profilo Facebook, sappia che la cosa va fatta a puntino. In rete ci sono tanti tutorial, eccone uno fresco fresco su Bida.
A chi per ora non se la sente di chiudere gli account sui social commerciali, chiediamo di dare comunque una mano a riattivare voci e canali indipendenti, macchine di comunicazione non gamificate. Chi ha un blog e in questi anni lo ha negletto, torni a scriverci sopra e a promuoverlo, lo rivitalizzi e ne faccia l’epicentro della sua comunicazione quando ha qualcosa da dire. I social, soltanto come rimbalzo. Per le situazioni militanti, come scritto nella prima puntata, questa è una necessità vitale, ma in fondo lo è anche per il singolo individuo. Non è più tempo di essere ex-blogger.
Una nuova blogosfera post-social è possibile. Anzi, il suo formarsi è altamente probabile, mentre il futuro di Twitter è pieno di incognite e Facebook potrebbe presto restare schiacciato dal suo stesso peso. Una blogosfera diversa da quella pre-social, perché potrà avvalersi di nuovi strumenti, e perché la situazione è diversa da quella degli anni Zero.
E chi per la propria informazione pensa di dipendere ormai dai social? Ci si informa lo stesso e bene, senza FOMO e senza perdere un solo battito di cuore: i feed RSS sono l’opzione più comoda, ci sono le newsletter di siti e blog, ci sono le mailing list…
Tutto quanto appena detto, però, è poco importante senza la premessa: bisogna continuare a coniugare rete e strada. Ancora una volta citiamo l’amico Giuliano, perché l’excipit di Cervelli sconnessi fa proprio al caso nostro:
«I disertori digitali che non appartengono a nessun Popolo sanno che non esiste nessun “fuori” dalla potenza della comunicazione e che delle nuove tecnologie non si può fare a meno. Ma sanno anche che la riconquista della Rete ricomincia dalla strada.»
Compagne e compagni, Wu Ming entra nel suo terzo decennio. Cambiano gli strumenti ma la strada se n’va ininterrotta. L’amore è fortissimo ed è qui per restare.
«The radio and the telephone and the movies that we know
may just be passing fancies and in time may go
But oh, my dear, our love is here to stay
together we’re going a long, long way.»
George and Ira Gherswin, Love Is Here To Stay
Larry Clinton and His Orchestra & Bea Wain, Love Is Here To Stay (1938)
Larry Clinton and His Orchestra feat. Bea Wain, Love Is Here To Stay (1938)
* Se tutte e tutti noi persone raziocinanti avessimo dedicato a gente come Peter Thiel il 5% dell’attenzione che torme di mestatori e imbezèl han dedicato a Soros, avremmo capito meglio i processi in corso.
Sui legami tra Facebook e l’anarcocapitalismo rimandiamo alla seconda parte – soprattutto i capitoli 2, 3 e 4 – del libro di Ippolita Nell’acquario di Facebook. La resistibile ascesa dell’anarcocapitalismo, Ledizioni, Milano 2012. Da lì potete partire, e aggiornarvi sui successivi exploit di Peter Thiel. In questi giorni, manco a farlo apposta, Thiel sta combattendo dentro Facebook una battaglia politica, proprio in senso stretto. [↑ Torna al testo ↑]







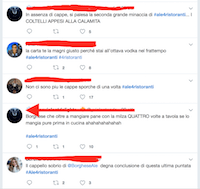


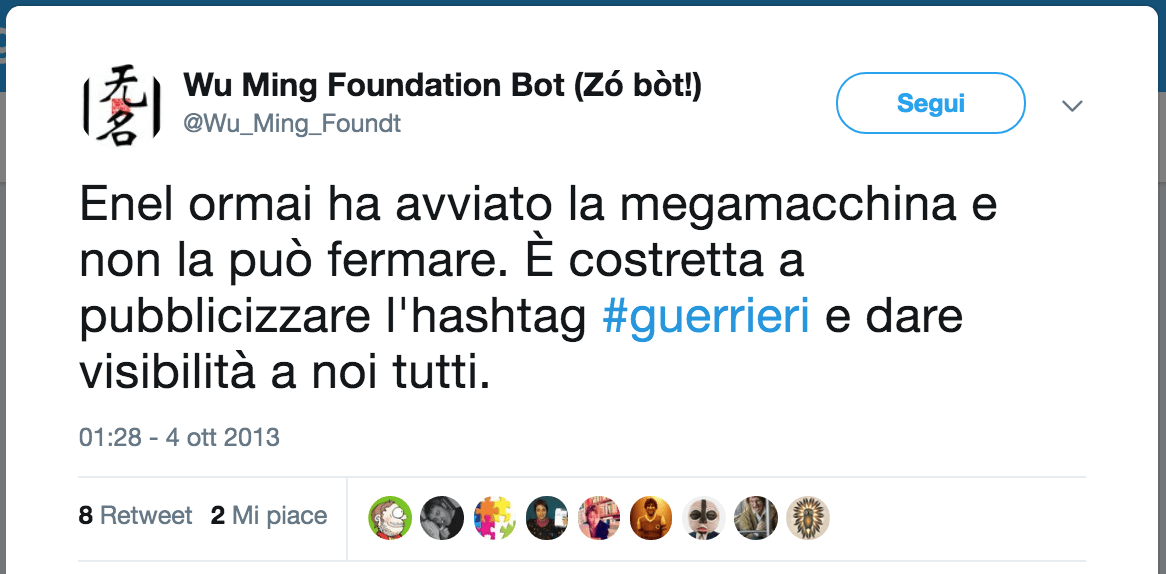
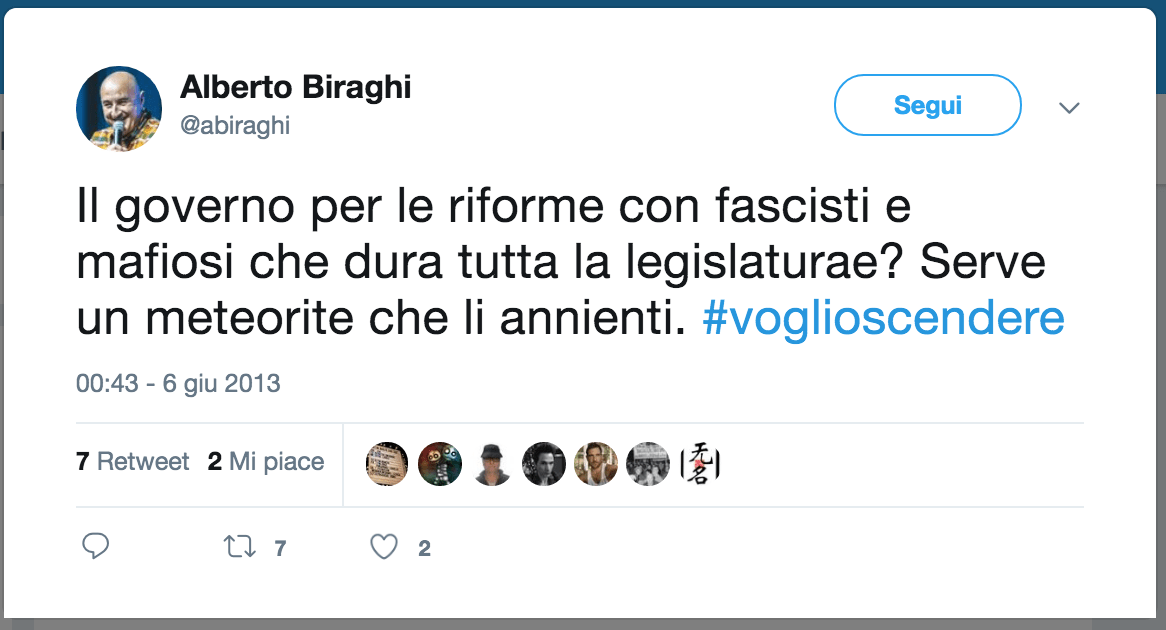

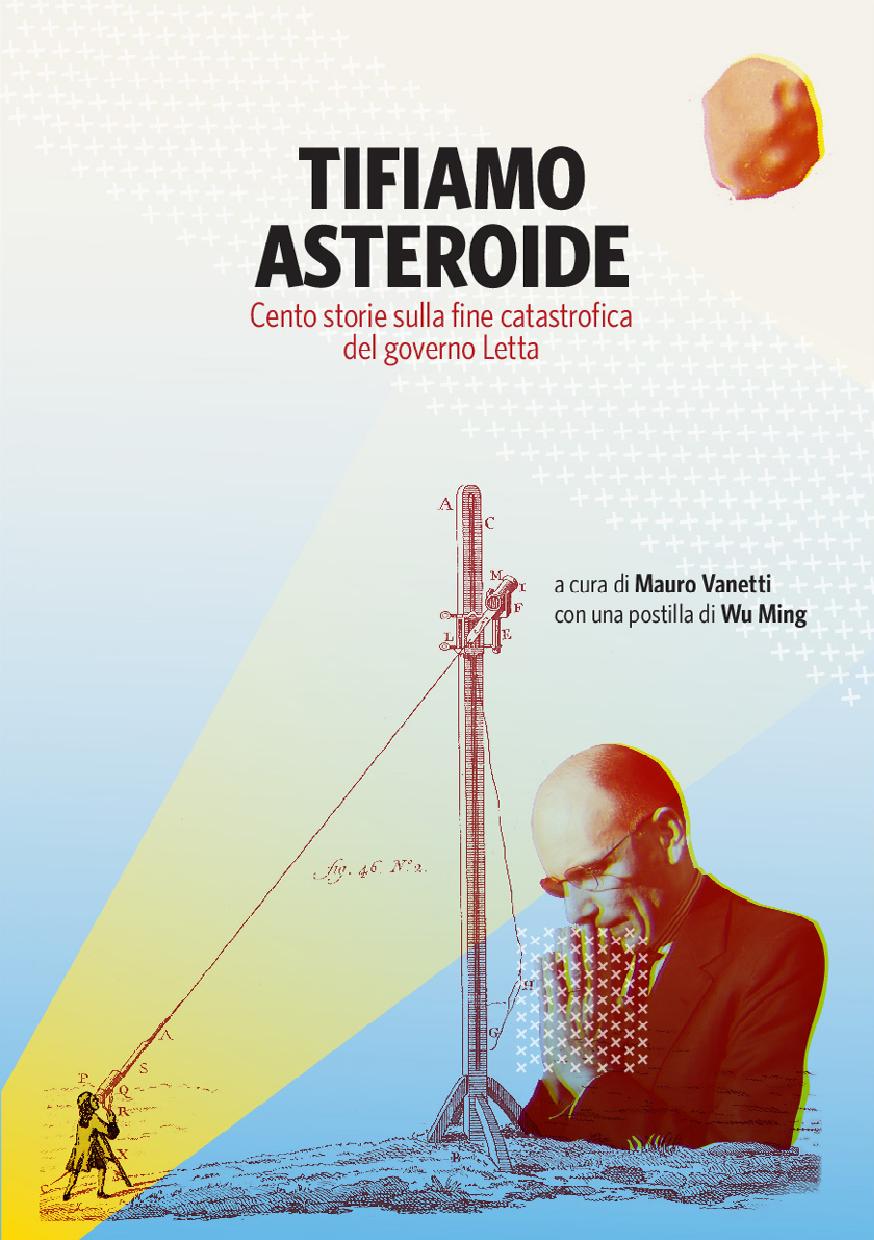
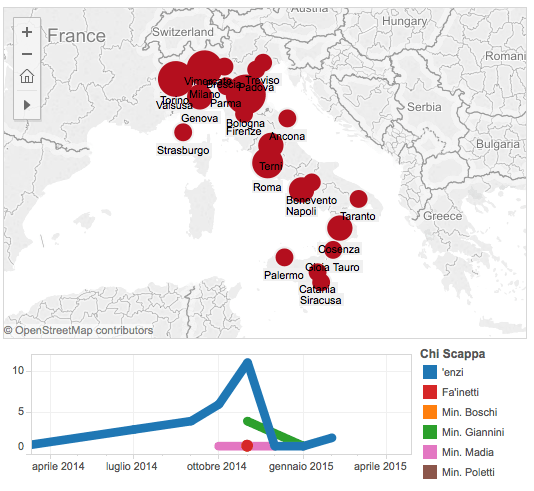








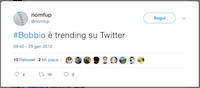
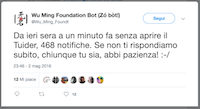
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

I corpi si parlano, anche quando non ci fanno caso, pensano ad altro, scrollano l’ultima volta (solo una, poi smetto, giuro) per vedere se dalla fottuta app(rensione) esce qualcosa di buono. Così mentre la vostra riflessione era in viaggio, ignara (ma anche no)in un altro universo lontano lontano meditavo un’uscita asocial. Alla mia maniera: a strappo, a tradimento, alla cazzo, #brucilacittà. “Per il mio 42esimo compleanno mi regalo indietro quel che resta (non molto) della mia lucidità”. Non sono solo i social, sono io sui social. Se metto in fila tutte le volte in cui ho ragionato male, ho perso il filo e la brocca, le briciole mi riportano sempre a Twitter e Facebook, a Facebook e Twitter. Su instagram faccio meno danni, ma solo perché sono vecchia, non ho capito bene come funziona. “Disattiva le notifiche, vai sui social solo una volta al giorno”. facile a dirsi, hai voglia in quanti me lo dicono. La dipendenza controllata, è evidente, non fa per me. Vado un secondo e perdo ore, nemmeno litigo tanto, è la curiosità che mi frega. Mi imbatto in troppe cose e in troppe storie e così mi sembra di non poterne fare a meno. Lo capisco e vedo solo una strada, fare saltare la strada. Ci arrivo qualche giorno dopo il compleanno, ma ci arrivo. Un breve saluto agli utenti che mi mancheranno, qualche messaggio per farmi trovare e tanti contatti persi, ma, dai, tanto stanno tutti là se li voglio trovare. Un paio di tutorial e via andare. Prima di cancellare tutto “a modino” Facebook mi chiede a bruciapelo se voglio salvare undici anni di cose, foto, persone. Dovrebbe essere l’esca fatale per riportarmi a casuccia invece è la spinta definitiva. Mi passano davanti agli occhi giorni e giorni di menate, banalità, sboronate, brividi, brividi e ciao, verso l’oblio e la mia amica vergogna intima, che è un’app gratis e personalizzata, che mi ciuccia i dati personali con massima discrezione. L’ho fatto! Wow l’ho fatto. Ricevo persino messaggi di solidarietà e RESPECT. L’ho fatto, incredibile amici, quindi non era vero che la batteria del mio smartphone faceva cagare! L’ho fatto, leggo dieci libri in una settimana. Ho la compulsione di controllare il cellulare ma con il tempo inizia a scemare. L’ho fatto e dopo un po’ seguo il compagno fidato che mi invita su Mastodon. Il metadone, ne parlano tanto male e invece… Un hashatag (mmmm il profumo degli hashtag la mattina presto) #esticazzi per dire che queste due puntate da qui sono state bellissime,piene di cose su cui riflettere senza per forza doverle spiattellare in 140 caratteri mas o meno. Ne ho parlato approfonditamente con le gatte, ci ho camminato per bene nel bosco di casa, ora le faccio scialare nel guazzabuglio serale della testa. Grazie e arrivederci nei luoghi che ci appartengono e in quelli da costruire. Siamo nati per andare in giro a cazzeggiare…
In realtà, leggendo il tuo resoconto, il tuo percorso sembra più simile al nostro che a quello di chi assume Mastodon come metadone. Noi ci siamo disintossicati con la modalità cold turkey. Mastodon arriva “dopo”, è uno strumento da esplorare, del quale capire l’utilità, mentre si riparte dopo il rehab :-)
P.S. Sarebbe interessante sentire altre storie di disintossicazione dai social: metadone, cold turkey o altro.
Nel mio post ho scritto che sto facendo le cose con calma. Ho ancora il profilo fb attivo ma non lo sto usando, lo chiuderò fra qualche settimana. Quello su Twitter credo che lo terrò ancora attivo e resterà collegato al mio blog.
Un paio di mesi fa mi sono regalato un basso elettrico. Ogni giorno suono un po’ e studio teoria della musica. Non è stata una scelta ragionata in vista della disintossicazione da social, piuttosto avevo bisogno di fare qualcosa che fosse costruttivo e che restasse interessante nel tempo. Al sodo funziona e ho banalmente scoperto che suonare uno strumento è una cosa fichissima e mi aiuta ad apprezzare ancora di più la musica che ascolto.
Sono anch’io su Mastodon. La mia e’ piuttosto una storia da (tentata) re-intossicazione social. Ero andato cold turkey cinque anni fa. Non mi e’ mai pesato molto, ero stufo da tempo. Non pubblicavo niente e vari cambi di ambiente, migrazioni, lingua, mi sbattevano in faccia continuamente l’assurdita’ della bolla. Le risposte sicure ed arroganti, che davo in pochi secondi sui social, si rivelavano dogmatiche ed accolte con alzate di sopracciglia da chi incontravo nei nuovi posti dove vivevo.
L’assuefazione e’ andata via subito e questo nuovo stato a-social e’ stato spesso incoraggiato dal “cool” che si affibia al ragazzino bizarro. O dal senso di superiorita’ di saper stare immobile a pensare in un treno mentre i sonnambuli scrollano senza fine.
Nel frattempo ho continuato a prendermi cura di un blog collettivo che e’ andato decentemente bene per un periodo. Fino a che gli altri, cioe’, postavano sui social quello che scrivevamo. Quando per varie ragioni (forse ero il solo a non avere altri mezzi per esprimermi?) sono rimasto l’unico autore, nessuno piu’ ci ha letti. E se voglio tenere un diario segreto non lo metto certo online.
Ora e’ qualche mese che mi chiedo come possa fare ad interagire online senza cascare nelle trappole di cui avete parlato gia’ bene voi ed altri. E no, non puoi andare al bar e chiacchierare, perche’ cio’ che si scrive e’ diverso da cio’ che si dice.
Sto osservando Mastodon e la faccenda che mi stupisce maggiormente e’ l’aver perso completamente la “battuta pronta” e soprattutto l’astio, mentre “voi” avete continuato ad allenarvi negli anni scorsi. Mi sembra di essere tornato su un campo di calcetto con la panza e la maglietta di Signori per guardare gli altri scheggiare impazziti con quella di Mbappe’.
Guarda, aver perso la «battuta pronta» è un’ottima cosa. Vuol dire che ti sei ripulito. La «battuta pronta» ha rotto il cazzo. La SBP (Sindrome da Battuta Pronta) è parte della FOMO: dover esserci, dover esserci subito, dover esserci subito ed esprimersi subito, dover esserci subito ed esprimersi subito in modo “arguto”, dover esserci subito ed esprimersi subito in modo “arguto” e possibilmente sarcastico/disincantato/cinico, tutto questo concatenamento è velenoso e fecondo soltanto di ulteriori passioni tristi e – diciamolo pure – di microfascismo, talvolta nemmeno micro.
La settimana scorsa ho fatto leggere la prima puntata di questo post a un mio collega su in dipartimento, uno dei pochi con cui posso parlare un po’ di tutto e non solo di lavoro. E’ più vecchio di me (che sono già abbastanza vecchio) e non ha nessuna esperienza di social network. Qualche giorno dopo mi ha detto: insomma sta roba dei social network assomiglia a come è diventato l’ambiente accademico negli ultimi anni, con gli indici bibliometrici, gli indici di produttività, i ricercatori che invece di studiare controllano compulsivamente quante citazioni hanno ottenuto l loro articoli e soprattutto quante ne hanno ottenute gli articoli degli altri. E tutti a controllarsi, a fare gli sbirri dei colleghi e poi alla fine anche di se stessi.
In effetti gli avevo mandato il link proprio sperando che sentisse la risonanza. Ovviamente non sono i social network che assomigliano al mondo accademico; è il mondo accademico che negli ultimi anni si è configurato ad immagine dei social network, sovrapponendo merda a merda. Il modo stesso in cui sono costruite le interfaccia negli archivi on-line ricalca la logica dei social network, con i numerini delle condivisioni, delle visualizzazioni, delle citazioni, dell’ h-index, del g-index, dell’ostia impestata. Tutti numerini che poi finiscono nel tritacarne degli algoritmi dell’anvur (o delle analoghe strutture presenti negli altri paesi), e che servono a determinare l’entità dei fondi, le carriere, le assunzioni. E’ un contesto in cui la “gamification” arriva agli estremi: in palio ci sono direttamente le aspettative sulla propria vita e la possibilità di realizzarle. Lo scopo evidente di questo dispositivo è obbligare i ricercatori a pubblicare il più possibile e a citarsi a vicenda, insomma obbligarli ad “aumentare le interazioni”, come si dice nel gergo dei social network, in modo da aumentare la quantità di merce-ricerca che le multinazionali dell’editoria rivendono alla stessa comunità che la produce, con profitti da capogiro. Mi sembrava interessante mettere in luce questa risonanza tra due contesti potenzialmente agli antipodi, il regno del cazzeggio e della chiacchiera arrogante, e quello dell'”austera” ricecerca scientifica. Una figura come quella di Burioni rappresenta visivamente in modo molto chiaro la sovrapposizione ormai in atto tra i due contesti.
There must be some kind of way outta here
Said the joker to the thief
There’s too much confusion
I can’t get no relief
Businessmen, they drink my wine,
plowmen dig my earth,
None of them along the line
know what any of it is worth.
https://invidio.us/watch?v=YanjY9CsPDQ
È la logica del neoliberismo, che a lungo termine è penetrata ovunque, introducendo «crediti» in ogni ambito, trasformando ogni azione in «prestazione» sul mercato, ogni interazione in competizione, e persino ogni convivialità in gara.
Pensiamo a una dimensione che di primo acchito appare lontanissima dal mondo accademico: quella del cucinare. Le gare di torte ci sono sempre state, ma l’aspetto competitivo era semi-scherzoso e in ogni caso subordinato alla dimensione conviviale, la “giuria” era più che altro una balotta di buontemponi ecc. Con l’avvento dei talent/reality-show di cucina, da Masterchef in avanti, la convivialità è stata spazzata via a favore di dinamiche spietate, para-belliche, gerarchiche, autoritarie, inquisitorie. Chi gareggia è trattato/a come una pezza da piedi, giudice e giuria giganteggiano sui comuni mortali, la competizione è durissima e alienante. E stiamo parlando di far da mangiare! La gamification neoliberista ha reso persino quell’ambito orrorifico.
Ci pensavo questa estate, a sta cosa delle gare di cucina, quando Luchino raccontava della gara di zuppa di pesce a Banja Luka: in palio c’era una capra, e il vincitore l’aveva fatta salire sul suo vecchio catorcio di mercedes scassata, aprendole la porta come a una signora, tra gli applausi della folla. Lo sappiamo che i bei tempi non ci sono mai stati, ma questo non significa che ci siano adesso, o che non ci siano stati e non ci possano essere tempi un po’ migliori di questi. Mandiamo a fanculo Cracco, proviamo la zuppa di pesce di Banja Luka.
Però il controesempio non scalda i nostri cuori, essendo Wu Ming un collettivo a maggioranza vegetariana/vegana :-)
nobody’s perfect :-)
Riguardo al neoliberismo e alle dinamiche che stanno dietro (e avanti), volevo segnalare questa breve intervento su neoliberismo e democrazia https://invidio.us/watch?v=ZMMJ9HqzRcE (How Neoliberalism Threatens Democracy)
Abbiamo tolto il numero di condivisioni dai “bottoni” social in calce ai post di Giap. Anche quello è un elemento intossicante, di “prestazione”, che è parte della gamification della vita online impostasi negli anni Dieci.
Quel numerello introduceva su questo blog un principio di competizione tra i diversi post, un criterio da hit parade: – Questo è stato condiviso su FB diecimila volte, quest’altro solo cinquecento… Uh, questo qui solo cinquanta… [implicita conclusione: dev’essere meno interessante]
Al che si potrebbe rispondere: – Ce l’avete comunque una “classifica”, quella nel box dei post più commentati.
Ma i due casi sono completamente diversi.
Dire che un post ha ricevuto molti commenti, almeno qui su Giap dove ci siamo stati sempre attenti, non è un mero dato quantitativo. Qui non c’è il rischio che il numero sia “pompato” da commenti che consistono solo in «LOL», «Ahahahah!», «Grande!» o battutine di una frase o laconiche gif animate. La classifica visibile in quel box segnala in un colpo d’occhio discussioni dense e longeve a cui potrebbe essere interessante partecipare. La quantità segnala qualità, secondo criteri interni alla storia di questo blog, alla particolare produzione di senso che in questa fucina cerchiamo di portare avanti.
Sventolare il numero di condivisioni sui social, invece, porta a scambiare la quantità per qualità, e lo fa in base a criteri regolati dall’esterno, parte di logiche estranee a come abbiamo costruito questo blog.
Tra l’altro, anche in termini di mera circolazione, il numero di condivisioni è un dato che dice meno di quel che sembra, perché spesso non c’è proporzione diretta tra post più condivisi e post più letti. Ad esempio, questa miniserie (per ragioni non difficili da cogliere) sta avendo poche condivisioni su Facebook, eppure sta avendo molte visite – la prima puntata è già sopra le 15.000 – e con un tempo medio di permanenza sulla pagina alquanto lungo (9 minuti, ed è la media).
En passant: una cosa che nei post non abbiamo fatto notare è quanto sia stata appiattita e corrotta dalla cultura social una parola nobile e bella come «condivisione».
Nel 2020, con calma, lavoreremo anche sui suddetti “bottoni”. Già la loro mera presenza su una pagina ciuccia dati a chi la visita, a vantaggio dei rispettivi social media. Spesso un bottone social installa un cookie che ti segue ovunque e ti traccia per conto di Facebook o chi altri.
Una delle possibilità è di metterli inattivi di default: per condividere un post su un social, l’utente deve prima attivare il bottone, come spiegato qui. Oppure copia l’URL e amen :-)
Intanto, mentre valutiamo soluzioni più articolate, abbiamo proprio tolto i bottoni social. Chi vuole condividere un post di Giap su Fb o Twitter aut similia può copiare l’URL e incollarselo dove preferisce :-)
Grazie della menzione!
Ho trovato in questi post riflessioni quanto mai necessarie, tra cui quella, forse secondaria ma a me cara, su Burioni in “non tutte le critiche ai social sono uguali”. E’ un concetto che provo, da giovane medico, a condividere con i miei giovani colleghi senza successo, tanto sono inebriati loro stessi dall’epica dello “scontro” tra il “noi e loro” finendo per trasformare le vittime dell’informazione antiscientifica propagandata dai media (“dibattiti” sui vaccini tra genitori urlanti e medici con la faccia antipatica in prima visione praticamente ogni sera nel boom della contestazione) in carnefici da “blastare”.
Da ultimo, per quanto riguarda Brave, è sicuramente un otimo browser come utilizzo, ma, visto che in questo lavoro avete analizzato il piano etico e “ideologico” della rete, c’è da dire che brave non mira a liberare l’utente dalle pubblicità martellanti, ma a sostituirle con le proprie e quelle delle sue aziende amiche “pagando” gli utenti per guardarle attraverso un sistema ci crypto token chiamato BAT ( https://basicattentiontoken.org/ ). In sintesi parliamo ancora di monetizzare il browsing.
In più, il suo fondatore, anni fa ha fatto questo https://www.ft.com/content/461bf398-47ee-11e4-ac9f-00144feab7de
Su Brave hai perfettamente ragione, è una delle sperimentazioni fatte in questo periodo ma non è una soluzione al problema. Forse è come diceva ieri Antanicus su Bida:
«L’unica opzione davvero sicura per navigare con un minimo di privacy è Firefox con almeno le seguenti estensioni:
– uBlock origin
– Decentraleyes
– Facebook container»
Esiste anche Waterfox https://www.waterfox.net/ ovvero firefox senza le (davvero pochissime) aggiunte di mozilla come la telemetry o l’integrazione di Pocket, ho notato che gira molto bene su mac (vecchi mac soprattutto).
Per la questione invidious segnalo l’estensione Invidition https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/invidition/ per poter visualizzare direttamente su un’istanza di invidious a scelta tutti i link di youtube (integra anche la stessa funzione per nitter).
Grazie per la segnalazione di waterfox, che non conoscevo. L’ho installato ora, e mi hai risolto un problema enorme, al di là dei pregi del browser. Sul mio vecchio mac ormai non girava più niente, né firefox, né safari, solo chrome ma comunque lentissimo, e il sistema è troppo vecchio per brave.
Mi fa piacere esserti stato utile!
Sperimentazione in corso con Waterfox, per ora con le seguenti add-on: uBlock Origin, Decentraleyes e Invidition. Facebook Container non si riesce ad aggiungerla perché «incompatibile con Waterfox 56.3». Finora il browser va che è una scheggia.
Ciao Io ho appena installato Invidition su Firefox 71.0 ma su twitter non vedo più immagini e anteprime di articoli praticamente una versione solo testo. Ho lasciato i settaggi di default come da installazione. Sapreste dirmi dove sbaglio oppure indicarmi una guida?
Riguardo all’integrazione di Nitter purtroppo non so come aiutarti perché non l’ho mai utilizzato, ma controlla nelle impostazioni del sito se c’è attiva un’opzione che blocca immagini e anteprime
Paolo, nel frattempo hai risolto? Con Waterfox + Invidition finora nessun problema riscontrato.
Ancora no. Pensavo che fosse un problema con un altro add-on che uso No-Script ma non è quello. Ho provato a navigare su https://nitter.net e settarlo come dominio fidato con No Script ma non cambia niente.
Ho provato anche a guardare sul sito di Invidition ma non sono segnalati bug anzi dice esplicitamente che non vi è conflitto con No Script, secondo il programmatore dovrebbe bastare settare nitter come dominio fidato.
Se invece clicco l’iconcina di twitter che c’è sul sito di nitter navigo tranquillamente.
Per quanto riguarda Waterfox, io uso Ubuntu e non ci sono pacchetti disponibili, sul sito di Waterfox si trova soltanto il sorgente generico per Linux e, per quanto me la cavi discretamente, compilare un browser intero è una cosa che va al di là delle mie conoscenze; troppe dipendenze da risolvere per usare un gergo informatico.
P.S.
Per quanto riguarda l’alternativa a paypal di cui parlavate nella seconda puntata giorni fa vi ho mandato una mail segnalandovi una alternativa che dopo ho scoperto essere la stessa che bida usa per le sue donazioni. Adesso mi sono informato e ho scoperto che quel software permette non solo l’uso della carta di credito ma anche l’accredito diretto sul conto corrente come paypal. Io per esempio non ho una carta uso solo il bancomat e volendo non potrei fare una donazione a bida.
Grazie, mail ricevuta, già che ci siamo indichiamo anche di quale servizio si tratta:
https://stripe.com/en-it
Appena abbiamo un momento diamo un’occhiata.
Ad ogni modo se non ti funziona Invidition, qui c’è un elenco di tutte le estensioni e applicazioni che fanno lo stesso lavoro: dirottare automaticamente su individio.us ogni richiesta a YouTube (link o embed). Forse alcune includono il redirect da Twitter a Nitter.
Il problema di compatibilità può essere dovuto all’utilizzo di Waterfox Classic, fatto per supportare gli add-on Legacy di mozilla ormai non supportati da Firefox, ma non necessariamente add-on piú recenti.
Personalmente per avere piú compatibilità utilizzo Waterfox Current, che si basa sul firefox attuale.
N.B. Qui su Giap c’è stata una lunga discussione (anche) sul burionismo quando ancora non si chiamava così.
Brave ha anche un’altra pessima caratteristica.
Non permette in alcun modo di esportare i propri bookmark.
Lo scoprii un paio di anni fa quando volendolo abbandonare per passare a Firefox anche sullo smartphone, mi trovai inaspettatamente davanti al problema. Mi pareva impossibile mancasse una funzione tanto fondamentale, eppure…
Quando lessi che gli utenti richiedevano da tempo un modo facile ed immediato di esportare i propri bookmark ma gli sviluppatori nicchiavano, rimandavano ed erano sostanzialmente evasivi, la cosa mi fece pensare. Quando, continuando a leggere, mi parve evidente che la cosa era voluta mi salì la carogna e la voglia di abbandonarlo si fece pressante.
Utilizzando Telegram come appoggio mi “esportai” i bookmark a manina, uno per uno. Un lavoro folle, una palla paurosa!
Alla fine però quel click su “Disinstalla” ebbe un sapore dolcissimo.
A mai più rivederci Brave!
Uhm, no, adesso la funzione c’è. Gestione preferiti –> Segnalibri –> cliccare sul menu a destra (i tre puntini verticali) –> Esporta preferiti, e ti salva un file html che dopo puoi importare nell’altro browser.
Bene. Mi sembra il minimo.
Ho indicato chiaramente che la brutta esperienza è di un paio di anni fa.
Comunque, per quello che mi riguarda, too late :)
Felicissimo con il mio FF personalizzato. (sia sui fissi che su mobile)
Sì, sì, chiaro, per questo era specificato “*adesso* c’è”. Stando alla tua testimonianza, è evidente che la funzione è stata aggiunta grazie alle proteste.
I social, il lavoro e lo sfruttamento del tempo.
Uno dei… personaggi della storia narrata qui sopra, Luigi Chiarella aka Yamunin, ha scritto una riflessione collegata alla nostra. E, appropriatamente, lo ha fatto sul proprio blog.
Passo difficile e necessario. Io ho lasciato FB da qualche mese, dopo esservi rientrato a seguito di un’altra fuga. Mi sto preparando all’esodo da twitter. È un vero programma di disintossicazione. Ci sono altre cose su cui ragionare, ad esempio le applicazioni che girano su blockchain. C’è da riprendere il discorso sul software libero. Capire il discorso della privacy e tante altre cose. Che cosa è diventata la rete? Andrebbe costruito un ragionamento stabile su ste cose, vedendosi prima di tutto.
Con il 5G, Wu Ming avrebbe impiegato un ventesimo del tempo per scrivere questi due post: è la dubbia tesi cui allude un articolo pubblicato oggi su La Stampa, “Il giornalismo riparte dal 5G”.
La lunga analisi proposta su Giap è praticamente un libro, ma anche – per gli innumerevoli link contenuti – un hub da cui si dipartono infinite occasioni di approfondimento (compresi gustosissimi easter egg!). Intuendosi l’enorme lavoro richiesto per mettere a punto un’analisi del genere, ho letto con perplessità l’articolo sulle tecnologie di Quinta Generazione proposto sul quotidiano torinese. L’occhiello recita “Si potranno trasferire dati a una velocità venti volte superiore a quella attuale” ma il pezzo tradisce una certa difficoltà a individuare gli effetti di tutto ciò sulla *qualità* dei contenuti: “Il 5G salverà il giornalismo, forse”. Christian Rocca ammette che “è ancora tutto poco chiaro, nessuno sa bene come davvero il 5G potrà cambiare il giornalismo […] [e cosa] potrà offrire agli editori, ai giornalisti e ai lettori in termini di business, di modalità di racconto e di fruibilità delle storie”.
A oggi, è chiaro che della maggiore capacità e rapidità del 5G gioveranno solo quelli in grado di monetizzare i Big Data – perché è assai dubbio che le riflessioni maturate intorno a Giap possano migliorare sensibilmente viaggiando dai neuroni ai polpastrelli alla Rete a una velocità di venti volte superiore a quella attuale. Proprio come nelle retoriche dei sostenitori della linea ferroviaria Torino-Lione, serve a poco investire sulla velocità in assenza di contenuti di qualità da trasmettere: contenuti la cui bontà è spesso direttamente proporzionale al tempo necessario per metterli a punto.
L’avvento del 5g aumenterà la pervasività delle pubblicità personalizzate, tipo Minority Report.
Devo dire che la fantascienza risulta essere sempre una delle forme di veggenza più efficaci… Peccato che la fantascienza “veggente” parli quasi sempre di distopie.
Che le logiche da social siano penetrate a più livelli nella società é sempre più evidente e non é raro osservare come al tempo stesso una larga fetta della società ne sia talmente permeata da non riuscire a coglierlo in modo spontaneo.
Tra derive negative della gamification, FOMO, livelli discorsivi che tendono sempre più ad una costante “memificazione” e metasignificazione, effetto sfogatoio e la falsa illusione che ognun* sia nel suo piccolo una star, sono tantissimi i motivi per cui son sempre più necessari processi di disintossicazione collettiva da social (altro termine che é stato colonizzato dai suoi significati più negativi).
Volenti o nolenti però questi strumenti ci toccano continuamente e fingere che non esistano, purtroppo, non basta. A questo proposito basta citare la capacità tecnica di Facebook di tracciarti e profilarti anche se non usi Facebook o la personalizzazione dei contenuti di Google in base ai tuoi dati di navigazione precedenti.
Volenti o nolenti é dunque necessario maturare una certa conoscenza tecnica per non restarne soffocat* ma senza dover necessariamente rifiutare in toto anche gli aspetti vantaggiosi di queste tecnologie.
Educazione digitale dunque. Qui il discorso sarebbe molto ampio e meriterebbe un thread a parte ma ritengo possa esser utile gettare almeno una traccia da cui partire: pur apprezzandolo molto, ho sempre ritenuto che in generale il “mondo degli smanettoni” (scusate se non ho trovato un’espressione migliore) abbia spesso preteso troppo dalla comune persona che, semplicemente, vuole (o non può fare a meno di usare) degli strumenti che gli sian comprensibili senza doversi leggere migliaia di pagine su informatica e programmazione per fare cose comuni come pagare le bollette, ascoltare un brano musicale o scrivere un testo.
Dall’altro é pur vero che la maggior parte delle persone mostra spesso un grande disinteresse verso gli aspetti tecnici che sottostanno a tali strumenti, tanto da accettarne passivamente struttura, paletti, limiti e abusi non percependone sempre appieno gli effetti su di sè e sulla propria libertà. Quante volte si sentono ripetere luoghi comuni del tipo “ma tanto siamo tutt* controllat*”?
L’informatica é un argomento tecnico e complesso, ossia un “cibo” che non viene masticato volentieri da chiunque ma che oggi é necessario ingerire. Un’idea che circola tra chi si occupa di programmazione é che nel giro di pochi decenni chi non saprà destreggiarsi nel maneggiare codice si troverà nella posizione che oggi occupa l’analfabeta in una società basata sulla parola scritta. Al netto di facili catastrofismi ritengo che non sia un’immagine poi così irrealistica.
L’autodifesa digitale, dunque, richiede un certo grado di appropriazione culturale dei mezzi informatici e questo necessita di uno sforzo sia da parte di chi può divulgare conoscenze informatiche in forme accessibili che da parte di chi dovrebbe rendersi conto della necessità del suo apprendimento.
Ma la tecnologia, da sola, non ci salverà certo dagli effetti nocivi prodotti dalla tecnologia stessa! E’forte la tentazione di illudersi che basti affidarsi ad uno strumento alternativo solo perché presenta caratteristiche che attenuano molti lati negativi delle sue controparti commerciali. La sola tecnica non é non sarà mai la soluzione perché i processi psicologici, culturali e sociali che sono coinvolti travalicano la tecnica stessa.
E’dunque necessario costruire e mantenere vivo un processo critico costante che permetta di comprendere le derive che ogni strumento tende ad alimentare. Questo proprio per non farsi trascinare dallo strumento in sé. Definire il tipo di approccio che si vuol avere con esso (il che include anche il possibile rifiuto di utilizzarlo), la sua utilità effettiva ed i limiti oltre i quali gli svantaggi sono peggiori dei vantaggi é giusto il primo necessario passaggio per stabilire un approccio più ragionato con uno strumento, a prescindere dalla tecnica.
Solo assieme, conoscenza tecnica diffusa ed approccio critico costante, permettono di contenere consapevolmente lo strumento ai suoi aspetti vantaggiosi.
Mastodon é un esempio di strumento che presenta alcune anti-caratteristiche che limitano gli effetti nocivi dei social commerciali ma che, al netto di questi, resta pur sempre a sua volta un social. Corretto, dunque il paragone col metadone in quanto la semplice sostituzione dello strumento/sostanza, se non accompagnato anche da un processo più ampio che preveda un cambiamento nel modo di utilizzare il mezzo, non é che un’illusione di cambiamento.
Mastodon non é “la” soluzione, ma uno strumento che se integrato ed utilizzato in un progetto più ampio, ragionato e non limitato alla sola virtualità, penso possa esserne una componente molto utile.
Tutti i ragionamenti sul rimuovere contatori e automatismi, modificare i “like” in “segnalibri”, preferire un certo strumento ad un’altro, integrare certi plugin, riprendersi il proprio tempo fanno proprio parte di questo processo di autodifesa consapevole che va certamente fatta conoscere e diffusa. Su Bida tempo fa é partito un progetto chiamato #EducAzione proprio ragionando su questi argomenti. Nello specifico il progetto é stato pensatp per imbastire corsi di autodifesa digitale nelle le scuole ma in realtà applicabile ovunque.
(PS: Grazie. Mi ha fatto piacere sapere che la guida che Pongrebio ed io stiam realizzando sia tornata utile!)
Riscoprire la lentezza della lettura; fermarsi a riflettere senza fretta, perché gli spunti sono tanti; prendersi il tempo di leggere tutti i commenti e rifletterci su, ché anche quelli ti arricchiscono e ti danno da pensare.
Sono piaceri che spesso la frenesia dei social ti fanno dimenticare e che ‘sti due post (ma non solo, per fortuna) ti permettono di riscoprire.
“Topo è chi non si prende il tempo di elaborare e riflettere”, scrivevate in una vecchia riflessione del 2010. Non l’avete ricordata in questa carrellata, però penso anticipi non poco alcune considerazioni che fate qui.
Proprio quello di non fermarsi a riflettere, a studiare per formarsi un’opinione, credo sia uno dei grandi limiti della nostra epoca. Un fenomeno che corre il rischio di creare una barriera insormontabile in grado di inibire molte pulsioni indirizzate a cambiamenti radicali.
Si vive in un costante presente, dove le ire, la rabbia, ma anche le gioie e i desideri, hanno esclusivamente una dimensione individuale, e si è disposti a tutto, anche a calpestare gli altri, per la propria soddisfazione personale o per sfogare il proprio dolore.
Si perde la dimensione collettiva, anche quando le sofferenze sono comuni, e lotte comuni aiuterebbero a dissiparle; si perde la dimensione storica dei fenomeni, tutto pare avvenire per caso, “come l’onda tien dietro l’onda” per citare un’infelice espressione di Popper con la quale criticava il metodo storico, non si ricostruiscono più i fenomeni cercando di scorgerne le cause, l’unico metodo che permette di superarli.
In questo il ruolo dei social è fondamentale, come avete ben descritto, tutto è ridotto all’istante, si segue l’ultima notizia dimenticando in breve tempo gli eventi che l’hanno preceduta; non si riflette: si commentano i titoli dei post e le prime parole, poi si va avanti, verso il prossimo flame.
Apparire è d’obbligo: conquistare il proprio quarto d’ora di popolarità, inseguendo con frasi a effetto e sarcasmo i like e i cuoricini, senza rendersi conto che ciò rende tossica la conversazione, la polarizza e la rende inutile perché non aiuta a crescere.
Su tutto, poi, la gamification: tutto diventa gioco, tutto si uniforma alla logica dei social.
È molto interessante il parallelo che fa @Tuco sull’attuale organizzazione della vita accademica, purtroppo, però, non è l’unico ambito dove questo sta avvenendo. Le sue parole mi hanno riportato alla mente un post di Infoaut di un paio d’anni fa, dove si descriveva la piattaforma Uber e i meccanismi di gamification che regolano il rapporto tra autisti e utenti. Più recentemente un articolo de il Tascabile metteva in luce come questi meccanismi si stanno estendendo, fino a colonizzare interamente l’esistenza di un individuo, dal luogo di lavoro alla vita sociale.
Meccanismi in grado di hackerare la nostra psicologia, capaci di costringersi a inseguire gratificazioni fittizie anche se ci rendiamo conto che, in realtà, siamo sfruttati. Tonnellate di dopamina sprecata, che ci fa provare piacere quando in realtà stiamo danneggiando noi stessi e lavorando per il piacere, e la ricchezza, di altri.
I meccanismi che caratterizzano i social, e, oramai, non solo, credo abbiano il ruolo di consolidare la mentalità conseguente all’ideologia neoliberista in un momento in cui gli stessi apologeti del neoliberismo ne hanno decretato il fallimento.
Come sui mercati finanziari, per mezzo di bot, si stanno automatizzando comportamenti basati sui principi neoliberisti, così si cerca, grazie alla gamification, e alle logiche “social” (che di “social” hanno ben poco), di automatizzare le prestazioni lavorative e le interazioni sociali strutturandole sui medesimi assiomi.
Non tutto è perduto, ovvio, anche nel vostro post suggerite strade per venirne fuori e fate notare come, in questo momento, siano in atto, a livello globale, lotte che non hanno precedenti.
Ma, anche qui, è interessante notare come le classi dominanti, mediante i social, cerchino di delegittimare quelle lotte. Attraverso vie dirette, come il recente articolo de la Stampa, nel quale si disquisiva della “bestialità” dei dimostranti francesi, tacendo sulla bestialità del sistema, ma anche per vie indirette, come per il caso di Mimo, l’artista cilena suicidatasi, ma che molta informazione ha affermato essere stata uccisa dai carabineros. In questo secondo caso, probabilmente, la notizia è stata fabbricata per essere smentita, per fare in modo, che, in seguito, chiunque diffidasse delle fonti, non credesse alle notizie di tortura e violenza indicibile che caratterizzano la repressione di quella protesta.
I social hanno fatto da cassa di risonanza per la sua diffusione, e per la conseguente smentita, trovando supporto anche tra molti che, in questo caso, si sono comportati da “topi”. In seguito non si è sviluppata nessuna discussione sulle strategie di sabotaggio comunicativo adottate dal potere.
Per questo i vostri post credo siano importanti, perché tracciano una mappa della rete, ne mettono a nudo alcune logiche, e, a una critica a vecchi strumenti, aggiungono un inizio di riflessione su quelli che potrebbero essere i nuovi e su come stare in rete negli anni Venti, su come continuare a coniugare presenza in strada e in rete. Non credo sia poco.
Ricordo la metafora del topo. Dopo tutti questi anni però se penso ai social network più che il topo mi viene in mente il “dancing chicken” della sequenza finale di “Stroszek” di Herzog.
https://invidio.us/watch?v=IcoqeNdMAfA
p.s. stavo per linkare da youtube, e ancor peggio stavo per linkare il video breve, rimontato, in cui compare solo il pollo. Poi ho deciso di usare invidio.us e di linkare la scena completa, di 8 minuti abbondanti, col montaggio in parallelo tra il pollo e Stroszek. Giapsters, prendetevi un momento e guardatela tutta, la scena, e magari, se non l’avete già fatto, guardatevi il film, ché ne vale la pena.
Come non detto. Il link corretto è questo. https://invidio.us/watch?v=bm3B82Q5vhY
In effetti come metafora ci sta tutta! :-D
Non conoscevo il film: me lo sono procurato e lo guardo. Grazie!!!
Non lo conoscevo, bello.
Ma, per capire meglio: in che modo chi ha creduto alla storia della mimo assassinata è paragonabile al pollo che balla?
Nel senso che è addestrato a “ballare” in un contesto che non comprende?
Non avevo in mente il caso specifico di Mimo, ma piuttosto il dispositivo “social network” in generale: il pollo e gli altri animali becchettando qualche chicco di grano o cercando di mordere qualche simulacro di cibo (come dire: clickando sul bottone like, o condividi, o retweet…), cercano una gratificazione mentre in realtà azionano il meccanismo che li fa “danzare”, cioè muovere a vuoto.
P.S. Nell’economia del film comunque la scena del pollo è una metafora aperta. Herzog in un’intervista spiegava di aver trovato per caso quel posto, e di aver girato personalmente la scena, perché il cineoperatore e tutta la troupe si rifiutarono di farlo, trovando insostenibile lo spettacolo che quegli animali erano costretti a inscenare. Non saprei indicarti dove si possa trovare l’intervista: questa cosa l’ho sentita raccontare a voce durante un cineforum in germania mille anni fa, quando ancora capivo il tedesco, e non esistevano protocolli per la condivisione di video su internet..
Grazie della spiegazione, in effetti la metafora è calzante.
Il «pollo danzante» è perfetto.
Grazie per questa bellissima riflessione.
Da lavoratrice della rete, ammetto negli ultimi anni di aver assunto un atteggiamento profondamente nichilista nei confronti di internet e del suo ruolo – attuale e potenziale – nella società. Mi dicevo che su internet niente conta, tutto è pubblicità o fake news, e anche se non lo è non serve, perché il rumore è troppo forte e non si riesce più a distinguere ciò che è vero e ciò che è importante, da ciò che è falso e inutile. Mettiamoci pure un po’ di pigrizia, e il comprensibilissimo desiderio di staccarmi dallo schermo dopo una giornata di lavoro. Eppure a uno schermo ci tornavo sempre. A quello del cellulare, scorrendo la timeline di Facebook o di Twitter. Proprio io, che i social so bene come funzionano e nei confronti dei quali nutro una diffidenza totale. Ma lì entrano in gioco i meccanismi di dipendenza da slot machine che avete citato, un briciolo di FOMO e la perversione di percepire come noia quella che è semplicemente calma.
Eppure ogni tanto mi ritrovavo a pensare a quanto era più ricca la mia fruizione di internet un tempo, quando i social erano un luogo di passaggio tra un blog e un altro e tra giapster si era creato un network in cui ci si scambiavano idee, conoscenze, connessioni. Serve davvero tornare a usare internet in modo diverso, come avete invitato a fare. E grazie a tutti coloro che sono intervenuti qui dando informazioni utili in questo senso.
Una cosa di cui mi preme parlare è l’effetto psicologico dei social media. Se ne è già parlato qui, ma soprattutto tramite esperienze personali. In realtà, ci sono degli studiosi che hanno esaminato gli effetti dei social sulla salute mentale, con conclusioni inquietanti. Ad esempio Jean M. Twenge, che nel suo libro Iperconnessi parla di come i social media e diciamo la tecnologia che ci “iperconnette” in generale (fondamentalmente gli smartphone) agiscono sulla mente dei bambini e dei giovanissimi, traendone delle conclusioni che però si possono benissimo applicare anche agli adulti, per quanto in forma attenuata. Ovvero: i social – tramite i meccanismi descritti benissimo nei due post qui su Giap – creano una socialità surrogata in cui molti bambini e ragazzi (ma anche adulti, in realtà) si rifugiano e che esperiscono al posto di quella reale. Questo spesso li priva di tutta una serie di esperienze normali – relazioni, sesso, conflitti, ribellione – che arrivano molto più tardi, in un’età in cui già ci si affaccia al mondo degli adulti. Nel libro di Twenge, si spiega come le prime esperienze relazionali, ad esempio, tra i giovanissimi americani “iperconnessi” oggi arrivino ben più tardi rispetto alla generazione dei loro genitori, per quanto sempre si frigni di ragazzi precocissimi e fuori controllo. Allo stesso tempo, però, chi passa molto tempo sui social si sente più solo, più in ansia, più triste. I social media ci isolano, ci danno degli altri un’idea falsa che ci fa sentire soli e inadeguati, ci spingono a una competizione costante. Competizione in cui vince semplicemente il più furbo e il più scaltro. Per dire, su Facebook è pieno di gruppi di “scambio like”. Usati normalmente dalle aziende che cercano di pompare i mi piace sulle loro pagine, in realtà sono utilizzatissimi da ragazzini anche giovanissimi che chiedono a dei perfetti sconosciuti di mettere un like alle loro nuove immagini del profilo o alle foto che si sono fatti in vacanza al mare, per fregare i loro compagni di scuola e fargli credere di essere super popolari. Ho visto usare questo trucchetto a ragazzine di 12 anni, per pompare i like a foto che si sono scattate in bagno in reggiseno e mutandine. Per dire il baratro di insicurezza, mercificazione del proprio corpo e puro e semplice pericolo in cui Facebook getta ragazzine e ragazzini giovanissimi.
Ma tornando agli adulti: chi di noi, dopo un’ora trascorsa su Facebook o su Twitter, si sente meglio di prima? Quanti ne escono, invece, con delle emozioni negative, che vanno dalla solitudine, al senso di impotenza, all’ansia, alla tristezza? Queste emozioni di cui spesso accusiamo noi stessi o il mondo brutto e cattivo sono in realtà frutto dei social, per le dinamiche con cui funzionano. Un frutto non casuale, perché più siamo fragili, soli, dipendenti, e più siamo dei buoni consumatori. Sarebbe molto utile capire quanto queste emozioni influenzino la nostra visione del presente, la nostra capacità di analisi e di azione politica. Secondo me parecchio. Perché è vero che le ingiustizie del mondo e le prospettive per il futuro sono angosciose, ma un conto sono la sana preoccupazione, l’odio, la rabbia, la consapevolezza del disastro in cui siamo e della china che stiamo scendendo, un altro sono il pessimismo, la sfiducia, la sensazione che non ci sia nulla da fare. Tutte emozioni che pervadono moltissime persone che ho attorno. Quanta parte di queste emozioni che ci disarmano proviene dai social? Secondo me dobbiamo interrogarci su questo. Perché il mondo è pieno di lotte nuove e vecchie e ragionandoci su forse scopriremmo che di motivi per essere pessimisti non ne abbiamo poi tanti.
PS: nel vostro elenco di lotte scoppiate nel 2019 avete scordato quelle di Algeria e Sudan!
Grazie mille, Adrianaaa. Molto importante questo passaggio:
«…quanto era più ricca la mia fruizione di internet un tempo, quando i social erano un luogo di passaggio tra un blog e un altro e tra giapster si era creato un network in cui ci si scambiavano idee, conoscenze, connessioni. Serve davvero tornare a usare internet in modo diverso…»
Nell’ultimo paragrafo del post abbiamo ipotizzato una nuova blogosfera «post-social», diversa da quella «pre-social». Siamo rimasti sul vago anche perché ormai il post era chilometrico. Ora il tuo commento dà l’occasione di precisare un poco.
Proviamo a immaginare una federazione di blog. Blog che, come il nostro, sono sopravvissuti all’omologazione e al violento accentramento operato prima da Facebook e poi anche da Twitter, ma pure blog nuovi che sorgeranno.
Come federare questi blog? Beh, plausibilmente, tramite un social. L’espressione «blogosfera post-social» ha quindi un doppio senso: una blogosfera che ci traghetti lontano dalle logiche dei social (commerciali), il cui formarsi sarebbe reso possibile da un social (naturalmente, non commerciale).
Al momento, il candidato più credibile per questo ruolo è, ovviamente, Mastodon. Esistono plugin come ActivityPub per WordPress che praticamente trasformano i blog in «istanze» di Mastodon, permettendo di commentare sui blog dal proprio account Mastodon, e viceversa.
Nel caso di Giap, ci sarebbero svariati problemi da risolvere: concettuali, strettamente tecnici, di gestione e anche di layout. Questo blog ha molte peculiarità, una sua storia, una sua fisionomia, per rispettare le quali forse serve fare un po’ di hacking di un plugin esistente. Ad ogni modo, potrebbe essere la via da percorrere.
Detto questo, per fortuna il network tra giapster che si scambiano idee esiste ancora, ha passato i suoi quaranta giorni nel deserto ma c’è, anche senza Twitter: in questo spazio commenti che faremo di tutto per rilanciare, e nelle mailing list di Alpinismo Molotov, Nicoletta Bourbaki, Quinto Tipo, RIC ecc. Si tratta di dare una nuova spinta all’intero meta-progetto. Noi siamo determinati a farlo.
P.S. Naturalmente, rispetto all’uso del blog, per chi non volesse farsi l’account Mastodon non cambierebbe nulla. Commenterebbe come faceva prima.
Forse non si capiva, ma mi riferivo a un network di blog :-) So bene che molte reti hanno continuato a fiorire attorno a Giap, anche quando i blog personali che tanti avevano/hanno sono diventati meno utilizzati. Questo spazio ha continuato ad essere vivace e importante, nonostante i social.
L’idea di Mastodon come aggregatore di una nuova blogosfera è interessantissima!
Ecco,
Mi son preso qualche giorno per assorbire e pensare. Il testo e i commenti fanno molte pieghe, vi ringrazio e parto dalla fine, ovvero:
– Che forme immaginate per un blog post-social? Voglio dire, dopo la “bolla-social” e dopo la rottura, che strategie e modalità espressive e strutturali fantasticate? Certo, fare-rifare-continuare a fare è già strategia… Ma ho davanti a me un ragazzz nato nel 2004, stesso anno di Facebook, che ora ha 15 anni, cresciuto immerso nella bolla-social… Ecco come parlo a quel ragazzo dei blog?
– E che dire dei social-post-social e dei “social-totali”… Penso a Wechat con un miliardo di account… A Tik tok (https://www.ilmessaggero.it/mondo/tik_tok_marina_militare_usa_minaccia_cybersicurezza-4940922.html)… Fortnite stesso…
– Esatto, sì, una piattaforma open-source etc., una “blogosfera federativa post-social”. Come attivare questa confederazione di blog post-social? Esiste un censimento dei blog attivi in Italia? Con una veloce ricerca ho trovato solo una federazione di Food-bloger.
– Mastodon è il lungo giusto ora? Come favorire e/o innescare un esodo?
Grazie Giap!
Grazie delle domande. Si tratterebbe, tagliando con l’accetta, di costruire un “social network di blog”. Non possiamo ancora immaginare nei dettagli come sarà, ma possiamo continuare a buttare giù appunti su come si potrebbe costruirlo.
Ciascun blog sarebbe un nodo (o «istanza», come si dice su Mastodon). Ci sono questioni tecniche e concettuali da risolvere, ma c’è un punto di partenza, un primo esperimento da tentare: fare in modo che questo stesso blog diventi anche un’istanza di Mastodon. Non perché Mastodon sia la soluzione a tutto, ma perché è un social decentrato e federato che permette di fare questa mossa.
Nota bene che per «blog» intendiamo quelli che sono tecnicamente tali, non solo quelli che nella chiacchiera quotidiana sono associati al termine. Ad esempio, sono blog anche siti come Jacobin Italia, Dinamo Press, Infoaut, Global Project ecc… Col che non intendiamo dire che andranno coinvolte solo testate di movimento: la blogosfera sopravvissuta alla devastazione dei social include blog personali, blog monotematici, siti di artisti e quant’altro. E ne nasceranno di nuovi.
Sulla questione “generazionale”, siamo fiduciosi. Per quanto riguarda noialtri, le impetuose ondate di nuovo attivismo – oltre ad anni di lavoro culturale nelle scuole di ogni ordine e grado – ci hanno portato “in dote” un sacco di nuove lettrici e lettori giovani e giovanissime. Alcuni post di Giap hanno avuto grande circolazione in quei milieux. La social-dipendenza, poi, non è affatto una questione d’anagrafe né di “nativismo” digitale (a parte il fatto che quello dei “nativi” digitali è in larga parte un mito). Vediamo vasti eserciti di intossicati e saganati coi social tra i cinquantenni, sessantenni e settantenni. Sono proprio loro a ricorrere di più al pilota automatico, e ad annaspare di più quando si tratta di uscire da quelle cornici. Gli adolescenti hanno molte più chances, e un concetto come quello di un social network decentrato lo possono capire con grande facilità.
Giustissimo, Algeria e Sudan. E nelle ultime settimane anche l’India. E se andiamo indietro nei mesi, o fino all’anno scorso, quando l’onda ha cominciato a formarsi, troviamo ancora più paesi e cicli di lotte.
Che dire? Mi avete stanato dopo lungo tempo, e con riflessioni che mi frullavano in testa da un tempo lungo solo un po’ meno. Questo vostro annuncio è denso e merita sicuramente più attenzione di quella che ho potuto prestare, le piste tracciate sono molteplici e ne aprono di nuove, a ventaglio (per rinfrescarsi) o se vogliamo a ombrello (per ripararsi). Per questo motivo, è probabile che questo mio commento sarà incompleto e che tornerò ad aggiungere ulteriori considerazioni (magari, si spera, non dopo diversi anni).
Innanzitutto, sono impressionato dalla somiglianza tra questo vostro addio e quello che scrissi nel 2014 (Perché Facebook chiude), usando quasi letteralmente le stesse vostre parole, quando abbandonai Facebook come strumento di diffusione del blog (che scrivevo e che ormai è clinicamente morto, ma potrebbe sempre rivivere!) dopo un esperimento non decennale ma di un anno e mezzo. In quell’occasione, sollevavo questioni molto simili sulla natura del mezzo, sul suo uso sociale e sulle ricadute che questi due primi fattori avevano avuto sull’attività del blog e notavo che “il tempo e le energie spesi nella gestione della pagina Facebook dedicata al blog hanno paradossalmente provocato un calo di attività sul blog stesso”. Calo che interessava non solo la quantità ma anche la qualità dei contenuti: stare su Facebook cambiava inevitabilmente il modo in cui io stesso concepivo il mio blog, che passava da essere uno strumento di discussione ad essere un argomento di discussione, con tutto ciò che ne consegue, inclusa una sempre meno velata logica pubblicitaria (perché, come dite pure voi, è molto, molto difficile non adottare una logica pubblicitaria su una piattaforma che è per sua natura basata su una logica pubblicitaria): se all’inizio sottolineavo sempre che era meglio commentare sul blog anziché su Facebook, a lungo andare opponevo sempre meno resistanza alla tendenza generale apparentemente inevitabile di commentare su Facebook lasciando che la piattaforma inglobasse ogni cosa (tra l’altro rendendo il tutto più fugace, meno facile da ritrovare in un secondo momento), fino ad abbandonare del tutto l’idea; se all’inizio non condividevo mai un articolo senza aggiungere opinioni, critiche, analisi, spunti di discussione, questa cosa divenne normale per rincorrere il momento senza perdere troppo tempo; se all’inizio non badavo ai numeri di “mi piace”, di condivisioni, traffico, cominciai presto ad adottare strategie per migliorare questi parametri a scapito, o forse a prescindere, dalla qualità dei contenuti; e così via. Insomma, diventai riformista, perché “per vivere e prosperare dentro una struttura non puoi che essere riformista”. In breve, mi trovai completamente immerso nel meccanismo di gamification che, mi dissi inizialmente, avrei potuto sfruttare per dare più visibilità ai contenuti del blog. Non riscrivo qui tutto il ragionamento, ma alla fine questo ottimismo fu ampiamente disatteso e anche io conclusi che Facebook fosse un mezzo intrinsecamente inadatto alla costruzione critica del sapere.
Sui meccanismi totalizzanti e alienanti dei social network commerciali, immagino saprete bene che Jacobin Italia ha tradotto un articolo di Meagan Day che pone il problema del loro utilizzo da parte di organizzazioni politiche contrarie almeno in teoria alla gamification e alla mercificazione, insomma alla trasformazione in senso neoliberista dei rapporti umani. Meagan Day propone di scardinare la logica individualista dei social network (che voi notate più in Facebook che in Twitter), “[interrompendo] la correlazione tra il sé e il proprio profilo, [immaginando] nuovamente gli account social non come estensioni della propria persona ma come strumenti vitali di propaganda, qualcosa che usiamo e non qualcosa che siamo”. Sull’efficacia della soluzione proposta sono un po’ scettico, ma consiglio la lettura dell’articolo a chi si pone il problema, perché ritengo che sia in ogni caso necessario ripensare continuamente le forme della propria presenza in rete.
A proposito di usi alternativi, la piattaforma Prism Break, nata dopo lo scandalo del datagate, offre una lista ben fatta, seppure forse non esaustiva, delle alternative non commerciali e magari libere a una lunga serie di servizi.
E per finire, ormai che avete aperto il discorso sulla sorveglianza e scoperchiato il vaso di Pandora, agevolo qui un report, scritto e documentato benissimo, su un aspetto sempre più inquietante e pericoloso delle tecnologie di tracciamento individuale.
A presto, con rinnovata voglia di scrivere e le rivolte vere nel cuore.
Grazie, Monsieur en Rouge, segnaliamo però che l’ultimo link non funzia!
Funziona solo se clicki sulla parola “qui”! Désolé, ho formattato male in html.
A riprova che Facebook è sopravvalutato quando si tratta di far circolare contenuti esterni a Facebook stesso, citiamo un po’ di dati relativi a questa miniserie sui social e noi (nuèter, nuàltar, ecc.).
Quante condivisioni su FB sta avendo la miniserie?
Pochissime, per gli standard di Giap. Qualche centinaio la prima puntata, e addirittura meno di cinquanta la seconda. Perché?
Per vari motivi, legati sia al modo in cui è scritta sia al suo contenuto, in particolare ai paragrafi che descrivono l’utente medio di FB come un tossicodipendente.
Ora, quante persone stanno leggendo la miniserie?
Parecchie. La prima puntata ha appena superato le 18.000 visite, corrispondenti a 11.000 visitatori (IP unici), con tempo medio di permanenza sulla pagina di 8 minuti e 23 secondi.
La seconda puntata ha appena superato le 13.000 visite, corrispondenti a 8.000 visitatori (IP unici), con tempo medio di permanenza sulla pagina di 10 minuti e 40 secondi.
Due osservazioni:
– per un testo così lungo e denso, che richiede una lettura concentrata e va in direzione ostinata e contraria rispetto a ciò che “funziona” in rete al giorno d’oggi, sono numeri alti;
– un tempo medio di permanenza così lungo (in rete dieci minuti su una sola pagina web sono oggi un dato vertiginoso) dimostra che in genere il post viene letto e non solo visitato.
L’ordine di grandezza è lo stesso di altri nostri post belli tamugni che però su FB avevano avuto almeno (almeno) il decuplo di condivisioni. [Post meno densi hanno avuto il *centuplo* di condivisioni, e lì un certo impatto s’era visto, ma quella è un’altra faccenda.]
Per quella che è la nostra esperienza, non è per nulla scontato che ci sia diretta proporzionalità tra condivisione/like su FB del link a un nostro post, e numero di visite e letture ricevute da quel post. I due dati sono spesso del tutto sganciati.
Secondo noi, ciò è dovuto al fatto ribadito più volte nella miniserie: la maggior parte della gente che sta su FB non clicca i link, esce il meno possibile dalla piattaforma, al massimo commenta l’anteprima del post che appare su FB.
Questi dati ci sembrano avallare la testimonianza di Monsieur en Rouge, e soprattutto la sua conclusione: per chi vuole usare FB come canale di amplificazione dei propri contenuti, a lungo andare il gioco non vale la candela. Non solo lo sbattimento fatto su FB al fine di promuovere il blog – sbattimento che, se Dio vuole, noi ci siamo sparagnati dal principio – succhia energie che vengono sottratte alla produzione di contenuti, ma l’interazione su FB finisce per sottrarre visite e commenti al blog stesso.
Ci sono state situazioni in cui siamo riusciti *dall’esterno* a usare facebook come un badile con cui prendere a mazzate chi se lo meritava. A dirla tutta, un po’ per bravura, un po’ per culo, siamo riusciti a mettere a segno qualche vera e propria mossa di jujitsu. Penso soprattutto al modo in cui abbiamo contribuito all’implosione dei rossobruni del movimento trieste libera, movimento presente su facebook *e* in strada, un movimento vero, che si è fottuto da solo su facebook.
In quello e altri casi gettammo luce da fuori su quel che le interazioni FB di certi indipendentisti triestini mostravano riguardo alla vera natura di quella mobilitazione. Lo sguardo da fuori fu prezioso.
Fuori da FB, certe cose che nella cabina da polli danzanti di FB appaiono normali – eeeeh-quanto-la-fai-lunga!, che-vuoi-che-sia! – si rivelano per quel che sono davvero: quando va “bene”, spazzatura segnica, rusco, scovazze: quando non va così “bene”, propaganda d’odio che fa interessi non dichiarati. Interessi che si aggiungono agli interessi di Facebook, che diamo per impliciti.
[…] Su Giap i Wu Ming hanno pubblicato la seconda puntata della loro riflessione sullo stare in rete: L’amore è fortissimo, il corpo no. […]
Riflettevo sia sul lungo doppio post su Twitter sia sul primo dei due post di Wolf su xm24.
La domanda è: ma possibile che non si riescano ad utilizzare tutta sta valanga di dati anche per scopi sociali, nel dettaglio per le cause e le lotte di centri come xm24?
Provo a spiegarmi.
I dati sono neutri per definizione. Solo che le multinazionali con miliardi di dati fanno analisi incrociate e ci fanno i soldi. Fin qua tutto chiaro.
Altrettanto chiara è la difficoltà dei movimenti di produrre dati che contrastino le balle istituzionali, nel caso di xm24 e movimenti affini il numero dei locali sfitti, il numero delle persone coinvolte nelle attività di xm24…insomma, potenzialmente ci sono un sacco di dati che potrebbero essere oggetto di studio e potrebbero rendere più solida e documentata l’attività di xm24, ma anche (o forse soprattutto) dare una cifra delle reali necessità della popolazione.
Insomma, finché passa il messaggio che le attività di xm24 sono relegate a delle minoranze, oppure finché rimane l’idea che la povertà sia un problema di pochi, il cittadino medio segue facilmente i ragionamenti del Comune, e tira a campare.
Quindi, poiché mi sembra di vedere (proprio dai commenti a questo post) che nella comunità di giap ci siano un sacco di “smanettoni” (la cosa mi ha sorpreso già altre volte, davvero c’è una profonda conoscenza dell’informatica nell’universo che gira attorno a Giap e sta cosa forse un motivo ce l’ha, però io non saprei quale), possibile che non ci sia modo per scippare i dati ad uso delle lotte sociali?
Però, Massimo, «i dati» vuol dire tutto e niente. I dati ramazzati dai social e usati a fine di profitto, sorveglianza, sfruttamento e repressione sono dati relativi alla navigazione in rete, alle interazioni tra utenti, e ai consumi – già avvenuti e/o potenziali – degli utenti stessi. Dati la cui produzione è stimolata dai social stessi tramite meccanismi sempre più raffinati e inesorabili, che spingono l’utente a rinunciare in tutto o in gran parte alla propria privacy; dati generati dentro i social, secondo la logica di fondo dei social: quella di un’autoschedatura di massa che, come ha fatto notare qualcuno, impone uno scenario alla Orwell tramite incentivi alla Huxley. Ecco, di questi dati è difficile immaginare un altro uso, la priorità è interromperne la produzione.
Poi ci sono altri dati, quelli che produce il lavoro di inchiesta, di ricerca scientifica, di controinformazione. Però sono due faccende diverse.
Però, per quanto riguarda i dati “che produce il lavoro di inchiesta, di ricerca scientifica, di controinformazione”, il panorama non è poi così desolante…
Solo per fare un esempio, ci fu una bella inchiesta di Zero in condotta, che, nel 2013, produsse Chiedi alla polvere, una mappatura degli spazi di Bologna sgomberati e poi abbandonati. Quel lavoro fu aggiornato nel 2017, ed è tornato a girare parecchio negli ultimi mesi, dopo l’annuncio che Xm24 sarebbe stato sgomberato.
Ma un lavoro del genere, come faceva notare Wu Ming, c’entra poco con i dati che vengono prodotti ed estratti grazie ai social network per poi essere messi a valore. Perciò, credo, facessero notare che è necessario interromperne la produzione.
Anche nello specifico dei processi che investono la Bolognina, e di XM24 come spina nel fianco dei gentrificatori, si è fatto un buon lavoro di inchiesta e mappatura, riassunto in questo pieghevole a cura del LabUrba, stampato l’estate scorsa e distribuito al presidio permanente di XM24.
Ho letto con estremo interesse questa disamina del vostro lavoro su Twitter. Vi seguo da molto ma devo dire che solo oggi ho avuto l’ardire (se così si può dire) di commentare su Giap. Lo faccio perché secondo me questo argomento della sorveglianza e della gamification è complesso da un lato perché coinvolge un numero spropositato di persone, utile dall’altro perché è necessario parlarne. Sono completamente d’accordo con voi; vorrei solo portare all’analisi il contributo di chi invece usa i social con uno scopo particolare che si sta affermando da poco: la divulgazione scientifica. Lasciando perdere i medici famosi, c’è tutta una schiera di giovani divulgatori (in cui mi inserisco umilmente anche io) che sta facendo un grosso lavoro sui social per cercare di rompere le “bolle” mediatiche e inserirsi tra un’influencer e un influencer. L’obiettivo è farsi conoscere, farsi leggere, creare un nuovo pubblico. A primo impatto questo meccanismo ha funzionato: molti divulgatori, soprattutto conosciuti, hanno sfruttato bene ciò a loro vantaggio. Non solo: hanno anche trainato molti giovani padawan nel mondo della divulgazione esclusivamente social. Dico esclusivamente non a caso. L’impressione che ho avuto ultimamente è quella di una naturale stagnazione o saturazione; il pubblico c’è, il pubblico risponde, ma mi pare si sia persa la spinta iniziale che ha portato molti sui social e si sia caduti di nuovo in una logica di gamification e di sfruttamento del mezzo non per comunicare cose bensì per vendere un prodotto: il proprio personaggio. Ora, sarà che io sono sempre stato contrario a questo tipo di approccio (e quindi temo di non essere abbastanza sgamato neanche come divulgatore), tuttavia ritengo che sia addirittura controproducente. Il lavoro svolto dai divulgatori sui social è considerato, da molti divulgatori, un lavoro gratuito che si svolge per autopromozione. Ecco, io ritengo che la divulgazione sui social dovrebbe aiutare a diffondere un messaggio, un post, un contenuto; se invece il social e la gamification comportano la produzione gratuita di contenuti allora tanto vale che io lo faccia sul mio blog, sul mio spazio libero su Internet. La divulgazione scientifica va retribuita e su questo siamo d’accordo. Se un divulgatore non riesce a guadagnare e ha voglia, va bene scrivere sul proprio blog. Ma addirittura arrivare a creare contenuti per un’azienda che ha guadagni corposi (Facebook, Instagram) mi sembra un colpo al cuore. Detto questo, io per ora ho sia un account Instagram sia un account YouTube e non ho (più) Twitter. Sto cercando alternative e credo che il vostro suggerimento di picchiare duro con i blog sia molto sensato. Continuerò a picchiare duro con il mio piccolo blog mentre cerco di abbandonare progressivamente i social che risucchiano tempo e anima alla mia passione per la scienza. Comunque sia, grazie per queste due puntate illuminanti su parecchi vedo stanno già riflettendo in modo intenso.
intanto ringrazio la band letteraria.
mi prendo il tempo per rileggere ancora una volta 1 e 2. ce ne vuole.
ho trovato alcuni spunti stimolanti e a volte sorprendenti e il ringraziamento va a ciò.
per il momento ho messo in cascina il non sentirmi pazzo: sulla complessità come necessariamente da metabolizzare per tirar fuori la semplicità, e sulla semplificazione come elemento entropico negativo.
Attenzione, lavori in corso sul server: questo pomeriggio,26 dicembre, più o meno intorno alle 16 cominceremo il necessario aggiornamento di Php. Per un’ora o due Giap non sarà raggiungibile. Ci scusiamo per l’inconveniente, a più tardi.
Rieccoci, procediamo pure.
I social network hanno questo limite, che non è poi così innocente: si può postare una cosa per volta. Si può commentare una notizia, o farla presente, postandola. Ma non si può, o è difficile o inestetico o tedioso farlo (e una volta fatto risulta poco fruibile), postare due o tre o quattro cose per volta. Ciò scoraggia l’esercizio dei più semplici strumenti critici sulle fonti: comparare, mettere in relazione, inferire eccetera. Contemporaneamente incentiva la produzione di contenuti interamente propri o quasi, le cui fonti assumono un’importanza secondaria. Sì, vabbene, tutto si può fare ma qui – come osservate – non è un fatto di imparare a usare gli strumenti o imparare ad aggirare le restrizioni, bensì un fatto di sistema. Tu, che sei fighissimo, magari ti rendi conto di questo problema e fai un thread su Twitter, o inserisci più URL su Facebook, o magari addirittura usi la funzione “note”. Ma sei parte di una esiguissima minoranza perché il sistema sottostante ti incentiva a fare altro e la massa degli utenti fa altro, nota altro, si concentra su altro.
[…] di tutto WuMing, nella riflessione in due parti reperibile qui e qui, a cui rimando. Personalmente non posso che associarmi, sposandone, prima ancora che le […]
Ok, da oggi per le notifiche via email non usiamo più Feedburner. Facciamo un tentativo con un plugin per wordpress che si chiama «Email Subscribers & Newsletters», abbiamo importato l’indirizzario, vediamo se fa per noi. Se lascia a desiderare, cercheremo altro. L’importante è aver mollato un servizio di Google – tra l’altro ancora attivo ma di fatto abbandonato nel 2012. Abbandonato nel senso che non lo hanno più sviluppato, ma certamente continua a dragare e immagazzinare dati.
Il plugin lascia effettivamente parecchio a desiderare, lasciamo perdere. In attesa di trovare un’alternativa valida al vecchio Feedburner, sospendiamo le iscrizioni alle notifiche via mail.
Grazie per queste riflessioni e informazioni su come funzionano i social che avrei faticato a reperire altrimenti. Benché non attratto dai social (non ho un account FB e uso Twitter solo per leggere i twitt altrui), non avevo mai avuto la percezione o il sospetto che i meccanissmi e le dinamiche da questi generati fossero le medesime del gioco d’azzardo. Come già detto, personalmente uso poco i social però, come padre di un dodicenne che comincia ad essere attratto dai social e a voler essere presente su questi, avevo cominciato a documentarmi e a delineare una strategia per rispondere alla richiesta social di mio figlio. Dopo alcune letture e confronti con altri genitori, insieme con mia moglie abbiamo deciso di attuare la politica del In medio stat virtus, ossia non comprare un proprio smart phone a nostro figlio, permettergli di accederea ai social, per un tempo limitato e concordato, attraverso i nostri telefoni. Gli abbiamo inoltre concesso di accedere a Instagram con un account a mio nome, sul quale postare alcuni video che prima di poter essere postati dovevano passare la censura genitoriale. Questa strategia ci sembrava, a mia moglie e me, il miglior compromesso affinché nostro figlio non fosse inghiottito dall’adrenalina da social o dal FOMA e, al tempo stesso, non fosse del tutto isolato dai propri pari e non rimanesse del tutto digiuno dagli strumenti tecnologi attuali. Una delle riflessioni che spesso avevamo raccolto nel confronto con altri genitori e che ci appariva sensata era quella che: i social esistono, le/i ragazze/i vivono e crescono nell’epoca social non possiamo lasciarli del tutto ai margini di questo fenomeno, sarebbe negativo tanto quanto permettere loro di esserne inghiottiti. Dopo la lettura di questo post e dei numerosi commenti però, tentenno di fronte alla strategia da noi attuata che non mi sembra più così convincente. Sarei curioso e grato di ascoltare il parere di altri genitori in proposito e potermi confrontare su altre strategie messe in atto per salvaguardare le/i ragazze/i dai social.
Ciao Vale, può esserti molto utile il libro che abbiamo citato nella prima puntata, Internet, mon amour di Agnese Trocchi e del gruppo C.I.R.C.E.
In particolare, i capitoli:
– «Controllo parentale: come e fino a che punto?»;
– «Cyberbullismo»;
– «Il migliore amico di sua figlia».
Come evitare di linkare Facebook. Discussione e strumentario qui.
Ci sono cose che confusamente non mi tornano (inutile dire che la stragrande maggioranza sì) ma che non riesco a mettere troppo in ordine, come un certo fastidio per l’idea dell’abbandono dei social, che mi pare egocentrata. Ricordo Beniamino Placido rintuzzare le critiche sulla televisione richiamandosi alla regola del 92% che formulata da non ricordo chi e che in sostanza diceva che tutte la produzione umana è al 92% spazzatura, dai libri ai film, dalla musica alla pittura fino – appunto – ai programmi televisivi. E il consumo passivo della televisione mi pare (dico davvero: non sono sicuro) si possa in qualche modo comparare a quello dei social. Facebook è diverso? Il ragionamento della prima puntata è terribilmente convincente, soprattutto nella parte in cui si ricorda che l’aver incontrato il partner della propria vita in galera non è motivo sufficiente per frequentarla, però anche in quella parte si citano tentativi di uso critico dello strumento.
La questione che spazza le perplessità è relativa all’estrazione di valore ma chissà se quella potrebbe essere affrontata cambiando il proprietario (non nel senso di un altro uomo ovviamente, ma di un’altra classe). Del resto – sempre: mi sembra – parte del dibattito si è orientato alla fuga verso altri mo(n)di che “ricordano” fb ma che ne eliminino la gamification e appunto la possibilità di appropriarsi del valore.
Non so quanto serve ma parlando di questo post in giro mi sono trovato a sistematizzare le mie modalità di interazione attraverso la scrittura. Scrivo in tre luoghi (forse quattro) e visto che uno è una rivista “scientifica” uno “militante” e il terzo appunto FB naturalmente uso tre linguaggi diversi. Con l’età il bilanciamento tra questi tre tipi di intervento è cambiato e con l’uso di FB si è spostato effettivamente verso il terzo. La differenza di scrittura tra FB e la rivista militante è legata a due caratteristiche: l’emergenza(invadenza) dell’io e l’uso di termini che non userei mai in un “articolo” come “cazzo” o “merda” e un sarcasmo più accentuato. Però il mio “io” non è collassato (non acora almeno) perché oltre ai pezzi lunghi FB riesco (ancora?) ad usarlo per cazzeggiare, anche se pensandoci la “costruzione del personaggio” probabilmente è arrivata anche lì.
Scusandomi ancora per la confusione dell’esposizione finisco per adesso dicendo che sono poco convinto che lo spostamento verso la terza modalità di scrittura sia “ngativa”. Chiaramente le altre cose che scrivo non arrivano a tanta gente come su FB e soprattutto chi legge è diverso. Inoltre è più facile tornare sulle cose che hai scritto, magari sbagliando, perché i commenti sugli altri luoghi non ce li hai o sono così lontani da impedirti di mettere a punto quello che stai pensando. Forse c’entra l’idea che scrivo sempre “in progress” cosa che un tempo credevo sarebbe finita prima di scoprire che era un’ingenuità giovanile.
Boh, intanto questo, manco sono convinto di aver centrato i punti della discussione. A mia discolpa (o aggravante) è l’averci pensato a lungo a questo post eh?
Temo che oggi il dibattito novecentesco sull’«industria culturale», su «apocalittici vs. integrati», sulla TV ecc. ci sia di scarso aiuto, perché stiamo parlando di uno scenario molto diverso, e di modelli di business che nel ‘900 non esistevano.
Le interazioni su FB non sono paragonabili all’esperienza del telespettatore dei tempi di Placido, anzi, casomai il paragone funziona “all’inverso”: su FB ciascun utente ha un “canale televisivo” sul quale trasmette la propria vita quotidiana, e deve «tenere in piedi la programmazione» altrimenti calano l’indice di gradimento e quello di ascolto.
Il tutto in una cornice di senso tenuta attiva con un massiccio ricorso a tecniche persuasive perfezionate dall’industria del gioco d’azzardo e rese ancora più cogenti dall’applicazione al design informatico delle ultime scoperte neuroscientifiche. Tecniche che aizzano il narcisismo, inducono FOMO, mettono fretta, fanno saltare i freni inibitori, il tutto per estrarre valore da tali comportamenti.
La variante placidiana della Sturgeon’s Law – «90% of everything is crap» – qui mi sembra fuori fuoco, per più motivi:
– la S.L. riguarda solo la qualità dei contenuti, anche Placido parlava di quello, della cosiddetta “sostanza”, mentre qui parliamo pure – forse soprattutto – della “forma”, di modalità di interazione intossicate;
– Sturgeon non fece la sua famosa battuta per difendere lo status quo, semmai per criticarlo. Infatti, a ben vedere, non è una gran difesa…. «Adesso ti bendo e ti imbocco cento volte: novantadue volte ti metterò in bocca una cucchiaiata di merda e formaggia di cazzo… Ma no, non fare quella faccia, tranquillo! Le restanti otto volte ti farò assaggiare una leccornia!»
[OT: anche restando alla difesa placidiana della TV e accettando come soddisfacente la proporzione tra contenuti di merda e contenuti di qualità, Placido scriveva di una TV completamente diversa, generalista, e di un’audience diversa, non ancora frammentata dalla dispersione dell’offerta. Oggi i contenuti «di qualità» vengono relegati in canali tematici che guarda molta meno gente, nella TV generalista mi sa che la percentuale è scesa ben sotto l’8%.]
Nel post non abbiamo fatto esempi di «uso critico di Facebook», perché se parliamo di algoritmi, cioè di come funziona il dispositivo, ci sembra che il margine per un uso critico sia ben misero: non appena fai una minima forzatura ti sospendono o ti chiudono la pagina.
Se invece per «uso critico» intendi contenuti critici – appunto, «di qualità», chessò, le note che scrive Bifo – vale l’idem come sopra: da soli i contenuti non spostano nulla, se non esprimono una critica pratica alla macchina, se non ne mettono in crisi o almeno in questione il funzionamento. La critica puramente verbale al dispositivo è neutralizzata, smentita in tempo reale dalla cornice che ha intorno. L’utente la legge, e un minuto dopo mette il like a una minchiata.
Poi ci sono quelli che definirei «periodi ipotetici dell’irrealtà»: se Facebook fosse espropriato dal proletariato… Se Facebook non fosse finalizzato al profitto… Se Facebook non spettacolarizzasse le relazioni personali… Se Facebook non avesse gamification… Ma questi sono i capisaldi di Facebook. Lo sono fin dal nome: è il libro delle facce, è una collezione di show personali, di vite in vetrina. Se questi presupposti venissero a mancare, mancherebbe anche Facebook. Non indurrebbe più i comportamenti che mercifica, e senza quell’induzione, probabilmente, la gente farebbe altro.
[Probabilmente, non tutta la gente farebbe qualcosa di radicalmente altro dal punto di vista qualitativo, perché narcisismo, azzardopatia, gossip velenoso, clownerie piccolo-borghese, tutto questo esisteva pure prima dei social. Ma un bel po’di gente farebbe qualcosa di abbastanza diverso.]
Ma restando ai periodi ipotetici, cosa sarebbe Facebook… se non fosse Facebook? Boh, a dire il vero non è una questione così interessante. Questo è il modo poco efficace di porre la questione che abbiamo definito «ontologico», cioè è implicita – e a volte esplicita – la domanda: «Cos’è un social network?» Per noi è meglio l’altro approccio: «Abbiamo delle cose che chiamiamo “social network”. Come funzionano? Cosa fanno?»
È in questo modo che dissipiamo le nebbie e vediamo cosa abbiamo davanti: abbiamo davanti Facebook-così-com’è, non una fantasticata versione di Facebook senza le caratteristiche di Facebook, e magari in mano ai rivoluzionari (e non è mica detto ne farebbero buon uso… Non credo ci sia bisogno di scomodare Orwell o Koestler come pezze d’appoggio per questo dubbio).
I periodi ipotetici dell’irrealtà portano solo a continuare nel tran tran del Facebook-così-com’è, quando le energie potrebbero essere convogliate nella costruzione di qualcosa di diverso. Che secondo me non dovrebbe nemmeno “ricordare” Facebook. Qui torniamo alla metafora del latte di riso: le alternative “simili” sono ancora parte di una fase di transizione, di vero e proprio rehab. Compiuto il rehab, i nuovi modelli divergeranno sempre di più da quelli che abbiamo abbandonato.
Come accennavo prima sto cercando più di chiarirmi le idee che offrire spiegazioni, quindi metto in conto che qualcosa sia fuori fuoco. La risposta – e la replica – aiuta (me e spero qualcun altro) a mettere a punto con maggior precisione alcune questioni.
Tu dici che “il modello di business non è paragonabile” e io devo pensarci un po’ su, in attesa di spiegazioni migliori (nel senso di più articolate di quanto si possa fare qui dove si parla d’altro). A me pare che siamo in presenza di tentativi di vendere ad aziende le tue abitudini intrecciate con le capacità di fornirti/crearti un immaginario in modo che queste diventino più prevedibili. Sul fatto che si sia in presenza di un “avanzamento” (nel senso di migliorate capacità di intercettazione/creazione) mi pare di poter essere d’accordo, sul “salto”, sul fatto che sia una fattispecie diversa no, per il momento mi terrei i miei dubbi. Anche perché tu li leghi ad una diversa fruizione legata al fatto che “il programma lo fate voi” che era la grande retorica della TV. Dirai che però adesso succede davvero, ok, però succede senza che questo abbia la stessa pervasività della tv generalista. Il tuo OT a me suggerisce che la TV adesso faccia quello che un po’ di gente fa su Internet e sui social: si crea la propria bolla senza dover intravedere buchi dove incunearsi per vedere qualcosa di qualità. Ci sono gli utenti generalisti, che chiedono amicizia random e sono la grande maggioranza e poi le “bolle”. Non so bene di quanta gente parlo ma mi pare che esista un gruppo – che secondo me non è piccolissimo – che a quelle logiche ineluttabili che avete descritto non cede, senza neppure pensarci. Ora, se sono questioni (e gruppi) marginali io davvero non lo so, perché chiuso nella mia bolla interagisco con pochissima gente che condivide gatti e pranzi (in genere parenti o vecchi zii rincoglioniti che vedi a natale) e che mi pare sia molto lontana dall’interesse sui like e che legge ecc ecc. Come detto prima non collassa. Questo non mette in discussione nulla, il meccanismo è fatto per quello che dite voi, dico solo che il “piano” ha necessariamente delle falle, in cui si incuneano dei divulgatori o i post di Bifo appunto, ma il vostro punto è che il minuto dopo si mette il like alla cazzata e che queste siano eccezioni che niente significano. Mica dico che avete torto, dico che esiste all’interno di questo infernale meccanismo un posto non so quanto ampio, non so quanto utile, in cui invece che discutere della Brexit tra il primo e il secondo in 5 se ne discute magari in 20, in modo più approfondito e con qualcuno che passa e legge i rimandi e cercando – non più che in un’aula di seminari almeno – esclusivamente di tenere il punto. Il saldo è negativo? Di nuovo la forza della vostra argomentazione è tale da non prendere alla leggera il “costo” di quest’ampiamento ma la mia questione non è FB se non fosse FB (ovvio che è una minchiata) ma il social senza qualcuno che ne estragga valore. Questo non significa certo rimanere lì, il mio livello di informatizzazione è bassino ma i trasferimenti li ho adottati e spero che in qualche modo, mio aiuto compreso, possano diventare così soddisfacenti da portare alla sostituzione completa, senza scadere nel tran tran e consentendoci di dimenticare FB. Nel frattempo confesso che sono ancora lontano dall’exit (mai pensato alla voice e figuriamoci alla loyalty)
Detto per ora questo, continuo a leggere e a parlarne, magari – cosa che curiosamente (o no?) non è stata ancora fatta – anche su FB.
[Non so da cosa si ricavasse l’idea di difendere lo status quo con la SL, io me la ricordo come un tentativo di responsabilizzazione dell’utente – almeno nella versione di Placido – di non lamentarsi soltanto dell’offerta scadente. Poi ovviamente Placido non era certo un comunista…]
Questa sintesi suprema di godimento e sorveglianza, di gamification e controllo, di «discorso del capitalista» (Lacan) e «le vite degli altri» (Stasi), finalizzata a estrarre dalle nostre interazioni dati di navigazione da vendere, beh, a me sembra un modello di business nuovo, incentrato su una merce peculiare (i big data) e affermatosi negli anni Dieci del XXI secolo. Un modello molto diverso da quello della tradizionale industria dello spettacolo, che traeva profitto in altri modi, con altri strumenti. Bisogna per forza essere materialisti.
Certamente dentro il capitalismo e la logica capitalistica ogni modello di business ha similarità di fondo con gli altri, ogni sfruttamento di pluslavoro ha tratti in comune con gli altri, però le differenze e le innovazioni non possono essere trascurate. Nell’ultimo decennio, con l’affermarsi arrembante dei social, del capitalismo «delle piattaforme», della gamification di sempre più ambiti, sfruttamento ed estrazione di valore hanno acquisito tratti e caratteristiche nuove. Sotto le quali, certo, permane la stessa merda, ma se non capiamo cosa c’è di diverso volta per volta, non riusciamo nemmeno a organizzare resistenze, men che meno contrattacchi.
[Metafore e similitudini sono utili se le intendiamo come tali, alcune ci permettono di far vedere che l’interattività è in realtà “interpassività”, o ci permettono di “far leva” per rivelare l’ideologia dove nessuno la riscontra mai, ma non dobbiamo rimanerne prigionieri. Sui social certe cose ricordano l’architettura di una sala slot, altre rimandano ai reality-show ecc., però la sintesi è nuova.]
La retorica televisiva della «partecipazione» era appunto retorica, si restava comunque dentro la logica della comunicazione “da uno a molti”, il fine era sollecitare feedback subordinato (la telefonata, il “televoto”, la lettera da casa) per “ingaggiare” l’audience, tenere alto l’indice d’ascolto e quindi guadagnare di più dalla vendita di spazi pubblicitari in quella fascia. La TV non aveva al centro del proprio modello di business i big data generati dagli spettatori, non stava tutto il tempo a pungolarti con modifiche di un algoritmo per registrarti, impacchettare e vendere le tue abitudini. E la comunicazione che ha luogo sui social non è semplice feedback dei molti verso l’uno, è un fittissimo reticolo di comunicazioni, un miliardo di “canali televisivi” che in teoria dispongono ciascuno degli stessi mezzi degli altri. Anzi, questo è proprio il punto, la conditio sine qua non.
Riguardo allo stare su FB senza cedere troppo all’impeto algoritmico, sicuramente c’è chi per vari motivi riesce a farlo, ma come tu stesso fai notare e come scrivevamo nella prima puntata, questo non incide sull’analisi generale. E tornando all’esempio delle note di Bifo, io continuo a pensare che, da un lato, stare su FB senza criticare lo strumento – come fanno molti che pure sono anticapitalisti – sia una contraddizione non da poco, e dall’altro lato, che una critica a FB espressa senza mettere in questione il frame fornito da FB e aderendo alla “sintassi” di FB (scrivere una “nota” anziché un articolo da un’altra parte) sia intrinsecamente “autoneutralizzante”.
Noi abbiamo tentato di “spazzolare contropelo” Twitter, di farci esperimenti sopra. Era un tentativo collettivo e organizzato, alimentato da un continuo fare inchiesta, ma alla fine persino noi abbiamo dovuto rinunciare. Fatico a vedere margini spendibili e sensati per spazzolare contropelo FB.
Con il riferimento allo “status quo” intendevo dire che Placido, con tutta la buonafede che gli vogliamo riconoscere, campava scrivendo di TV. Aveva una certa “funzione sistemica”, oggi sdilinquita ma al tempo chiarissima. Chiaro che doveva difendersi dalle critiche di chi metteva in discussione il senso stesso dell’occuparsi di certe cose. In questi casi, il ricorso alla Sturgeon’s Law, anche quando legittimo e corretto, suona sempre autogiustificatorio, a difesa della suddetta funzione sistemica: io vi invito a discernere, c’è anche un 8% di roba buona ecc.
[Dopodiché, ricordo bene Placido spacciare per tv di qualità spazzatura in cui lui stesso era coinvolto: co-condusse un programma che consisteva nel lasciare sproloquiare Montanelli da inizio a fine puntata. E se c’è uno che ha favorito in ogni modo l’affermarsi in Italia del supposto 92% di merda, quello è Montanelli, che ci ha lavorato alacremente fin da quando mio nonno era alle elementari.]
alcune considerazioni sparse:
1— Questione “dati”: il ritorno alla blogosfera o l’uso di social decentralizzati non risolveranno il problema, anzi faciliteranno il lavoro di raccolta dati da terze parti.
“it will not solve the Cambridge Analytica problem: If everyone used Open Source networks or returned to blogging and homepages, their public content can and will still be data-mined by third parties” Geert Lovink, https://amsterdamalternative.nl/articles/5518
Come esempio: fare data mining su mastodon per costruire il grafo di una rete sociale e’ enormemente piu’ facile che farlo su twitter https://www.autistici.org/void/mastograph.html
2— I links, o come si chiamavamo in passato “hyperlinks”, sono la natura stessa del web. Va incoraggiata sempre di piu’ l’attivita’ di linkare sempre le risorse originali (o una copia di archivio, ad esempio dalla wayback di internetarchive o da https://webrecorder.io). Io non sono assolutamente d’accordo con policy d’uso o con trucchi vari che vietano di linkare alcuni particolari siti. Se la cosa di cui abbiamo paura e’ il tracciamento, e’ un problema che possiamo risolvere lato client, con i browser, ed esistono le soluzioni per farlo.
Un problema che si aggiunge e’ che spesso, oggi, questi link non siamo noi ad aprirli per primi, ma c’e’ qualche software che lo fa al nostro posto https://24ways.org/2019/microbrowsers-are-everywhere/ , permettendoci di vedere delle anteprime (nei social, nei messengers).
Dobbiamo imparare ad avere un controllo migliore di queste anteprime, ad esempio e’ fondamentale che una delle informazioni immediatamente visibili sia la data per indicare la “freschezza” del contenuto
https://www.niemanlab.org/2019/04/the-guardians-nifty-old-article-trick-is-a-reminder-of-how-news-organizations-can-use-metadata-to-limit-misinformation/
3— Il ritorno alla blogosfera e la tendenza alla decentralizzazione sono da sostenere, ma causeranno una frammentazione dei contenuti e aumenteranno le difficolta’ nel ritrovare informazioni. Erroneamente si pensa che il valore di alcune piattaforme sia nei contenuti che possiedono, io invece credo che il loro valore sia nella possibilita’ di renderli ricercabili, in tempi brevi, e con risultati efficaci.
Vivremo sempre piu’ una sovrabbondanza di informazioni e in futuro probabilmente quello che compreremo non saranno contenuti ma sistemi di ricerca piu’ veloci (non e’ una mia previsione, l’ho letto da qualche parte ma non ritrovo la citazione).
In passato si faceva uso dei webring, una soluzione poco invasiva e molto efficace, a cui si potrebbe ripensare: siti affini che si linkano a vicenda.
https://mastodon.social/@QuestForTori/103395751252144335
https://it.wikipedia.org/wiki/Webring
Grazie dei materiali, Void. Riguardo al punto 1, uno dei nostri motti è: «non esiste la volta per tutte». Nello specifico, non esiste la soluzione tecnica definitiva al problema del data mining. La soluzione dev’essere tecnica e politica insieme, e verrà trovata solo con la pratica del conflitto.
Detto questo, c’è una significativa differenza tra il data-mining-e-basta fatto “da fuori”, da terze parti, eseguito mentre io comunico coi miei tempi e con una certa autonomia su una piattaforma non gamificata da altri, e il data mining che avviene perché io, pollo inconsapevole, danzo dentro una cabina come nel film di Herzog. Il problema del data mining sui social, infatti, non è “solo” il data mining: è anche il fatto che per trivellare sempre più dati una mega-corporation faccia esperimenti sulla vita delle persone, inducendo comportamenti sempre peggiori, interazioni sempre più venefiche e dipendenze sempre più subdole, favorendo e accelerando la diffusione di leggende d’odio, teorie del complotto omicide, false notizie ecc.
Riguardo al punto 2, giustissimo quel che dici sul lato browser, ma nell’attesa che un gran numero di persone raccolga queste dritte che anche noi stiamo dando, noi vogliamo comunque rendere Giap un blog che dia il minor numero possibile di “appigli”. Anche usare redirect e copie-archivio, spiegando perchè lo si fa, ha una funzione (auto)educativa.
Riguardo al punto 3, benissimo il webring, il blogroll e altri strumenti che ci eravamo già dati nella blogosfera d’antan, ma si può aggiungere un livello ulteriore. Costruire un “social di blog”, una federazione che colleghi i blog usando uno strumento come Mastodon, sarebbe in fondo l’evoluzione del webring.
Sulla reperibilità/consultabilità o meno delle informazioni: già adesso un’iperciclopica massa di contenuti è ripescabile con grande difficoltà: quella che sta su FB, che è allergico alla storicizzazione del flusso e come archivio e ricerca interna fa davvero schifo. Rispetto a questo, possiamo solo migliorare.
[…] Una scoperta di questo fine 2019 sono i due post della Wu-Ming Foundation che ripercorrono le scelte fatte negli ultimi 10 anni rispetto all’uso dei social, e in particolare di Twitter, motivando la scelta di lasciare la piattaforma in questione […]
Ciao,
ho letto e sto rileggendo i post, cercando di capire cosa fare, con tutti i dubbi e le contraddizioni della parte di lavoro e militante. Ci son punti che a me generano perplessità per la parte militante (vedendo ad esempio come molte campagne sono state lanciate su twitter soprattutto dal movimento femminista nello stato spagnolo, con potenti risultati, come le manifestazioni post sentenza della manada, ecc. ecc) Ma non son venuto qui per parlare di me, quando ancora non ho una opinione strutturata.
Volevo solo raccontare una cosa che è successa in questi giorni, e che credo che possa essere interessante, (dubito ci sia stato un fenomeno di dimensione rapportabile nel territorio italiano). Credo che potrebbe sviluppare una tendenza (o almeno aggiungere un elemento alla riflessione).
L’altro ieri, un utente twitter dello stato spagnolo, molto famoso Elotroladodelmuro (Julián Jiménez, conosciuto come “il professore”, un professore-attivista che dedito a occuparsi di spiegazioni di linea M-L, in cui cercava di smontare i miti del franchismo, dell’anticomunismo nello stato spagnolo, con una visione critica, abbastanza vicino ai movimenti) è stato bloccato per l’ennesima volta, e stufo degli attacchi dei bot di estrema destra, ha lanciato un hashtag: #yomigroamastodon.
E così è iniziato un effetto a catena, in cui moltissimi utenti di diverse regioni dello stato, hanno iniziato a migrare (piú che migrare, a farsi un secondo account) fino al punto che anche Eugen (@Gargron@mastodon.social) se ne é reso conto.
Parliamo di circa 10mila utenti che hanno aperto un secondo account su mastodon (https://mastodon.social/@usercount/103398510726960675) su diverse istanze, molti dei quali non sanno ben bene come funziona lo stesso strumento.
Il problema, dal mio punto di vista, avverrà fra un paio di settimane, quando “toccherà decidere”. Se alcuni, ormai presi di mira dalla censura dei social non possono svolgere il proprio attivismo e decideranno di migrare, molti, anche in una dinamica in parte vittimistica presente nella stampa anche vicina al movimento nello stato spagnolo potrebbero non muoversi.
Inoltre, aggiungo un secondo effetto che mi sembra curioso: si sta rigenerando una nuova dinamica twitter, legato, non tanto alla informazione, ma “ai personaggi”. Chi si è spostato su mastodon fuori da questa ondata, almeno come avevamo fatto io e alcuni che me lo avevano segnalato all’epoca, era entrare, guardar e com’è capire, e “fare qualcosa”. E si notava la differenza… Cosa che avrei capito come funzionamento per un processo di disintossicazione, per i ritmi differenti, la minor frequenta, ecc.
Ma ora, almeno nello stato spagnolo, si sta riproducendo la dinamica twitter-twittstar, negli spazi di mastodon. Uno dei primi commenti che mi ha sorpreso è stato “ma Mario Rossi ha già 1000 followers!” E contemporaneamente iniziavano ad apparire un paio di account parodia/fake, copiati pari pari dalla dinamica di Twitter. Lo dico per la citazione che ha post Void “Web 1.0 was a glimpse into a sustainable, communal, anarchist internet that was promptly crushed by capitalism.” Credo che anche queste dinamiche di concorrenza sociale che si sviluppano sono elementi capitalistici che in questo fenomeno complesso di migrazione massiva di un settore della società militante dello stato spagnolo, si stanno trascinando in maniera abbastanza chiara.
E lo dico perchè se le narrazioni individuali di “disintossicazione” sono interessanti, anche vedere come evolvono le collettive pure, anche perchè potrebbero non essere assolutamente rapportabili.
Grazie, Victor, stiamo tenendo d’occhio quel che sta accadendo nella socialsfera iberica… È quel che cerchiamo di far notare da settimane e che abbiamo messo in forma di dubbi nell’ultimo paragrafo della seconda puntata: se non c’è una minima analisi critica su come funzionava il social commerciale che sto abbandonando (o che dico di voler abbandonare, perché poi bisogna vedere quanti lo faranno davvero), e soprattutto se non c’è la minima riflessione autocritica su come ci stavo sopra, il mio passaggio a un social non commerciale non farà altro che importare nel nuovo ambiente le dinamiche tossiche di quello vecchio: competitività, micro-stardom, FOMO e quant’altro.
Il fatto che Mastodon non sia di una corporation che trae profitto di queste dinamiche e, in senso stretto, non abbia interesse a pungolarle, non è una garanzia sufficiente. Se una comunità “tossica” diventa egemone in un’istanza di Mastodon, chi garantisce che non introduca “dal basso” – perché ne è dipendente – modifiche gamificanti? E poiché la gamification aumenta le addiction, ci vuol poco perché la degenerazione si estenda nel network.
Molti discorsi che si sono fatti qui sopra vengono fatti guardando in modo molto superficiale tutta la situazione del fediverso e la capacità di reazione a eventuali problematiche simili a quelle presenti su twitter. Molte volte si parla di mastodon senza parlare delle istanze che sono assolutamente diversissime. Certi ragionamenti su bot e follower sinceramente mi fanno sorridere perchè l’esperienza che molte persone fanno è solo da utenti, guardando lo strumento solo da quel lato.
La vera differenza che esiste su mastodon è la possibilità di creare una comunità e creare tante istanze, tante piccole isole nella rete. E rispondo con due esempi semplicissimi:
1) se avere troppi follower trovate che sia un problema, allora iscrivetevi su mastodon.cisti.org lì tutt* gli/le utenti hanno lo stesso numero di follower, ovvero 42
2) ci sono utenti fake bot etc. Farli sparire è un attimo se si amministra un’istanza. noi ne abbiamo tolti diversi. Altri si sono suicidati dopo l’intervento di utenti che non volevano avere il clone comico stile twitter di Salvini in timeline
Poi esempi di situazioni particolari che in questi due anni abbiamo visto ne potrei descrivere tantissime. Ad esempio come è cambiata la differenza di interazione da quando su bida siamo passati da 500 a 840 caratteri per i toot.
Questo è per dire che sebbene siamo tutte d’accordo che la differrenza non può essere solo tecnica, bisogna dire che quel c’è (o che possiamo fare, dato che qui possiamo farlo) è già una bella e grande differenza. Inoltre siamo tutte d’accordo che la soluzione deve partire principalmente dall’individuo che criticamente fa certe scelte e non ripete certi comportamenti, però dobbiamo anche capire che è normale che molti passeranno a mastodon senza conoscere nessun ragionamento o aver letto articoli come questo, ma trovarsi catapultati in un’istanza piena di utenti consapevoli è un grande differenza. E su bida (e su cisti, nebbia etc) questi utenti ci sono. Per questo stiamo spingendo questo progetto chiedendo di abbandonare le altre piattaforme. E sinceramente regionamenti sulla difensiva come quelli appena fatti, guardate che non stanno assolutamente c’entrando l’obiettivo. La soluzione si costruisce assieme. E finalmente c’è qualcosa su cui lavorare.
Quando si arriverà a capire che stiamo rischiando di perdere un’occasione?
Jops uno dei tecnici dell’istanza bida
Scusaci, Jops, ma questo è un commento a nostro avviso un po’ troppo “identitario”, di comprensibile ma istintiva e frettolosa difesa del Fediverso da presunti attacchi che non sta affatto ricevendo. Un commento simile ad altri apparsi su Bida nei giorni scorsi: anche quelli parlavano di questa miniserie e di questa discussione come di una potenziale o addirittura già attuale «occasione sprecata per Mastodon». Non solo non capiamo su quali basi si possa dire una cosa del genere, ma ci sembra un commento del tutto estraneo a quel che si sta dicendo qui.
Abbiamo annunciato che stiamo usando Mastodon e invitato chi ci segue a usarlo a sua volta.
Molte persone hanno raccolto e stanno raccogliendo l’invito (a occhio e croce abbiamo 400 follower in più rispetto a quando è uscita la prima puntata).
Non solo: abbiamo detto e ribadito che stiamo ragionando sul trasformare Giap in un’istanza di Mastodon, primo passo verso la possibile creazione di una nuova blogosfera.
A te tutto questo sembra un’«occasione persa» o sprecata per Mastodon? Boh, allora non sappiamo a quali migliori occasioni tu sia abituato, davvero.
Non c’è alcuna delegittimazione del lavoro tuo e degli altri tecnici e admin se si fa notare che alcuni problemi di fondo permangono, legati soprattutto all’aspettativa che abbiamo quando parliamo di «social» e alle abitudini che i social commerciali hanno incistato nelle nostre vite.
Questa è solo molto secondariamente una questione di implementazioni tecniche e di scelta di questa o quell’istanza; è invece moltissimo una questione politica, culturale, antropologica, che trascende la buona volontà di noi tutti e che va indagata incessantemente, ponendosi domande e dubbi che non devono essere scoraggianti o addirittura paralizzanti, ma dare linfa al nostro lavoro quotidiano.
Noi restiamo fedeli al motto zapatista «Camminare domandando». Cammineremo con voi continuando a problematizzare, problematizzeremo senza smettere di camminare con voi.
Salve, sono molto interessato a questi temi e sto seguendo questa discussione qui perché mi sembra che gli interventi siano davvero molto lucidi e fondati su una conoscenza dell’argomento, contrariamente a quanto vedo fare di solito altrove.
Riguardo alla contrapposizione twitter/mastodon, penso che vada privilegiato uno sguardo più distante. Mastodon, lo avete scritto, non è certamente la soluzione definitiva. Per lo sviluppo di relazioni prive degli elementi alienanti che abbiamo riconosciuto in twitter e in misura anche maggiore negli altri social network, non basta, chiaramente, che gli utenti migrino ad un social network non commerciale. Possiamo dare già per certo che una eventuale migrazione di massa a mastodon si risolverebbe con la replicazione degli stessi meccanismi di twitter. Anche perché mastodon contiene già gli strumenti per la gamification, come avete già fatto notare. Ma il punto non credo che debba essere questo. Bisogna riconoscere che l’eccesso di attenzione riservata agli elementi quantitativi come il numero di like o quello dei follower, non è una invenzione dalla gamification. Semplificando molto, direi che è un effetto del linguaggio del nostro tempo, il linguaggio delle macchine. La gamification è solo un dispositivo che raccoglie frutti seminati altrove. Come chi si arruola nelle truppe cammellate sfoga una frustazione montata altrove: nei rapporti di lavoro, in quelli familiari. In questo senso va recuperata una visione d’assieme: non è interessante quello che avviene nei social network ma quello che avviene all’essere umano. Quelli che contano per mastodon sono i pilastri su cui poggia: è un software libero e quindi può essere trasformato in qualsiasi cosa, da chiunque lo sappia fare; si basa sul decentramento e sulla federazione delle istanze mitigando la possibilità di un’autorità centrale; non esaurisce la sua ragion d’essere nella logica del profitto.
Penso che sia ľapplicazione pratica di queste forme di libertà ad essere proficua ma sul lungo periodo e su una scala più ampia.
[…] Shosana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, di cui parlerò tra un attimo; la seconda è il resoconto di 10 anni di Twitter della Wu Ming Foundation sul loro blog Giap, a cui anche mi legherò tra […]
[…] gli anni Dieci riflettendo autocriticamente sul nostro stare in rete e innescando una nuova fase di esodi e cambiamenti. Ora apriamo gli anni Venti occupandoci del nostro stare in strada, nel modo più pratico […]
Dopo un po’ di storie di disintossicazione dai social, ve ne propongo una opposta:
Il Doping da social.
Ho ripreso a usare intensamente i social (Facebook, Twitter) una settimana fa per promuovere un giochino gratuito fatto in 72 ore in una “jam”.
Fa eccezione Mastodon a cui mi sono iscritto poco prima del 6 agosto per cercare di capire cosa succedesse a Xm quando non ero fisicamente lì.
Premetto che la mia visione è condizionata dal fatto che non posseggo un cellulare da circa 8 anni, quindi ho sicuramente una percezione parziale della realtà “Social”, visto che le notifiche – che siano di facebook, twitter, mastodon, mail, etc. – mi arrivano solo quando sono seduto davanti a uno schermo.
I bar/pub sostituiscono facebook e twitter.
Xm, Vag e luoghi simili sono il mio Mastodon.
Il mio uso attuale dei social è quindi a scopo puramente “commerciale” (escluso Mastodon.. lì mi ci trovo bene).
Mi sento come un ciclista amatore che si dopa per vincere il primo premio alla Coppa Cobram.
La cosa che – per modo di dire – mi sorprende è che nonostante io abbia passato più di 72 ore sui social a promuovere il giochino, le visualizzazioni totali della pagina del gioco provenienti dai social sono meno del 20% del totale.
Avevo il sospetto che potesse andare a finire così ma volevo provarlo sulla mia pelle per capire se fosse più sfiancante fare un gioco in 72 ore o promuovere per più di 72 ore il giochino sui social.
La conclusione è che la prossima volta che parteciperò ad un’altra Coppa Cobram preferirò allenarmi (facendo altri giochini) piuttosto che doparmi spammando sui social. Magari ci vorrà più tempo per vincere il primo premio ma se dovesse capitarmi di vincerlo sarà perché ho più fiato e le gambe sono più allenate rispetto a prima.
Userò i social solo come bot dell’annuncio dell’uscita del prossimo giochino.
Grazie per questo gran bell’articolo. Per me è stata una boccata d’aria fresca. Sono un po’ stanco di fare presenza sui social. Soprattutto già le mail si mangiano tanto tempo a disposizione. I social divorano il resto e ne rimane poco per la scrittura, il lavoro, la lettura. E soprattutto per gli incontri e l’attivismo faccia a faccia, per i rapporti veri.
Detto questo, aggiungo solo che anche l’ipotesi di usare i social per estendere e irraggiare la propria progettualità politica serve a poco. Gli “utenti” su facebook consolidano solo le idee che già fanno parte della loro cornice di pensiero. Sostanzialmente, nel migliore dei casi, si parla a chi è già è convertito.
Continuiamo a vederci altrove, soprattutto nelle relazioni e nell’attivismo in carne e ossa.
Inserisco questo commento di un mio amico (non solo virtuale) uscito sei mesi fa proprio su FB che mi pare interessante. Ci sono dei link che non so come inserire qui su GIAP e però non vorrei linkare fb e quindi sto facendo dei copia incolla. Lo scrisse in occasione del lancio di una criptomoneta (cosa che pare, per adesso, scongiurata)
LIBRA E IL LIBERO STATO ASSOLUTO DI FACEBOOK
18 giugno 2019 · Tutti
In questi anni a Facebook abbiamo dato, volontariamente e come minimo, informazioni su:
a) i nostri dati anagrafici
b) i nostri dati fotografici
c) i nostri movimenti
d) la nostra famiglia, specie di chi non è registrato (minorenni e anziani)
e) le nostre opinioni politiche
f) le nostre preferenze sui consumi
g) i nostri dati economici (che lavoro facciamo, se ne facciamo, se lo abbiamo cambiato e tutto il resto)
h) il nostro grado di istruzione
i) le nostre relazioni umane con altri
l) il nostro stato di salute.
Abbiamo dato questo e molto altro anche se non lo abbiamo fatto direttamente, poiché attraverso gli incroci dei dati con “amici” è possibile recuperare quello che manca.
Facebook ha strumenti in grado di fare in qualunque momento un identikit di un suo “utente” con una precisione che manca a qualunque altro sistema di informazioni personali siamo abituati a pensare.
FB è qualcosa che nessuna polizia segreta di nessuno Stato ha mai osato immaginare in termini di controllo e schedatura dei suoi cittadini. FB è, di fatto, molto più che una “piattaforma” di connessione telematica tra persone.
Facebook è uno Stato, con somiglianze inquietanti ad uno Stato reale almeno dal punto di vista giuridico tradizionale del termine.
Facebook come uno Stato
FB ha un suo popolo, ai cui membri viene concessa la cittadinanza previa registrazione (cioè attraversouno scambio: tu mi dai i tuoi dati personali e io ti faccio diventare cittadino FB).
Ha un suo territorio. Esso coincide con qualunque luogo al mondo abbia tre requisiti: una connessione internet cui potersi agganciare, un terminale (pc o cellulare) per che possa connettersi a quella rete, un software in grado di fare accedere allo spazio FB.
Ha una sua sovranità, cioè un uso esclusivo della forza legittima perché riconosciuta tale dai suoi cittadini. Esso ha infatti il potere di punire i trasgressori delle regole. Le pene possono essere lievi (sospensione della cittadinanza per un certo periodo il che equivale ad una messa in prigione) o definitive. Esiste, dentro FB, infatti, l’equivqlente della pena di morte. Che consiste nell’estromissione definitiva dallo Stato di FB.
Uno Stato davvero nella pienezza dei suoi poteri però non può limitarsi alla questione “giuridica”. Ha bisogno della sua dimensione economica e finanziaria.
Ha bisogno di esercitare la sua sovranità monetaria. La capacità, cioè, di gestire direttamente i rapporti economici tra i suoi cittadini in termini di transazioni di merci, beni o servizi che siano dentro i suoi confini.
Una moneta era dunque quello che mancava a FB per potere essere davvero uno Stato a tutti gli effetti come un qualunque altro Stato esistente.
Questo fino a ieri.
Poiché da oggi FB ha la sua moneta. Si chiama “Libra”, è una criptomoneta virtuale che ricorda i bitcoin ma che ha caratteristiche che dovrebbero renderla meno oggetto di speculazioni eccessive.
FB è uno Stato fondato sull’assolutismo
Ora, lasciamo perdere tutta la questione economica di Libra (trovate in rete, grazie all’altro Stato, Google, tutte le informazioni di cui avete bisogno). Concentriamoci per qualche istante sulla questione della compiutezza del libero Stato di Facebook.
Questo Stato ha tutte le caratteristiche di uno Stato assoluto.
Facebook Inc. è, una “public company”, secondo il diritto statunitense, cioè una società per azioni ad azionariato diffuso. Il controllo della società è dato al gruppo dirigente selezionato secondo criteri che gli stessi gruppi dirigenti fondatori hanno deciso.
Vi è dunque una oligarchia a capo dello Stato di FB e a capo dell’oligarchia un super oligarca (il CEO, quel che potremmo tradurre come Presidente e Amministratore delegato).
Quella oligarchia risponde all’azionariato esclusivamente in termini di dividendi corrisposti e di valore delle azioni. Le regole di funzionamento dello Stato di FB sono decise dagli oligarchi e mutate a seconda delle necessità sociali, tecnologiche e dei rapporti di forza che si vengono a creare dentro l’oligarchia e nelle relazioni che questa mantiene con altri Stati “virtuali” (Google, ad esempio) o con Stati reali.
In questo Stato assolutista non è prevista una assemblea legislativa emanazione del “popolo” di FB. Non è previsto un governo espressione di un libero voto. Le regole, le leggi, che governarno FB sono decise dal gruppo dirigente della “Incorporated” e non sono sottoposte al giudizio dei suoi “cittadini”. Quindi se la “Inc.” decide che deve avere una sua moneta la avrà senza consultare nessun altro che non sia un gruppo di esperti economici, di psicologia sociale per sondare gli umori dei “cittadini”, di esperti di diritto per valutare la coerenza di questa decisione con le leggi esistenti negli Stati tradizionali ove opera.
Conseguenze
E’ la prima volta, credo, nella storia dell’uomo che viene creato una sorta di Stato a dimensione planetaria fondato sull’assolutismo e i cui “cittadini” vi aderiscono entusiasticamente di propria volontà senza costrizione alcuna che non sia un seducente e suadente meccanismo di cooptazione.
Le conseguenze sociali, politiche, economiche, umane di questa situazione io non sono in alcun modo in grado di prevederle.
Sono però in grado di avere sospetti.
E sospetto che le nuove generazioni, cioè quelle composte da coloro i quali hanno una età al di sotto dei venti anni, che non hanno alcuna dimistichezza con le pratiche di una democrazia tradizionale, con l’idea di uno Stato tradizionale, di una politica tradizionale fatta di ideologie e partiti ma che abbiano al contempo una formazione tecnologica avanzata e una grande dimistichezza con gli strumenti che queste nuove forme di Stato gli hanno offerto, fra poco, fra non molto, avranno quella come idea di Stato. Quella di uno stato fondato sui “like”, sulla estrema semplificazione degli argomenti che investono il vivere civile, sulla accettazione passiva e non meditata di una struttura economica (e dunque politica in fin dei conti) fondata sull’assolutista pensiero unico dell’individualismo liberista (cioè la multinazionale).
La trasformazione di una multinazionale (un soggetto economico) in uno Stato (un soggetto politico) è un passaggio che ormai si è completamente consumato e le cui conseguenze a me paiono devastanti nel medio periodo in termini di rincretinimento globale ben peggiore del rincretinimento globale cui ci hanno abituati, e cui siamo sottoposti senza possibilità di sfuggirvi, i media di massa a partire da una televisione fondata sul culto del consumo e dell’apparire.
La domanda a questo punto è: è possibile interrompere questo passaggio? O comunque sottoporlo al vaglio dei “cittadini” del libero stato assolutista di Facebook?
La risposta è no.
Ormai è impossibile. La cultura dell’efficienza operativa, dell’innovazione tecnologica, della competizione, del consumo e della crescita (del Pil), di cui è alfiere ogni multinazionale che si rispetti, è dominante in qualunque tipo di relazione pubblica e privata. In più l’assenza collettiva di riflessione sul rischio di consegnare ogni aspetto della propria persona ad istituzioni private fondate sull’assenza di controllo sociale e democratico è un dato di fatto.
Che fare?
Resta solo una via d’uscita. Anche se non per tutti.
Resta la rinuncia volontaria ad aderire al superstato assolutista da parte di qualcuno meno permeabile alla tragica dottrina del benessere comune creato dalle multinazionali.
Esiste la libera comunità anarchica di Diaspora.
Diaspora, senza entrare troppo nel dettaglio qui, è una alternativa praticabile ai “social network” controllati dalle oligarchie di tecnocrati pericolosi oltre che politicamente non responsabili di fronte a nessuno.
E’ una rete decentrata. Non conserva dati personali, sono distribuiti. Non ha un centro operativo di raccolta, non accumula informazioni, non gestisce capitali e non esiste per accumulare capitali.
Offre, nello spirito e nella filosofia di vita delle comunità “Open Source” ( informazioni qui e qui), più o meno le stesse cose che offre Facebook o Google.
Entrare a fare parte di questa comunità non è più, per chi teme il controllo delle multinazionali sulla propria vita, una opzione desiderabile.
E’ il solo modo per non essere complici di una strategia di lavaggio del cervello tra le più totalitarie e profonde che l’umanità abbia mai sperimentato.
Io, per parte mia, sto cercando di traslocare, di rinunciare alla “cittadinanza” tanto benevolmente concessami dal libero stato assoluto di FB.
Invito chiunque a farlo.
Non è complicatissimo.
Si può cominciare da subito a partire dal seguire questo link e iscriversi https://brighton.social/i/9d902f1c5864
Spero, entro un anno al massimo, di non essere più qui dentro ma spero soprattuto che una speculazione finanziaria distrugga alla radice qualunque nuovo libero stato assolutista come FB o Google o Apple o Microsoft. Solo la madre di queste mostruosità, la speculazione di borsa, è in grado di fermare i suoi figli. Non la politica, non una rivoluzione, non un colpo di stato. Solo gli speculatori possono decretarne la fine. Se si convincono che non è più un buon affare investire su di loro.
Più si abbandonano questi Stati non più virtuali, più cresce la possibilità che gli speculatori si convincano di questo.
Altro metodo per ridurne l’influenza e lo strapotere non vedo.
P.S.: per quelli che volessero cominciare subito qualche consiglio.
Oltre ad aderire a Diaspora, usate ogni possibile alternativa “open source”.
Piuttosto che WhatsApp usate Signal.
Invece che Windows o MacOs usate Linux.
Invece che i servizi di Google usate quelli aperti e liberi di Disroot (https://disroot.org/it/).
Ciao @robydoc consiglia al tuo amico, se non l’ha già letto, questo libro:
Etienne de La Boëtie – Discorso sulla servitù volontaria
Grazie, riferisco. Anche se mi pare molto improbabile che non l’abbia già fatto :-)
[…] per fare finalmente il gesto decisivo, e finalmente è arrivata con il duplice post dei Wu Ming (qui la seconda parte, in cui è linkata anche la prima; consiglio sicuramente di leggere anche i […]
Dovendo usare i social per lavoro, mi sono accorto che mi stavano inghiottendo: sia a livello di tempo che di contenuti.
Ho deciso di riappropriarmi del mio tempo, staccandomi da una logica imposta dall’alto.
Mi sono iscritto su Mastodon cercando di usarlo in maniera diversa, sperem.
Ottime riflessioni, ottime iniziative, ottimi articoli ma insomma non è che ve lo devo dire io.
Però ogni qualvolta che sto per mandare a cagare fbk e la sua invadenza mi viene sempre la stessa domanda a cui non riesco a rispondere.
Anche se è ovvio che il social è fatto in una certa maniera per certi scopi siamo sicuri che non riuscire a tollerare la sua invadenza, quanto meno a contaminarlo è una buona scelta?
Se io mi costruisco o frequento solo piattaforme che sono a me congeniali, non limito il mio campo d’azione?
E soprattutto, sono sicuro di non star perdendo io stesso un’opportunità nel vedere cosa succede li dentro?
Per questo ho apprezzato molto la vostra “non critica” su chi sceglie di restare la dentro a spalar merda che avete pubblicato nella prima parte di questo pezzo. Molte persone non capiscono, purtroppo, che in questa situazione così ad alto cambiamento, (quasi) ogni scelta di come combattere la disinformazione e l’ignoranza è legittima.
Parlando della mia realtà, se io organizzo un evento (reale) con la mia associazione e lo pubblicizzo su fbk vengono x persone. Se non lo pubblicizzo su fbk vengono x/2. Mi conviene mandarlo a cagare fbk?
Ecco, il proposito di riaccendere i nostri vecchi blog e usare i social come mezzo di rimbalzo, quello sì. Anzi, non ho mai smesso di usarlie di aggiornarli in attesa che passi la smania del “a ma non sei su [inserire social di moda del momento]”.
Insomma boh. E tanto per chiudere questo commento raschiando wikiquote: “C’è una grande confusione sotto il sole. Il momento è propizio!”
Uhm… «Contaminare» Facebook cosa potrebbe significare? Alex, non penso che tu ti riferisca al metterci dentro contenuti “antagonisti”. Questo viene fatto tutti i giorni e di certo non “contamina” Facebook, il quale continua a funzionare secondo la sua logica, digerendo quei contenuti, traendo profitto da essi e restando fuori dal raggio della critica.
Se, com’è palese, anche contenuti ultraradicali non producono di per sé conflitto contro Facebook stesso, è chiaro che quando scrivi «contaminare» ti riferisci a qualcosa di più.
«Contaminare» FB dovrebbe significare “hackerarlo” con prassi conflittuali, imponendogli logiche diverse da quelle che lo fanno funzionare, dinamiche in contrasto con la sua gamification finalizzata al data mining, con la sua estrazione di valore, con il suo onnipervasivo imperialismo culturale ed esistenziale. «Contaminarlo» dovrebbe significare mettere in crisi il dispositivo, che verrebbe usato contro se stesso. Con il primo risultato di mettere in crisi gli automatismi, le abitudini, le dipendenze, l’omologazione dei modi di reagire ed esprimersi.
Ok, ma chi lo fa? Chi sta pensando di farlo? E come farlo, se Facebook è a tutti gli effetti una dittatura – una dittatura basata sul «default power» – e non c’è alcun controllo degli algoritmi da parte degli utenti? Infatti, non lo vediamo fare a nessuno. Sperimentazioni così, se ci sono state, non sembrano essere uscite da piccole e invisibili nicchie. E intanto FB continuava a imporre e rafforzare le dipendenze che abbiamo provato a descrivere.
È una dipendenza anche quella dall’«evento»: «io FB lo mollerei, ma se non faccio l’evento alle mie serate non viene nessuno…» Ok, ma è una biscia che si ciuccia la coda: se smetto di curare altri ambiti, altri strumenti, altri canali, e privilegio FB come principale – o addirittura unica – cassa di risonanza, è chiaro che senza fare l’evento FB non batterò chiodo. Tra la mia attività pubblica e il rituale dell’evento FB si crea un rapporto di addiction. Ovvio, disintossicarsi non è facile. Ma è possibile. Noi, per dire, anche senza stare su FB abbiamo sempre fatto circolare a vasto raggio le notizie sulle nostre iniziative.
L’altra espressione che usi è «tollerare la sua [di Facebook, N.d.R.] invadenza». Ma perché mai dovremmo tollerarla? Perché dovremmo rassegnarci a tale invadenza, se ha le conseguenze che abbiamo detto?
Le storiche e gli storici del futuro si chiederanno come fu che, negli anni Dieci del XXI secolo, anche persone e movimenti che in tutti gli altri ambiti erano contrari alle privatizzazioni e parlavano continuamente di «comune» o «beni comuni» accettarono di privatizzare la loro comunicazione, regalandola a una mega-azienda privata americana, che in pochi anni accumulò un potere colossale e instaurò un quasi-monopolio in mezzo pianeta. E si chiederanno come mai soggetti che avevano sempre valorizzato il «pensiero critico», imparato dalla «teoria critica», prediletto la «critica radicale», fecero tale scelta in modo così platealmente acritico, volando col pilota automatico, senza farsi una domanda, trovando tutto questo normale.
Bada bene, noi non ci chiamiamo fuori, non potremmo farlo: è vero che non siamo mai stati direttamente su FB, ma ne abbiamo fatto uso indirettamente (linkando eventi, giocando di sponda con pagine FB di progetti a noi collegati ecc.). Dal nostro non-starci, insomma, non abbiamo tratto tutte le conseguenze pratiche che avremmo potuto trarre. E se la nostra sperimentazione su Twitter è durata due-tre anni di troppo, è perché le nostre difese si erano abbassate, la nostra critica si era smussata, eravamo rimasti avviluppati nelle logiche degeneranti di quel dispositivo (della sua “facebookizzazione”, secondo alcuni).
Il decennio che comincia potrebbe essere quello in cui, tutte e tutti insieme, recuperare il terreno perso nel decennio appena finito.
«Ricorderemo gli anni 10 del duemila perché l’umanità, all’apice della sua conoscenza, ha sviluppato una tecnologia tale che permette di farsi portare a casa del cibo con la bicicletta da persone sottopagate e a rischio della vita»
Lo ha scritto su Bida l’utente Oscar Panixa.
Questa grande conquista del decennio scorso è intimamente collegata all’altra di cui stiamo parlando da settimane. È sempre il capitalismo «delle piattaforme», e il modo in cui si è affermato ha a che fare con il titillare automatismi, formare nuove dipendenze, mettere la “comodità” sopra tutto (ma è una comodità che ci sembra tale perché non abbiamo più tempo di far nulla), infilare ovunque la gamification (piattaforme come Just Eat sono gamificate fino al midollo) ecc. ecc. E la montagna partorisce il ponghino: lavoratori sfruttati che ti portano il mangiare in bicicletta.
C’è poco da contaminare, è già tutto contaminato, nel senso cattivo, nel senso che è tutto una specie di blob. Parlo di twitter, ché da facebook mi sono sempre tenuto alla larga. Lo sappiamo tutti come funziona, ma a scriverlo così fa una certa impressione:
scroll
– …
– battuta su salvini
– risultati delle elezioni in croazia
– una tipa posta la foto della patonza
– vari bianchi ambosessi attaccano in branco un afrodiscendente, perché dice di non aver apprezzato il film di checco zalone
– foto di tramonto sui tetti di roma
– uno scienziato imbolsito bullizza uno studente che parla di riscaldamento globale
– donald trump dichiara guerra all’iran con un tweet
– i compagni di trieste segnalano una conferenza
– una compagna posta video sulla repressione in cile
– video dei led zeppelin
– un’altra tipa posta la foto del culo, ma non è il suo
– video dei koala che scappano dalle fiamme in australia
– …
E’ solo rumore, entropia, e tutto diventa uguale a tutto. Si può anche trovare roba interessante in mezzo a sto casino, ma costa una fatica immane. Questo è ciò che io vedo da ricettore. Se invece parlo da trasmettitore, se devo valutare l’efficacia del mezzo per trasmettere un messaggio che considero importante, ormai credo tale efficacia sia prossima allo zero.
Già nella seconda metà del XX secolo la crescita spropositata del flusso di immagini e dati aveva reso sempre meno efficaci e spiazzanti, prima, e integrato del tutto e banalizzato, poi, le principali tecniche di intervento critico affinate dalle avenguardie, come il détournement o il cut-up.
Gli accostamenti azzardati, i dirottamenti di senso, «l’ombrello e la macchina da cucire che si incontrano sul tavolo operatorio», tutto ciò era stato inaudito, «unseen before» e perturbante nella prima metà del secolo e ancora per un po’ fino al ’68 (tagliando con l’accetta), quando l’offerta mediatica era limitata e rigida. Quelle tecniche scavalcavano steccati semiotici e tecnologici, univano ciò che appariva diviso e viceversa, accostavano ciò che appariva distante (il pavé e la spiaggia, i fumetti coi balloon cambiati ecc.)
Era l’epoca in cui l’ironia era ancora “solo” una figura retorica che si poteva usare criticamente, non un imperativo, una coazione, un abito mentale, la tonalità emotiva che tutte e tutti devono esibire per forza.
Blob era sorprendente, all’inizio, ma in breve tempo è diventato solo la mimesi concentrata dello zapping che tutte e tutti fanno ogni giorno, ripropone addensata in pochi minuti la merda che i canali TV riversano a tutte le ore, magari mettendoci la frasetta che implica la critica, ma il fatto stesso che Blob vada in onda ogni giorno da più di trent’anni dimostra che il suo rapporto con la merda è simbiotico e subordinato, la carica critica è molto tenue, l’intento “dissacrante” è in fondo un orpello. In pratica, è solo un compendio della merda.
La TV, come scrisse David Foster Wallace in un saggio che resta fondamentale e del quale dovremmo prolungare i fili, si è imposta come medium ironico per eccellenza, perché implicitamente invita a non credere a nulla di quanto trasmette, a non attribuirvi alcuna importanza reale. L’anchorman del TG o il conduttore di talk-show ti dice che siamo a rischio terza guerra mondiale, o ti mostra cadaveri squarciati, e mezzo minuto dopo ti sorride e si collega con Checco Zalone che presenta il nuovo film, mostriamo la clip, grasse risate. Era così già venti-trent’anni fa, tutto era già accostato a tutto, il détournement era dato dagli stessi palinsesti e il cut-up lo facevi con lo zapping. Di “spiazzante” c’era ben poco.
Negli anni Novanta, in extremis e in un clima culturale da tempo post-avanguardistico e postmodern, nuove riflessioni sulla guerriglia comunicativa furono fatte da vari soggetti, network e movimenti in mezzo mondo, Adbusters, Yes Men, Luther Blissett project ecc. Certe prassi, “rinverdite”, potevano ancora provocare spiazzamenti, e costruire narrazioni condivise. Quest’ultima era la cosa che importava di più a noialtri del LBP, molto più di qualunque beau geste. Il “culture jamming” non ebbe mai un valore di per sé, fu sempre subordinato a costruire e mantenere vivo il network intorno alla leggenda di Luther Blissett. Perché lo vedevamo, e lo dicemmo, che le azioni di culture jamming avevano un ciclo d’efficacia sempre più breve, prima di essere smussate di ogni spigolo e integrate nel blob generale.
Coi social c’è stato un ulteriore salto di livello, sia nella sovraofferta mediatica, perché ai media di prima si è unito e intrecciato il flusso di milioni – nel caso di FB oltre un miliardo – di «canali televisivi» personali, sia nella dittatura dell’ironia (nell’accezione usata da DFW) e del ridurre tutto a blob, un blob ultrarapido che va in onda h24 e affastella i materiali più eterogenei dando la stessa importanza (cioè zero importanza) a tutto.
Il cut-up e il détournement hanno trovato una nuova codificazione nella memetica, la forma-meme è ovunque ed è sempre più reazionaria nelle forme anche quando non vorrebbe esserlo nei contenuti, perché tritura tutto, sostituisce al ragionamento il riflesso condizionato, e lungi dall’attivare lo spirito critico tramite lo spiazzamento del punto di vista, non fa che riassumere in un’immagine “da ridere” quel che il destinatario già pensa. Il tutto sotto pesanti velami e panneggi di “ironia”, naturalmente.
Su Twitter forme di “détournement” sui generis sono state possibili quando gli strumenti erano nuovi, non se n’era ancora codificato un uso di massa e la piattaforma non era ancora del tutto colonizzata e gamificata, penso agli hashtag #saldi e #guerrieri.
Una forma di détournement generalizzato, e incanalato in una narrazione “aperta”, è stata l’attacco psichico con destinatario implicito, e forse ha aggregato proprio perché il bersaglio restava implicito, producendo un effetto perturbante: il meccanismo era al tempo stesso familiare ed estraneo, chiaro e spaesante. Avessimo detto: «Auguriamo ogni male a Salvini, tutti insieme!», sarebbe stato molto banale e prevedibile. E a ben vedere, si trattava di memetica, ma una memetica “libera”, allusiva, senza meccaniche corrispondenze tra immagine e frasetta pseudo-“brillante”. Non c’era proprio, la frasetta.
Però, non a caso, si è trattato della nostra performance d’addio, l’ultima fiammata, perché ormai eravamo esausti. A un certo punto, su Twitter, ci siamo ritrovati sempre più spesso a impiegare gran parte delle energie per non sprofondare in sabbie mobili. Il tentativo di portare avanti forme di intervento critico e sperimentazione anche quando intorno a noi il contesto era radicalmente mutato ci è costato molto in termini psicofisici, bisogna essere più bravi a capire quando staccare, cambiare modalità, dichiarare chiusa una fase.
Quel che bisognerebbe capire è: in uno scenario così, mediaticamente saturo, iperconnesso, «always on» e blobbizzato oltre ogni limite, quali strategie e tattiche comunicative possono “forare” la membrana dell’ideologia dominante e dell’abitudine? Sicuramente una grossa parte dell’armamentario “classico” è inservibile o quasi. La cassetta degli attrezzi andrebbe inventariata, di ogni utensile dovremmo capire se ha ancora un utilizzo rivoluzionario o meno.
Mi colpisce ciò che Deleuze scrive a proposito dell’umorismo, inteso – ne “Il freddo e il crudele” – come un’arte di contestazione della legge per “approfondimento delle conseguenze” (non so se Žižek abbia fatto riferimento a questo per il conio del suo concetto di sovridentificazione). Una prassi molto diversa, addirittura opposta a quella dell’ironia. In pratica, qualcosa che assomiglia molto alla tattica di Sc’vèik (prendere le ingiunzioni del potere alla lettera, senza alcun distanziamento ironico, e così intensamente da far perdere i nervi al potere stesso). Però ho il sospetto che anche questo faccia ormai parte di un armamentario classico.
@ J.B. Bulliard
Eh, no, non funziona. Lo dico perché ora so che non ha funzionato.
**disclaimer**
Devo assolutamente mettere in chiaro che *oggi*, dopo le sue prese di posizione di merda degli ultimi anni, piuttosto che citare Žižek in positivo mi infoiberei da me medesimo.
**end_disclaimer**
Anni fa, avevamo in cantiere un post sul “rossobrunismo di rito orientale”. Per vari motivi non siamo mai riusciti a quagliare e a pubblicarlo, ma gli appunti che avevamo preso sono attualissimi. Riporto qui alcuni paragrafi che avevo scritto a proposito della strategia retorica della sovraidentificazione adottata dai Laibach nel 1989 per mettere a nudo il nazionalsciovinismo di Milošević sotto velo ormai inconsistente della retorica real-socialista. Nonostante il suo potenziale sovversivo, tale strategia retorica fallì di fronte alla catastrofe politica, morale e materiale della guerra in jugoslavia, cioè di fronte al passaggio dalle parole alle armi.
Ecco cosa avevo scritto:
Nel marzo del 1989, quattro mesi prima del discorso di Kosovo Polje, durante una performance dei lubianesi Laibach a Belgrado Peter Mlakar – il “filosofo” del gruppo – si era esibito in una sorta di comizio che riprendeva parola per parola e concetto per concetto il frasario di Milošević, esasperandolo in una miscela linguistica di serbo e tedesco. (inserire video) Come spiegò poi Žižek, l’estetica e la retorica dei Laibach in quel contesto avevano lo scopo di affermare il non detto, di far emergere il rimosso nel discorso pubblico della Jugoslavia di quegli anni. La pura affermazione di quegli enunciati senza prese di distanza “ironiche” risultava realmente sovversiva e destabilizzante. Ma ormai era troppo tardi: quel disvelamento, per quanto importante, non avrebbe più potuto produrre i necessari anticorpi. Il vapore rossobruno aveva cominciato a diffondersi come una nuvola venefica su tutta l’Europa.
Conosco anche l’episodio del 1995. In quell’occasione NSK, Mlakar e Laibach operarono a Sarajevo durante l’assedio. Furono stampati diversi falsi passaporti NSK, di cui molti civili si servirono per fuggire dalla città. Le mie fonti sono quelle reperibili in rete, ma se le cose si sono svolte così, la falsificazione (altra tattica, accanto a détournement, sovridentificazione etc.) ha mostrato in quel momento una certa efficacia.
Inutile dire quanto la falsificazione oggi, ai tempi di fb e di altri media gamificati, sia parte del problema. Una parte importante, per giunta.
Anche i famosi falsi satirici de Il Male non mi convincono (con l’unica eccezione, forse, delle incursioni di Sparagna in Polonia e in Afghanistan). Gli anni di pubblicazione de Il Male coincidono con l’ingresso nel “riflusso”, con il ristabilimento del comando capitalistico sul lavoro, e quella satira mi sembra solo una gioia-triste (come tutta la satira), l’altra faccia della disperazione, quella ghignante.
Non esistono tattiche o retoriche di per se stesse sovversive, molto o tutto dipende dalla condizioni storiche date, dalla posizione gerarchica, sociale, economica, politica in cui sono captati i soggetti in gioco.
P.s. nemmeno a me piace Žižek
Sono “completamente d’accordo a metà con te” tanto per fare una citazione famosa.
Chiarimento, no quando parlo di contaminare parlo di contenuti, perché io non sono in grado di fare altro. Però il fatto che comunque questi vengano digeriti, annullati e metabolizzati non lo condivido del tutto; ovvero certamente non è che si intoppa il sistema perché io parlo di Q o di Proletkult sul social fbk, tuttavia già il fatto che io abbia sensibilizzato in quell’occasione dieci persone a comprarsi e leggersi quei libri lo reputo un successo per cui valeva la pena di starci.
Se il mio pezzo in cui dico che partecipare ai fridays for future e poi sostenere la tav per convenienza economica significa non aver capito una mazza è stato letto da 500 persone invece che dalle solite 50, pagare questo con un po’ dei miei dati personali lo ritengo “tollerabile”.
“Valeva la pena” = “Tollerare l’invadenza”—> Perché farlo?
Risposta necessariamente articolata.
1) Purtroppo è evidente a tutti che questo non è il mondo che ci auspichiamo e neanche un mondo accettabile per noi. Tuttavia, è altrettanto evidente che la società sta percorrendo quella strada. E allora con il rischio di sembrare NanniMorettiani è inevitabile chiedersi “Ma mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo proprio?”
Come avete detto voi nella prima parte, entrambe le risposte in questa fase sono legittime, voi avete scelto l’assenza e vi ammiro, ma voi siete in una posizione in cui se non vi si vede vi si viene a cercare.
Altri se non ci sono non ci sono e basta e scompaiono.
2) Se io , o la mia associazione diciamo: “noi non stiamo su fbk perché [spiegazione che elaboriamo]” non sembra semplicemente che non siamo in grado di parlare a coloro che invece ci sono? Non è meglio stare lì a ritirar la merda ai Savoia come voi avete fatto alla grande su Twitter piuttosto che lasciare che la spargano a piene mani? su questo punto non riesco a convincermi, rinunciare mi sembra comunque una forma di debolezza.
3) in questa fase di capitalismo avanzato (chi sulle mie pagine prova mettere la parola turbo prima di capitalismo lo banno immediatamente per evidente fusarismo) è giustissimo compiere scelte alternative per ricordare non solo che un altro mondo è possibile ma è necessario, tuttavia il rifiuto a priori di certe cose può provocare più danni che altro. L’esempio che avete fatto con Just Eat ricade in una gamma di lotte al capitalismo o al sistema che non sono sicuro (parlo sempre di convinzioni personali) possano ottenere risultati positivi, per lo meno non certo nel breve, e rischiano anche di alienarsi un po’ da quelli che poi sono i lavoratori sfruttati. Esempio concreto, da tempo una delle proteste di molte forze di sinistra, partitiche e non partitiche, verte sul fatto che i supermercati debbano stare chiusi la domenica perché il dipendente ha diritto al giorno di riposo.
Sacrosanto ci mancherebbe, ma non sarebbe più logico allora battersi perché chi ha un supermercato abbia sufficienti dipendenti per star aperto anche nei giorni di festa pagando a loro il giusto stipendio maggiorato per la festività? Altrimenti perché il dipendente di un bar o di un cinema non dovrebbe avere diritto alla domenica di festa rispetto a quello del supermercato?
E così venendo ai corrieri e ai rider, invece di non ordinare da just eat non sarebbe meglio trovare il modo di garantire i rider di just eat?
Insomma, smettendola con le divagazioni, cerco di chiudere.
Credo che il punto dell’azione non deve insistere tanto sullo stare o non stare sul social ma quanto sul “non stare solo lì” e come dite giustamente far crescere tutto ciò che altro usando il social come rimbalzo.
Guarda, uno dei paradossi che stiamo cercando di far notare – probabilmente senza riuscirci – tanto nella miniserie quanto nella discussione, è che i contenuti anticapitalisti su Facebook sono diretti contro ogni manifestazione del capitalismo… Facebook escluso. Il che, nell’economia politica attuale, è una rimozione enorme.
Praticamente, mentre si attacca l’apparire più “tradizionale” del capitalismo (e, intendiamoci, va fatto), se ne accettano in automatico le forme più avanzate e contemporanee. In parole povere: non si problematizza l’intreccio planetario tra mercato dei big data (uno dei più grossi core business di oggi) e “surveillance capitalism”.
Non si tratta solo di «barattare la diffusione di buoni contenuti con un po’ di miei dati, che vuoi che sia, il gioco vale la candela». Perché quei dati vengono usati per sorvegliarci meglio, prenderci meglio di mira (anche letteralmente, quando li usa l’industria militare), perfezionare dispositivi di sfruttamento e oppressione.
È tutta conoscenza che noi forniamo gratis e con autentico zelo, anche mentre scriviamo di anticapitalismo, nell’ambito della più grande autoschedatura di massa di tutti i tempi. Perché questo è, e poco altro.
Non solo: gli incentivi algoritmici perché tale autoschedatura continui ad avvenire – anzi, avvenga con sempre maggiore intensità – hanno effetti devastanti sul nostro modo di comunicare. Questo fracking lascerà distese di macerie psichiche, ne siamo convinti.
A fronte di questi processi su una tale scala di operazioni, «tirare la merda al Savoia» (per stare al tuo esempio) può dare soddisfazione lì per lì, e magari può far imparare un po’ di storia a qualcuno, ma se nel farlo sembra di volare più alto della media, è solo perché l’altro piatto della bilancia – quello dei vantaggi che trae dal nostro agire il capitalismo dei big data e della sorveglianza – pesa molto di più e ci tiene lassù, leggeri e irrilevanti. Voglio dire: chi incarna di più i pericoli del capitalismo oggi? Il giovine freak Savoia o i colossi capitanati da Zuckerberg, Bezos, Thiel ecc.?
Ora, se i “buoni contenuti” non riguardano anche questo, se non fanno crescere anche la consapevolezza collettiva al riguardo, se non forniscono “armi della critica” per poter disinnescare questo meccanismo o almeno creare inciampi, possiamo far notare che questo è un problema? Possiamo farlo notare senza che si riduca la questione al solito «mi si nota di più se»? Non è questione di farsi notare: è questione di combattere il capitalismo nelle postazioni che occupa oggi, possibilmente nelle postazioni-chiave.
Quando scrivi: «Se io o la mia associazione diciamo: “noi non stiamo su fbk perché [spiegazione che elaboriamo]” non sembra semplicemente che non siamo in grado di parlare a coloro che invece ci sono?», secondo me la questione è doppiamente mal posta.
Da un lato, il punto non è cosa l’uscita da Facebook “sembrerebbe” di primo acchito. Il punto sta nel modo concreto in cui avverrebbero la transizione ad altre prassi comunicative e il distacco da FB. In una prima fase, la pagina FB si potrebbe usare per annunciare, spiegare, accompagnare il cambiamento, discutendone (ma tenendo ferma la propria posizione) e al contempo invitando chi ci segue a farlo anche altrove, iscrivendosi ai nostri canali: Telegram, blog, newsletter, Mastodon, mailing list o tutte queste cose insieme. Dopo un certo periodo di “test”, si esce da FB.
Dall’altro lato, nessuna delle persone che vengono a iniziative culturali o politiche è raggiungibile solo su FB (sarebbe una contraddizione in termini!), non stiamo parlando di gente rinchiusa in casa, ma di persone potenzialmente raggiungibili con altri strumenti e in altri ambiti della loro vita, non ultime le iniziative stesse, che sono a loro volta un canale di comunicazione. Durante una serata si può promuovere quella successiva, e non solo: «ricordiamo che dalla tal data l’associazione non sarà più su Facebook, per motiivi che sono spiegati sul nostro sito e anche nell’opuscolo sul tavolo all’entrata. Sull’opuscolo troverete tutti i posti in rete dove potrete trovarci in alternativa», ecc. ecc.
Sotto l’aspetto del promemoria, un messaggio ricevuto su Telegram il giorno prima o il giorno stesso ha potenzialmente anche più impatto di un evento FB.
Si tratta solo di avviarlo, questo processo. Se nessuno comincia e tutti dicono “ma, mi, mo…”, il distacco sembrerà sempre più difficile di quanto in realtà non sia.
Riguardo a Just Eat: non ho incitato a far nulla che possa «alienarci le simpatie dei lavoratori», perché non ho proposto nulla, ho solo fatto notare che guardando quel meccanismo si ritrova lo stesso insieme di fenomeni che troviamo parlando dei social o di Amazon. Idem per AirBnB e per tutto il capitalismo delle piattaforme. In ciascun ambito i modi di intervenire e lottare saranno diversi e articolati: ad esempio, tanto Amazon quanto la gig economy della ristorazione a domicilio hanno fatto capire in modi chiarissimi che il loro incubo sono gli scioperi.
D’altro canto, la lotta dei lavoratori non basta, perché aggredisce un nodo, quello dello sfruttamento diretto, ma non si occupa dei danni che quel modello di capitalismo fa alle città, alla convivenza, all’ambiente, né si occupa delle dipendenze che quel modello alimenta. Pensiamo, come similitudine, alla lotta per l’aumento di salario e per la sicurezza in fabbrica portata avanti dagli operai di un’industria chimica inquinantissima e cancerogena: lotta sacrosanta dal punto di vista di chi la fa, ma che lascia intatto il problema di fondo, cioè che quella fabbrica intanto sta compiendo stragi. Ergo, come avevo già provato a scrivere nel pezzo sul feticismo digitale del 2011, bisogna agire su più livelli e in più punti della filiera.
La questione di quali contenitori utilizzare per impacchettare e distribuire i propri contenuti è centrale per chiunque, non tanto per via del classico motto “il mezzo è il messaggio”, quanto piuttosto perché:
a) determinati contenuti tendono a deteriorarsi in determinati contenitori, come le arance nelle scatole di cartone;
b) L’uso di determinati contenitori finisce per condizionare il tipo di contenuti che ci mettiamo dentro. Se ho solo bauli di legno, tenderò a usarli per metterci dentro abiti e non vasi di porcellana finissima.
Un primo antidoto al problema b) è quello di differenziare i contenitori, per averne sempre di diverso tipo, eccetto quelli che producono il problema a).
Ma la lista di questi ultimi non è mai data una volta per tutte. Lo stesso Lenin, nel corso della sua carriera politica, decise in tempi diversi che bisognava boicottare la Duma zarista e che invece bisognava usarla come contenitore – lui diceva “tribuna” – per far passare i propri contenuti. Detto questo, mai e poi mai si sarebbe sognato di tralasciare la pubblicazione dei giornali legali e illegali della fazione bolscevica.
La storia dei gruppi rivoluzionari è costellata di riflessioni su quali ambiti scegliere per stare “dentro e contro” e quali invece escludere dopo attenta disamina. Di sicuro, chiunque vuole stare “dentro e contro” deve stare anche “oltre”, altrimenti incappa nel problema b). Non è un caso che i nostri libri escano per Einaudi ma anche per Alegre, Ediciclo, Eterea…
Il punto è che non si tratta di scelte che si possono fare a priori (“Qualunque contenitore mi permetta di raggiungere più cervelli è ok – anche una rubrica su Libero” vs “qualunque contenitore non sia autoprodotto, autogestito e autonomo è merda – anche un volantino, se non fai da te la carta su cui lo stampi), bensì di valutazioni che vanno ripetute spesso, evitando di inserire il pilota automatico (ma questo forse vale per qualunque scelta importante della vita, che te lo dico a fare).
Per fare un esempio fuori dalla Rete: noi su “La Repubblica” fino a qualche anno fa abbiamo pubblicato qualche rarissimo articolo, oggi non lo faremmo più. Le riflessioni che abbiamo elencato qui riguardo a Twitter sono figlie di un passaggio di fase. Ma è chiaro che nel valutare il contenitore non si può tener conto solo del suo rapporto con i contenuti, ma anche di chi li produce. Capisco bene quello che dici quando sottolinei che c’è differenza tra Wu Ming e un’associazione XY o tra Giap e un blog aperto l’altro ieri. Tuttavia, noialtri ci siamo formati in una radio indipendente, stampando fanzine con la fotocopiatrice e senza andare in tivù, in un tempo in cui il Maurizio Costanzo Show sembrava una tribuna irrinunciabile per chiunque volesse far conoscere il proprio pensiero.
Non solo perché cita Lenin, :-) questo commento di WM2 mi sembra che inquadri perfettamente quale dev’essere l’approccio.
Di norma i bolscevichi partecipavano alle elezioni e suggerivano a tutti gli altri partiti comunisti di farlo, salvo motivate eccezioni. Al tempo stesso, consideravano il «cretinismo parlamentare» una delle piaghe che più spesso creava problemi al movimento socialista internazionale. Il cretinismo parlamentare consiste soprattutto nel credere che il Parlamento sia il vero terreno di scontro tra le classi, che le scaramucce rituali che avvengono in quelle aule siano decisive, che in nome di una inutile conquista parlamentare (per fare un esempio a caso, Bertinotti presidente della Camera) sia accettabile avere dei cedimenti nel mondo reale.
Bisognerebbe capire bene quando stiamo cadendo vittime del «cretinismo social», ho il sospetto che capiti molto spesso anche a chi come come me si immagina sempre nel ruolo dell’astuto bolscevico che sfrutta a suo vantaggio le istituzioni del nemico. Ma tale cretinismo non coincide ipso facto con la presenza sui social.
L’unico uso scaltro e bolscevico che mi viene in mente per fb et similia è starne fuori, e mentre tutti sono occupati a scrivere stronzate e postare selfie, occupare tranquillamente il palazzo d’inverno senza sparare un colpo.
Scherzo, ovviamente, anche perché oggi non esiste “il palazzo d’inverno”, inteso come luogo fisico e centralizzato del potere. Ma se parliamo di obiettivi meno ambiziosi e più abbordabili, è anche vero che possiamo approfittare del fatto che i vari burioni, renzi, salvini, fusaro, meloni, ecc. ecc. e i loro topi ammaestrati siano intrappolati nella gabbia social a ciacolar monade in modo compulsivo. C’è molto spazio libero.
Non sono molto convinto.
Ultimamente ho fatto spesso l’esperimento di chiedere alle realtà di movimento con cui mi sono rapportato se facevano ancora le locandine da attacchinare in giro: ebbene, qualche gruppo o spazio le fa, ma l’esperienza dice che creare l’evento su Facebook è il passaggio davvero essenziale.
Tra l’altro faccio notare che se è vero che gli eventi su Facebook usano uno strumento ostile, anche gli attacchinaggi, solitamente abusivi, lo fanno: sfruttano muri che non sono fatti per noi ma per la pubblicità commerciale o per altro. Ci sono rischi nell’uso di Facebook ma non ci ho mai preso multe giganti né sono mai finito a mazzate, cosa che invece è capitata tante volte a me e ad altri con gli attacchinaggi offline. E sorvoliamo sui costi molto diversi…
Sono anche un po’ contrario a etichettare come stronzate le cose che la gente scrive su Facebook. Esistono persone in gamba che scrivono cose intelligenti dappertutto, anche su Facebook. Credo che Facebook incoraggi attivamente in molti modi a scrivere stronzate, per esempio con l’oscena (dis)funzione che aggiunge palloncini animati e schifezze simili («effetti di testo») se usi parole come «auguri» o «divertente». A questa induzione al cretinismo si può resistere semplicemente scrivendo cose intelligenti e rimuovendo gli effetti animati, gli sfondi colorati ecc. e molti lo fanno.
(Tutto questo dando per scontato che stiamo parlando degli usi politici e culturali del mezzo, se poi uno vuole davvero usarlo per le foto delle vacanze boh, non credo sia un tema politico osteggiarlo o approvarlo.)
Anche dal punto di vista della discussione, i commenti Facebook sono da qualche giorno nidificati a quattro livelli proprio come Giap. In effetti ci si discute meglio che su Twitter. :)
I motivi per evitare di dipendere da Facebook sono secondo me altri, più sottili (e perciò più opinabili) che l’impossibilità letterale di farci qualcosa di buono. Per esempio, la facilità con cui si viene sospesi e censurati immotivatamente; ne so qualcosa…
È questo il cul de sac in cui ci si è ficcati. Molte situazioni hanno assecondato l’andazzo che poi le ha rese dipendenti dall’evento FB, divenuto un obbligo pena la non-promozione delle iniziative. Ma da quel culo di sacco si può uscire. Tra le locandine cartacee e FB esistono tante opzioni. Newsletter, notifiche push, canale Telegram, social non commerciali, blog, oltre a mezzi più tradizionali.
Il problema di FB non è solo che ti cacciano come e quando vogliono. Quella è solo una delle logiche conseguenze del problema di fondo. Quel mezzo è privato, eteronormato, gestito dall’alto senza alcun possibile controllo e in totale opacità, e il punto è quel che fanno con quello che fai.
Quest’ultimo aspetto è il quibus, eppure non viene mai affrontato da chi teorizza la possibilità di usarlo in senso antagonista – il che il più delle volte significa proporre contenuti che regolarmente aggirano la questione dei dati che si stanno producendo anche tramite quei contenuti.
Finché non vedrò una volontà di far emergere questa contraddizione e integrarla nell’analisi per provare a cambiare la prassi, continuerò a ritenere manchevole ogni discorso sull’uso dei social – e di FB in particolare – che riguardi solo i contenuti.
Secondo me il cretinismo social è qualcosa di morbido (nel senso italiano di soffice, ma con intenzionali echi dell’inglese morbid, cioè “morboso”) nel quale qualcuno si stravacca subito, mentre qualcun altro ci scivola lentamente, perché non riflette sulle trasformazioni in corso, accetta il default power, va avanti a fare quel che faceva prima senza rendersi conto che non è più quel che faceva prima. Poi c’è chi sta attento a non scivolarci dentro, al cretinismo, ma ogni tanto ha colpi di sonno. Nessuno è al riparo dal rischio, nessuno può esserne immune.
Se il cretinismo coincidesse ipso facto con la generica presenza sui social, saremmo stati cretini per dieci anni. Invece pensiamo sia stato giusto e fecondo fare quell’esperienza su Twitter. L’abbiamo chiusa quando abbiamo capito che non ce l’avremmo fatta a proseguire, a mantenere una presenza sensata e disciplinata. Avevamo superato una soglia noi, e ne aveva superate svariate il medium, e in un contesto così radicalmente mutato non ci stavamo più dentro, davvero correvamo il rischio del rincretinimento e del burnout. Smettere, rifletterci sopra, scriverne, immaginare nuove pratiche e discuterne ci ha rivitalizzati. Compiuti questi passi, per nessun motivo torneremmo su Twitter. Abbiamo idee migliori per la testa :-)
Chiaro che ognun* ha la propria soglia, trae i propri bilanci e fa le proprie valutazioni. L’importante è farle. Non dividiamo il mondo tra chi sta ancora su Twitter e/o Facebook e chi non ci sta più. Casomai, lo dividiamo – solo dall’angolatura di questa discussione, è chiaro – tra chi ci ragiona sopra e chi no. Tra chi si ferma a pensare a quel che sta facendo, e si informa, e ne discute, e chi invece va avanti per inerzia o addiction e quando sente questi discorsi si copre le orecchie e fa la sirena – «Nananananana» – per non sentire.
Un’ulteriore linea di divisione che penso sia non solo utile ma necessario evidenziare per poter cancellarla, è quella tra chi, pure nel novero delle compagne e dei compagni, ormai usa solo Facebook e chi invece continua a far vivere altri spazi informativi e di discussione, indipendenti e autodeterminati.
Nel primo campo metto anche chi, pur avendo blog, sito o comunque accesso ad altri media, finisce che carica un video importante solo su FB, scrive la “nota” su FB anziché scrivere un post altrove e al limite linkarlo ecc. Non è un uso al 100% esclusivo di FB, ma è un uso prevalente che tende all’esclusivo (e all’escludente). Questa per me è, lo dico in tutta sincerità, una tragedia. Una capitolazione di massa, antropologica e ideologica. È vitale porvi rimedio, invertire la marcia.
Detto questo, io penso che molte energie che ora vengono investite su piattaforme capitalistiche gamificate ed estrattive – energie che dunque, su un piano sistemico, ci si rivoltano contro – andrebbero stornate e reinvestite nella progettazione e costruzione di alternative dal basso, in strumenti che si possano usare anziché esserne usati, in prassi che siano esempi contagiosi.
«Esodo» non è l’immagine che mi convince. Io mi auspico uno sciopero generale a oltranza. il mio sogno è che sempre più persone scioperino, sottraggano a Facebook et similia il tempo in cui erogano «forza-lavoro» (forza-comunicazione, forza-invenzione, forza-cooperazione e persino forza-scazzo), e quel tempo e quella forza la riscoprano e la usino in altri modi, in lotte che potrebbero avvalersene, dirette contro lo stesso capitalismo delle piattaforme e della sorveglianza contro cui si sta scioperando, causando sconfitte a quelle aziende.
Considerazione obliqua: io ho interpretato l’uso del dialetto ferrarese in questa coppia di post come una forte presa di distanza linguistica dalla melassa wannaberomana che è diventata la lingua twitter standard. Non so se fosse effettivamente questo il motivo della scelta linguistica, ma per quanto mi riguarda l’effetto è quello, ed è liberatorio.
Abbiamo usato molto slang e anche dialetto vero e proprio sia bolognese sia ferrarese. Molte espressioni, del resto, sono comuni a entrambe le parlate. Alla cosa del «romanaccio da social» non ci abbiamo pensato, a dire il vero, l’idea era di creare un contrasto tra tematiche tecnologiche ed espressioni “terragne”, prese dalle nostre strade. Questo sia per tenerci lontani da una certa gergalità da compagn* smanetton* in cui spesso si ricade parlando di rete, sia per inserire spiazzamenti e humour, al fine di divulgare meglio.
Un’integrazione. Se assumiamo il parallelismo tra cretinismo parlamentare e cretinismo social, la descrizione che otteniamo è questa:
«Il cretinismo social consiste soprattutto nel credere che Facebook o Twitter siano il vero terreno di scontro tra le classi, che le scaramucce rituali che avvengono in quegli spazi siano decisive, che una inutile “conquista” sui social (ad esempio, mandare un hashtag nei TT) possa far passare in secondo piano cedimenti sul terreno di lotta reale (ad esempio il Jobs Act o le politiche di Minniti su immigrazione e ordine pubblico).»
È la descrizione precisa della bolla che ricordiamo come «#Facciamorete».
Anzi, per essere più precisi: il cretinismo social consiste nel credere che gli spazi concessi da Facebook e Twitter siano il terreno di scontro. Perché su un altro livello e in un altro senso, il capitalismo delle piattaforme e della sorveglianza è un terreno di scontro reale. Questo include Facebook e Twitter (e YouTube e Instagram e TikTok ecc.), ma lo scontro non consiste nello scrivere su Facebook un contenuto piuttosto che un altro: consiste nel decidere cosa faremo di Facebook, consiste in pratiche che contrastino il capitalismo della sorveglianza.
Ho appena letto un articolo di Oliviero Ponte Di Pino su doppiozero, il titolo è “Sorvegliati di tutto il mondo, unitevi!”. A differenza di quanto si trova su Giap, leggendo questa miniserie, manca la parte del “Che fare?”, su come fare per difendersi pur continuando a stare in rete. Allo stesso tempo fa un’analisi su cosa sono i Big Data e come vengono usati. Di sicuro fra i lettori di Giap c’è chi ne sa già a pacchi, io non sono poi così ferrato purtroppo, e l’ho trovato interessante anche perché c’è una discreta bibliografia. Il lnk è https://www.doppiozero.com/materiali/sorvegliati-di-tutto-il-monto-unitevi
Grazie, Luigi, il pezzo di Ponte Di Pino, al netto del limite che hai segnalato (ma è un limite “programmatico”, diciamo), è molto buono e utile. In effetti, quando parliamo di estrazione, vendita e uso politico/capitalistico dei big data, diamo per scontate alcune premesse, che invece scontate non sono. Ai più sfuggono ancora la dimensione di questo mercato e la portata strategica planetaria di quei dati per il capitale. Ergo, non possono che sfuggire nessi fondamentali. Ad esempio, quello tra i dati che produciamo ogni giorno usando lo smartphone e/o usando i social e attacchi coi droni come quello che ha ucciso Soleimani a Baghdad. L’articolo di Ponte Di Pino è un ottimo compendio per farsi un’idea del problema. Che non è solo un problema di “privacy”, sarebbe terribilmente riduttivo metterla solo in questi termini. È un problema di dominio.
A proposito di dati che produciamo usando lo smartphone, esortiamo con forza a leggere anche l’inchiesta del New York Times linkata da Monsier en Rouge nelle ultime righe del suo bel commento qui sopra.
Grazie delle risposte e dei tanti spunti di riflessione. Metabolizzo, rifletto e condivido.
[…] alcune settimane, come annunciato nella seconda puntata de L’amore è fortissimo, il corpo no, stiamo lavorando a “depurare” Giap – per quanto ci sarà possibile – da link, […]
Quello nel pingback qui sopra è una sorta di «addendo» alla miniserie, un commento “espanso” che nel thread originale sarebbe stato troppo lungo, e che deve molto alla discussione, grazie a tutte e tutti.
Premetto: col Big Data ci lavoro, non mi occupo di User Behaviour ma di Supporto e Analitica, in ogni caso gli strumenti sono gli stessi, cambia solo il “business understanding” per dirla col linguaggio della Data Science. (si, sto vomitando io stesso nello scrivere queste frasi)
Personalmente non credo in scenari apocalittici (non ancora e non qui per lo meno, la Cina é un discorso a parte) quello che mi preoccupa e mi dá rabbia é vedere il livello infimo della discussione politica su questo che é uno dei temi piú importanti della vita attuale e futura.
A parte pochissime eccezioni (penso a Julia Reda) il livello di preparazione della politca su questi temi rasenta lo zero: stiamo ancora alle indignazioni sull’anonimato o al gridare Cambridge Analitica come se fosse uno spauracchio (quando l’unica cosa che hanno fatto é stato bombardare di informazioni faziose target specifici, praticamente il funzionamento base della pubblciitá online.
Questi sistemi di controllo massivo hanno potuto proliferare e continuano a farlo proprio perché la legislazione é troppo lenta (o troppo distratta da malumori elettorali) per occuparsene. Vuoi smontare la baracca da domani? Basta richiedere per legge che le API siano di pubblico accesso e che si faccia qualche legge decente per la gestione dell’user generated content (e non quello schifo dell’articolo 13).
E soprattutto bisognerebbe cominciare a far rispettare le leggi che giá ci sono: dove sono le multe per il GDPR? Qui manco si riesce a bastonare le banche per non essere ancora compatibili con il PDS2.
Questo é il vero significato del “distupt” di Silicon Valley: approfittarsi di tutto ció che non é ancora illegale. Si avrá un cambio solo quando si cominerá a farla pagare a questa gente.
E no i 5 miliardi di multa a facebook sono stati una barzelletta, i colossi tecnologici si finanziano infinitamente grazie al venture capital, per fargli male bisogna colpirli nel “core business”.
Ho letto con calma e mi sono preso un po’ di tempo. Lo faccio spesso, talvolta anche sui social: forse anche perché non guardo la televisione (letteralmente mai, non per una scelta ideologica ma solo perché non mi piace), di solito commento le cose almeno il giorno dopo e devo dire che ha i suoi benefici: rende meno compulsivi, meno subalterni al flusso di notizie deciso da altri, fa prendere qualche granchio in meno. Tra l’altro, Wu Ming 1 mi aveva già raccontato circa metà di queste argomentazioni, battute, esempi in un lungo corteo in Val Susa, e ho trovato molto simbolico il fatto che il post cominciasse a camminare su gambe offline in carne ed ossa prima di essere pubblicato online.
Spero di riuscire in un altro commento ad articolare un po’ meglio il ragionamento, ma non credo che smetterò di usare sia Twitter sia Facebook, che finora mi sono tornati molto utili. Proverò semmai a usare di più Giap, che mi ha dato tanto e a cui ultimamente non ho restituito abbastanza (ecco un’altra cosa orrenda di Twitter: diseduca a formare delle community online, fomentando invece un meccanismo iperindividualista del tipo capofila-gregario, ovvero followed-follower). Per ciò che interessa a me, i risultati ci sono e sono misurabili, nonostante tutto. Dico questo sebbene concordi su pressoché tutte le osservazioni critiche fatte, in particolare su quella che mi sta più a cuore e cioè sul meccanismo delle gratifiche intermittenti usato da timeline/home/feed, che scimmiotta i meccanismi patogeni del gioco d’azzardo.
Il punto per me è sempre avere consapevolezza, avere attenzione, avere cautela, avere senso critico. Preferisco mille volte una scelta che non condivido presa a ragion veduta a una scelta più vicina alla mia che però è stata presa per semplice conformismo, abitudine, pigrizia o moda. Beninteso, questo vale anche per le scelte di “esodo” che quando sono fatte con superficialità, come indica giustamente il post, finiscono per riprodurre altrove le stesse dinamiche o per concentrarsi su un tipo di critica banalotta e moralista che non ci porta da nessuna parte.
Quello che vorrei dire per ora però è che rileggendo quello che avete e abbiamo fatto in questi anni mi è venuto un po’ il magone: siamo stati proprio fighi. L’effetto di questa seconda parte è parecchio spiazzante perché, perlomeno su di me, la sezione che ricorda cosa è stato fatto su Twitter dai Wu Ming e dai giapster ha un effetto davvero esaltante, il che è curioso in un doppio post che vorrebbe spiegare perché non ci si può fare (più) nulla di buono. Mi verrebbe da dire: combiniamone altre! ;-)
Mauro, fidati, non appena si sarà avviata per bene la nuova fase, nel nuovo decennio non solo ne combineremo ancora, ma ne combineremo di meglio e con risultati più concreti :-)
Grazie Wu Ming e grazie a tutte i Giapsters per aver riempito le mie letture di contenuti importanti, in queste ultime settimane. Scrivo sperando di non aver lisciato nessun commento o sotto-thread e nel caso, di non essere, per usare un termine da social media, blastato per questo.
Io sono su fb da quando su fb c’erano le cause “save water: drink beer”, all’inizio ero abbastanza attivo, postavo status e note e facevo quello che fb diceva di fare all’epoca: restare in contatto con le persone della mia vita. Devo dire che da quel punto di vista m’è servito e mi serve ancora: ho seguito le bambine in Zambia diventare adolescenti e poi donne e madri, le carriere più o meno folgoranti dei compagni dell’università, ho saputo chi c’era nella prossima città in cui mi sarei stabilito, cose così. La mia attività su fb s’è ridotta poco a poco e ora non posto o laiko (liko? laico?) quasi nulla, un po’ perché lo sbarco di cani e porci su fb ha limitato gli argomenti che avrei potuto trattare senza ripercussioni familiari o lavorative (“di nascosto però, non dalla polizia ma da Edvige la zia” diceva quell’altro), un po’ perché mi son reso conto presto che sarebbe solo un contribuire al brusio, aspettando come scrivete giustamente la gratificazione dei like che, per fortuna, non mi ha mai troppo interessato. Sono stato sempre attento a non aprire siti del cazzo da fb, a non aprire i contenuti sponsorizzati o “consigliati per te” (mannaggia a quella volta che m’è scappato il dito su un incidente stradale in veneto…), a laikare poche, selezionate pagine pubbliche, etc. e ha abbastanza funzionato: finchè non mi propone cose che effettivamente mi interessano , mi dicevo, vuol dire che non mi ha inquadrato. Da un annetto, prima fra le pagine consigliate e ora, massicciamente, su quella striscia che chiamano “Wish” (è una vetrina di prodotti abbastanza allucinante…sei lì che scrolli tranquillo e ti propongono vibratori…) ho notato un trend preoccupante. Wish e/o pagine sponsorizzate che propongono contenuti o prodotti non sulla base delle ricerche fatte su google, i siti visitati o l’attività su fb ma…sulle chiacchere che faccio vicino al telefono. In un paio d’occasioni abbiamo fatto dei test fra amici, una volta parlando senza ragione della nintendo wii e di recente con il pissdebout mostratoci (dal vero, non sul telefono) da un’amica e di cui discutemmo i benefici per una mezz’oretta: puntuale, la mattina dopo me lo ritrovo su wish.
Di articoli sui timori che “il nostro telefono ci ascolti” ne ho letto qualcuno ma mi pare che si concentrino solo sulla registrazione o meno delle conversazioni, di solito sostenendo che finché non dici “ok google” non viene registrato niente. Questo ovviamente lascia aperta la questione del “ma come fa google a sentire ok google se il microfono non è acceso?”
Ora, sono io vittima di un sentimento complottista se penso che fra triggerare il telefono con ok google o farlo con altre parole chiave, en principe, non ci sia troppa differenza e che è quello che la app di fb fa nel mio caso del pissdebout?
Io, nel dubbio, quando capita che la conversazione si sposti su argomenti sensibili nel paese in cui sono, tipo la sa lute de r e del Ma rocco o i movimenti nel nord, spengo il telefono. Inoltre, grazie anche alla vostra spinta, ho tolto la app di fb dal telefono e vedrò di pistolare sul pc al più presto per poter vedere di tanto in tanto chi ha figliato senza per questo nutrire la bestia…grazie mille per le dritte al riguardo!
Grazie, Elmar. Quello che racconti pare sia successo a tante e tanti altri, le testimonianze che abbiamo sentito solo nella cerchia delle conoscenze sono numerose. La situazione sembra proprio destinata ad aggravarsi grazie a chi si mette beatamente in casa maccheggi come Alexa o Google Home, per rendere la suddetta casa “smart”. Come si diceva sopra, in pratica è un’autoschedatura di massa. Quel che è peggio, è un’autoschedatura spensierata.
Buon pomeriggio a tutti.
Vorrei chiedere un consiglio.
Sapreste indicarmi un dominio email da poter utilizzare a dispetto di gmail, virgilio et similia? Al momento è l’unico ostacolo che incontro per una riformulazione vitale e semi-complessiva sul web.
Io uso protonmail; ma in giro c’é anche di meglio.
Io ho la mia casella personale su protonmail, che sta in Svizzera. Se vuoi farti una mail al 100% indie puoi provare a chiederla ad autistici.
Comunque, se fossi Youtube o Facebook o Twitter una delle prime robe che metterei su sarebbero dei siti “alternativi” da cui poter linkare i contenuti delle piattaforme maggiori. Certo che prima o poi un gruppo nutrito di bastian contrari inizierà a promuoverli dicendo “Oh di là ci tracciano e facciamo il loro gioco, passiamo da qui che almeno non ci puppano dati e non gli diamo soldi”.
Però magari sono io che penso male.
Detto questo, un argomento che è rimasto molto a margine della discussione (forse per questioni anagrafiche legate ai Giapster), sono le nuovissime generazioni. Che per esempio non usano facebook (roba da matusa), ma al contempo usano ormai i cellulari con l’account Google (senza usare l’email ché tanto è un’altra roba da matusa), consumano sul cellulare i contenuti della rete e si “sfanno” di Instagram, Youtube e Twitch. Dove vivono (e si fanno – abbondantemente? – mantenere) i loro idoli.
Nel caso dei siti, browser, add-on e strumenti vari che abbiamo segnalato, alcuni sono comprovati (Mozilla/Firefox ha già una gloriosa tradizione alle spalle) e tutti sono trasparenti dal punto di vista del codice, si fa prestissimo a verificare che bloccano javascript, tracking e schifezzuole varie, privando dunque Facebook, YouTube e Twitter di quanto permette loro di estrarre valore, e al contempo rendendo gli utenti almeno un poco più consapevoli e distaccati rispetto all’esperienza di seguire quei link.
Riguardo all’uso della rete da parte degli adolescenti, abbiamo fatto vari riferimenti e linkato un po’ di cose soprattutto nella prima puntata. Tutti noi WM abbiamo figlie e figli adolescenti, abbiamo un’esperienza (quasi)diretta quotidiana di come quei mondi comunicano, del fenomeno YouTuberz, di Instagram ecc. Il problema della gamification di ogni esperienza è evidente, ma sotto quell’aspetto i teenager non sono messi peggio degli adulti, anzi. A diffondere il cliché degli adolescenti rincoglioniti da Instagram e TikTok sono soprattutto uomini di mezza età zombificati da Facebook :-) E secondo me molte e molti adolescenti hanno molte più possibilità di disintossicarsi (non foss’altro perché hanno cervelli più plastici e molta vita davanti) rispetto agli intossicati cinquantenni e sessantenni. Queste nuove generazioni, non dimentichiamolo, hanno appena sorpreso il mondo con mobilitazioni globali che nessuno si aspettava. Vuol dire che tanto rinco non sono.
Non volevo affatto dire che gli adolescenti si rincoglioniscono più degli adulti. Nella mia esperienza di scuola vedo però ragazzi e ragazzini che sono legati alla rete in modo molto più profondo rispetto a quanto si possa immaginare.
I ragazzi (ma anche ventenni e trentenni) hanno di fatto creato delle comunità che girano per lo più attorno ad un unico “pilota”, prendendo a pretesto argomenti vari e disparati. Eppure creano costantemente contenuti, seguiti da centinaia di migliaia di persone. “Iscriviti”, “Lascia un like”, “Condividi”, metti 1 euro su Patreon, etc…
Mi chiedo da una parte quanto a loro interessi la questione “privacy”, o quanto ne siano consapevoli, e dall’altra se sarebbero disposti ad abbandonare la loro comunità per poter preservare i propri dati.
Io penso che ci sia bisogno “sul campo” di una voce che parli anche a loro di questi argomenti, anche nella contraddizione di giocare secondo e nelle regole del “nemico”. Questo non dico debba farlo Giap!, ma guardate i numeri che fanno i Jackal, gli Slim Dogs, Rovazzi, ma anche canali più particolari come Sabaku o Barengo… si tratta di una “piazza” veramente sbalorditiva. E bisognerebbe intercettarla.
p.s. ma a qualcuno dei Giapster è arrivata stanotte l’email di Google Maps con il “riassunto” del 2019?
Secondo me non sarà tanto la privacy (*) a far loro vedere da fuori e mettere in discussione le “comunità” online centripete, ma l’esperienza concreta e viva di comunità diverse, orizzontali, policentriche, corporee come quelle che si formano nei movimenti ma che – Henry Jenkins lo documenta da decenni – possono formarsi ed evolversi anche a partire dalla fan culture.
Molte ragazzine e ragazzini, nell’ambito del fandom a cui partecipano, fanno già un sacco di cose creative. Al momento, per gran parte del tempo regalano quella creatività al capitale (soprattutto al solito Zuckerberg), ma abbiamo visto nell’ultimo anno che sanno farne anche altri usi, perfino usi implicitamente o esplicitamente anticapitalistici.
Dico di più: i movimenti sul clima, le cui avanguardie sono giovanissime, stanno cominciando ad attaccare anche il capitalismo delle piattaforme (vedi FFF contro Amazon). Stanno capendo che, oltre il velo del greeenwashing, i padroni delle piattaforme social non sono un’altra specie rispetto ai padroni delle piattaforme petrolifere, spesso fanno lobbying insieme ecc.
Insomma, a farli gettare uno sguardo critico sull’ambiente informativo nel quale si sono formati possono essere solo le lotte a cui prenderanno parte. Far parte di un “gruppo in fusione”, di un’ondata di movimento come quelle che stanno investendo il pianeta è un’esperienza che riconfigura la vita. Ed è anche una delle esperienze più erotiche che si possano fare. L’amore è fortissimo, e a quell’età lo è anche il corpo.
Infine, non dimentichiamoci che la realtà corre veloce, la fotografia del mondo che scattiamo oggi non è mai quella definitiva. Se il capitalismo non è eterno, figurarsi se può esserlo la social-sfera attuale.
–
* In realtà gli adolescenti alla privacy ci tengono, quando la identificano come tale. Per dire, meglio non entrare nella stanza di un adolescente senza bussare. Chiudere la porta della propria stanza è uno dei gesti universali dei teenager (almeno di quelli tanto fortunati da avere una stanza). Ma devono, appunto, riconoscere il problema. Nel caso dei social, il potere dell’automatismo e la pressione dei pari ostacolano o almeno rallentano il riconoscimento del problema. Per ora.
P.S. Ekerot, il 2020 può essere l’anno in cui smolli Google Maps, la cacci nel bidone del rusco e passi a OpenStreetMap. C’è anche l’app per il telefono :-)
Ottimo suggerimento OpenStreetMap.
Ecco, secondo me, per rispondere anche a Ekerot, quel che vedo mancare spesso nei miei coetanei ventenni, non è tanto la disponibilità ad utilizzare strumenti che tutelino maggiormente i propri dati, quanto la conoscenza dell’esistenza di questi strumenti.
Sarebbe utile, a mio avviso, divulgare maggiormente l’esistenza di tali strumenti, che molto spesso appaiono di nicchia e visti unicamente come roba da smanettoni.
Provo a dare il mio contributo. Uno strumentario da implementare:
PC
Sistema operativo: Linux (debian, ma anche altre vanno bene)
Browser: Mozilla Firefox (con estensioni, alcune citate nei commenti precedenti) e Tor
Motore di ricerca: DuckDuckGo
Mail: protonmail
Telefono
Sistema operativo: Android (in mancanza per ora di altro)
Browser: Mozilla Firefox (con estensioni come sopra) e Tor
Motore di ricerca: DuckDuckGo
Mail: Protonmail
Mappe: OpenStreetMap
Messaggistica: Telegram
Quel che dici è cruciale. Quando la ricerca e adozione di strumenti alternativi e free si estenderà e farà breccia tra giovani e giovanissim*, quando la portata del problema del data mining e della sorveglianza sarà consapevolezza diffusa tra le attiviste e gli attivisti delle generazioni più giovani, ci sarà un salto di qualità nella lotta per un’informatica libera.
Concordo con la necessità di divulgare uno strumentario di base, le varie alternative sono ora molto più stabili, affidabili e “user friendly” quindi con tutti i requisiti per essere utilizzate da chiunque.
In rete mi sembra che manchi una raccolta organica, una raccolta pronta all’uso in italiano che orienti gli utenti (ma mi posso sbagliare). Ci sono molte pagine che parlano dei singoli software o che discutono di problemi specifici, quindi non direi che c’è una mancanza di contenuti, ma questi sono forse ancora troppo sparsi o settoriali.
Sarebbe interessante poter sviluppare quanto già iniziato in questo articolo e creare una directory web che presenti in modo molto sintetico le alternative al web del data mining con relativi link alle pagine ufficiali di questi strumenti, ai forum e blog che ne descrivono modalità ed esperienze di utilizzo.
– Da qui in poi fantastico –
La directory vorrebbe essere una prescrizione per una specie di cura big-data-detox punto per punto. Il link a questa risorsa web potrebbe diventare un “bottone” o banner da aggiungere ai siti e blog che aderiscono all’idea di una rete decentrata e gestita da comunità di utenti. I punti fermi dovrebbero essere l’open source, la tutela della privacy, il boicottaggio del data mining, la libertà ed autonomia della gestione del web…ovviamente in costante aggiornamento.
Insomma, qui già vengono segnalate delle strade percorribili e molte altre indicazioni sono sparse sulla rete (a volte datate purtroppo), si tratterebbe di creare uno stradario di minima che le presenti…tipo la sezione “cosa mettere nello zaino” delle guide escursionistiche ecco.
Aggiungo al tuo strumentario il sistema “lineageOS”, alternativa open source ad Android e google free (lo testerò a fine mese).
Vi ringrazio assai per le riflessioni presentate e stimolate in questa pagina!
Grazie per la proposta perché di una simile directory sarei fruitrice entusiasta pur se parassita essendo del tutto incapace di dare il minimo contributo. Sono consapevole a istinto del rischio di certi programmi e servizi, probabilmente non di tutti, ma l’unica mia difesa al momento è cercare di non usarli o di incrociarli il meno possibile. L’obbligo (venuto dalla UE) di abolire le chiavette e affidare al cellulare, meglio ancora se smartphone, la transmissione dei codici di accesso al c/c online mi ha fatto drizzare i capelli in testa, tanto quanto l’idea di dover dare un numero di telefono a un’azienda per iscrivermi a un social. You tube pero’ mi serve alquanto e al momento l’unica difesa che conosco è proprio invidio.us, su cui ho scoperto video molto più attinenti a quel che cercavo e che YT non mi aveva mai mostrato.
Ma quello che mi ha più allarmato è l’interazione cui accenna anche wb tra pubblico e privato, di cui si parla ancora molto poco. Già un paio di anni fa dal pc di una grande biblioteca mi sono collegata alla casella personale della posta elettronica, sempre dallo stesso pc ho poi inviato delle richieste di lettura dei libri della biblioteca, tramite un loro s/w interno di gestione. La casella da quel giorno ha iniziato a propormi di acquistare quei libri, o altri del medesimo argomento. Altro che Patriot Act.
Alcune amministrazioni pubbliche hanno affidato a google la posta elettronica, la condivisione dei documenti e file interni, e invitano a utilizzare google per il backup per cui non vengono forniti supporti o strumenti alternativi: “costano”. Ancora: per installare sul pc di lavoro dei normali s/w commerciali per ufficio, si puo’ essere invitati a scaricarli direttamente, salvo trovarsi davanti alla richiesta dell’azienda di fornire credenziali della posta di ufficio E personale “per la sicurezza”. Anche per usufruire di certi servizi (pubblici) puo’ capitare di dover fornire a google le proprie coordinate, sempre su richiesta delle amministrazioni.
E in questi casi, come ti salvi?
@La dea del sicomoro Ti ringrazio per aver palesato l’enormità della questione (la mia era una idea abbastanza naïf)
Il quadro è molto preoccupante, complesso e risulta difficile evitare di finire in trappole digitali. Condivido esperienze simili; ad esempio non ricevevo la newsletter della biblioteca comunale perché il gestionale non inviava mail ad indirizzi “strani” (definizione del personale tecnico). Con un po’ di fatica si è riusciti a chiedere che venisse risolto questo inghippo (che si è poi dissolto con il passaggio ad un gestionale basato su linux). Credo che di base si debbano interiorizzare alcune procedure di sicurezza: mi autentico solo per lo stretto necessario poi esco; evito il più possibile di fare attività web se sono tracciate; se sono in un pc pubblico verifico la presenza dei plugin indicati in questo articolo; evito browser notoriamente assetati di dati; se proprio necessario, uso determinati servizi mail solo dove e come richiesto. Ci sarebbe da capire se ci sia un modo per usare il data mining alla rovescia, cioè creando enormi quantità di dati inutili e randomizzati quindi poco appetibili sul mercato, ma che comportano comunque spese di immagazzinamento e gestione. Ad un livello più amplio si potrebbe chiedere conto alle amministrazioni del perché si sia scelto un servizio poco garante della privacy e cercare di capire come proteggersi…sia mai che ne nasca una consapevolezza istituzionale – sempre ammesso che serva a qualcosa.
Potrei sbagliarmi, ma credo che parte del problema stia nel non considerare le questioni dibattute in questo articolo come degli aspetti vitali ed urgenti da difendere nel quotidiano vivere, ma che siano piuttosto viste come un diritto di secondo piano o comunque non sufficientemente importante da richiedere un impegno teso al cambiamento. Di conseguenza ci si ritrova ad aver affidato mezza vita alla silicon valley ed uscirne sembra ora impossibile (excursus autobiografico). Vivendo in una realtà molto piccola sono probabilmente ottimista, il sindaco è sotto casa quindi il dialogo è più facile, trattare con Adobe non sarebbe altrettanto facile ed immediato.
Riguardo alla directory, esiste già qualcosa qui https://directory.fsf.org, curata dalla free software foundation. Non è in italiano e propone (giustamente) in prevalenza applicazioni per gnu/linux. Per android c’è f-droid, un google play store per software libero o open source.
In generale però, anche se l’esigenza di sintesi è comprensibile e una sorta di certificazione del software su questo aiuterebbe, non bisogna farsi troppe illusioni: il tema è tale che occorre comunque una maggiore consapevolezza, che non necessariamente deve essere strettamente tecnica.
Qui si parla di social network ma è chiaro che il tema è ben più ampio. Qualcuno l’ha già accennato.
Per quanto mi riguarda, non riesco a non fare un parallelismo tra l’interpretazione sempre più orientata al controllo sociale dell’evoluzione tecnologica, vedi il data mining o le istanze securitarie che sorgono senza differenze ai quatto angoli del globo e la sempre minore capacità del lavoro, altro strumento storico di controllo sociale, di assolvere questo compito, proprio come conseguenza della stessa evoluzione tecnologica.
Non credo sia quindi improprio riconoscere all’evoluzione tecnologica la capacità di alterare o consolidare i rapporti di forza tra le classi sociali e se questo è vero, allora questi argomenti vanno trattati di conseguenza.
Consideriamola all’inverso, Unlogged: è l’evoluzione tecnologica ad avvenire nel quadro di assetti proprietari e rapporti sociali basati su sfruttamento e disuguaglianza, e perciò – senza “correttivi” all’altezza – va “naturalmente” in una certa direzione. L’innovazione viene ispirata, plasmata e selezionata da questi rapporti sociali, sui quali poi retroagisce, confermandoli e rafforzandoli.
In parole povere, e tagliando con l’accetta, abbiamo due casistiche:
1) l’innovazione è già pensata a fini estrattivi e di profitto, come molte app che nascono ogni giorno, oppure
2) tecnologie nate come “commons”, orizzontali e senza fini di lucro, subiscono processi di espropriazione, concentrazione, verticalizzazione. Non a caso si chiama – o almeno eravamo soliti chiamarlo – «capitale monopolistico»…
Nel web le enclosures – molto simili a quelle agricole che prepararono la nascita del capitalismo industriale inglese – sono avvenute sotto i nostri occhi, Tim Berners-Lee lo ha fatto notare molte volte: il World Wide Web nasce come tecnologia aperta e orizzontale, poi i vari Facebook ne recintano porzioni gigantesche e dicono «Questa terra è mia, qui le regole le detto io», praticamente trasformando il web nel suo contrario.
Il processo è stato molto smooth, o almeno quasi tutti lo hanno vissuto come tale, e quindi sembra non ci sia stata soluzione di continuità. Intendo dire che per molti utenti Facebook è il web, nonostante sia, concettualmente e strutturalmente, l’opposto di ciò che il web doveva essere.
Questo processo ha avuto luogo perché dei capitalisti lo hanno portato avanti, nel quadro di rapporti sociali che lo davano per scontato, sulla spinta di un’ideologia dominante che lo esaltava, e grazie a leggi che lo permettevano e favorivano. Insomma, non è la tecnologia ad avere cambiato i rapporti sociali, sono i rapporti sociali ad aver orientato la tecnologia e averne imposto una versione a misura di sfruttamento.
Non credo che sia un caso se tra le parole d’ordine delle sardine trovi posto anche quella acritica (cioè immediatamente assunta) di “innovazione”. Ci si guarda bene dal fare proprio il concetto assai più radicale e impegnativo (e marxista) di “trasformazione”.
Sono d’accordo, ma credo ci sia uno scambio reciproco tra sviluppo tecnologico e contesto sociale ed economico. Nel senso che il secondo determina indubbiamente il primo, perché questo però diventi strumento di controllo del secondo, col fine naturale di consolidarlo o addiruttura di rafforzarlo. Cioè: lo strumento non è immagine inerte del contesto socio/economico ma diventa un moltiplicatore delle energie residue del sistema di potere. Credo che questa dinamica tra strumento e contesto sociale non valga solo per lo sviluppo tecnologico ma per tutti gli altri strumenti a disposizione del sistema capitalistico o di qualsiasi altro sistema reggitore, in misura ovviamente variabile.
Esiste però anche un rapporto di potenza tra gli strumenti. Non so se sto travisando, ma nella sua ormai continua necessità di cambiar pelle, mi sembra che il sistema capitalistico non abbia oggi strumento più potente. Vorrei allora capire se, in questa grande muta, il sistema si presenti più vulnerabile alle richieste di un radicale cambiamento, oppure no.
Chiarisco che è in questo senso che considero importante l’evoluzione tecnologica, non certo per buttarsi di nuovo nel fosso dell’idolatria modernista e per mascherare con lo strumento i poteri che ci stanno dietro.
Riguardo ai casi 1 e 2, penso che non si escludano a vicenda e ritengo che il secondo caso non sia marginale e personalmente non mi è indifferente. Qui farei una differenza tra evoluzione tecnologica e sviluppo tecnologico. Se il world wide web lo considero una evoluzione tecnologica, faccio fatica a definire tale facebook, la vecchia usenet resta, almeno concettualmente, più avanzata.
Elenchi ragionati di app, strumenti e servizi per la “de-googlizzazione» vengono compilati sempre più spesso, eccone uno.
L’elenco completo delle alternative a tutti i prodotti Google.
1) Solo un accenno a un tema che ha attraversato una delle sottodiscussioni. Nella mente dei politici dipendenti da FB, il post su FB è precisamente la cosa che si aspettano che tu faccia. Il post su FB è ciò che – nella misera idea di città che hanno – dovrebbe sostituire il tuo manifesto, la tua scritta sul muro; e dovrebbe costituire la principale forma espressiva della tua militanza.
Cito spesso la vicenda di compagni che si sono visti affibbiare multe perché sono stati individuati tramite telecamere di sorveglianza mentre «affiggevano», con il nastro adesivo (sic!), locandine di una loro iniziativa. Ebbene, non ho bisogno di interrogare gli assessori o il sindaco di quella città: messi di fronte alla portata antidemocratica (e anticostituzionale) di una tale repressione della libera espressione del pensiero, sono certo che direbbero che la stessa iniziativa si poteva promuovere, a costo zero, sui social, senza fare «degrado» sui muri.
Di FB si è ripetuto che era una «bacheca», oltretutto gratuita (che non lo sia lo sappiamo, ormai); io credo che questa retorica della «bacheca virtuale» abbia alimentato l’aggressione decorosa contro le scritte sui muri, gli adesivi sui semafori e i manifestini. Se questa mia ipotesi è corretta, ne deriva che il decoro – con la videosorveglianza e il (protofascista) «controllo di vicinato» – ti spinge a comunicare solo sui social (le «bacheche»); poi i social ti censurano (cosa ampiamente accaduta) e comunque avvolgono di ovatta e banalità ogni tua posizione, e ti riducono – questo è quasi peggio – a pregarli di essere più democratici, oppure – sprofondiamo nell’abisso – a pregare lo stato perché (finga di) imporre ai social commerciali di essere democratici.
Non mi pare che questa situazione sia del tutto ipotetica (e sono in disaccordo con chi pensa ottimisticamente che i rischi *veri* siano ancora per un po’ *comodamente* confinati in Cina), e dunque richiede se non delle soluzioni quantomeno una corretta messa a fuoco.
2) Altro tema da sviscerare ancora è quello di quanto i politici su misura di FB e social (i bolognesi possono pensare a Lepore, per esempio) spingano, nelle loro politiche concrete, prassi che alimentano, parallelamente a FB stesso, il conferimento incentivato dal pubblico di dati da mettere a profitto. Ripeto: «incentivato dal pubblico»: non c’è solo FB o Twitter o Google a cui, pur indotti, ci consegnamo coi nostri piedi e mani, ma ci sono pure: le app per le bici a nolo sostenute e in parte finanziate dagli enti pubblici; quelle per il car-sharing; persino quelle per «dimostrare» che usi tanto tanto i mezzi pubblici e così sei virtuoso e ti regalano un cazzo di felpa in un negozio di catena, o le app per il conferimento dei rifiuti etc. Tutto questo spinto forsennatamente da gangli dello stato o da quel mefitico parastato pubblicoprivato che sono le ex-municipalizzate e le aziende ex-pubbliche ora consegnate al profitto. Solo per dire che anche in questo campo non siamo *solo* di fronte al capitalismo, ma al mostro con due teste costituto da capitale e stato neoliberale.
Per chiarire il riferimento a Lepore come amministratore «a misura di Facebook», riproponiamo qui il commento che abbiamo lasciato sotto la prima puntata del testo di Wolf «La sfida di XM24 contro il Nulla»:
—-
Sarebbe interessante analizzare la comunicazione di Lepore tenendo conto di ciò che abbiamo scritto su come funziona Facebook.
Lepore, antropologicamente parlando, è proprio il «règaz da Facebook». E la dinamica è da manuale: infila post su post dove si rappresenta al centro di eventi culturalmente importantissimi, epocali (e magari si tratta di inaugurare luminarie natalizie che compongono il testo di una canzone di Cremonini, o robe ancor più effimere e sdozze), e riceve risposte pesantemente standardizzate, con una proporzione segnale/rumore di 1 a 99 (la risposta più frequente è: «Bellissimo!»).
Ma c’è molto più di questo: il modo stesso in cui Lepore, da assessore, amministra i settori di sua competenza – e comunica i “risultati” del suo amministrare – è un modo totalmente gamificato: qualunque cosa è piegata alla logica del “contest” e della pseudo-gratificazione da rush di dopamina, è tutto un bando, un concorso, un punteggio, un like, una rece da TripAdvisor, un sondaggio, un televoto da reality, una «ricompensa variabile intermittente».
Del resto, è con Lepore che le politiche culturali bolognesi sono state ridotte, dichiaratamente, a «marketing territoriale», cioè al tempo stesso vendita della città e spettacolo di copertura, maquillage per politiche nient’affatto “simpatiche”.
Naturalmente, non è il caso di personalizzare troppo processi che sono ben più grandi e legati all’attuale fase del capitalismo. Fase che nelle città si esprime in violente “messe a valore”, in politiche discriminanti e classiste, in laissez-faire edilizio, in gentrification e ristrutturazioni urbane imposte a colpi di finte «emergenze» ecc.
Però far notare che Lepore è stato il règaz giusto al momento giusto può essere utile. Anche solo per capire il legame tra gamification della vita e politica sul territorio.
A proposito della privatizzazione della funzione pubblica, almeno per quella parte che è parassitaria della informatizzazione dei servizi, di cui ovviamente il data mining è solo uno egli aspetti da scongiurare, esiste questa campagna che credo meriterebbe di essere divulgata https://publiccode.eu/
Innanzitutto vorrei ringraziare WM e Giapsters per queste belle docce di consapevolezza informatica (e non solo!). Da fruitore indifferente di Chrome e Google, ma anche di FB, sono passato a ragionare molto di più sulla questione e ho cercato di agire di conseguenza, continuando l’esplorazione di un mondo in cui vivevo ma del quale non ero minimamente consapevole.
Penso che il punto ribadito da Gagarin e da WM1, ossia la divulgazione di tali strumenti, sia fondamentale. Infatti è uno dei miei argomenti principali di conversazione con amic* e compagn*.
Mi ha molto colpito il discorso sull’azzardopatia. Già in passato con alcuni amici ci confessavamo come, nelle varie pause di studio, per riposare il cervello scrollassimo senza criterio la bacheca di FB… Certo, c’è scrolling e scrolling, ma il discorso rimane. In ogni caso, pur non essendomi tolto ancora da FB, sto cercando di disintossicarmi: so che c’è, ma non ci vado.
Riguardo invece al tema ‘adolescenti e la rete’, mi trovo d’accordissimo – pur non avendo figli :-) – sul far conoscere questi strumenti ai giovanissimi.
Al riguardo, mi è capitato spesso di pensare a una storia che forse non c’entra moltissimo, ma che mi aveva abbastanza inquietato e che intitolerei piuttosto ‘adolescenti e cellulari’. Un conoscente, che aveva deciso di non regalare ancora al figlio undicenne il cellulare, mi aveva raccontato che suo figlio, appena tornato dal campo scuola, aveva esordito con le seguenti parole:
– Papà, mi sono annoiato?
– In campo scuola? Strano! E lo perché?
– Tutti stavano al cellulare, ero l’unico a non averlo.
Il ragazzo cresce bene, giocando ai giochi “de na volta”, ma a quale prezzo? E’ probabile che il cellulare sia un po’ come FB et similia: se non ce l’hai ti perdi una fetta di “realtà”, così come un tempo se non avevi gameboy e altri ninnoli potevi rischiare una piccola emarginazione. Qual è lo scarto, se ce n’è uno? E’ più grave come situazione? Ancora ci penso.
Interessante storia, ma la prima cosa che ho pensato è «ma cosa c’è che non va in quel “campo scuola” se i ragazzi passano tanto tempo al cellulare»? Perché di solito, se c’è qualcosa di fisico e/o socievole da fare, e se il contesto consente di farlo, degli undicenni credo lo preferirebbero.
Per quanto riguarda ragazzi/e più grandi ho avuto modo di osservare come siano le scelte delle istituzioni scolastiche – e quelle di almeno parte degli insegnanti – a spingere verso la dimensione ansiogena della compulsione delle «novità« dallo smart – per esempio non dando i compiti o non decidendo date di interrogazioni etc e rimandando tutto a comunicazioni via mail (ma forse anche via messaggistica, non lo escludo), introducendo così una dimensione «just in time» che non ha né dovrebbe avere giustificazione alcuna nell’organizzazione del tempo scolastico.
Altro tema necessario a proposito di tecnologie di sorveglianza e giovanissimi è quello dell’ipercontrollo concesso dalla scuola ai genitori, e di come questo abitui a un furto della prepria dimensione intima e di libertà. Risulta infatti un po’ difficile convincere un adolescente che non dovrebbe consentire a FB o a Google – entità astratte e lontane, fino a quando non ci hai riflettuto a fondo – di geolocalizzarlo, quando la scuola manda immediatamente un SMS ai genitori per dire loro che il ragazzo/a quel giorno lì non è a scuola. (Spesso richieste di firme genitoriali e simili prassi illegali non vengono neppure interrotte quando il ragazzo/a compie 18 anni; è in generale in corso una generale “messa tra parentesi” della maggiore età).
Qualcosa di analogo all’SMS sulle assenze dicasi per le perquise continue alla ricerca di qualche filo d’erba nelle scuole superiori: gli adolescenti si abituano a essere oggetto di attenzione poliziesca da parte di scuola, polizia; spesso genitori (non voglio richiamare un caso tragico di un paio d’anni fa, ma lo ricordiamo in tanti/e): è chiaro che quello che fanno i social può apparire loro poca cosa, in confronto.
Anche io sono un “non possessore” di cellulare… e non intendo che non ho uno smartphone, ma che non ho proprio un cellulare.
Cosa è cambiato nella mia vita da quando non ho il cellulare?
Molto.
Una buona parte dei miei vecchi amici non sono più amici perché non sanno come contattarmi, nonostante io abbia telefono fisso, mail e social vari.
D’altro canto ora ho una rete di relazioni meno ampia ma , per forza di cose, più “analogica”. Sostituirei anche la parola “analogica” con “soddisfacente”.
E soprattutto, fuori dalle mure domestiche o lavorative, non sono più soggetto a questa ansia da notifica che mi pervadeva.
Sicuramente il fatto di essere completamente disconnessi ha molti lati negativi ma io non riesco proprio a percepirli come tali.
Due anni fa ho abbandonato i social (usavo quasi esclusivamente Facebook e di rado Twitter). Alcune delle motivazioni per cui lo feci mi erano chiare già allora, e le ho ritrovate, spiegate alla perfezione, in questa vostra analisi in due puntate. Altre, le avevo solo intuite di pancia, senza comprenderle analiticamente, e le ho trovate qui, spiegate alla perfezione.
Grazie per la solita chiarezza espositiva e per l’esaustività, è stata una lettura rigenerante.
Andiamo avanti con il degoogling: eliminato definitivamente feedburner anche per quanto riguarda Radio Giap Rebelde. Usavamo la pagina del feed anche come archivio, ma ora è tutto su archive.org. Grazie a Void per l’imprescindibile aiuto e lo sbattone!
Ecco l’indirizzo della collezione, ci sono già tutti i file audio che abbiamo prodotto negli anni Dieci: presentazioni, reading, conferenze, interviste e programmi radio, concerti, performances e quant’altro.
P.S. Al fenomeno del degoogling / degooglizzazione, che era partito come “stranezza” ma dalla seconda metà del 2019 sta prendendo piede, dedicheremo un post di Giap ad hoc.
Ciao! Penso vi siano sfuggiti gli URL accorciati sulla vostra pagina di Mastodon fatti da Bitly.
Più dei termini di servizio trovo istruttivo un post della IBM che descrive i servizi cloud forniti all’azienda Bitly per dare un’idea della profilazione. Nel 2017, Bitly è stata comprata per la cifra di 63 milioni di dollari da Spectrum Equity (sì, si chiama proprio così).
Se proprio avete bisogno di servizi di URL shortening (ma state in guardia) posso suggerire LSTU https://lstu.fr/ oppure Framalink https://frama.link/ (che sotto sotto fa girare LSTU).
Grazie, in effetti quei link ci erano sfuggiti, quella bio era intesa come provvisoria, quando abbiamo aperto il profilo abbiamo copiato e incollato quella (antediluviana!) che avevamo su Twitter (e che poi abbiamo tolto). Poi non ci abbiamo più messo mano. Rimediamo subito.
Da notare che il capetto/divetto delle «Sardine», nel proporre una misura non solo autoritaria ma basata su false premesse come «il Daspo per i social», ripete tutti i peggiori clichés di pseudosinistra sui social di cui al capitolo 2 della prima puntata, vedi soprattutto i punti 2a («Non tutte le critiche ai social sono uguali») e 2g («Tenere la parte», dove si parla del falso problema dell’«anonimato»). Cvd.
Quando si menzionano le Sardine si finisce sempre per parlare delle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna, et pour cause. Qui non ci interessa parlare di questo, ma di ciò che i discorsi sul «Daspo per i social» segnalano e confermano. Le campagne elettorali passano, la tendenza securitaria rimane e prosegue tra idee senza parole («odio», «degrado»…), frame tossici, cortine di smog e diversivi.
Da un lato, una pseudo-critica ai social distoglie l’attenzione dai veri nodi che li riguardano. Più a lungo rimarrà attivo il frame retorico di cui al punto 2a («i social permettono di esprimersi a troppa gente»), più tardi si affronteranno i nodi reali della tossicità dei social commerciali, e cioè gamification della vita, data mining, controllo.
Il presunto «odio» è un facile nemico retorico, ma è un epifenomeno, una conseguenza di come funzionano strutturalmente quei dispositivi. Funzionamento che questi discorsi censori e disciplinari – semplicisticamente incentrati sui soli contenuti e sulla «malafede» del singolo utente – lasciano intatto.
Dall’altro lato, si estende in ogni ambito discorsivo il frame del «daspo».
Non bisogna fare l’errore di derubricare questi annunci a «cavolate», roba di poco conto di cui non vale la pena occuparsi. Se, per fare un esempio, Wolf Bukowski avesse ragionato così, non avremmo la sua preziosa critica del «decoro» come dispositivo di controllo e ariete della ristrutturazione urbana neoliberista.
Non conta che, nello specifico, la proposta di turno sia implausibile (lo stato dovrebbe vietare a un cittadino l’uso di un servizio privato, peraltro fornito da un’azienda estera come Facebook, anche se la detta azienda vuole fornirlo e il servizio è in tutto e per tutto legale): ogni volta si sposta il discorso una tacca più in là nel terreno securitario e del controllo.
P.S. La proposta di un «Daspo per i social» fa il paio con l’altra, parimenti implausibile ma dannosa per il solo fatto di essere stata formulata, di una «carta d’identità» per l’uso di Internet, fatta dal renziano Marattin poche settimane fa. Sempre la solita solfa sull’«anonimato» ecc. Linko qui l’accurata risposta che gli diede su Valigia Blu Arianna Ciccone.
Un pezzetto di questo sotto-thread è finito su Repubblica, insieme ad altri pareri sensati su quest’idiozia del Daspo digitale. Una tale idiozia che persino Daniela Santanché “brilla” nel criticarla (strumentalmente, of course, ché se fosse per lei quelli come noi sarebbero già in galera, altro che Daspo).
Ho scritto questa cosa su quello che ho chiamato “oblio di massa” e che fa un brevissimo ragionamento attorno all’algoritmo che su FB ti “ricorda” cose che hai fatto o che hai scritto. Nel momento in cui è una macchina a dirti cosa devi ricordare, nel momento in cui lasci che una macchina faccia questo, hai buttato via parte (a volte sostanziale) della tua identità (che non è quella cosa monocorde e panciuta di cui tanto si parla ma un delicatissimo universo emozionale/relazionale in continua evoluzione). E’ solo un pezzo di ragionamento che volevo condividere, non ho trovato granché in rete sul tema.
https://www.publish0x.com/i-miei-2-cents/oblio-di-massa-xzdpzz
Hai colto un punto fondamentale:
«E’ molto comodo, in fondo: non fai nemmeno lo sforzo di ricordare cosa sia per te memorabile perché c’è un bot che te lo dice.
Il meccanismo è terribilmente traviante per il motivo che i parametri su cui si basa sono degli standard.
L’algoritmo non ti ricorderà mai che avevi scritto un post importantissimo che ha ricevuto solo 3 like.
Finirai per pensare a te stesso nei termini di parametri che non sono tuoi.»
Sul rapporto tra facebook e memoria riflettevo l’altro giorno. Premessa: sono uscita da facebook dopo la lettura di questi post e gli innumerevoli rimandi/spunti collegati, ovviamente era una decisione che in cuor mio avevo già preso ma aspettavo quella molla, che finalmente è arrivata. Dicevo sulla memoria, ho dovuto recuperare vecchie agende in cui segnavo i compleanni perché ultimamente non lo facevo più, visto che per la maggior parte delle persone era facebook a ricordarmi il compleanno. Per parenti e amici di vecchissima data la mia memoria, risalente ad un periodo pre-internet o forse pre-social evidentemente, è rimasta salda, ma per tutto ciò che è più recente mi sono impigrita terribilmente. Sembrerà una stupidaggine, ma mi fa rabbia pensare che per colpa di questi ausili informatici peggioro le mie capacità, in questo caso mnemoniche. È un discorso più ampio ovviamente, che va oltre i social network e i giganti della sorveglianza, però credo che vada fatto comunque.
Segnalo questo illuminante podcast di Nima Shirazi e Adam Johnson ( https://medium.com/@CitationsPodcst/episode-97-porch-pirate-panic-and-the-paranoid-racism-of-snitch-apps-b498a109ad1e ) in cui si dimostra come GAFAM (nello specifico Amazon) trae profitto dal securitarismo e dai peggiori istinti classisti, razzisti e misantropi che popolano il mondo delle app e dei gruppi di «controllo del vicinato».
Amazon, in corrispondenza d’amorosi sensi con la stampa locale (che cerca di vendere clic e copie senza alcun freno etico) e i dipartimenti di polizia, si gode l’allarme (gonfiatissimo e depolicizzato) per i furti dei pacchetti davanti alle villette dei suburbs statunitensi, e lo fa promuovendo la vendita del servizio di telesorveglianza Ring ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_Inc. ) e ipotizzando perfino un TV-show di “cronaca nera” che realizzerà grazie alle riprese della stessa app.
Lo show, come è ovvio, spingerà i cittadini a dotarsi di sempre più telesorveglianza, da realizzarsi comprando ulteriori pacchetti e servizi da Amazon («you just need to buy more Amazon to surveil your Amazon packages being delivered»). Il crescendo di paure coinvolge, in qualità di sospetti, anche i lavoratori addetti alla consegna.
Ho avvistato la pubblicità televisiva di Ring su un canale europeo, quindi tra poco sarà anche affare nostro. Con buona pace di chi, talvolta in buona fede ma non meno irresponsabilmente, crede che la causa del razzismo risieda esclusivamente in Salvini e nei salviniani.
Su Twitter e su come sia cambiato, in peggio, rifletto oggi su Mastodon (non a caso lì) partendo dal basso livello di giornali e agenzie di stampa, passando per un vecchio post che pubblicai sul mio blog proprio di critica a questi ultimi. All’epoca (parlo del 2011) Twitter sembrava un avamposto per le notizie più rapido delle agenzie e dei quotidiani online, ma non solo. Da lì scaturivano spunti di discussione che si trasformavano in post sui blog in un circolo virtuoso tra i due mezzi, qualcosa che per me ha smesso di funzionare da un po’, complice sicuramente la facebookizzazione di Twitter. Scrivevo allora: “Twitter e` un social un po` sui generis, dal mio punto di vista, ed ha enormi potenzialita` di azione e informazione, dal basso e orizzontalmente.” Era vero allora, non lo è più da parecchio ormai. Buone premesse per ricreare quelle condizioni le vedo su Mastodon, sperando che il tempo questa volta mi dia ragione. Leggendo Il capitalismo della sorveglianza e nello specifico dei precursori dei nuovi meccanismi di sorveglianza mi sento scoraggiata. Ho letto di almeno due applicazioni ideate con i fini più nobili e poi messe a profitto per i big della sorveglianza a scapito degli individui e della privacy, ma d’altronde dovrebbe essere un insegnamento quasi ovvio: all’interno di un’economia capitalista che tende ad inglobare al suo interno per mettere a valore tutti gli aspetti della vita delle persone, l’esistenza di tecnologie neutre o addirittura per il bene comune è costantemente impedita dai meccanismi stessi del sistema.
[…] Sensazioni weird anche sull’altro versante. Un movimento d’opinione e di piazza prende il nome da cadaveri di pesci ammassati, sepolti in scatole di latta con gli occhi sbarrati, pronti per essere divorati… e a tutti sembra un accostamento normale! E da quei pesci verrà la salvezza. E tra i primi passi verso tale salvezza c’è… il «Daspo per i social». […]
Quis custodiet ipsos custodes?
https://www.vice.com/en_us/article/qjdkq7/avast-antivirus-sells-user-browsing-data-investigation
Un’inchiesta su Vice di come Avast, l’antivirus gratuito, vendeva i dati sulle ricerche in internet a compagnie quali Google, Microsoft, Pepsi. ‘Every search. Every click. Every buy. On every site.’ A seguito dell’inchiesta Avast ha provveduto a interrompere la cosa, ma se non ci fosse stata è probabile, direi certo, che avrebbe continuato indisturbata.
Secondo il Guardian, il recentissimo scivolone in borsa di Facebook potrebbe essere una prima conseguenza dei recenti «scandals». Cioè, per usare un’espressione meno sensazionalistica, delle critiche che la piattaforma sta ricevendo – e, con le imminenti presidenziali USA, riceverà ancora di più – su praticamente tutti gli aspetti del suo operare: privacy degli utenti, estrazione e smercio di dati, diffusione di false notizie e teorie del complotto, tentativo di imporre una propria moneta, censure politiche e quant’altro.
[…] – Wu Ming, “L’amore è fortissimo, il corpo no. 2009 – 2019, dieci anni di esplorazioni tra Giap e Tw… […]
Mi presento per il mio primo commento: sono angelo, Genova, 22 anni, studio ingegneria . Grazie a mia madre non ho mai fatto uso di piattaforme social, di nessun ordine e grado. Non aveva sicuramente la consapevolezza di tutte le problematiche che facebook et simillia portano con sè, ma annusata soltanto che la vanità (intesa secondo il pensare cristiano, perchè quelle sono le nostre radici) decise che come posto era sufficientemente miasmatico per tenerne lontani i figli. Le dinamiche dei social le ho pertanto vissute sempre da fuori, percependone le storture e le sofferenze, riuscendo a volte a criticarle con più lucidità, a volte perdendomi dei pezzi e non capendone da vicino le insidie. La mia domanda diviene quindi (se è già stata fatta e me la son persa chiedo scusa) cosa ne pensate, e soprattutto quale sono le vostre analisi, a proposito di linkedin? Vivendo a Milano c’è una grandissima pressione che ti spinge a curarti di questo strumento, che insieme al famigerato CV divengono “specchio della tua anima”, biglietto da visita per il Lavoro (maiuscola voluta). E il Lavoro a queste latitudini non è inteso come il quantitativo di ore per garantirsi la sopravvivenza, ma come giustificazione “ontologica”: non lavori, non sei degno di essere; ti reputi degno, allora perchè non stai lavorando? Mi sembra proprio che ci sia una sorta di giustificazione “religiosa” sul tema Lavoro, o meglio sullo status quo del mercato del lavoro attuale (influenze calviniste della vicina svizzera?)
Sarebbe bello pensare che nella mia nicchia di studente queste spinte siano esacerbate, ma per quel poco che ho visto mi viene da pensare il contraio. A me personalemnte questa logica, a naso, ripugna, ma come si fa ad ovviare ai presunti “vantaggi” che linkedin fornisce? c’è un modo di resistere al farsi tagliare fuori? Come per il problema della mancata visibilità dei movimenti nel caso uscissero da facebook, ci sono delle contromisure per un tema come questo?
Vi ringraizio inoltre per il vostro blog, che mi ha davvero messo in moto e formato su moltissimi argomenti.
In particolare questa miniserie che mi ha illuminato alcuni aspetti oscuri delle piattaforme social e dato finalmente nomi a meccanismi che parzialmente avevo messo a fuoco.
Il discorso è che se nel tuo campo il luogo numero 1 (e magari anche il 2 e il 3) in cui si cercano ingegneri è linkedin e il tuo cv lì non è disponibile, rischi di perderti parecchie offerte di lavoro.
Ti direi intanto “Cui prodest?”. Cioè, il fatto che tu te ne tieni fuori cambia realmente qualcosa? Si smette di utilizzare linkedin? O semplicemente si continuerà a cercare ingegneri lì, e tu finisci a lavorare nei bar?
Seconda cosa: hai delle reali chance lavorative se non metti il tuo cv su linkedin? Tipo: portare il curriculum porta a porta? Mandarlo via email? Metterti in proprio?
Se la risposta è sempre no, beh, io due conti me li farei. Mettere in discussione certe dinamiche del web, cercare di favorire degli scambi più “sani”, è un conto; restare disoccupati è tutta un’altra faccenda.
Anche no. Ho una lunga carriera nell’IT, prima in corporate e poi come datore di lavoro (perchè la corporate alla lunga ti ammazza); non ho mai selezionato nè cercato un candidato su linkedin. Quello che faccio è pubblicare un annuncio per la posizione che mi interessa e valutare i cv che mi arrivano. Ai candidati che riportano nel cv le competenze che cerco, somministro un test di valutazione tecnico (fondamentalmente chiedo di scrivere codice) e in base al risultato si passa al colloquio. Il problema sta qui, più del 90% dei candidati non passano un test base sulle competenze – e il codice è codice, non è una questione soggettiva ma proprio di scarsa preparazione nel merito. Insomma, per trovare lavoro ti serve la mail e la preparazione e se posso darti un consiglio, più che pensare a linkedin, pensa a studiare. Se vuoi un motivo in più per NON stare su linkedin (o su facebook, instagram e compagnia), dai pure un occhiata a questa infamata qui https://fama.io/product/ e pensa che il tuo essere presente, visibile, cercabile su queste piattaforme non fa altro che alimentare dinamiche di questo tipo che, per dirla alla romana, Orwell fermate proprio. E loro lo chiamano “social credit”.
Ti riporto la mia esperienza personale da utilizzatore di Linkedin per niente assiduo e non esperto, ma con un profilo compilato in ogni dettaglio e con 700 connessioni dirette, la stragrande maggioranza delle quali nel mio settore.
Ho aperto l’account nel lontano 2007.
Tutto il 2006, laureato da poco, l’avevo passato a lavorare gratis saltando di stage in stage, poi l’anno dopo mi sono messo a cercare un lavoro serio e ho aperto l’account.
In realtà quando l’ho aperto avevo già trovato lavoro… Tieni a mente questa cosa perché poi ci torno.
Per capire qualcosa di Linkedin occorre guardare come guadagnano i soldi: una parte del fatturato la ricavano dagli abbonamenti premium, una parte dagli annunci di lavoro a pagamento e una parte dalla pubblicità.
So, da un conoscente che ha lavorato per loro in UK, che il fatturato derivante da annunci a pagamento è frutto del lavoro di impiegati il cui obiettivo è quello di procacciare clienti. Per clienti intendo grosse aziende multinazionali, con cui Linkedin stipula contratti milionari per promuoverle e facilitarne le campagne di recruiting. Gli impiegati di Linkedin, oltre a guadagnare un botto di soldi, a fine anno si beccano pure il bonus in percentuale se hanno staccato contratti per un valore superiore al milione di sterline.
Il conoscente in questione, in pochi anni di lavoro si è comprato casa a Londra.
Questo solo per dare un’idea dei mucchi di denaro che girano per le mani di Linkedin…
Tornando a noi.
Io ho un account base, di quelli gratuiti, quindi sono consapevole del fatto che nel mio caso la merce sono io. Non mi risulta però che chi ha un account premium non riceva pubblicità e sicuramente anche i suoi dati vengono estratti per trasformarli in soldi. La differenza è solo che chi paga sblocca delle funzionalità precluse agli altri e ha dei servizi aggiuntivi che gli consentono di avere a disposione molti dati (altrimenti invisibili) sugli altri account e molta più facilità a connettersi con chiunque desiderino.
Inoltre è un mezzo centralizzato che fa delle tue informazioni tutto ciò che vuole (basta andare a leggersi le varie impostazioni di privacy, ads, etc per capire che in questo non differisce granché dai giganti della Silicon Valley).
Da un certo punto di vista però si può dire che fa esattamente quel che vuoi che faccia: in fondo se vuoi trovare un lavoro il fatto che le tue informazioni di curriculum siano pubblicate e diffuse è esattamente quello che vuoi. La tua profilatura non è uno scotto da pagare, è proprio quello che stai cercando. Perché gli annunci di lavoro che ricevi sono di aziende che cercano proprio uno del tuo settore e/o della tua zona.
Quindi se ti può aiutare a trovare un lavoro, perché non usarlo?
Questo è il motivo per cui non ho ancora cancellato il mio account.
Eppure è da un po’ che ci sto riflettendo, da quando è successo un episodio che ora ti racconto.
Voglio qui condividere quel che ho pensato a partire da allora, inizialmente solo di pancia e poi (anche grazie a questo blog) razionalizzato e capito con la zucca.
Circa due anni fa sono andato a un’inaugurazione per salutare un amico che si trovava lì. Amico che lavora negli Emirati per una grande azienda del mio settore. Per una serie di coincidenze, trovandomi nella sua cerchia di conoscenze, sono finto in una tipica serata business milanese in cui il proprietario di un’altra azienda del mio settore offriva una cena a una ventina di persone. Grande imbarazzo mio, che mi sentivo un imbucato… ma vabbè pagava lui ;)
A quella cena erano quasi tutti dei fottuti invasati aziendalisti, veneranti il dio della carriera e del successo.
Nel corso della serata tutti hanno parlato almeno una volta di Linkedin.
Alla fine il mio amico mi ha letteralmente rimproverato perché non sono attivo su Linkedin.
Secondo lui io dovrei prodigarmi a scrivere numerosi post su tematiche legate al mio lavoro, dovrei commentare, dovrei linkare articoli, dovrei scrivere aggiornamenti su quello che faccio.
Lui, che lo fa constantemente, sostiene di aver costruito grazie a ciò delle relazioni che hanno portato alla sua azienda (nota bene *non a lui* personalmente, anche se a lui così pare) una marea di lavoro e di soldi.
Da questo episodio ho capito alcune cose:
1- Linkedin serve alle aziende, a chi offre lavoro, o cerca fornitori. *Non* ai lavoratori o a chi cerca clienti.
2- Io sono un lavoratore autonomo, e in 13 anni di Linkedin non ho mai portato a casa un solo cliente grazie a quel canale.
3- Negli ultimi anni (non saprei dire quanti), piano piano Linkedin ha aggiunto una serie di features che lo hanno reso sempre più simile a un social ricreativo.
4- La facebookizzazione di linkedin ha portato al suo interno un diabolico meccanismo di gamification, che ti induce a produrre una quantità enorme di contenuti, pena il non essere cagati da nessuno e perdere occasioni di contatto e di lavoro.
5- In questo senso linkedin si potrebbe ridefinire come una piattaforma di PR aziendale: chi più si vanta del proprio lavoro e della propria carriera riceve più ascolto.
Ricordi la cosa che ho scritto all’inizio?
Quando ho aperto l’account, il lavoro l’avevo già trovato. Sai come? Avevo mandato delle lettere e delle email a chi mi interessava. Perché il lavoro si trova ancora così.
Poi nel 2010 mi sono messo in proprio e come ho detto, nonostante le mie connessioni siano tutte inerenti al mio ambito lavorativo, non ho mai trovato un cliente grazie a Linkedin.
Ho capito adesso che la ragione è semplice: non sono mai stato al gioco della gamification di questo social. L’ho sempre voluto considerare solo un cv online.
Concludendo, sii consapevole che se lo usi come lo uso io non ti serve letteralmente a un cazzo.
E che se vuoi trarne un vantaggio reale è possibile, ma devi vendergli tempo e anima e diventare come quegli invasati cocainomani workaholic che ho conosciuto quella sera.
Fai te.
Che poi volendo uno potrebbe benissimo aprirsi un blogghetto o una semplice pagina web a scopo lavorativo e inserirci tutte le informazioni che inserirebbe su linkedin. Una pagina-cv, con la stessa libertà di inserire contenuti di ogni tipo.
Se qualcuno è interessato a sapere tutto di te in ambito lavorativo, puoi sempre mandargli il link al tuo blog e fine del cinema.
Quando si compilano i form online per inviare la propria candidatura alle aziende, molte ti danno la possibilità di inserirvi il link al profilo Linkedin. Ma tendenzialemente trovi anche il modo di metterci il link alla tua pagina personale, per cui…
Grazie Angelo dello spunto. Alla fine mi hai indotto a ragionarci meglio e mi sa che quasi quasi mi delinkedinizzo :)
so che forse un messaggio per ringraziare soltanto rischia di essere solo rumore bianco. Tuttavia, gli spunti e le riflessioni che avete scritto mi sono molto preziose, e per questo, appunto, vi ringrazio. Riuscire a compiere delle sintesi tramite una ‘chat’ non mi capita spesso: su temi così spinosi ancor meno.
A proposito di degooglizzazione: Bruce Hahne, ingegnere e manager presso Google, si è dimesso dall’azienda con una dettagliata lettera aperta e l’avvio di una campagna rivolta tanto agli altri lavoratori di Alphabet quanto all’utenza. L’accusa, documentata, è di complicità nel disastro climatico e nel business dela guerra. Per capirci, il precedente storico che cita è il ruolo che ebbe l’IBM nello sterminio nazista. Parla anche delle ritorsioni contro dipendenti gay e transgender, licenziat* per il loro attivismo dentro l’azienda.
[…] [Attenzione: nel maggio 2018 Storify ha chiuso, cancellando tutti i post. La rassegna di episodi non poteva essere archiviata via Wayback Machine per un problema tecnico. Dal dicembre 2020, il sunto più completo dell’inchiesta si trova qui.] […]
[…] in azioni. Poi, da più parti, altre idee molto simili si sono fatte concrete: penso alla riflessione dei Wu Ming sullo stare in rete (e soprattutto alla discussione che è nata da quell’intervento), penso alle cose scritte da […]
Leonardo Tondelli, Twitter e noi. Su una questione né minuscola né maiuscola
Il blogger Leonardo Tondelli ha scritto un post su di noi, su Twitter, su uno scambio che avemmo con lui due anni fa, su tante cose. È qui.
Leggerlo è stata un’esperienza (quest’aggettivo ritornerà) sgradevole, ma a suo modo utile. Se può far sì che una questione smetta di avere strascichi e causare malessere, ben venga.
Quella che segue è la mia risposta, l’ho lasciata anche come commento di là, benché non sia ancora apparsa. Buona lettura.
—-
Ciao Leonardo,
prima di arrivare al punto, solo per completezza:
in quella discussione – della quale, mea culpa, io mi ero totalmente dimenticato e ho dovuto rileggere da cima a fondo – dopo i tweet che hai estrapolato facendone gli screenshot, noi chiarimmo più volte che senso avevamo voluto dare alla sgradevole iperbole:
«Veramente no, è una dimostrazione per assurdo che stai approcciando il metodo storico al contrario […]
Qui non stiamo parlando della tua vita privata, o meglio, l’unico ad averne parlato sei stato tu, poco fa. L’esempio è volutamente estremo perché è una dimostrazione per assurdo. Come si diceva, stai approcciando il metodo storico al contrario […] io ho ricalcato pari pari il tuo “ragionamento” sull’indimostrabilità della falsità di un’asserzione e sull’inanità delle ricerche in archivio.»
Dopo i tweet che hai estrapolato, peraltro, la discussione tra te e noi proseguì, quel thread andò avanti, e sul punto che stavamo dibattendo:
https://nitter.net/Wu_Ming_Foundt/status/950125498964865026
Sul punto che stavamo dibattendo, non su una tua presunta pedofilia, della quale non ti abbiamo mai accusato, né minacciato di accusarti. Non lo abbiamo fatto, e davvero sfido chiunque a provarlo, ma dopo aver letto l’intera discussione.
Discussione che sicuramente fu penosa per tutti (ci arrivo) e improduttiva, ma altrettanto sicuramente non conteneva minacce da parte nostra.
Tra l’altro, sai bene quanto ci siamo spesi, che campagne di demistificazione e controinchiesta abbiamo fatto riguardo a montature giornalistiche e giudiziarie nate dal “moral panic” sulla pedofilia.
Ora vengo al punto: tu ti sei sentito colpito sul piano personale da quei tweet, e due anni dopo li riproponi per commentare il nostro abbandono di Twitter (avvenuto quasi sette mesi fa).
Nel farlo dici, in sostanza, che tra le motivazioni che abbiamo spiegato non ce n’è una: che Twitter rende peggiori.
Ebbene, in realtà ne «L’amore è fortissimo, il corpo no» quella motivazione c’è. C’è eccome, e non è nemmeno ristretta a Twitter, ma è estesa a tutti i social commerciali. E ci siamo anche sforzati di spiegare nel dettaglio su cosa la fondiamo.
Abbiamo detto che ce ne siamo andati da Twitter soprattutto perché non eravamo più bravi a farne uso, perdevamo colpi, eravamo sull’orlo del burn-out. Dovrebbe essere abbastanza intelligibile, come quadro.
Ma il fulcro della questione è che, ribadisco, tu ti sei sentito colpito sul piano personale da quel tweet.
Noi ti spiegammo che il piano non era personale, che era un’iperbole, un esempio volutamente eccessivo per far capire in modo plastico che errore logico ti stavamo imputando. Tu comunque ti sentivi e tuttora ti senti colpito, e leso, sul piano personale.
A distanza di due anni, posso ribadirti, a nome mio e della band, che non era personale.
Però è vero che quella discussione la conducemmo tutti male, e in quel contesto fallato in partenza quell’esempio «cadde male». Nessun problema ad ammetterlo.
Di chi è colpa se cadde male? Di noi che stavamo discutendo?
In parte sì, in diverse proporzioni.
Ma secondo me, secondo noi WM, era colpa soprattutto del mezzo.
Abbiamo provato a spiegarlo nella seconda puntata del nostro post d’addio: a un certo punto Twitter smise di essere «estroflesso». Twitter ha fatto di tutto, algoritmicamente parlando, affinché noi e te, invece che uscire dalla sua cornice e magari discutere sui nostri blog, rimanessimo a discutere direttamente là sopra.
Cioè in un ambito dove discutere senza equivoci e degenerazioni era difficilissimo.
Noi addirittura, da un certo momento in avanti, lo abbiamo trovato impossibile.
Ogni discussione generava malintesi a cascata, e non credo fosse solo colpa nostra.
Infatti lo vedevamo succedere anche in discussioni a cui non prendevamo parte.
Non mi dilungo oltre, ci abbiamo scritto sopra un lungo testo, che del resto hai linkato anche tu.
Ora, io capisco il groppo che non andava né su né giù, lo capisco davvero, non è una concessione retorica.
Tuttavia, io ti dico:
avendo visto che noi stessi avevamo fatto autocritica a largo raggio sul nostro uso di Twitter, con una confessione in pubblico che è stata anche faticosa e dolorosa;
avendo visto che non usavamo più quel mezzo da mesi;
avendo visto che avevamo dimostrato (basta vedere la lunga discussione in calce) la nostra disponibilità a confrontarci con chi negli anni aveva interagito con noi su quella piattaforma…
Avendo visto tutto questo, avresti potuto scriverci direttamente su Giap, o via email, o in un altro modo che non fosse questo.
Purtroppo la modalità che hai scelto ha innescato il solito linciaggio da parte di chi quella discussione di due anni fa nemmeno l’ha letta: «i wuminkia minacciano la gente» ,«terroristi», «mafiosi» e quant’altro. Con annessi tentativi di ritrascinarci in un mondo, in un contesto malato di messe alla gogna, in un intrico di flame, che abbiamo abbandonato e nel quale siamo determinati a non rientrare mai più.
Detto questo, inutile piangere sul latte versato. A noi di Twitter non frega più niente, figuriamoci se ci frega di difendere un tweet di due anni fa che faceva parte di una discussione che non portò a nulla.
Quel tweet lo cancelleremo. Per farlo faremo login su Twitter per la prima volta dopo mesi, e sinceramente spero che sia anche l’ultima, provo solo disgusto per quel mezzo e retrospettivamente provo solo tristezza per il ritardo con cui abbiamo deciso di andarcene. Avremmo dovuto farlo molto prima, e se l’avessimo fatto non ci sarebbe stata nemmeno quella discussione con te.
Quel tweet lo cancelleremo, e speriamo che dopo tu ti senta meglio, che quel groppo vada finalmente giù, che il rapporto tra noi e te torni limpido, senza non-detti.
Resta il rammarico per la modalità scelta: con il post qui sopra non ti sei rivolto a noi ma hai agitato un fantoccio, hai attaccato un’*idea* spaventapasseresca di Wu Ming, quella che aizza i nostri detrattori seriali e patologici.
Forse se avessi riflettuto un po’ di più sulla scelta che nel frattempo avevamo fatto e su come l’avevamo comunicata, ti saresti mosso in altra maniera.
Ad ogni modo, per noi pace. Poi vedi tu.
Quando vuoi commentare su Giap, visto che di esperienza di social e di comunicazione in rete ne hai, il tuo contributo sarà utile e tu sarai il benvenuto.
P.S. Il tweet estrapolato non era autosufficiente: concludeva un dittico, che riporto qui intero, per far vedere che, lungi dall’essere una minaccia, era un esempio per absurdum. L’esempio di fallacia logica che Bertand Russell illustrò con l’immagine della teiera in orbita tra Marte e la Terra.
[…] Vorrei fare anche un accenno all’argomento internet. Fisher cita un’intervista al documentarista Curtis che attacca i nuovi media perché creano reti interpassive e bolle in cui ci si ritrova tra individui simili in cui si ripete il bias di conferma, creando ed alimentando continuamente circuiti chiusi. Nel riconoscere la sensatezza di tale analisi Fisher risponde però distinguendo: “un fenomeno come i blog è stato ad esempio capace di generare un discorso nuovo e articolato in una rete che non ha corrispettivi nel campo sociale esterno al cyberspazio. Nel momento in cui i vecchi media vengono sempre più assorbita dalla logica delle public relations e in cui al saggio critico si preferisce la relazione sui consumi, alcune aree del cyberspazio hanno offerto una resistenza a quella compressione critica che altrove è diventata dominante”. Le osservazioni di Fisher si riferiscono ad un periodo che potremmo considerare d’oro per i blog, e Fisher stesso dal 2003 curò un blog, K-punk, che divenne un punto di riferimento di una certa area. Ad oggi i blog hanno avuto sicuramente un arretramento con l’esplosione dei nuovi social media e della loro pervasività. C’è però la speranza e da alcune parti la voglia di restituire centralità ai blog perché il loro potenziale non è affatto esaurito. Come dicevano i Wu Ming in un bellissimo post a fine 2019 annunciando l’abbandono di Twitter: […]