
[Sono trascorsi due mesi e mezzo da quando i giornali hanno dato la notizia del primo morto italiano per coronavirus, interrompendo la lunga serie di titoli dedicati a Renzi e alle liti di governo.
«Virus, il Nord nella paura», tuonava la prima pagina di Repubblica del 22 febbraio.
Da quel momento, i media italiani a reti unificate e la retorica dei governanti non hanno più smesso di ingigantire quella paura, di trasformarla in terrore, e soprattutto di renderla nociva.
Abbiamo a lungo ragionato sugli effetti e gli scopi di questa manipolazione delle nostre fobie, ma ancora non ci siamo soffermati a sufficienza sull’ipotesi che quei timori – ben comprensibili di fronte a una pandemia – siano diventati a loro volta un morbo, una patologia che s’è aggiunta al Covid19, abbassando le difese immunitarie della popolazione e rendendo il contagio più grave.
In svariati commenti ai post di queste settimane è emersa l’idea che l’esercito in strada, i toni dei ministri, la scelta e la presentazione dei dati, le homepage dei giornali abbiano contribuito a farci – letteralmente – ammalare di paura.
Questo articolo, scritto appositamente per Giap, affronta la questione dal punto di vista dell’antropologia medica e dello studio scientifico sull’effetto placebo e il suo contrario: l’effetto nocebo. WM]
di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni *
[Deutsche Übersetzung hier.]
0. Il Covid-19 come macchina di visione
La migliore filosofia della nostra epoca lo insegna da anni: la grande partizione fra natura e cultura, fra regno dell’oggettività e regno dei desideri, non è che un costrutto moderno. Nell’impero del rilevamento e dei big data lo abbiamo (ri)scoperto a nostro danno: i fatti neutri non esistono; nessun dato è semplicemente “dato”, ogni dato è l’esito di una scelta osservativa, di un’interpretazione, di un’intenzione, di una politica. Non c’è visione del mondo che non sia frutto del convenire degli sguardi, delle attitudini, delle scelte consapevoli e inconsapevoli di una comunità; e non c’è cultura condivisa da un gruppo che non operi delle semplificazioni perché, come insegnano le scienze fisiche, il reale è troppo complesso per essere afferrato a partire da una sola prospettiva.
Finché tali semplificazioni non sono eccessive, quel mondo resta vivibile; se lo diventano, e non sono più in grado di “reggere” all’impatto dell’esperienza, si arriva a quella che Ernesto de Martino chiamava «apocalisse culturale», un soprassalto del reale che scompagina il quadro condiviso e mette a rischio la tenuta di quel mondo. Quando ciò accade, quel che si rivela non è il reale nella sua oggettività primigenia, ma una sorta di “buio epistemologico”, nel quale occorre navigare a vista con strumenti antichi.

Ernesto De Martino
È quanto possiamo osservare nell’emergenza Covid-19, vera e propria “macchina di visione” in grado di strapparci al sonno delle nostre convinzioni e rimetterci di fronte alla complessità del reale. Nella più grande crisi pandemica del dopoguerra, non abbiamo dati affidabili né sul numero di infettati, né sul numero di morti, né sugli effetti delle diverse misure di contenimento, né su quel che si prospetta per il prossimo futuro.
Prevedibile, in circostanze siffatte, una sorta di «nostalgia del semplice», il tentativo di spiegare un universo complesso in base a poche ipotesi elementari. Complottismo e letture paranoiche trovano qui la loro radice, come anche i richiami alla Scienza – e cioè allo scientismo – di raffinati intellettuali che, fino a ieri, si atteggiavano a pensatori critici. Hic Rhodus, hic salta: ora più che mai bisogna riaffermare che la realtà è enormemente complessa e può essere – parzialmente – afferrata solo attraverso un pensiero complesso. Attorno a questo nodo si giocheranno le possibilità di uscita intelligente dalla crisi; e, d’altro canto, la semplificazione della complessità è, da sempre, operazione reazionaria di dominio sulle coscienze.
Ottime analisi critiche della pandemia in corso, delle politiche di contenimento e dei loro effetti sociali sono già disponibili in rete e ad esse rimandiamo per la descrizione del campo critico all’interno del quale ci muoviamo, dai post pubblicati in questo blog agli interventi di Roberto Beneduce e del Collectif Malgré Tout. Il quadro che questi testi compongono è giustamente incompleto, non lineare, difficile da tenere insieme con uno sguardo solo e poco suscettibile al riduzionismo. Prospetta un intreccio di fattori causali, nessuno dei quali è sufficiente, da solo, a render conto dei fatti: vi si mescolano la ricerca microbiologica sul virus, i dati epidemiologici, le politiche di contenimento, le politiche nazionali, le rese dei conti fra capitale e lavoro salariato, lo sconcerto della popolazione, gli effetti di quarant’anni di neoliberismo sulle strutture della sanità pubblica e, più ampiamente, sulle catene biotiche ed ecologiche a livello mondiale, i livelli d’inquinamento, le scelte amministrative e politiche.
Qui vorremmo aggiungere solo un’ipotesi collaterale che, pur non modificando nella sostanza il quadro di riferimento, lo approfondisce in una direzione eterodossa. Alcuni dei bocconi che metteremo sul piatto sono amari: prima di presentarli, proponiamo quattro passaggi che delineano il contesto teorico nel quale l’ipotesi prende corpo e che la giustifica. Sappiamo, così facendo, di chiedere ai lettori uno sforzo di attenzione difficile in tempi concitati ed emergenziali come quelli che stiamo vivendo, ma indispensabile per restare nella complessità.
1. Primo passaggio. Breaking news dalle scienze della vita
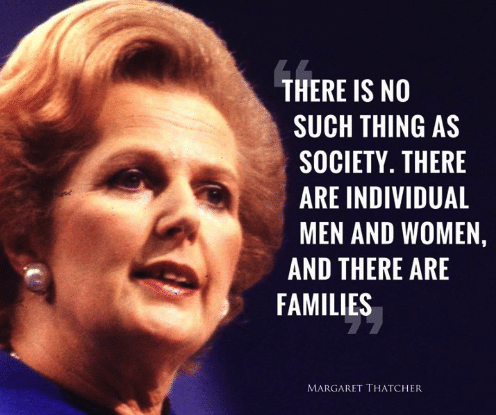 Entrambe lavoriamo da molti anni nella zona di confluenza fra antropologia medica, etnologia, etnopsicologia e geopolitica clinica e impieghiamo, nella lettura dei fenomeni, la teoria antropologica secondo cui gli umani sono frutto della loro storia. Niente di nuovo, per carità; ma dopo settant’anni di riduzionismo genetico, biologico ed ecologico e di enfasi neoliberista sull’individuo (Do you remember «there is no such thing as society»?), le prospettive che si aprono nel pensare gli umani come prodotti del loro tempo e delle circostanze che hanno attraversato sono davvero liberatorie.
Entrambe lavoriamo da molti anni nella zona di confluenza fra antropologia medica, etnologia, etnopsicologia e geopolitica clinica e impieghiamo, nella lettura dei fenomeni, la teoria antropologica secondo cui gli umani sono frutto della loro storia. Niente di nuovo, per carità; ma dopo settant’anni di riduzionismo genetico, biologico ed ecologico e di enfasi neoliberista sull’individuo (Do you remember «there is no such thing as society»?), le prospettive che si aprono nel pensare gli umani come prodotti del loro tempo e delle circostanze che hanno attraversato sono davvero liberatorie.
Non si tratta solo di wishful thinking da umanisti: tutta la ricerca genetica, evolutiva ed eto-ecologica degli ultimi vent’anni muove in questa direzione e indica che non solo gli umani, ma tutti i viventi sono enti molto più complessi di quel che pensavamo fino a poco tempo fa. Non derivano dallo sviluppo di un programma predefinito a livello di geni, ma sono l’esito di un’interazione continua e profondissima con l’ambiente, il paesaggio, i conspecifici, gli altri viventi.
Nel caso degli umani, questo significa che il tempo-spazio culturale nel quale prendiamo forma ci plasma secondo linee specifiche non solo in ciò che pensiamo, ma fin dentro le cellule, in un processo di vera e propria plasmazione bioculturale. Detto altrimenti, sono le ricerche scientifiche stesse, in questi anni, a mettere in discussione l’antica partizione cartesiana fra un corpo materiale, meccanico e oggettivo e una psiche immateriale: a ogni livello, i soggetti umani incorporano il loro mondo. La loro tenuta dipende dunque da una certa congruenza con il loro mondo e le transizioni richiedono tempo, sensibilità e intelligenza.
2. Secondo passaggio. Fra antropologia medica ed etnopsichiatria
Fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, in parallelo con l’ultima grande stagione di lotte politiche, l’antropologia medica ha avuto una fioritura magnifica. Nata per studiare i sistemi terapeutici tradizionali e usata tatticamente per far capire agli “altri” – ai non occidentali o, se si preferisce, ai colonizzati – la superiorità della nostra medicina, alla fine della sua traiettoria essa è arrivata a interpretare anche la biomedicina come un sistema terapeutico tradizionale (quello della modernità industriale) e ha elaborato quadri epistemologici raffinati per leggere in modo complesso la salute, le malattie, la costruzione delle nosologie, le pratiche semeiotiche, l’efficacia, la compliance e via dicendo.
Si è notato, per cominciare, che l’idea e i modi della salute sono variabili e dipendono in via diretta dalla cosmovisione nella quale trovano posto. Non dappertutto la salute è intesa come “silenzio degli organi” o come “stato di benessere fisico, psichico e mentale”: altri mondi umani la intendono come equilibrio, oppure come flusso, o come giusta posizione rispetto agli assi cosmici o ancora come buona tenuta dei rapporti.
Nel frattempo la psichiatria transculturale, e in modo ancor più deciso l’etnopsichiatria, mettevano in discussione i manuali diagnostici degli psichiatri e teorizzavano che ogni gruppo umano impazzisce in modo specifico, sia mettendo in forma la sofferenza mentale in maniere differenti, sia predisponendo piste di crisi del tutto particolari e altrove sconosciute. Allo stesso modo, l’antropologia medica ha ipotizzato che ogni cultura plasmi non solo l’ideale di salute, ma anche i modi e le piste lungo le quali è possibile ammalarsi.
Arriviamo così al primo boccone difficile: in un quadro concettuale antropologicamente avvertito, neanche la malattia è qualcosa di dato e di universale, anch’essa è il prodotto di una storia in cui diversi fattori interagiscono in modi complessi. Le relazioni fra umani e ambiente; il clima; il tipo di cibo disponibile; la distribuzione del potere e delle risorse; il rapporto con la vita e con la morte; le pratiche igieniche e rituali; la definizione di salute e le tecniche per mantenerla; le descrizioni delle malattie; le tecniche di cura: tutto questo, e molto altro ancora, influisce sui modi in cui ci ammaliamo e sulle vie possibili per la guarigione.
3. Terzo passaggio. Cosmovisione, credenza, placebo, nocebo.

Robert A. Hahn
Nel 1983 Robert Hahn e Arthur Kleinman pubblicano sul prestigioso Medical Anthropology Quarterly un breve articolo sugli effetti della credenza. Nel richiamare fenomeni “etnologici” che cominciavano a essere riconosciuti anche dentro i nostri confini (le guarigioni per fede, l’effetto placebo/nocebo, l’efficacia simbolica ecc.), gli autori aprono senza mezzi termini:
«Le credenze uccidono; le credenze guariscono. Ciò che una persona crede all’interno di una società gioca un ruolo significativo tanto nel produrre malattia quanto come rimedio» (p. 3).
Nei decenni seguenti, Kleinman diventerà una delle massime autorità della psichiatria transculturale e Hahn, coordinatore di un centro di controllo e prevenzione delle malattie, approfondirà le sue ricerche sull’effetto nocebo. L’anno di pubblicazione rimanda agli ultimi scampoli di un periodo in cui, anche nella ricerca scientifica, era possibile inseguire ipotesi eterodosse:
«La portata di queste credenze come causa di malattie e come cura è la stessa dei microorganismi e dei farmaci: date determinate condizioni dell’organismo ospite e dell’ambiente, patologia o guarigione dipendono in modo consistente dalla credenza» (p. 3).
La loro tesi è sostenuta dalla letteratura etnologica, dalle loro stesse osservazioni e dalla ricchezza del sottofondo teorico emerso, in occidente, da due decenni di lotte, resistenze e sperimentazioni. In seguito le ricerche, i dati e gli esperimenti sull’effetto placebo si moltiplicheranno, confermando sostanzialmente le ipotesi dei due autori, ma le interpretazioni pubbliche resteranno sempre molto caute, come se vi fosse, nella stessa possibilità dell’effetto placebo/nocebo, qualcosa di troppo scandaloso per poter essere detto ad alta voce.
In effetti, ci sono antichi equivoci da sciogliere. Il primo dipende dalla nostra propensione ideologica all’estremismo: sostenere l’efficacia di ciò che è immateriale non significa negare l’efficacia di ciò che è materiale:
«È improbabile che la credenza nelle virtù terapeutiche dell’arsenico in dosi massicce trasformi questa sostanza chimica in un agente di guarigione; nondimeno suggeriamo – anche se non proveremo a dimostrarlo – che una simile credenza ne ridurrebbe l’effetto tossico. Allo stesso modo, l’assenza di fede negli antibiotici può diminuirne la potenza, e la fiducia o lo scetticismo circa pratiche o materie “farmacologicamente inerti” può indirizzarne l’effetto nella direzione attesa» (p. 18).

Il bel René
Il secondo equivoco viene dalla permanenza del modello cartesiano, cioè dalla separazione tra psiche e materia: in questo dualismo, l’effetto placebo/nocebo risulta “magico” nel senso deteriore di «pensiero magico», plagio o superstizione («se penso che guarirò, guarirò», «se un gatto nero mi attraverserà la strada, l’auto sbanderà»).
Per contro, il paradigma antropologico della plasmazione bioculturale richiede un’ontologia non cartesiana:
«Gli eventi umani non sono solo o mentali o fisici, per cui non ci si può chiedere come gli eventi mentali causino eventi fisici e viceversa. Semmai, tutti gli eventi umani hanno aspetti fisici e aspetti mentali (e altri aspetti ancora: chimici, fisiologici, consci, inconsci ecc.). La mente è incorporata, il corpo è consapevole. Reciprocamente, quando parliamo di “stati mentali” (credenze o aspettative, speranzose o spaventate), ci sono dei correlati fisiologici di questi stati» (p. 18).
Gli assunti fondamentali di una collettività si fanno corpo, cellule, fisiologia, neurologia; non di verità astratte o di pensieri disincarnati viviamo e moriamo, ma della nostra intima, radicale congruenza a un mondo.
4. Quarto passaggio. Nocebo vortex.
L’ultimo passaggio va a ritroso: comincia da un lungo articolo di Robert Hahn sull’effetto nocebo, pubblicato nel 1999, e termina con il celebre articolo di Walter Cannon sulle morti per choc, pubblicato nel 1942.
Dopo aver definito l’ipotesi nocebo come il fatto che «aspettarsi la malattia aumenta la probabilità che la malattia attesa si presenti» (p. 335), Hahn procede a una rassegna della letteratura scientifica disponibile e illustra diverse forme dell’effetto nocebo, di cui qui proponiamo solo un riassunto con qualche esempio.
C’è, per cominciare, lo sviluppo dei sintomi negativi attesi. In un esperimento viene detto a un gruppo di studenti che la somministrazione di una scossa elettrica causa mal di testa; sebbene la scossa non venga materialmente applicata, nelle ore seguenti il 70% di loro riporta il sintomo atteso. Certe allergie e la nausea anticipatoria dei pazienti in chemioterapia si possono ascrivere a un effetto di questo genere. Lo sviluppo sintomatico può avvenire anche osservando le reazioni di altri: si parla, in questo caso, di malattia sociogenica – un esempio di timbro leggero: il «colpo d’aria» è una malattia etnospecifica italiana, sconosciuta oltralpe e di cui i francesi ridono molto.
In assenza di eventi o comunicazioni specifiche, le convinzioni influenzano gli esiti: il timore di essere affetto da una malattia cardiaca aumenta il rischio di attacco ischemico; analogamente, gli stati depressivi – ovvero un senso generalizzato di impotenza – aumentano la probabilità di morte a seguito di eventi ischemici, a riprova del fatto che l’effetto nocebo non è affatto una “fisima” psicologica e i suoi effetti sono del tutto reali. Le cosiddette «morti voodoo», che si verificano a seguito dell’induzione di uno stato pervasivo di terrore, testimoniano a sufficienza gli effetti, tragicamente reali, del fenomeno.

L’autore tratta poi gli episodi di panico collettivo in cui interi gruppi di persone sviluppano sintomi in relazione a cause organiche dubbie o provate come inesistenti – ad esempio, in relazione a uno strano odore percepito nell’aria, che viene imputato al diffondersi di sostanze tossiche, o a morsi d’insetto normalmente innocui. In questi casi, lo sviluppo dei sintomi è, per così dire, “corale”: al diffondersi dell’allarme, i segni attesi vengono manifestati da un’alta percentuale dei soggetti coinvolti.
Si può quindi escludere che l’effetto nocebo colpisca solo soggetti psico-emotivamente fragili o inclini alla crisi: esso può manifestarsi globalmente su un’intera popolazione esposta a una circostanza percepita o descritta come rischiosa. L’analisi comparata di questo genere di episodi evidenzia diversi fatti notevoli: essi tendono a verificarsi in luoghi dove le persone sono assembrate in gran numero (scuole, fabbriche, città); coinvolgono prevalentemente le classi socioeconomiche più fragili o precarie; e aumentano nei periodi di maggior stress sociale ed economico. La strutturazione sociale gioca dunque un ruolo chiave nella diffusione e nella pericolosità degli eventi.

Walter B. Cannon
Questa riflessione può essere ampliata fino a toccare una delle zone più critiche e delicate dell’esistenza umana:
«Il fenomeno nocebo è un effetto collaterale della cultura umana. Esso suggerisce che le categorie etnomediche di una certa società non solo descrivono le condizioni di malattia che si reputano esistenti, ma possono anche indurre tali condizioni inducendo l’aspettativa che esse si presenteranno. […] In questo modo, un sistema culturale che si ritiene solitamente essere al servizio della funzione di guarigione, può anche avere un effetto collaterale paradossale e indurre quelle stesse patologie che cerca di prevenire o di curare» (p. 350).
Si parla infatti, in antropologia medica e in etnopsichiatria, di funzione patoplastica e funzione patogenetica delle culture.
La prima è, per così dire, il lato in sole del processo di plasmazione bioculturale: la capacità collettiva di dare forma alle malattie, di non lasciare la crisi nel disastro dell’insensatezza.
La seconda ne è la parte in ombra: ogni messa in forma è anche, inevitabilmente, un’induzione. In fin dei conti, questo significa che non c’è modo di evitare l’effetto nocebo, che nasce dal movimento stesso che rende possibile la terapia, nella zona in penombra della strutturazione culturale e dell’immaginario dove l’ambiguità è la regola. Anche così, però, c’è modo e modo di navigare nell’ambiguità che lega malattia, terapia, diagnosi, cura, placebo e nocebo: è possibile, ad esempio, che le culture in cui l’esistenza di quest’intreccio è ammessa e osservata si trovino in una posizione migliore per contenerne gli effetti.
Come molti autori successivi, Hahn precisa e conferma le celebri ipotesi avanzate da Cannon in anni di conflitto mondiale: rabbia e paura possono causare il tracollo dell’equilibrio neurovegetativo e questo può essere talmente grave da paralizzare le funzioni vitali e indurre la morte. È il caso delle cosiddette “morti voodoo”, lungamente descritte dagli etnologi, ma anche di molte osservazioni fatte da medici sui fronti di guerra: il terrore degli eventi e lo stress prolungato della situazione di guerra possono avere esiti letali anche in assenza di lesioni organiche.
5. Fra circensi e bravi padri di famiglia
L’attuale pandemia da coronavirus non può che interrogare chiunque si occupi di antropologia medica. Più nello specifico, ci sembra ineludibile una riflessione complessa sull’andamento differenziale dell’infettività e della mortalità nelle diverse nazioni colpite e, per l’Italia, nelle diverse regioni. Fermo restando che ipotesi epidemiologiche affidabili saranno possibili solo quando (e se) si arriverà a un computo realistico, e internazionalmente confrontabile, dei numeri, il caso italiano – e in particolare quello tremendo della Lombardia – manifestano una fenomenologia specifica nella quale conviene cominciare ad addentrarsi.
Arriviamo così all’ipotesi eziologica che vorremmo aggiungere alla spiegazione degli eventi. La enunciamo fin da subito, di modo che sia possibile tenerla presente lungo il resto dell’argomentazione: è possibile che la gestione della crisi operata all’intersezione fra politiche nazionali e locali e le strategie comunicative delle istituzioni pubbliche e dei grandi mezzi d’informazione abbiano innalzato il rischio di mortalità da Covid-19 anche – e sottolineiamo: anche – inducendo paura, panico e paranoia nella popolazione.
Cominciamo con un’analisi sommaria della trattazione mediatica dell’epidemia. Sulla dinamica dei grandi mezzi di comunicazione non vale la pena insistere: nel libero mercato dell’informazione vince chi riesce a catturare l’attenzione e poi a tenerla, ed è noto che la paura è un gancio eccellente. In Italia la copertura mediatica accordata al Covid-19 è stata, fin dall’inizio, spropositata, frenetica e allarmistica.
Per cominciare, c’è stato un convergere esclusivo e ossessivo su questo singolo tema. Alcuni ricorderanno la distanza abissale, nelle prime due settimane di marzo, fra quanto si leggeva sui giornali italiani e quanto proponevano invece le testate francesi, inglesi e tedesche – discrepanza che è stata causa di angosce bidirezionali: quella degli italiani all’estero, che sospettavano una minimizzazione del problema da parte delle nazioni ospitanti; e quella degli italiani in Italia, che sospettavano un’esagerazione del problema da parte del nostro governo. In questa fase, le celebrità dell’infosfera hanno fatto per intero la loro parte, allarmismo e negazionismo esasperati hanno occupato l’intero della scena pubblica e il premio della visibilità è andato a chi ha urlato più forte usando l’insulto in luogo delle argomentazioni.
 Subito dopo, in concomitanza con il rapido susseguirsi dei DPCM, immagini di medici in tuta spaziale che parevano tratte da B-movies hollywoodiani hanno invaso gli schermi, mentre il conteggio di morti e infettati diventava un macabro rituale quotidiano. All’indomani del primo sconcerto, la comunicazione ha imboccato con molta decisione una battente retorica di stampo bellico, punteggiata di richiami all’immaginario apocalittico che giace nell’inconscio sociale già da decenni.
Subito dopo, in concomitanza con il rapido susseguirsi dei DPCM, immagini di medici in tuta spaziale che parevano tratte da B-movies hollywoodiani hanno invaso gli schermi, mentre il conteggio di morti e infettati diventava un macabro rituale quotidiano. All’indomani del primo sconcerto, la comunicazione ha imboccato con molta decisione una battente retorica di stampo bellico, punteggiata di richiami all’immaginario apocalittico che giace nell’inconscio sociale già da decenni.
Anziché informare sulla situazione – e cioè esporre quel che è noto, ammettere ciò che non è noto e discutere delle diverse scelte possibili – le retoriche di guerra hanno compattato l’inconscio sociale intorno alle necessità straordinarie imposte dalla lotta senza quartiere contro un nemico invisibile, ubiquo e pericolosissimo.
Per sua parte, la politica italiana si è espressa, sia a livello regionale che a livello nazionale, nelle consuete forme paternalistiche e opportunistiche: ad esempio, nelle decisioni sull’uso delle strutture; nella scelta di non fare (o fare) i tamponi; nei comandi contraddittori sull’uso delle mascherine. Anziché coordinare le diverse competenze del settore pubblico per gestire la crisi nella maniera più efficiente e meno traumatica possibile, le scelte delle regioni e del governo hanno riverberato in modo feroce sulle possibilità operative dei medici e del personale sanitario, imbrigliando i loro interventi in funzione della convenienza politica e delle necessità elettorali di una schiera di “uomini forti”. La compensazione simbolica si è giocata sull’eroizzazione del personale sanitario, a tutto vantaggio del melò emotivo bellico-nazionalista.
Nella stessa direzione è andato anche il varo di misure di contenimento particolarmente vessatorie rispetto a quelle di altre nazioni. Ferma restando la necessità di rallentare il contagio e la difficoltà, in situazioni di buio epistemologico, di discernere fra ciò che è efficace e ciò che non lo è, le disposizioni italiane sono arrivate all’assurdo: divieto di uscire insieme per chi vive nella stessa casa; di passeggiare da soli nei parchi o nei boschi; di stare all’aria aperta; di far uscire i bambini; di fare la spesa fuori dal quartiere di residenza; di andare in spiaggia. Assurdità di dubbia tenuta costituzionale, che hanno criminalizzato gli affetti e le reti familiari e costretto alla clandestinità le realtà territoriali solidali, che garantivano la sopravvivenza alle fasce più deboli ed emarginate. E che, di conseguenza, potevano essere fatte rispettare solo autorizzando i controllori all’abuso.
Analogamente, alcune delle misure ipotizzate e ampiamente mediatizzate – lavare le strade con ammoniaca, lasciare la spesa fuori dalla porta di casa per giorni, disinfettare i vestiti con cui si esce – possono suonare ragionevoli solo in un progetto delirante, e dalle assonanze orribili, di igienizzazione del mondo.
La stampa, a ruota, ha preferito ammonire e rinforzare che spiegare e discutere criticamente. Come nota Osservamedia Sardegna,
«a fronte di limitazioni della libertà collettiva molto pesanti imposte per le politiche di contenimento dell’epidemia, le motivazioni scientifiche alla base dei provvedimenti sono state punto o poco spiegate, privilegiando una ossessiva ripetizione delle istruzioni da rispettare, esattamente come farebbe un adulto a un bambino. Questa impostazione paternalista e totalmente digiuna delle più elementari basi democratiche, continua a venire propagandata dagli attori legittimi in campo in questo momento a parlare dell’emergenza: esperti, politici e commentatori, ed ha assunto venature isteriche di massa nella sua diffusione sociale attraverso le piattaforme digitali» (p. 7).
Fino al caso di chi, come Barbara D’Urso, ha fatto audience mostrando cacce all’uomo con i droni e istigando il pubblico a dar corso a emozioni da Ku Klux Klan.

Qui troviamo un altro boccone amaro, quello delle emozioni politiche, il modo in cui il discorso pubblico dà forma, sostanza e durata a ciò che proviamo verso gruppi di “altri”: stranieri, migranti, membri di altre classi sociali, soggetti appartenenti a gruppi etnici o razzializzati, cittadini di nazioni nemiche ecc. In relazione all’epidemia di Covid-19, l’infosfera italiana ci ha mostrato non solo come avremmo dovuto comportarci, ma anche cosa dovevamo provare, generando emozioni, odî e polarizzazioni i cui effetti misureremo in tutta la loro portata solo all’uscita dall’emergenza.
6. Una fine del mondo in tonalità minore
Speciale attenzione meritano il distanziamento sociale, che vieta per legge il contatto con il prossimo, e il divieto di celebrare riti di qualsiasi genere.
Un’ampia varietà di ricerche psicologiche, etologiche ed endocrinologiche indicano che la mancanza di contatto fisico induce nei neonati sindromi che vanno dalla depressione al nanismo, fino a sfociare, nei casi più gravi, nella morte; e che la regolazione emotiva e fisiologica del nostro essere dipende dall’insieme delle nostre relazioni. Ed è noto che l’isolamento totale è, da sempre, un metodo di tortura impiegato nelle carceri. Anche concedendo che la capacità di tenuta degli adulti sia ben più tetragona di quella dei neonati, è indispensabile chiedersi a quali effetti psichici e fisici possa andare incontro un’intera popolazione sottoposta a un regime uniforme di isolamento.
I riti pubblici – lauree, matrimoni, battesimi, funerali – sono stati vietati tout court anche laddove sarebbe stato possibile farli in tutta sicurezza a ranghi ridotti. Particolarmente tragico, come altri ha fatto notare, la combinazione fra l’isolamento totale dei malati di Covid-19 negli ospedali e il divieto di salutarli una volta morti. Non c’è alcuna sicura ragione medica a fondamento di una norma così crudele, ma solo una scelta politica dettata dalla necessità di fare troppo dopo che si era fatto troppo poco. Se ora proiettiamo la situazione italiana sullo sfondo della letteratura antropologica, siamo costretti ad ammettere che si tratta di una congiuntura talmente gravi da mettere a rischio la tenuta stessa di un mondo – come, appunto, è successo in Lombardia.
L’apocalisse culturale descritta da de Martino arriva quando, a un gruppo umano nel suo insieme, non è possibile né mantenere gli istituti precedenti, né inventarne di nuovi – gli istituti più cruciali essendo quelli che regolano i momenti critici dell’esistenza: nascita, morte, passaggi di status. Quando la consuetudine è sovrascritta per decreto, quando gli istituti del vivere umano (quelli che ci fanno umani: v. prima parte di questo articolo) sono passibili di annullamento improvviso, quel che ne risulta è la crisi della presenza individuale e collettiva.
Proprio perché sono misure gravissime, distanziamento sociale e sospensione dei riti avrebbero dovuto essere trattati in tutt’altra maniera: si trattava di rendere meno traumatiche possibile misure che hanno comunque un portato destrutturante. Perché questo fosse possibile, tuttavia, si sarebbe dovuto attribuire agli italiani lo statuto di adulti in grado di valutare i rischi e di attenersi a comportamenti ragionevoli – ipotesi che, con ogni evidenza, non è quella del governo.
7. Atmosfear. Soggetti di terrore
Il prevedibile effetto di questa totalizzazione del discorso pubblico è stata dapprima la paralisi conoscitiva, una situazione temibile che richiama quel che succede nelle circostanze costruite apposta per de-umanizzare i soggetti tramite la dissociazione di parole e cose, di linguaggio e mondo. Subito dopo sono arrivati il bisogno di sicurezza e la necessità emotiva di aderire a una qualche interpretazione comune dei fatti e di azione collettiva. Bisogni umanissimi, in tempi di incertezza, che tuttavia non hanno prodotto (se non in settori ancora minoritari) aperture critiche e sguardi innovativi, e sui quali si è invece innestata di una forma particolarmente ripugnante di unità nazionale di stampo piagnucoloso, consolatorio e applaudente che ben merita la celebre definizione che ne diede Brecht.
 Un’ampia letteratura psicosociale indaga questi fenomeni; nel caso italiano, esso si esprime, tra l’altro, con la delazione dei vicini e con l’uso diffuso delle mascherine come testimonianza pubblica di adesione a una messinscena sociale che rassicura e permette di posizionarsi dal lato giusto della barriera che separa gli onesti e adempienti cittadini dai colpevoli untori.
Un’ampia letteratura psicosociale indaga questi fenomeni; nel caso italiano, esso si esprime, tra l’altro, con la delazione dei vicini e con l’uso diffuso delle mascherine come testimonianza pubblica di adesione a una messinscena sociale che rassicura e permette di posizionarsi dal lato giusto della barriera che separa gli onesti e adempienti cittadini dai colpevoli untori.
Gli esiti di questo clima nazionale non hanno tanto a che fare con le posizioni intellettuali dei singoli individui, quanto con un sentire diffuso mediaticamente indotto. Ferma restando non solo la sensatezza, ma la necessità di proteggersi e proteggere (specie nel caso delle fasce più a rischio), la questione è un’altra: come già visto nei peggiori decenni del Novecento, la possibilità di distanza critica sparisce, la perplessità è già tradimento.
È osservazione comune come, anche all’interno degli ambienti politicamente più attenti, sia necessario astenersi da osservazioni critiche in merito agli eventi pandemici per non rischiare riprovazione, scontri o rotture. Questa polarizzazione guerresca, insieme al bisogno emotivo di aderire alla logica del confinamento, è un sintomo.
In mezzo a tutto ciò, il terrore del virus domina pensieri e movimenti. Terrore, e non paura: come scriveva de Martino, fra la paura che induce a un’azione ponderata e il terrore di chi è dominato da un pensiero fisso passa una forma di alienazione psichica. E proprio qui sta il punto: quest’alienazione non è arrivata per caso, ma è il prodotto di scelte politiche e comunicative; è l’esito di un battage propriamente terroristico.
La via prescrittiva paternalista e poliziesca – #iorestoacasa, applausi alla finestra, in emergenza non si pensa ma si agisce, non c’è scelta, rinuncia a ogni diritto, procurati il lasciapassare, accetta ogni controllo da parte delle forze dell’ordine, lasciati tracciare – è una pista magistrale per il totalitarismo del pensiero. Inoltre, produce un circolo vizioso emotivo-cognitivo particolarmente perverso: non solo chi rompe le regole è passibile di punizione, ma rischia di morire, e di far morire, per le immediate conseguenze del suo stesso gesto. Una “colonia penale” che richiederebbe la penna di un novello Kafka.
Lo ripetiamo ancora una volta: in quest’articolo non è in discussione la pericolosità del Covid-19 né la necessità di misure straordinarie di contenimento, in particolare a fronte della scarsa tenuta del sistema sanitario. Ciò che è in discussione è la pericolosità dell’induzione di terrore da parte di chi è delegato alla gestione della cosa pubblica e all’informazione.
È poi notevole, in tutto ciò, come la manipolazione informativa induca scandalo per ogni morte direttamente ascrivibile a un fallimento dell’azione terapeutica (com’è appunto il caso del Covid-19, almeno nei casi che si è scelto di riconoscere come tali tramite ricorso al tampone), mentre lascia del tutto in ombra i numeri delle morti indirette dovute a fattori socio-ambientali – ad esempio quelle derivanti dall’inquinamento che in Italia, secondo Greenpeace, sono circa 56.000 all’anno.
È il trionfo della chiusura dell’individuo in se stesso e dell’atomizzazione: quel che dà senso al mondo e al vivere non sta nella relazione con altro e altri, nella condivisione di un ambiente comune, nel con-divenire, ma si gioca esclusivamente nell’interiorità dei soggetti.
La paura dell’altro, del contatto, del contagio, che già dilagava in un ampio settore della popolazione e si esprimeva in forme razziste e talvolta simil-fasciste, trova così piena e legittima espressione non più nei confronti di un particolare gruppo umano, ma nei confronti di chiunque altro. È una specie di “razzismo totale”, che esclude tutti e tutto dalla possibilità di una relazione umanamente sensata: in certe zone d’Italia i bambini indossano mascherine chirurgiche perfettamente inutili per andare a giocare nel giardino di casa.
Qui troviamo la chiusura propriamente totalitaria di un circuito perverso e pericolosissimo: tanto maggiore la paura dell’altro e il bisogno ossessivo di proteggersi dall’esposizione, tanto più ci si qualifica come bravi e obbedienti cittadini. È il circolo vizioso e psicopatologico nel quale molti, oggi, si trovano murati (ben descritto da questo video di Zerocalcare).
8. Dal terrore al rischio differenziale di morte
La violenza strutturale dei sistemi sociali causa malattia e morte: il fatto è talmente noto che non mette conto insistervi. A questo punto, tuttavia, ci si può porre un’altra domanda: è possibile che scelte di contenimento assurde e imposte con violenza, legittimazione della paranoia e induzione di terrore inneschino stati psicofisiologici che peggiorano la sintomatologia e predispongono a una maggiore gravità del fenomeno patologico, tanto nella popolazione in generale che, soprattutto, nella fascia di popolazione già soggetta a violenza strutturale?
Le ricerche presentate sopra autorizzano almeno la formulazione della questione. Se pure, da un certo punto di vista, il virus «non guarda in faccia nessuno», né la morbilità né la mortalità da coronavirus è altrettanto equamente distribuita fra le nazioni e fra le classi sociali. Non è difficile supporre che la gravità temuta dell’infezione da Covid-19 e le speranze sul suo decorso siano peggiori in chi vive in condizioni economiche ed esistenziali già precarie; e che la difficoltà di accesso alle cure (tanto quelle ospedaliere quanto quelle diffuse territoriali) sia un pesante fattore di aggravamento.
Nel caso dell’Italia, si può ipotizzare che la durezza delle politiche di contenimento e le scelte comunicative dei media abbiano avuto un ruolo nell’induzione di uno stato psicologico di angoscia e panico, con conseguenti effetti sul sistema immunitario e sulla possibilità di reazione al virus.
Il caso della Lombardia sembra esemplificare quanto detto nella maniera più tragica possibile. Ancora una volta, il quadro non sopporta semplificazioni: in un territorio relativamente piccolo e in un tempo relativamente breve si sono concentrati eventi e fattori di rischio in numero esorbitante, che “spiegano” qualcosa solo nel loro insieme.
Il primo fattore è la densità abitativa più alta d’Italia insieme a quella dalla Campania, con il Lazio terzo a larga distanza. Poi c’è la più alta densità di imprese e industrie sul territorio nazionale, a cui si accompagna l’usuale propensione del padronato al regolamento di conti col lavoro salariato. Un elemento cruciale è dato dall’elevatissimo inquinamento della pianura padana e dai suoi effetti avversi sull’apparato respiratorio e sulla salute generale. A ciò va sommato il modello sanitario della Regione Lombardia, basato sulla privatizzazione dei servizi e sulla messa a profitto della salute: fino a ieri cantato come esempio virtuoso da esportare, alla prova dei fatti si è rivelato non solo inadeguato, ma gravemente inadempiente.
A coronamento, un governo regionale passato in pochi giorni dalla negazione del problema (la partita calcistica Atalanta-Valencia, il ritardo nel chiudere il settore produttivo) al panico (l’utilizzo delle RSA come dispositivi di confino degli infettati, il maldestro tentativo di autoassolversi per decreto, e via dicendo).
Ora, quale reazione ci si può aspettare, se non il panico, da una popolazione esposta a scelte azzardate, al collasso del proprio sistema sanitario, martellata senza tregua dalla retorica apocalittica dai media, nel momento stesso in cui si vietano gesti tanto fondamentali per la tenuta psichica e collettiva come le relazioni familiari, le chiacchiere per strada e il saluto ai morti?
Si potrebbe allora ipotizzare che concause – sia pur minime – della mortalità lombarda siano state l’inquietudine e la paura di chi si è trovato a vivere una crisi terribile come la pandemia da coronavirus dovendosela cavare sostanzialmente da solo, sotto un intreccio di violenza strutturale, collasso del sistema sanitario, norme approssimative e/o vessatorie, paternalismo e terrore mediatico; uno stato di apprensione peggiorato dal progredire stesso della vicenda lombarda – ovvero dai primi catastrofici esiti delle politiche regionali.
Per tradurre questo sospetto in qualcosa di minimamente scientifico sarebbe necessario uno studio comparato sulla morbilità/mortalità del virus in diverse nazioni in relazione alle politiche di contenimento e allo stile comunicativo dei grandi mezzi di informazione – studio che sarà possibile solo fra diversi mesi e solo ammesso che si arrivi a una qualche forma di consenso sul computo dei morti. Nondimeno, se quest’ipotesi fosse anche solo parzialmente confermata, allora le escalation retoriche a cui abbiamo assistito, lo sfruttamento della paura a scopi spettacolari e le strategie comunicative degli “uomini forti” dovrebbero essere considerati con tutta la severità che si applica ai gesti carichi di conseguenze.
La società dello spettacolo è una forma di cattura integrale dei soggetti, che li costringe a vivere e morire secondo linee finora sottratte alla pubblica riflessione. La manipolazione emotiva in vista dello share o del voto non sono trucchi innocenti, ma veri e propri attacchi all’integrità dei soggetti esposti. I loro effetti andrebbero dunque aggiunti sul piatto delle molte responsabilità politiche già evidenti, accanto a quelle per la distruzione della sanità pubblica e dell’ambiente della pianura padana.
9. Costruire la possibilità della fiducia
All’inizio del lockdown, Giorgio Agamben ha scritto che la gestione di questa crisi ha aspetti che richiamano in modo inquietante gli spettri del totalitarismo. Il linciaggio morale che ne è seguito è stato un vero e proprio avvertimento pedagogico per chi nutre gli stessi timori: meglio tenerli per sé… Non è il caso quindi, in questa sede, di sprecare le parole o di usarle in modo leggero. Al momento è impossibile stabilire se le restrizioni a cui siamo sottoposti siano solo quelle momentaneamente utili al contenimento del virus – come tutti, ovviamente, speriamo – o se siano l’incipit di un precipitare delle nostre vite in forme estreme di isolamento e controllo. Lo scopriremo nei prossimi mesi. I timbri della comunicazione, l’asprezza delle norme, la difficoltà di articolare pubblicamente un discorso critico e il moltiplicarsi degli spettri nell’inconscio sociale non sono di buon auspicio.
Già da ora, tuttavia, si può prevedere che, se la piega fosse davvero di tipo totalitario, saremo in grado di opporci solo uscendo dalla paralisi del terrore indotto, rifiutando di barattare l’intero dell’esistenza – che, per sua natura, è avventuroso e comporta rischi – per un deserto perfettamente igienizzato e sperimentando nuove forme di socialità e di azione. Si rischia, una volta di più, la barbarie di una lotta giocata intorno al maggiore o minore timore della morte – ma potrebbe esserci un’altra possibilità.
Hahn terminava il suo articolo del 1999 con queste parole:
«Il fenomeno placebo-nocebo suggerisce che potrebbe essere più sano peccare di ottimismo» (p. 351).
È la direzione che suggeriscono tutte le migliori intelligenze critiche dei nostri anni: contrariamente a quanto prevede l’ontologia cartesiana, l’ingrediente cruciale nei processi più delicati – crescita, guarigione, creazione di gruppi, deliberazioni collettive ecc. – è la fiducia, la possibilità di affidarsi. E poiché la fiducia non è un dato di natura, essa va costruita, resa possibile. Non è semplice, dopo quarant’anni di neoliberismo – e quindi di scelte al ribasso, di darwinismo sociale, di ottundimento dell’immaginazione, di emergenze, di alternative infernali – ma la possibilità migliore che abbiamo è quella di riattivare intelligenza, sensibilità, coraggio e passioni gioiose.
Per farlo, bisogna uscire dalla cattura operata su di noi dalla “stregoneria capitalista” e ricominciare a immaginare altre prospettive di breve, medio e lungo termine. Si potrebbe cominciare in modo citoyenne, prevedendo che chi ha un potere differenziale sia consapevole e responsabile delle sue scelte così come di ciò che comunica e meta-comunica; che l’azione terapeutica sia liberata tanto dalle procedure protocollari come dall’esigenza di difendersi sul piano legale, e possa così tornare a occuparsi anche degli aspetti politici della salute; che alla dimensione relazionale dei soggetti sia restituita tutta la sua rilevanza.
Chi prospera sul terrore altrui, i cantori di passioni tristi e tutti gli ometti forti andrebbero accolti con le risate che meritano. Ma è chiaro che la possibilità stessa di muovere in questa direzione, di abitare un immaginario meno avvelenato, richiede anche un ripensamento globale degli assetti sociali, della nostra relazione con gli altri viventi e non viventi, di cosa vuol dire vivere bene. La scommessa sulla tenuta del nostro essere, su una certa felicità nonostante il rischio, sulla possibilità di una buona vita a cui si accompagni una buona morte è la via d’uscita dalla prigione mentale e fisica nella quale il terrore del virus rischia di confinarci.
Approfondimenti.
Una proposta di tre letture per ciascuno degli argomenti toccati nel post.
Sulla “grande partizione” che separa natura e cultura: [1] D. Haraway (1988), Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective, «Feminist Studies» 14, 3, pp. 575-599; [2] B. Latour (1991), Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, Eleuthera, Milano 2009; [3] I. Stengers (1994), La Grande partizione, «I Fogli di ORISS», n. 29-30 (2008), pp. 47-6.
Sul “buio epistemologico” e sugli strumenti per navigarlo: [1] M. Taussig (1987), Shamanism, Colonialism and the Wild Man: a Study in Terror and Healing, University of Chicago Press, Chicago; [2] E. Melandri (1968), La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, Quodlibet, Macerata 2004; [3] C. Ginzburg (1979), “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione, Einaudi, Torino 1979, pp. 57-106.
Sulla “costruzione degli umani”: [1] V. Despret (2001), Le emozioni. Etnopsicologia dell’autenticità, Elèuthera, Milano 2002; [2] T. Ingold & G. Palsson (2013), Biosocial becomings. Integrating social and biological anthropology, Cambridge University Press, Cambridge; [3] F. Remotti (2011), Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Roma-Bari.
Sull’antropologia medica e l’etnopsichiatria: [1] H.A. Baer, M. Singer & I. Susser (1997), Medical anthropology and the world system. A critical perspective. Bergin & Garvey, Westport (U.S.A.) and London; [2] P. Coppo (2003), Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria. Bollati Boringhieri, Torino 2003; [3] I. Quaranta I. ed. (2006), Antropologia medica. I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano.
Su credenza, placebo e nocebo: [1] W.B. Cannon (1942), “Voodoo” death, «American Anthropologist», New Series, 44 (2), pp. 169-181; [2] R. Hahn & A. Kleinmann (1983), Belief as pathogen, belief as medicine: “Voodoo death” and the “placebo phenomenon” in anthropological perspective, «Medical Anthropology Quarterly», 14 (4), 3+16-19; [3] R. Hahn (1999), “Expectations of sickness: concept and evidence of the nocebo phenomenon”, in I. Kirsch, How expectancies shape experience, American Psychological Association, Washington D.C. 1999, pp. 333-356.
Sulla violenza strutturale e le emozioni politiche: [1] M. Marmot (2004), The Status Syndrome. How Social Standing Affects Our Health and Longevity, Owl Books, New York; [2] F. Sironi (2007), Violenze collettive. Saggio di psicologia geopolitica clinica, Feltrinelli, Milano 2010; [3] R. Beneduce (2010), Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Roma-Bari 2010.
Sulla presa del capitalismo e la possibilità di costruire fiducia: [1] A. Tsing, H. Swanson, E. Gan & N. Bubandt (2017), Arts of living on a damaged planet. Ghosts of the anthropocene, The University of Minnesota Press, Minneapolis. [2] D. Greaber (2011), Revolutions in Reverse: Essays on Politics, Violence, Art, and Imagination, Minor Compositions / Autonomedia, New York 2011; [3] P. Bartolini & S. Consigliere (2019), Strumenti di cattura. Per una critica dell’immaginario tecno-capitalista, Jaca Book, Milano.
–
* Stefania Consigliere è ricercatrice all’università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di “prendere gli altri sul serio”. Altre informazioni e articoli su: www.stefaniaconsigliere.it.
Cristina Zavaroni, antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente per l’Associazione Mamre Onlus di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Nessun effetto placebo, questo articolo è una vera medicina dell’anima! Ringrazio le Autrici per il loro impegno sull’erta via della ragione delucidativa. Un aneddoto personale-coda di pavone: il primo libro che ho letto in inglese è stato Patterns of Culture di Ruth Benedict.
L’asticella è molto alta. Posto queste righe scritte giorni fa ben sapendo di passarci sotto.
—Secondo me ci sono varie ragioni che spiegano questa follia. Sono costretto a spezzare l’intervento, scusandomi con gli amministratori ed i lettori per l’abuso della loro pazienza.
1-Imitazione obbligata: scoppia un’epidemia. Lo Stato F adotta una politica di quarantena. Se i dirigenti dello Stato D non adottano provvedimenti simili, per forza di cose nello Stato D si verificheranno più morti. Ecco che le opposizioni li accuseranno di avere sulla coscienza i cadaveri di migliaia di concittadini. Pertanto sono costretti a imitare lo Stato F. La Svezia ha avuto un tasso di mortalità nove volte più alto della Finlandia e cinque volte più alto della Norvegia. (HANS BERGSTROM)
2-Medicalizzazione della società: dal tempo della psicanalisi, del Gerovital e dei “miracoli” di Barnard, nei paesi occidentali i più sono abituati a considerare la medicina la soluzione per tutti i mali del corpo e della mente. Si va in ospedale come prima si andava in chiesa, con migliori risultati occorre dire, ma la fascinazione è la stessa.
3- Cultura della paura: le continue “emergenze” di cui hanno parlato spesso i WuMIng sono un elemento. Un altro è la perdita del ruolo centrale che l’Occidente aveva nell’economia-mondo. Finito il saccheggio, finita la festa. Per diverse generazioni la qualità della vita era oggettivamente migliorata. Adesso serpeggia la convinzione diffusa che le nuove generazioni staranno peggio di quelle vecchie. La cultura della paura si potrebbe forse meglio definire “ansia sociale generalizzata”
4-Ripiegamento funzionale dello Stato: In Occidente, dopo le due guerre mondiali e l’adozione generalizzata della filosofia di John Maynard Keynes, lo Stato era diventato Dio (Carl Jung). I rappresentanti di Dio erano potentissimi (es.italiano: Cefis e la “razza padrona”). Con la metà degli anni ’70 il controllo dell’economia è incominciato a sfuggire a Dio. Inizia il fenomeno della “deregulation” (Adam Curtis racconta gli albori del fenomeno, da par suo, in HyperNormalisation).
L’epidemia da Covid-19 ha riportato lo Stato ai “bei tempi” del 1916. I politici, frustrati da lustri di mediocrità retorica, sono ridiventati arbitri del destino dei loro sudditi (il vecchio Alfred Adler, ogni tanto, torna utile).
5- Influenza nefasta dei mass-media. La paura è un prodotto richiesto. Da Mary Shelley a Dario Argento diversi artisti hanno legato il loro nome al genere ”horror”. Giornali e televisioni non sono da meno e pur di vendere si accaniscono con storie morbose, tragiche, inquietanti, da buco della serratura, da fine del mondo.
6- L’ultimo libro del Nuovo Testamento, nei Paesi latini, si chiama “Apocalisse”. Nel mondo anglosassone, dal tempo della Riforma, “Libro della Rivelazione”. “Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve”. In un tempo in cui si credeva che i testi della Bibbia fossero “parola di Dio”, l’ultima, la definitiva parola di Dio ha influenzato alcune tra le menti più elevate del mondo cristiano. Qualcosa, di quest’attesa della fine, è rimasto nell’inconscio collettivo di un mondo secolarizzato.
Il punto 1 dovrebbe essere bidirezionale: lo stato F ha avuto un numero di morti paragonabile a quello stato D o poco superiore, nonostante le misure molto più restrittive; l’opposizione martella e lo stato F deve mitigare le misure, prendendo a modello lo stato D. Mi lascia perplesso il punto 4: non sono sicuro che tutte le decisioni prese da due mesi a questa parte siano una rivincita della politica (magari con la P maiuscola) sui Cefis contemporanei. Interessante anche il punto 6. Forse davvero, inconsciamente, stiamo tutti attendendo la fine, magari solo per patologica curiosità.
Ti ringrazio per le tue osservazioni. Sul punto 1 avevo portato, ad appoggio della tesi, l’esempio della Svezia, che ha in effetti avuto molti più morti delle nazioni circonvicine che avevano adottato misure profilattiche più rigide.
L’articolo sotto cui ho postato il mio commento dice però altro. Che ci si può ammalare per la paura di ammalarsi, come nei riti vudù o a causa del martellamento mass-mediatico sulla perniciosità del covid-19. L’effetto nocebo. E’ possibile che misure meno rigide facciano meno morti. In Italia ci sono stati 485 morti su 1 milione, in Svezia 238. Non mi sembra, però, che in Italia la Svezia sia stata presa a modello per ridurre le misure di confinamento, anzi, è avvenuto il contrario, come spiegato in un precedente articolo dei WuMing.
Sul punto 4: di Cefis e banda contemporanei non ce ne sono più, per quella sequenza storica che ha sostituito il capitale pubblico con quello privato (IRI scomparsa, ENI al 30% ecc.).
Ringrazio di cuore le autrici per questo illuminante intervento.
A proposito di servilistica disinformazione, non posso fare a meno di interrogarmi sul perché altre (e autorevoli) voci della comunità scientifica siano state (letteralmente) ignorate dai nostri patetici media o (letteralmente) aggredite dai “nostri” cosiddetti “esperti” (all’insegna del “se la realtà non si adatta alle mie teorie, dunque alle teorie di stato, tanto peggio per la realtà…”).
Penso all’intervento del Prof. Iannidis (Università di Stanford):
https://youtu.be/cwPqmLoZA4s
Perso all’intervento del Prof. Levitt (premio Nobel):
https://youtu.be/bl-sZdfLcEk
Penso naturalmente al trattamento (ignobile, nauseante) riservato, in difetto di ogni contraddittorio sul merito, agli scienziati tedeschi e svedesi:
https://youtu.be/bfN2JWifLCY
https://youtu.be/vrL9QKGQrWk
Intervento molto interessante, che sono riuscito a leggere per intero, nonostante la mole e la complessità, peraltro dichiarate, con grande onestà e umiltà, dalle autrici. Mi hanno tenuto agganciato diversi passaggi-cuneo disseminati nel testo, “il reale è troppo complesso per essere afferrato a partire da una sola prospettiva.”, “Non dappertutto la salute è intesa come “silenzio degli organi” o come “stato di benessere fisico, psichico e mentale”, fra i tanti. Molte cose ci erano già ben note, ahimè, ma forse è bene averle citate a mo’ di riassunto (una a caso: “… quest’alienazione non è arrivata per caso, ma è il prodotto di scelte politiche e comunicative; è l’esito di un battage propriamente terroristico.”). Personalmente ho apprezzato la menzione del caso di Agamben, che qualcuno anche qui, tempo fa, dopo le iniziali manifestazioni di plauso ha preso a criticare. Le autrici dicono poi: “Il linciaggio morale che ne è seguito è stato un vero e proprio avvertimento pedagogico per chi nutre gli stessi timori: meglio tenerli per sé”. In verità, A. non soltanto non si è fatto intimidire dai lillipuziani (v. direttore di Micromega) che lo hanno attaccato brutalmente, ma è andato avanti imperterrito, pubblicando altri otto interventi molto duri, senza fare alcuno sconto e senza chiedere scusa a nessuno, come qualcuno (v. sopra) aveva osato chiedergli: un bell’esempio di coraggio e di integrità, virtù sempre più rare ormai. Infatti (in questo le autrici hanno perfettamente ragione) pochissimi lo hanno seguito.
Se posso permettermi di esprimere un piccolo dubbio – ma è possibile che sia io a non aver inteso bene quel passaggio – il riferimento a un racconto di Kafka che conosco piuttosto bene, non mi sembra del tutto azzeccato, al di là del titolo. Ma chissà, proverò a rileggerlo più tardi.
Infine: mi vergogno un po’ a farlo notare, passerò probabilmente da puntiglioso, ma, nel passaggio “… che l’effetto nocebo è affatto una “fisima” psicologica e i suoi effetti sono del tutto reali” quell’affatto, senza il ‘non’ prima di “è affatto”, produce un senso della frase diverso da quello che, sicuramente, le autrici intendevano dare alla frase.
Riguardo all’ultimo tuo rilievo, è plausibilmente un refuso, basta inserire il «non», grazie per la segnalazione.
Commento al commento Mr. Skimpole: molto bene aver citato l’intervento del Premio Nobel per la Chimica 2013, che conoscevo; secondo me lo conoscono anche “nelle alte sfere”, e ovviamente nessuna testata ‘maggiore’ italiana lo ha pubblicato, perché quando, un giorno, sarà evidente e indiscutibile che aveva ragione, allora crollerà tutto o quasi il castello di menzogne e di minacce messo su da chi sappiamo negli ultimi due mesi. Ma allora sarà tardi, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, eccetera.
Spero di aver raggiunto in questo commento il numero minimo di 550 battute, dopo aver sudato sette camicie per stare sotto il numero massimo di 2300, nel commento precedente.
Complimenti alle autrici. Articolo complesso, illuminante (davvero suggestivo, poi, il punto 9).Confesso che ho fatto fatica a leggerlo, soprattutto i primi 4 punti.
A proposito del primo boccone difficile, vedo scritto: “ogni gruppo umano impazzisce in modo specifico[…]predisponendo piste di crisi del tutto particolari e altrove sconosciute.”
Tuttavia le TV (al netto della tossicità delle loro narrazioni) ci mostrano che in ogni parte del mondo le persone reagiscono più o meno allo stesso modo. Abbiamo visto persone in fuga in India, persone con le mascherine in Corea, strade deserte in Cina, la paura (apparentemente la stessa) ovunque. Forse l’omologazione delle persone a livello mondiale sta avvenendo più in fretta del previsto?
D’altro canto mi torna in mente quanto scritto da Saviano qualche settimana fa, secondo il quale al sud (lui si riferiva al sud Italia, ma potremmo estendere il concetto al sud del mondo) c’è una sorta di abitudine alla sofferenza, che consente di meglio fronteggiare la paura e la conseguente consapevolezza della morte (se non ho capito male).
Nel punto 7, citando l’alienazione psichica descritta da De Martino, si scrive: “quest’alienazione non è arrivata per caso, ma è il prodotto di scelte politiche e comunicative; è l’esito di un battage propriamente terroristico”. Assolutamente d’accordo, ma questo “battage” non è partito a marzo (come mi sembra di capire intendano le autrici), è partito molti anni fa. La polarizzazione, la creazione di fans o di nemici, o nero o bianco, la deificazione dell’uomo solo al comando, insomma, la semplificazione, sono pratiche politiche e comunicative che insistono da almeno un ventennio. È chiaro che è stato facile, oggi, prendere un popolo e dirgli: “seguitemi, so io cosa fare, fidatevi di me e degli scienziati che ne sanno” , e forse quel popolo non chiedeva di meglio che una guida forte, decisa e infallibile. Perdonate la…semplificazione.
Devo ammettere di essere prevenuto nei confronti di Saviano, ma questa del Sud (forse intendeva quello italiano) che avrebbe “una sorta di abitudine alla sofferenza, che consente di meglio fronteggiare la paura e la conseguente consapevolezza della morte” mi sembra veramente una grossa sciocchezza, fondata su logori luoghi comuni. Perché, al Nord hanno sempre goduto tutti come treni? ma quando mai? Già se pensiamo all’ultima guerra (ma ancor di più quella precedente) le devastazioni e le sofferenze patite nel settentrione, così come nel centro dell’Italia sono state oggettivamente ben peggiori che nella maggior parte del Sud (e buon per loro, ovviamente). Senza contare che ormai da decenni l’immigrazione interna ha stravolto gli assetti etnosociologici, e ad esempio a Torino credo proprio ci siano molti più italiani di origine meridionale che torinesi: come si fa a credere in una divisione netta come c’era alla fine del XIX secolo? Non so, dopo aver letto un intervento di alto livello, complesso e strutturato come quello di Consigliere e Zavaroni, una boutade come questa citata di Saviano fa cadere le braccia per la sua rozzezza e superficialità.
Giusta la notazione su Torino e sul fatto che da decenni «il Sud» non è solo al Sud ma anche al Nord e in generale disseminato ovunque. A Bologna, dove moltissim* abitanti sono di origine meridionale, tra gli imparanoiati e forsennati dello #stareincasa nel giro delle mie amicizie – alcune ormai ex-amicizie – e conoscenze, c’erano meridionali, polentoni e bulgnais, indistintamente.
Venendo al Sud-che-sta-al-Sud, a quello che si chiamava “il Mezzogiorno”, mi sembra che da Roma in giù gli arresti domiciliari di massa – con tanto di misure più draconiane e toni più “bananas” rispetto al resto del Paese, pensiamo alle ordinanze di De Luca (Vincenzo) in Campania o a quelle di De Luca (Cateno) a Messina – siano stati imposti con la medesima facilità che da Roma in su. Eppure in vaste zone del Sud il contagio non si è nemmeno visto e per tutto il tempo è rimasto poco più di un babau mediatico.
La motivazione che più ho letto per il chiudersi in casa al Sud era lo stato di dissesto dei sistemi sanitari di quelle regioni: se mi ammalo, nel mio ospedale mi fanno crepare in pochi giorni. Un timore fondato, che però ha portato all’accettazione di misure sovente deliranti e sganciate da qualunque base epidemiologica – e anche quando sensate, comunque sproporzionate rispetto all’incidenza reale del contagio.
In soldoni, al Sud ci sono stati terrore e paranoia come altrove, e forse, relativizzando, più che altrove. Dopodiché, immagino che la situazione fosse a macchie di leopardo, come già riscontrato per altre aree e territori: in alcune zone predominava l’intruppamento acritico, in altre la morsa era meno stretta e c’era margine per microtattiche di resistenza, assennate disobbedienze ecc. Ci sono stati anche episodi di ribellione e tentativi di jacquerie, benché sporadici.
È vero che al Sud sono certamente sopravvissute più a lungo la ritualizzazione e una dimensione collettiva del morire, e dove c’è questo non c’è tanatofobia, non c’è paura morbosa della morte. Però mi sembra che anche lì l’industrializzazione/burocratizzazione della morte si sia da tempo imposta come nel resto dell’occidente capitalistico.
Sì, concordiamo. Il “pedale della paura” ha cominciato a essere schiacciato forse già una quarantina d’anni fa (diciamo, dal duetto Reagan/Thatcher in avanti): prima lento e persuasivo, ancora giocato sulla possibilità del godimento individualistico, poi sempre più virato al terrore. Anche così, però, il “gorgo emotivo” che si è creato in Italia, e in particolare in Lombardia, ha qualcosa di davvero estremo.
Sulle forme di impazzimento delle diverse popolazioni mondiali, ci sarebbero da fare alcune considerazioni ulteriori. Fermo restando (per noi, almeno) che anche la follia è fenomeno culturale, con il Covid-19, per la prima volta nella storia, la gran parte della popolazione mondiale che vive in ambiente urbano è esposta in contemporanea a un medesimo agente patogeno; a messaggi mediatici analoghi; a misure di contenimento del tutto simili, che coinvolgono forze dell’ordine, personale medico, ospedali ecc. Ovvero, punto per punto, a un insieme di fenomeni legati a doppia mandata all’estensione planetaria del modello culturale “occidentale”, fatto di stato-nazione, città, connessione, trasporti rapidi, polizia, (bio)medicina, comunicazioni di massa e via dicendo. Stesse condizioni strutturali, analoghe reazioni. Nonostante questo, però, seppure il modello dominante di salute/malattia/mercato/industria/informazione si estende ormai su tutti i continenti, vicino e lontano a noi ci sono gruppi umani minoritari che si ammalano diversamente ancora r/esistono (stiamo pensando all’Amazonia, ad esempio, ma anche ad alcuni gruppi di signore che abitano a Torino, e che una di noi ha recentemente incontrato). Insomma: uniformazione da un lato, miriadi di resistenze e divergenze dall’altro.
Ho letto questo commento solo dopo aver scritto più sotto la mia considerazione sulla “civiltà rurale” e volevo dichiararmi assolutamente d’accordo.
Esiste certamente una “globalizzazione del modello culturale occidentale”, estremamente pervasiva e ormai diffusissima, ma per fortuna non è “ancora” l’unico modello.
E sono anche d’accordo che le miriadi di resistenze e divergenze esistano, e che siano anche “più vicine” di quel che potrebbe pensare in un primo momento. Bellissimo il parallelismo tra l’amazzonia e “alcune signore di Torino”: sono anch’io convinto che lo stile di vita ad esempio di alcune vallate alpine o di certi borghi fra l’appennino e la pianura sia ancora distante da quello di una metropoli come Torino o Milano “tanto quanto” quello di una tribù amazzonica (passatemi l’iperbole) e che in quelle differenze vada cercata qualche risorsa.
Non ho le competenze per valutare l’ipotesi, senz’altro interessante, di una globalizzazione della paura, o meglio: del modo di avere paura. Tuttavia, sono sicuro che le immagini televisive di “persone in fuga in India, mascherine in Corea e strade deserte in Cina” NON possano dimostrare tale “globalizzazione”. Il fatto che tre persone scappino di fronte a un pericolo, significa che hanno paura, ma NON significa che hanno la stessa paura, che hanno paura nello stesso modo. E il punto è proprio questo: a dispetto del nostro titolo – che per forza di cose semplifica il contenuto del pezzo – non ci si ammala “di paura”, ma è un certo modo di avere paura che fa ammalare. Aver paura di un leone, e scappare, non è certo nocivo. Ma se in ogni momento della vita penso che dietro l’angolo ci potrebbe essere un leone pronto a sbranarmi, questo di sicuro è un atteggiamento malato – anche se poi, quando il leone arriva, scappo e faccio la cosa giusta (sempre che questo accada, perché in certi casi una paura ossessiva finisce per bloccarmi, proprio nel momento in cui ne avrei bisogno, e questo la rende nociva due volte). Nel caso specifico del virus, e dell’effetto nocebo, quel che mi fa ammalare non è la paura del contagio, ma il terrore di ammalarmi, l’ossessione di “prendermelo”. Non so se il paragone ha senso, ma parlando con amici circensi, che fanno numeri da funamboli dove rischiano l’osso del collo, mi sono sempre sentito dire che il problema non è la paura in sé, anzi quella devi tenertela stretta, quanto piuttosto l’incapacità di “starci dentro”, che io traduco con l’espressione “aver paura della paura”. Ecco, quella paura ti mette davvero in pericolo, non l’altra, che invece al pericolo ti rende più attento.
Ringraziando le autrici per questo intervento (significativo come tutta la “serie COVID” di Giap), volevo solo chiedere se autrici e/o lettori possono spiegarmi e/o articolare di più uno dei passaggi finali: “Si potrebbe cominciare in modo citoyenne, prevedendo che chi ha un potere differenziale sia consapevole e responsabile delle sue scelte così come di ciò che comunica e meta-comunica”. Ringrazio in anticipo, ovviamente, chi avrà tempo e voglia di dire qualcosa. Tra l’altro, sono contento di leggere su Giap Stefania Consigliere che mi ha “esaminato” a Unige qualche anno fa; lo so che non e’un fatto di interesse pubblico e (giustamente) non gliene frega niente a nessuno, ma dovevo arrivare a 550 battute.
Ciao Giac, bello ritrovarsi qui…!
L’implicito era questo: la politica citoyenne non è proprio il massimo del desiderabile visto che, al meglio, arriva a essere riformista; anche limitandosi a questa, però, si può esigere che chi ha il potere di “fare discorsi” e di persuadere sia richiamabile agli effetti delle sue parole. (Un esempio: non se qualche disperato, negli USA, si sia iniettato del disinfettante dopo il discorso di Trump; se fosse successo, però, quel morto andrebbe messo subito sul conto del presidente e dovrebbe valere come giustificata causa di allontanamento permanente dai microfoni.) D’altro canto, se davvero vogliamo uscire dalla partizione cartesiana, allora i discorsi sono, a tutti gli effetti, azioni: modificano il clima, inducono cambiamenti, spostano pesi emotivi e cognitivi.
Ciao, io trovo che il passaggio da voi sottolineato sulla messa in discussione del riduzionistico paradigma cartesiano non possa sfociare “fluidamente” nelle teorie illustrate da Hahn e Kleinsman sugli effetti placebo/nocebo. La frase che non può giustificare questo salto logico è questa: “…Le cosiddette «morti voodoo», che si verificano a seguito dell’induzione di uno stato pervasivo di terrore…”: purtroppo riuscire a dimostrare una “correlazione diretta” fra gli eventi è estremamente difficile anche se la suggestione della teoria sembra già di per sè una prova fondata. Anche per me. Io credo, come voi, che gli effetti catastrofici dell’ induzione al terrore abbiano ripercussioni di tipo primario che, in una determinata percentuale da definire, possono facilmente portare alla morte ma che, molto più spesso, producono effetti “secondari” di pericoloso avvelenamento sociale diffuso. Resistere a questa pressione psicologica, attuata con la modalità del dittatoriale ottimismo d’accatto dell'” andrà tutto bene”, è enormemente più faticoso che adeguarsi passivamente. L’introiezione di un modello autoritario è già, drammaticamente e largamente, avvenuta. Le vittime più indifese di questa pandemia mediatica sono i bambini e chiunque non possa ribellarsi, i corpi sociali su cui si percuote con maggiore violenza il manganello dell’isolamento, compressi, schiacciati ed esposti a danni irreparabili e, sì, letali. Ma chiunque abbia una vita sociale lavorativa,negli ultimi “x” anni, è stato indotto ad una compressione violentissima dei diritti e della libertà a vantaggio esclusivo del capitale, e ha già in parte subito un inaccettabile ricatto ed esproprio. Le più importanti lotte sul posto di lavoro non sono state combattute per ottenere adeguamenti salariali ma per conquistare spazi di libertà dallo schiavistico sfruttamento lavorativo. Così come la Resistenza è stata la lotta per liberarsi dalla dittatura e dall’ oppressione. E mi scuso se ho ridotto l’analisi ad unico termine. Semplificando.
In realtà non hai semplificato, ma aggiunto uno strato in più – e di non facile trattazione. Rispondo a titolo del tutto soggettivo e con molta esitazione. Una delle domande che mi perseguitano da quando ero bambina riguarda il basso numero di ribellioni nei campi di sterminio. “Resistere alla pressione psicologica” non è solo più faticoso che adeguarsi: in certe circostanze, potrebbe essere quasi impossibile. Françoise Sironi, un’autrice a noi molto cara, ha lavorato per vent’anni con le vittime di tortura e ha studiato quel che avviene quando interi gruppi o intere nazioni sono sottoposti a regimi di terrore, alla potenza terribile delle “emozioni politiche”. Sospetto che la sua opera potrebbe essere utile non solo per analizzare quanto è successo in relazione al terrore da Covid-19, ma anche come indicazione, in tempi migliori, sul tipo di “pieghe mentali” che favoriscono la soggezione, l’impotenza appresa, la disperazione.
In questo senso, hai ragione da vendere quando dici che non c’è passaggio fluido dalla messa in discussione del paradigma cartesiano all’induzione di morte tramite terrore – e non c’è perché in effetti, per noi oggi, quel passaggio non è una transizione ma un salto (basti pensare che siamo ancora così tanto cartesiani che, quando ci ammaliamo, lo facciamo o nel corpo, o nella mente – con la psicosomatica che, nel creare un ponte, conferma la separazione delle due rive). Per questo, tra l’altro, ci serve costruire fiducia.
Ciao! Grazie mille per la risposta e per il preziosissimo riferimento a Francoise Sironi, che non conoscevo ma il cui ambito di indagine mi sembra, come il vostro, indispensabile per integrare ed ampliare il punto di vista sulla pandemia. Io sono molto interessata a comprendere come si sviluppano tutti quei fenomeni sociali che non possono meccanicamente essere spiegati nella prospettiva stimolo/ risposta, come se fossimo macchinari. Per questo la vostra analisi arricchisce di una complessità sfuggente il quadro. C’è qualcosa di inafferrabile, come sepolto sotto cumuli di presunta razionalità e che,per me, rimane insondabile e misterioso. Soprattutto per ciò che riguarda tutti quei comportamenti che mmettono in campo una reazione “attiva” e quindi passaggi e processi di consapevolezza ed autocoscienza. Accanto ai fenomeni diffusissimi di paralisi, mi interessa capire da dove e perché nascono le reazioni di rabbia e di protesta. Quale è il motore, come si accendono le micce come ,ad esempio, per quanto riguarda i movimenti di protesta dei neri, per citare solo un caso specifico. Perché parliamo,giustamente, di fiducia, invece che di rabbia. In un passaggio del libro Chav, di cui abbiamo parlato qui su Giap, si verifica una sovrapposizione ” colposa” da parte dell’autore dei concetti di rabbia e violenza, in una forma di semi identificazione. Si tratta di un meccanismo di repulsione indotto dall’esterno. Una forma di biasimo per tutto ciò che porta con sé distruzione, come la rabbia. Da condannare a priori. È questo che insegnano a tutti noi fin da piccoli. A non trascendere mai in sfoghi rabbiosi. Come se rabbia e violenza fossero sinonimi, forse è per questo che ci si ammala veramente, oltre che per l’ introduzione di massicce dosi di terrore. Se cresce la paura diminuisce il livello di reattività e lucidità. Chiedo scusa in anticipo se mi discosto forse troppo dalla vostra analisi. Cerco di spremere ogni goccia del vostro ragionamento fino alle estreme conseguenze.
Considerazioni condivisibilissime. Azzarderei dire logiche. Che di questi tempi sono ragionamenti purtroppo tutt’altro che ovvi ed è una specie di azzardo perfino cercare di essere razionali. Per quanto si parli di ragionamenti evidentissimi. Il discorso relativo alla fiducia, o se non altro alla possibilità di provare ad essere ottimistici, penso sia essenziale proprio per creare una narrazione importante. Ossia se il condizionamento distruttivo è scientificamente dimostrabile nella sua problematicità allora abbiamo comunque la risorsa delle eventualità che una narrazione differente potrebbe esserci di aiuto. D’altronde meglio pensare bene piuttosto che pensare male. Poi la differenza tra Korper e Leib è certamente più attuale che mai. Grazie delle interessanti suggestioni. Notte
In questa fase “storica” la narrazione su GIAP tocca davvero alture difficili da trovare altrove. Dai Diari Virali in poi, è nato un racconto collettivo capace continuamente di porre il lettore di testi e commenti su un’altra prospettiva fornendo strumenti mai banali con cui interrogare la quotidianità. Un perfetto antidoto contro le dinamiche totalizzanti in atto. Questo articolo, ad esempio, ha allargato ancora di più le possibilità di interpretazione spingendoci fino a pensare che “neanche la malattia è qualcosa di dato e di universale” ma “è il prodotto di una storia in cui diversi fattori interagiscono in modi complessi.” Si potrebbe aprire allora una diagnosi del “caso italiano” ancora più grave e profonda rispetto ai numeri dell’epidemia. I suoi tratti principali sono probabilmente già qui, tra queste pagine.
“La pillola” della salvezza che riporterà tutto come prima ancora non è stata trovata. In sua assenza la paura ha avuto tassi di contagio ben più alti di quelli del COVID. Questo mi ha fatto pensare a un rituale laotiano che è stato modificato per creare una protezione specifica contro “gli spiriti dell’epidemia”. E’ usanza di alcune popolazioni celebrare “una piccola apocalisse” come la fine dell’anno intagliando guerrier* di legno sulle vie di accesso dei villaggi. Servono per mantenere lontani gli spiriti che portano sventura come una cattiva stagione delle piogge o una malattia. Quest’anno alcun* dei guerrier* indossavano una mascherina e delimitavano aree di quarantena, frontiere che obbligavano a trascorre un periodo di chiusura in una stanza già predisposta. Il villaggio e le sue autorità si sono così riappropriate dell’ignoto senza affidarsi ai rotocalchi fascistizzanti stile “D’Urso” o ai rituali quotidiani del conteggio di morti e contagiati. Senza imporre alcun rovesciamento che salvasse il “sistema” e colpevolizzasse la “comunitas”, la saggezza locale ha considerato le relazioni come il primo vero antidoto da somministrare. Così insieme hanno intagliato guerrier*-pillola, un pò come i threads di questo blog. E pensare che la barbarie occidentale ha considerato queste manifestazioni come folclore di popolazioni “incivili” o “primitive”.
È appena stata pubblicata una traduzione in tedesco di questo articolo. Non parlando tedesco, non so dir nulla sulla qualità e fedeltà all’originale, ma intanto la segnalo:
https://non.copyriot.com/pandemie-kriegstagebuecher-neurosenlehre/
Chiedo scusa in anticipo, io sono sempre quello delle osservazioni puntigliose, ma devo proprio chiedervelo. Ho dato velocemente un’occhiata alla traduzione in tedesco dell’intervento di Consigliere e Zavaroni. So ben poco di tedesco, ma si capisce che è quello, incipit e chiusa tolgono ogni dubbio (insieme alla citazione della D’Urso, che immagino/spero sia del tutto sconosciuta in Germania). Ma allora perché è firmato Sebastian Lotzer, mentre il nome delle due autrici bisogna andarlo a cercare all’interno del testo? Costui sarà forse il traduttore, ma è strano che abbia il nome così in evidenza, sopra e sotto il pezzo, così chiunque, leggendolo distrattamente o parzialmente, è autorizzato a pensare che ne sia veramente l’autore. Hai capito i crucchi…
Se ho ben capito, Lotzer firma in quanto “titolare” della “rubrica” «Pandemie Kriegstagebücher» [Diari di guerra della pandemia], dentro la quale ospita volta per volta dei contributi introdotti – e a volte, come in questo caso, tradotti – da lui. Nella sua intro dice chiaramente che il testo è preso da Giap, poi c’è il titolo seguito dai nomi delle autrici. Direi che per chi legge il tedesco non c’è malinteso possibile.
Sì, confermo che non c’è spazio per fraintendimenti. Anche in chiusura scrive di non aver tradotto le note al testo e ha preferito mettere il link a Giap così che chi legge può andare a leggerle e recuperare i testi di riferimento. Si scusa più volte per la qualità della sua traduzione visto che il testo è complesso e reputa la sua conoscenza dell’italiano non totalmente all’altezza del compito.
Anche se il mio tedesco non è così buono da poter comparare la traduzione con il testo originale, per il poco che ne so non la trovo per niente male. trovo che sia una bella cosa che qualcun* si sia smazzato questo lavoro, l’articolo è così ricco di spunti e di aria fresca per le sinapsi che è un bene che possa circolare anche oltre le Alpi.
Questo articolo è fantastico e sono molto contento di leggere cose del genere su Giap.
Provo a fare qualche commento ben sapendo che ho a malapena gli strumenti per leggerlo, figuriamoci per commentarlo.
Però sono argomenti che mi hanno sempre appassionato molto, anche se non ne ho mai fatto letture sistematiche e coerenti, trovando “cose” saltabeccando in giro per internet che poi è difficile “piazzare” in un contesto più ampio (ad esempio avevo letto della differenza epistemologica fra Kuhn e Popper, ma non saprei piazzare politicamente nessuno dei due).
Veniamo ai commenti:
importante la visione di qualunque realtà come complessa (io lavoro in campo ambientale e qui è particolarmente evidente) e trovo positivo uscire da una visione riduzionistica e materialista che troppo spesso ha caratterizzato anche le letture del mondo “da sinistra”.
Tornando all’incipit, ecco perché sono contento di leggere qui cose del genere, perché nel posto “più di sinistra del web” (faccina sorridente) sono ormai anni che si toccano temi e punti di vista complessi e non immediatamente “materializzabili”.
Sul ruolo della “credenza”: secondo me centrale. Aggiunco che però la credenza difficilmente può essere “individuale”, o meglio, può esserci ma non sarà mai forte come una credenza collettiva.
Pensiamo ad esempio (faccio un’iperbole, non sono un medico ma faccio un esempio) al cancro:
quando era una diagnosi assolutamente infausta era molto più difficile “credere individualmente” che ci si sarebbe salvati con conseguente effetto “nocebo” oltre a tutti gli altri aspetti medici, mentre ora che le terapie sono non solo migliori ma universalmente riconosciute come efficaci e che i tassi di sopravvivenza aumentano, anche l’effetto placebo di una “credenza” nella propria guarigione è molto più efficace, perché anche “altri” oltre al soggetto malato possono crederci e quindi il soggetto negli occhi dei vicini e dei congiunti legge fiducia e non sconforto.
Bellissimo anche il pensiero che psiche e materia non sono separati e che a determinati stati mentali corrispondono anche semplicemnte degli effetti fisiologici: che quindi “esistono” e non sono fisime da fricchettoni.
Continua con un PS
continuo con un breve PS
Sul ruolo della politica italiana e la narrazione “Bellica” noi-contro-un-nemico-invisibile con tutto quello che ne consegue (chi esprime perplessità è un disfattista/sabotatore).
Sicuramente è stato un riflesso “esistente” nel pensiero italiano e della sua classe dirigente, che è venuto facile e che ha fatto comodo per spostare la rabbia e la frustrazione dalla gestione dell’emergenza e dai limiti infrastrutturali (sanità, scuola, etc.) ai “furbetti” della “passeggiatina”.
Resta da capire se quest’effetto sia solo un prodotto del caso (le condizioni di partenza italiane, l’inadeguatezza e l’approssimazione di molte scelte, shakera il tutto e ottieni sta roba qua, come le scimmie con la macchina da scrivere che dopo un po’ ti scrivono Shakespeare) o se fosse almeno in parte desiderato e messo in conto nella stesura dei decreti, nella fumosità delle interpretazioni, nell’arbitrio lasciato ai controllori, etc.
Poi faccio un commento ai commenti preced. sul discorso di Saviano.
Premetto che io sono un polentone del profondo nord-ovest e che mal digerisco una certa retorica “sudista” però, al netto delle condizioni materiali credo che il nocciolo del discorso di Saviano possa riassumersi in quanto detto da WM1 e che cioè al sud sono «sopravvissute più a lungo la ritualizzazione e una dimensione collettiva del morire, e dove c’è questo non c’è tanatofobia, non c’è paura morbosa della morte»
Aggiungo e integro: non è che queste cose sono sopravvissute “al sud”, sono sopravvissute nelle civiltà rurali, e quindi maggiormente al sud, dove, almeno fino agli anni novanta, c’era molta più “ruralità” che al nord, dove invece si è avuto un drammatico spopolamento delle campagne e di intere vallate per confluire nelle metropoli industrializzate.
Però ancora adesso, pur con tutti i limiti che le campagne e la civiltà rurale possono avere (conformismo, paura del diverso, difficoltà di integrazione per un forestiero che arrivi anche solo dalla città più vicina) è qui che ci sono ancora le risorse per non essere asfaltati in un unico corpo sociale “malleabile” alla narrazione dominante.
Chiedo scusa, gentile Cugino_di_Alf, non è per polemizzare, ma volevo soltanto far notare che estrapolare quelle tre righe (peraltro del tutto sensate e condivisibili) dal lungo commento di Wu MIng 1 delle 9:34 forse ne stravolge un po’ il pensiero sulla questione. Prima di quel breve periodo vi si leggono cose molto diverse, e comunque la riga dopo, in chiusura del commento, recita: “Però mi sembra che anche lì l’industrializzazione/burocratizzazione della morte si sia da tempo imposta come nel resto dell’occidente capitalistico.”
In verità direi proprio, e tristemente, che per trovare ancora culture in cui una “ritualizzazione e una dimensione collettiva del morire” ancora permangano si debba andare molto più lontano, e non necessariamente nel Sud del mondo. Penso a etnie del profondo Nord, radicate ad esempio in Siberia, da quel che si era potuto capire vedendo un bellissimo film di Werner Herzog del 1993, “Rintocchi dal profondo”.
Va beh, direi che la polemica sta tutta nel “gentile” di incipit..
:)
Comunque hai ragione, sembra che io abbia voluto “far dire” la cosa estrapolandola dal contesto.
In realtà ho citato espressamente solo quelle 3 righe perché per me il nocciolo della mia argomentazione stava lì. E’ certamente vero anche quanto detto dopo nel commento di WM1, e che “l’industrializzazione della morte” si sia imposta anche lì, ma continuo a pensare che ci sia un’importante cesura fra aree metropolitane ad alta densità di popolazione e mondo rurale a bassa densità di popolazione (e non parlo solo di grosse città: anche quelli che un mio collega definisce “non luoghi” come gli agglomerati di casette a schiera nei vari interland della pianura padana sono ormai separati dal mondo rurale) .
Non è nemmeno più una questione nord – sud, solo al sud fino a tempi recenti di aree rurali abitate dove la vita è continuata più o meno allo stesso modo ce ne sono state di più.
Al nord una piccola apocalisse di questo mondo c’è stata con lo spopolamento delle montagne e delle colline.
In estrema sintesi (finisco i caratteri) se zappi l’orto, spandi un po’ di letame o assisti al parto di una vacca o una capra sei probabilmente più “vaccinato” per cose come la tanatofobia…
L’articolo è interessante, ma rimango un po’ perplessa di fronte a certe affermazioni:
“Nel caso degli umani, questo significa che il tempo-spazio culturale nel quale prendiamo forma ci plasma secondo linee specifiche non solo in ciò che pensiamo, ma fin dentro le cellule, in un processo di vera e propria plasmazione bioculturale.” Fin dentro le cellule? Un qualsiasi adattamento genico della specie all’ambiente richiede migliaia di anni per avvenire…
“Un’ampia varietà di ricerche psicologiche, etologiche ed endocrinologiche indicano che la mancanza di contatto fisico induce nei neonati sindromi che vanno dalla depressione al nanismo, fino a sfociare, nei casi più gravi, nella morte;” Nanismo? Che io sappia non esiste alcuna correlazione tra assenza di contatto fisico e nanismo nel neonato.
Pur condividendo ampiamente le critiche alla gestione della pandemia, vi chiedo gentilmente se avete delle referenze per queste affermazioni.
Però il primo passaggio che citi non parla di filogenesi, arrivare all’evoluzione della specie partendo dall’espressione “fin dentro le cellule” è un salto logico. “Fin dentro le cellule” può essere riferito, ad esempio, a un tumore, che tra i co-fattori del proprio insorgere, aggravamento e decorso può averne di bioculturali, legati al come viviamo, al come ci ritroviamo ad affrontare quell’esperienza, al cosa proviamo, al bene che ci vogliono o meno le altre persone ecc.
L’azione dell’ambiente non cambia se non raramente la sequenza dei geni (es. mutazioni indotte da radiazioni), ma ha una forte influenza sulla frequenza e i tempi di espressione dei geni, in modo da cambiare profondamente il profilo delle proteine espresse dalle cellule e quindi il loro fenotipo e la loro funzione. Esiste un ramo affascinante della biologia che studia queste interazioni chiamato epigenetica. L’atl’iperattivazione di un gene sano da parte di fattori ambientali esterni o interni, quindi anche psicogeni, può indurre per esempio il rilascio incontrollato e non necessario di citochine infiammatorie che in mancanza di un agente infettivo da combattere danneggiano l’ospite che le produce. Un’esposizione prolungata a fattori di stress può silenziare chimicamente anche se non cancellare, i geni che regolano e abbassano il rilascio di queste citochine, producendo un circuito disfunzionale che può continuare a lungo anche quando lo stimolo venga eventualmente eliminato.
Nell’area fra genetica, evoluzionismo, embriogenesi ed ecologia c’è stato, negli ultimi vent’anni, un profondo mutamento di paradigma, che però non è ancora arrivato né sui manuali, né sulla stampa generalista – anche perché il vecchio approccio riduzionista è del tutto congruente con le premesse del neoliberismo. Riassumere qui tutti i passaggi sarebbe complicato, quindi passo subito ai riferimenti bibliografici: il primo è senz’altro uno di quelli già indicato in calce all’articolo (T. Ingold & G. Palsson (2013), Biosocial becomings. Integrating social and biological anthropology, Cambridge University Press, Cambridge); poi anche Carroll S.B., 2005. Infinite forme bellissime. La nuova scienza dell’Evo-Devo. Codice, Torino 2006 e Jablonka E. & Lamb M., 2005. L’evoluzione in quattro dimensioni. Variazione genetica, epigenetica, comportamentale e simbolica nella storia della vita. UTET, Torino 2007. Infine, vedi se riesci a procurarti questo vecchio gioiello: Gardner L.I., 1972. Nanismo da deprivazione. «Le Scienze» 50, pp. 72-78. (Se non riesci, contattami privatamente.)
«Nanismo da deprivazione» di L.I. Gardner si trova in pdf qui.
Grazie ad entrambi per le risposte e soprattutto a SteCon per l’esauriente bibliografia. Effettivamente nella prima perplessità avevo fatto un salto logico, ora mi è chiaro a cosa si faceva riferimento e sono completamente concorde con l’affermazione che l’ambiente che ci circonda abbia un ruolo nello sviluppo di una determinata patologia.
Per quanto riguarda la seconda è una scoperta stupefacente che mi avete fatto fare.
Spero che presto si arrivi ad una teoria unificata di epigenetica e antropologia.
Nel salutarvi vi volevo segnalare un articolo molto interessante sulla necessità di predisporre un metodo di gestione della salute mentale nella pandemia da Covid-19.
Mette in risalto temi che spesso ho ritrovato qui, come l’attenzione ai figli e l’effetto nocivo di un incessante bombardamento mediatico.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2008017
Buongiorno,
sono anni che non intervengo qui su Giap, ma ho continuato a seguire le discussioni sempre con interesse e reale sollievo intellettuale.
Per prima cosa volevo davvero ringraziarvi per questo spazio di discussione, che è uno dei pochissimi in cui circola ancora aria fresca e libera, che di questi tempi è cosa rara, pure quando si interagisce on-line, potersi scordare per qualche momento di dover indossare, anche intellettualmente, dei “dispositivi di protezione”.
Ringrazio poi le autrici di questo post, estremante interessante e utile e che solleva questioni fondamentali.
Io volevo sottolineare un punto in particolare, che nell’articolo è centrale ma trattato in modo trasversale, che ritengo particolarmente saliente: ovvero il rapporto tra malattia e potere, soprattutto della malattia come metafora possibile del potere o come forma di resistenza ad esso (spesso modalità che si intrecciano tra di loro). Riguardo alle sue ricerche sulla possessione, sopratutto femminile, nell’India del Nord, per esempio, la Moore scriveva che, talvolta, “to get sick is a mode to seek justice”. La possessione emerge qui come forma di malessere psico-sociale che mette in discussione le reti di potere in cui il soggetto è inserito e le costringe ad attivarsi e riconfogurarsi in vista di una guarigione del malato che può avvenire solamente all’interno di una ristrutturazione (almeno parziale) del campo sociale.
Sulla malattia come metafora del potere, persino divino, ho scritto recentemente un piccolo articolo uscito su Storie Virali (si trova qui: http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Storie_Virali_Sitala_Mata.html), suggerendo anche (sulla scia delle analisi proposte dai Subaltern Studies), che le classi marginali potrebbero talvolta persino preferire un’alleanza diretta con il “virus”, perchè esso si pone come potere di livello superiore e come critica dell’esistente, e di conseguenza come spazio di potenziale riformulazione delle relazioni politico-sociali ed economiche.
Ullallà, lo Sbriccoli! Bentornato!
Ah, un’ultima cosa.
Mentre mi aggiravo poco fa per Siena, ho incontrato un amico che mi ha detto che alla biblioteca di lettere sono ripartiti prestito e restituzione dei libri (solo su appuntamento). In caso di restituzione, i libri devono rimanere 72 ore in quarantena. Questa immagine di libri in quarantena (tra altro per un tempo che a livello scientifico è indicato come il massimo possibile, in condizioni ottimali, per determinate superifici, e solo per brandelli di materia organica virale) ha suscitato in me particolari visioni magiche (e altre più inquietanti…). La malattia degli oggetti o la loro contagiosità – e la figura del capro espiatorio è esempio principale, talvolta non animale ma oggetto investito del male e allontanato dalla comunità umana – mi sembra un altro tema interessante nell’ambito dell’antropologia medica e politica: il terrore scuscitato dagli oggetti (non in quanto tali, naturalmente, ma per come essi vengono investiti attreverso pratiche sociali, discorsive o vera e propria normatizzazione, di un particolare significato).
Ciao, articolo molto interessante. per mettere un po’ di carne al fuoco, dal punto di vista della medicina occidentale troviamo la sindrome tako-tsubo – che evidenzia la risposta del cuore alle modificazioni dell’umore dovute a lutto, angoscia, ecc, praticamente il “crepacuore” – nonché l’ampia letteratura prodotta sugli effetti placebo, di cui Fabrizio Benedetti ha scritto e bene. Questo tanto per dire che Agamben forse ha ragione a farsi certe domande, ma la separazione di corporeo dallo spirituale cui lui attribuisce effetti negativi (su quodlibet il 13 aprile) è forse una revisione del legame tra i diversi aspetti. E, comunque, se anche fossero separati spirito e corpo, vi sono degli indubbi vantaggi che non vanno dimenticati: il medico dovrebbe aver di fronte un fegato, non un fegato romanista, di sinistra, ricco, bianco, nero…In un certo senso, la “disumanizzazione” della medicina occidentale potrebbe dal punto di vista teorico limitare gli abusi di una medicina morale e paternalistica che vorrebbe curare “la persona” e non “la malattia”.
Leggendo l’articolo e i commenti sembra passare l’idea che l’umore delle persone sia importante tanto quanto altri fattori nel determinare la patologia da coronavirus. Il che è sbagliato e potrebbe portare alcuni a pensare davvero che se vivessimo felici e spensierati il virus avrebbe meno probabilità di infettarci.
Non metto in dubbio che la psiche prenda parte allo sviluppo di molte patologie, vedasi disturbi d’ansia, depressione, ocd, ecc., ma il nesso tra misure di lockdown e aumento della probabilità di contagio mi sembra quantomeno forzato.
Nella discussione si fa poi riferimento a epigenetica, etnomedicina e altri approcci che definirei Lamarckiani. Senza specificare che tutto ciò sono solo ipotesi e che andranno validate prima di trarne conclusioni di verità.
P.S. Passatemi la battuta ma definire prestigioso il Medical Anthropology Quarterly fa alquanto ridere. È un giornale con un impact factor di 0.57 e l’articolo a cui fanno riferimento le autrici è stato pubblicato nell’anno della sua fondazione (1983). Per i non addetti ai lavori, il New England Journal of Medicine, uno dei più prestigiosi giornali di medicina, ha un impact factor di 70.6
Ma il punto, secondo me, non è che vivendo «felici e spensierati» non ci infetteremmo di coronavirus, bensì che vivere nella paranoia, nell’angoscia, nella paura morbosa di morire non fa bene alla salute nel suo complesso (che, su questo saremo d’accordo, è qualcosa di più del non prendersi il Covid-19), non fa bene al legame sociale, non fa bene alle sorti collettive e getta le basi di un malessere che è anche la premessa di varie patologie…. E non è utile nemmeno per contrastare la pandemia, o quantomeno, non è utile a uscirne bene. Perché un conto è un razionale distanziamento fisico unito a misure di profilassi, un altro è l’atteggiamento fobico.
Alcuni amici psicologi mi dicono che i loro pazienti paranoici stanno molto meglio. In un contesto in cui la paranoia diviene sentimento “normalizzato”, non solo accettato ma incentivato, lo spettro stesso delle patologie si riconfigura, e così anche la percezione che la persona ha del proprio ben-essere psico fisico. Al di là della facile battuta che si potrebe fare, ovvero che questa situazione almeno a qualcuno sta facendo bene, è più interessante indicare come l’aspetto patogeno di una “cultura”, evidenziato nell’articolo, abbia effetti, in situazione di crisi, quasi immediati, che i paranoici “patologici” hanno subito percepito. A breve comparirà forse la nuova patologia dell’a-paranoia…
Bel paradosso! «Visto? Avevamo ragione a essere paranoici, adesso lo sono tutti quanti! Ora possiamo rilassarci» :-)
La tua battuta post scriptum mi ha fatto sorgere alcune domande in parte OT: premesso che del MAQ so poco e niente, a me risulta che l’impact factor di una rivista scientifica dipenda dal numero di volte in cui un articolo uscito su quella rivista è stato citato in altri articoli nel corso dell’anno precedente; ora, il numero di citazioni non dipende anche dalla vastità o ristrettezza del focus della rivista, dalla disciplina di cui si occupa, dall’essere quest’ultima “generale” o specialistica? In parole povere: si possono comparare le citazioni ricevute da una rivista di medicina generale come il NEJoM (o The Lancet, per dirne un’altra) e quelle ricevute da una di antropologia medica? Non è normale che un paper di antropologia medica sia citato meno spesso di uno che ha come oggetto questioni meno specifiche e connotate? E poi, impact factor e prestigio sono la stessa cosa? Non parlo nemmeno di qualità, perché sul fatto che impact factor e qualità non siano la stessa cosa c’è un dibattitone di lungo corso. Parlo di prestigio: essere una rivista peer-reviewed che viene pubblicata da quasi quarant’anni da un’università di una certa importanza (l’UCSF), non conferisce di per sé un certo prestigio?
Confesso anch’io di sapere poco o niente di impact factor. Ma quando si parla di citazioni che contribuiscono ad accrescere il prestigio di un articolo o una rivista, si parla anche di citazioni negative? Cioè si accumulano crediti/punti/prestigio anche se si parla male o molto male di un articolo pubblicato in una rivista? Se così fosse – ma vi prego di correggermi se sbaglio – avrei una qualche difficoltà a identificare il prestigio o la qualità di una rivista con il parametro in questione. In termini più generali, sarei più a mio agio con metriche più sofisticate e, ad esempio, in grado di valorizzare – nei termini di cui ha parlato WU Ming1 – riviste non generaliste (antropologia etc.), quali quelle citate dalle due autrici (alle quali, dopo la seconda lettura dell’articolo, rinnovo i miei complimenti).
Siamo assolutamente d’accordo con il fatto che la salute è qualcosa di più del non prendersi il Covid-19. La stessa WHO la definisce come:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
Forse per un eccesso di deontologia professionale ho voluto sottolineare l’assenza di un nesso diretto con l’aumento di morbilità.
Ciò non toglie l’importante lavoro che questo blog fa per mettere a fuoco la narrazione che si fa di questa pandemia, una narrazione dannosa e controproducente, che ha, questo sì, avuto un effetto diretto sullo stato generale di salute della popolazione.
Per quanto riguarda il discorso impact factor, la mia si limitava ad essere una battuta di spirito. Non trovo OT le domande che ti ha fatto sorgere, in quanto hanno molto a che vedere con l’epistemologia. È un dibattito molto acceso nella comunità scientifica e difficile da riassumere qua. Mi limito ad osservare che ovviamente l’impact factor di una determinata rivista non ha nulla a che vedere con la validità di uno studio che viene pubblicato su tale rivista. Un buono studio pubblicato su una rivista di nicchia rimane un buono studio. Un pessimo studio pubblicato su una rivista eccellente resterà un pessimo studio (e di esempi, in medicina soprattutto, ce ne sono ahimè troppi).
Lungo la sua storia l’Antropologia è finita quasi sistematicamente 1. a fare da spalla a poteri coloniali e neo-coloniali, come nel caso noto dello Human Terrain Project in Iraq, 2. a collaborare con vari soft power per la creazione di “credenze” in territori contesi o 3. dando parole a svariate forme di radicalità. Uno dei casi che conosco meglio riguarda la Colombia degli anni 70 e 80 quando l’intellighenzia di alcune guerriglie colombiane provenivano o dal catechismo della Chiesa dell’opzione per i poveri o dai dipartimenti di Antropologia. Gli antropologi erano di solito i quadri intermedi che poi, in alcuni casi, sono finiti a fare i Comandanti. Alfonso Cano lo fu delle FARC fino al 2011 e si definiva fieramente “Antropologo dell’Universidad Nacional”. Penso anche al caso del M19, guerriglia situazionista urbana, le cui azioni erano apertamente ispirate dall’antropologia amazzonica e dall’etnopsichiatria di Fannon quando nessuno le leggeva. Sto correndo OT e cito questo solo per ridere dell’Impact Factor di antropologi che non erano letti su vasta scala.
Ritornando all’articolo, credo che il problema di alcune critiche stia nella portata delle conclusioni che si vorrebbero ma che l’articolo è attento a non fornire. Se ci ho capito qualcosa in questi anni di letture e studi con scarsi risultati per la verità, è che la migliore antropologia è proprio quella che riesce a destrutturare alcune “credenze” rinnovando la consapevolezza di pratiche ripetute con continuità. Nel campo dell’Antropologia Medica il compito mi sembra più arduo poiché significa rendere evidenza “i morti voodoo” o “le statue dei guerrieri” dentro al mondo dei laboratori e mostrare che la malattia ha una sua esistenza specifica tra i tessuti connettivi del corpo sociale. Mi è parso allora parecchio interessante il tentativo delle autrici di ribadire l’importanza medica della fiducia per trovare ulteriori difese dalle affezioni della malattia. Questo certo non vuol dire “curare il Covid o un tumore” ma apre a una visione olistica dei processi chimici ed elettrici che ci compongono per opporre il non-farsi-malattia alla semplice guarigione via pillola.
Solo per conferma. È bene non inoltrarsi nella questione dell’IF; come sottolinea WM1 il dibattito è di lungo corso. Ci sarebbero poi altri fattori di cui tenere conto, più focalizzati sugli autori (H-index, Hc-index, G-index).
Certo, fra 0.57 e 70 la differenza è grande, ma le riviste con IF più alto o trattano argomenti molto più impattanti e seguiti (New England, Lancet), o sono generaliste (Nature, Science). Fra le riviste con IF più alto ci sono Diabets, Brain, Heart, Cancer Research, che di certo non si occupano di etnopsichiatria o antropologia medica, e hanno un IF alto certamente perché sono rigorose nel loro lavoro di revisione, ma anche perché possono contare sul contributo di decine di migliaia di ricercatori in tutto il mondo (che spesso amano citarsi tra loro). Generalmente settori di nicchia hanno riviste di nicchia, dunque con IF necessariamente più bassi. Magari MAQ è prestigiosa nell’ambito di studio delle autrici.
Dipende: se con “prestigiosa” s’intende “con alto impact factor”, allora no, il «Medical Anthropology Quarterly» non è una rivista prestigiosa. Se, invece, s’intende “pionieristica, celebre, storica”, allora lo è eccome, almeno per una disciplina qualitativa e assolutamente marginale come l’antropologia medica. Ed è notevole come sia cambiata l’accezione del prestigio nei quasi quarant’anni neoliberisti che ci separano da allora. Poi si può discutere a lungo sul senso di uno strumento come l’impact factor per valutare la qualità della produzione intellettuale: il Ministero e l’ANVUR marciano spediti in questa direzione (il che già è sospetto…), ma ci sono enormi resistenze in tutte le università, e non solo fra i rappresentanti delle discipline qualitative. Per farsi un’idea della posta in gioco, questo è il sito che indicherei: http://www.roars.it (e, in particolare, l’appello intitolato “Disintossichiamoci”: https://www.roars.it/online/disintossichiamoci-un-appello-per-ripensare-le-politiche-della-conoscenza/). Per il resto, concordo con Wu Ming 1, c’è un rovesciamento logico: l’articolo non dice “chi è felice non prende il coronavirus” ma “ammalarsi di coronavirus in uno stato emotivo che te lo fa temere come mortale è più pericoloso che ammalarsene in una situazione emotivamente tranquilla”.
Se l’intento dell’articolo è dire che: “ammalarsi di coronavirus in uno stato emotivo che te lo fa temere come mortale è più pericoloso che ammalarsene in una situazione emotivamente tranquilla” , questo è un intento avventato allo stato attuale delle cose e che può portare a conclusioni erronee chi non ha conoscenze mediche approfondite.
Pur basandosi su altri studi dimostrati, quali ad esmpio il deficit immunitario in pz ansiosi o depressi, non esiste ad oggi nessuno studio di coorte che suffraghi l’ipotesi che soggetti “terrorizzati” siano più a rischio di mortalità da Covid-19 (se si intende questo con pericoloso) di soggetti “non terrorizzati”.
Quello che si può con ragionevole certezza affermare, e su cui concordo con Wu Ming 1, è che il terrore causato dalla pandemia, il vivere nella paranoia e nella paura morbosa, influiscono negativamente sullo stato complessivo di salute degli individui, considerando lo stato di salute non il semplice avere o non avere malattia da Covid-19, e soprattutto influisce sullo stato di salute di una società.
Una cosa però credo si possa dire con ragionevole sicurezza: a causa del clima di terrore molte persone con sintomi di infarto e ischemia NON hanno chiamato il 118, per paura di contagiarsi in ospedale, o per paura di distogliere i medici dall’emergenza principale, e sono morti.
“Nello periodo 20 febbraio-31 marzo, infatti, il numero di accessi in pronto soccorso per ischemie e infarti in tutto il nord Italia è calato del 30%, secondo uno studio pubblicato sull’autorevole New England Journal of Medicine. Allo stesso tempo, le morti per arresto cardiaco sono aumentate del 60% nelle province della bassa Lombardia. Lo dimostra altro studio di prossima pubblicazione sulla stessa rivista condotto nelle province di Cremona, Pavia, Mantova e Lodi, dove i decessi per crisi cardiache sono addirittura triplicate.”
https://ilmanifesto.it/quei-11-600-morti-fantasma-mai-conteggiati-a-marzo/
Ho letto due volte l’articolo. Ne apprezzo l’approccio generale: il riferimento ai media, la critica legittima e in buona parte condivisibile sulla gestione politica dell’emergenza COVID (sulla scia delle posizioni espresse da WuMing), l’esortazione a non sottovalutare i disastri psicofisici causati dall’isolamento. D’altra parte, alcune affermazioni mi sembrano troppo nette. Parafrasando il testo, spero che le mie perplessità non siano considerate tradimento. Già il riferimento alla credenza sulle virtù terapeutiche dell’arsenico e all’improbabilità (non all’impossibilità) che tale credenza possa guarire le persone mi ha fatto venire il magone. C’è poi tutto il discorso sull’effetto nocebo (“aspettarsi la malattia aumenta la probabilità che la malattia attesa si presenti”), che “può manifestarsi globalmente su un’intera popolazione esposta a una circostanza percepita o descritta come rischiosa”. Allora, mi è venuta in mente Taranto: le persone che vivono a Tamburi e che muoiono o si ammalano di tumore muoiono o si ammalano perché si parla troppo di Taranto e hanno credenze negative? E quelli che vivono nello stesso quartiere e che non si ammalano o guariscono dal tumore non si ammalano o guariscono perché non leggono gli articoli sull’Ilva e hanno credenze positive? Non voglio svilire il ragionamento fatto dalle due autrici. Sono convinto che l’affetto placebo e nocebo si presenti in determinate situazioni. Ma credo che sia necessario circoscrivere questo ragionamento. C’è un altro elemento. Il discorso sulle credenze rischia di diventare un’arma a doppio taglio, se accolto acriticamente e impiantato in altri domini. Il suo nucleo può essere usato con intenzioni nefaste: il “volontarismo magico” di cui parla Fischer, il mantra capitalistico del “vince chi vuole, perde chi non vuole”. Ovviamente, il pensiero delle due autrici va in direzioni completamente diverse. Ma mi sembra una possibile diramazione. Brevemente, sull’argomento specifico del COVID: perché “paura, panico e paranoia nella popolazione” non hanno fatto gli stessi disastri – per quanto riguarda la mortalità – nel Centro-Sud? Eppure, in Lombardia alla strategia comunicativa della paura si è alternata anche la strategia del #bergamoisrunning.
Scusa Tesnota, ma mi pare che l’articolo affermi in maniera inequivocabile che l’effetto nocebo può essere stato un cofattore della malattia, ma non certo sullo stesso piano di altri. Quindi chiedersi, come fai, se la popolazione di Tamburi muore di cancro perché si parla di Taranto, non è “svilire il ragionamento delle due autrici”, ma reanderlo in macchietta, cosa che non merita di sicuro.
Sulle differenze tra Lombardi e Centro-Sud, è chiaro che – a parità di “paura tossica” e di “effetto nocebo” – tanti altri fattori possono spiegare le differenze di contagio e mortalità. Di nuovo, in nessun passaggio dell’articolo le autrici suggeriscono che mortalità diverse in luoghi diversi si devono spiegare sempre e solo in termini di “effetto nocebo” e paranoia. L’articolo ipotizza, con molti caveat, specie nel finale, che alcuni record negativi dell’Italia in termini epidemiologici possano anche – e si sottolinea anche – spiegarsi in termini di effetto nocebo. Il che, peraltro, non coincide con l’affermazione, tutto sommato banale, che situazioni di stress psicofisico incidano sulla nostra salute. Significa, ben più radicalmente, che il terrore di ammalarsi contribuisce – anche solo in minima parte – ad ammalarsi. Il che attribuisce comunque una terribile responsabilità a chi fomenta un clima di terrore di fronte a una pandemia.
Care autrici, il vostro approccio, per quanto in questo caso porti a conclusioni sulla controversa gestione di questa pandemia che ritengo molto condivisibili, mi lascia davvero perplesso. Quello che mi sembra di capire e’ che l’effetto nocebo non sia semplicemente l’opposto del placebo (prendo una finta medicina e mi sento meglio) che sarebbe: mi danno una medicina senza che io lo sappia e non guarisco. Vedo un salto logico fra questo e quello che descrivete voi: ti dico che sei malato anche se non lo sei ed in qualche modo lo diventi.
Considero logico che se ti dico che ti ammalerai di X e poi ti ammali magari di Y puo’ essere che ti sei innervosito e combini pasticci, che hai una reazione psico-somatica, che ti viene un raffreddore che altrimenti non noteresti. Quindi il mio malocchio ha funzionato, a patto che in maniera diretta o indiretta la vittima sappia di averlo ricevuto, ad esempio grazie a sguardi truci, isolamento della societa’, soffiate. Quindi fino a qui sono d’accordo.
Dove mi perdo e’ nella correlazione tra predizione X e stesso effetto X. Nel caso di un virus soprattutto, se non ti mando il virus nel pacco da lettera non lo puoi prendere. Quindi il voodoo o l’allarmismo pubblico in questo caso possono solo funzionare sui sintomi, non sull’infezione. D’altro canto una buona dose di informazione e’ fondamentale: pensiamo all’AIDS. Con le campagne informative si’, qualcuno potrebbe aver sofferto piu’ sintomi, ma molti in piu’ si sarebbero ammalati. Farei una certa distinzione fra un mal di testa o un aumento di battito cardiaco, dovuti a mille cause, ed una malattia virale.
Sempre a questo proposito: cosa ne pensate di questo quadro riguardo alle “patologie” mentali? Ritenete che la gente stia mediamente peggio a causa di tanti nomi specifici per disturbi lievi o passeggeri a cui pochi avevano precedentemente dato peso? (io temo di si’)
eh se siamo già perplessi quando siamo d’accordo figuriamoci come siamo quando abbiamo idee incompatibili. comunque mi permetto di rispondere sinteticamente e senza pretese di esaustività (ci mancherebbe. qui si studia da tempi immemori. non si pretende certo di riuscire ad intendersi con poche parole): penso che per il momento se riuscissimo a capire, o se non altro a cercare di capire, le problematiche a livello di struttura per così dire materialistica (perdonatemi la semplificazione) potremmo considerarci già bravi. invece relativamente alle cosiddette “patologie mentali” (tutto relativo comunque. e non lo dico per autocomprensione. penso sia davvero più problematico) direi che se riusciremo a capirle tra qualche decennio (percezione temporale comunque soggettiva) dovremmo ritenerci comunque studiosi con cognizioni esemplari. nel senso letterale di “a titolo di esempio”(infatti le considero decisamente più complesse. ma è opinabile in quanto inscindibile. come si è detto e ridetto finora). poi esistono diversi tipi di esempi, ed è comunque rischioso esemplificare. affidarsi all’intuizione (che detta così sembra semplice ma sappiamo che non lo è) penso sia più logico(ovviamente si parla di una logica non propriamente, come dire, standard).
poi il discorso è a mio parere davvero molto semplice. o meglio non è che sia semplice. però non è neanche così complicato. questi tempi di reclusione dettata (nel senso di diktat) da non si sa bene quale entità ci hanno condizionato un po’ tutti. e non sappiamo come immaginare il futuro. probabilmente non lo sapevamo neanche prima però forse tra ritmi lavorativi, famiglia, impegni vari, si tendeva a tergiversare sulle domande e di conseguenza sulle possibili risposte. intendo a livello di società. non che questo periodo sia stato propedeutico a qualcosa. personalmente facevo volentieri senza. anche perché un decennio fa mi capitò di essere reclusa sul serio perché avevo un pensiero, come dire, tendenzialmente differente dalla “narrazione” corrente (corrente da secoli oltretutto. quindi non è che si può pretendere di cambiare la narrazione così come se niente fosse). il mio pensiero da allora è comunque evoluto, e per fortuna. però il contesto sembrerebbe il medesimo: quando si hanno delle visioni che sono considerate “non scientifiche” (nel senso diffuso del termine e per essere eufemistici) si rischia l’ingabbiamento. detto questo devo ammettere che per me questi mesi non sono stati particolarmente costrittivi. ho continuato a fare le cose per me essenziali (con qualche timore di multa. ma senza farmi condizionare troppo. e infatti tutto sommato non mi hanno imparanoiato più di tanto. diciamo livelli standard di paranoia. come tutti all’incirca). ma volevo soltanto dire: la scienza è sperimentazione. la verità probabilmente non esiste e se esiste dovremmo comunque cercare di crearla. questo dona spazio a possibilità ipoteticamente importanti. ma dipende da come ce la giochiamo. pur essendo consapevoli che non stiamo certo parlando di un gioco. si potrebbe parlare all’infinito di queste tematiche. e va benissimo così
Propongo l’esperimento di togliere due parole da una frase piuttosto centrale del testo, e vedere cosa succede. Le due parole sono “da Covid”. “è possibile che la gestione della crisi operata all’intersezione fra politiche nazionali e locali e le strategie comunicative delle istituzioni pubbliche e dei grandi mezzi d’informazione abbiano innalzato il rischio di mortalità da Covid-19 anche – e sottolineiamo: anche – inducendo paura, panico e paranoia nella popolazione”.
Se togliamo “da Covid”, siamo tutti d’accordo (e si possono lasciare stare sia Taranto che l’epigenetica): le politiche istituzionali e mediatiche hanno innalzato la mortalità, folle ingestibili di pazienti (in prevalenza anziani con sintomi influenzali gravi, che in assenza di epidemie globali, come ha commentato in tempi non sospetti l’epidemiologo L. Salmaso, sarebbero stati tenuti a casa o nelle RSA), mettendo KO la sanità ospedaliera e con essa migliaia di altri pazienti. Pronto soccorso svuotati a più riprese per arrivo infetti, cardiopatici che rinunciavano alle cure per terrore del contagio, scarsità di medici, infermieri, persino bombole di ossigeno. Certo che aumenta la mortalità (anche quella di una normale influenza)! Ma attenzione: è mortalità “per Covid” quella che è aumentata? Nessuno sa quale sia la frazione di pazienti che è deceduta a causa del virus, perfino la coppia delle ore 18, almeno inizialmente, teneva a sottolinearlo. Quel che si sa, ad ora, è che il picco di mortalità dei due mesi più caldi è superiore (forse del doppio, a giudicare dagli ultimi dati non aggiornati che ho visto) del picco del periodo corrispondente di tre anni fa.
Finalmente posso leggere in questo articolo (e in tanti altri del blog) un punto di vista che aimè in questo periodo ho potuto condividere poco, trovando anche nei “compagni” il muro e la derisione quando ho provato ad avanzare dubbi e indignazione per le misure di chiusura. Dubbio = non sei alla sorte dei “nostri vecchi”, quando la retorica su questo argomento è stata così rivoltante e smascherata da quello che abbiamo scoperto sul Pio Albergo Trivulzio.
Come è possibile che non si sia capita questa ipocrisia, in un paese di anziani dove degli anziani non è mai importato niente a nessuno?
Sono gli stessi anziani che vivono con meno di 1.000 euro al mese, gli stessi che rinunciano a curarsi, che sono soli o con le badanti pagate da loro, che finiscono maltrattati nelle Residenze.
Si vorrebbe far credere che questo incatenamento diffuso, fisico e mentale, sia stato fatto per proteggere loro? Eppure lo abbiamo visto tutti l’armamentario del Truman show della paura, lo snocciolare dei morti, feriti e contagianti tutte le sante sere, la processione ostentata dei camion militari.
Paura e distanziamento sociale, un dittico micidiale che si è tramutato in un esperimento di deprivazione sensoriale collettiva, con divieti su divieti in nome della salute e necessariamente accettabile senza discutere.
Personalmente è proprio il concetto di “distanziamento sociale” che mi fa rabbrividire, si potevano chiamare “misure di precauzione”, “comportamenti di protezione”: distanziamento sociale è proprio il contrario di quello che il mio istinto umano e la mia storia personale e politica mi hanno sempre indicato come percorso da seguire.
Il confine si è spostato sulla porta di casa e mi sembra un epilogo pericoloso, che rende pervasiva anche la paura di andare oltre la soglia (o di far entrare qualcuno nella propria area).
E ora che siamo nella “Fase 2”, si aggiunge un’altra paura: se qualcosa non andrà come deve andare (secondo il cenacolo dei sapienti) si richiude tutto. Oppure prospettare la nuova ondata del virus in autunno, con un effetto fisarmonica e una tensione perenne che rende incerto ogni orizzonte temporale.
Solo il senso critico, il ragionamento e l’azione collettiva possono tutelarci.
Riguardo al post di Caloges
In realta’ l’aumento di mortalita’ (stando ai dati ISTA ufficiali) è relativo solo al nord. Al centro sud si ha in media una piccola diminuzione (-1,8%).
Interessante è anche che a Roma e provincia (quasi 4,5 milioni di persone) c’è stato ben il 9,4 % di mortalita’ IN MENO. Su un campione così grande non puo essere una oscillazione statistica. Allora o a Roma il COVID è benefico, o SS Pietro & Paolo ci hanno raccomandati al Principale, oppure in relata’ il numero di decessi che manca è avvenuto nei mesi precedenti. Ovvero forse da noi il COVID girava gia’ in autunno e nessuno se ne è accorto.Aggiungo che questo dato (-9.4 %) non è stato commentato o giustificato in nessun modo nella stampa mainstream
Andrei cauto nel trarre conclusioni. Ad esempio non hai considerato che una diminuzione della mortalità è invece normale che avvenga nelle zone meno colpite dal virus, ma comunque soggette al lockdown totale che abbiamo visto. Barricando le persone in casa riduci di molto altre cause di mortalità, quali traumi, incidenti sul lavoro e lo stesso circolare dell’influenza comune che solitamente porta ogni anno la sua quota di morti.
Inoltre il dato è stato sia commentato dal ISS sia pubblicato su un giornale mainstream come Repubblica.
Ti lascio il link all’articolo che ne parla:
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/05/05/mortalita-le-due-italie-dellistat-a-bergamo-568-a-roma-1014.html
Si certo, l’aumento è stato solo al nord, ovvero dove ci sono stati più decessi etichettati come Covid, ed anche dove ogni anno ci sono più decessi per influenza. C’è un grande, inspiegabile dato mancante (che manca, pervicacemente, dall’inizio della vicenda): la percentuale di sieropositivi (non il dato aggregato, che comunque manca pure quello, ma disaggregato per territori). Questo potrebbe dare risposte alle tua ipotesi sulla ragione dei diversi dati di mortalità. Certo, scoprire se a Bergamo sia ormai sieropositivo il 60% della popolazione e a Lampedusa lo 0,005, oppure se in Italia ci si aggira sul 15 % ovunque, cambierebbe molto in termini di analisi dell’accaduto, e costringerebbe anche, magari, ad applicare norme restrittive diverse (o a sopportare reazioni diverse dei cittadini alle restrizioni). Forse qualcuna di queste conseguenze non è gradita.
Buongiorno, è il mio primo commento e temo di andare già un poco fuori tema ma, leggendo il passaggio sulla stregoneria capitalista, il mio pensiero è andato a questa notizia che tocca da vicino, purtroppo, la mia realtà familiare
https://www.afr.com/companies/professional-services/mckinsey-bcg-and-bain-advice-on-surviving-covid-19-20200505-p54pwm?fbclid=IwAR1IgMPu2fRtlRyzPcQHoyap1zlS2VvxWMkcy0hqpb4-O8V8dSa_-idpCfk
La notizia è tanto più preoccupante quando si riflette sul fatto che nella Task Force, che ha di fatto sostituito il Parlamento, ci sono diversi rappresentanti di queste società di consulenza http://www.governo.it/it/articolo/task-force-la-fase-2-il-comitato-di-esperti-materia-economica-e-sociale/14453
E a questi link, ci si può fare un’idea di cosa siano queste organizzazioni e chi abbia consegnato loro le chiavi del Paese
https://altreconomia.it/i-big-three-della-consulenza-mondiale-sconosciuti-e-potenti/?fbclid=IwAR3BEGhfcljlGzY6yRswdDAHg2KA-UsW8A1Y1yKjGGc3KZB4ref7VXireeg
Mi chiedo se il lockdown sia funzionale e artificialmente prolungato al fine di consolidare le rendite di posizione di certe consorterie di affari che ruotano attorno a queste società di consulenza : si tratterebbe di un ‘accelerazione improvvisa e incontrollata verso la “democrazia digitale” che proprio democrazia non è, a mio parere (http://www.beunsocial.it/cosa-e-la-democrazia-digitale-parola-ad-adl-consulting/?fbclid=IwAR3leLg8-EtZuLBp3eVuZN1ngADDgtdvOFnUZVtm-ihBCwVgmz2R3DBox-4)
L’inizio di un secondo post lungo non può che essere un “grazie!”: a questo spazio di discussione (effettivamente unico, oggi, nel panorama nazionale), a Wu Ming che lo fa vivere, a tutti quelli che si sono presi la briga di leggere il nostro primo post e scrivere: commentando, aggiungendo temi e osservazioni, reagendo. Qui proviamo a raccogliere a fattor comune alcune delle questioni emerse e tentiamo una risposta più generale.
A partire dall’epistemologia. Fra Popper e Kuhn, scegliamo senz’altro l’anarchico Feyerabend. Ma non solo: il “giro lungo” dell’antropologia insegna che esistono sul pianeta (a volte lontani, altre volte più vicini, sempre piuttosto invisibili) una miriade di mondi umani assai differenti dal nostro. Si può scegliere di squalificarli come “arretrati”, “primitivi” o “selvaggi”, rinforzando così l’inconscio suprematista che ci perseguita da quattrocento anni; oppure ammettere che hanno la stessa dignità ontologica ed epistemologica della nostra modernità fatta di colonialismo, capitalismo, stato, individuo monadico e scientismo.
Questa seconda via comporta una difficile messa in discussione di tutti assunti che regolano la modernità e quindi anche le nostre menti, le nostre reazioni, le nostre credenze. In etnopsichiatria si parla di controtrasfert culturale: banalizzando un po’, è l’effetto che ci fa il fatto che altri pensano, conoscono, vivono, curano e costruiscono relazioni in modo diverso dal nostro. È la risposta che diamo allo straniamento e tipicamente, la prima reazione è di angoscia, un pugno allo stomaco: accorgersi che il mondo potrebbe non essere come ce lo hanno sempre descritto fa male. Reazione ecumenica: colpisce tanto i leghisti, che rispondono con il pogrom, quanto le/i compagn* antifascist*, che a volte rispondono con una riconferma allarmata della nostra visione (ad es., la separazione di corpo e mente, di oggettivo e soggettivo, di umano e animale ecc.) e con versione paternalista dello scientismo (ovvero con l’ideologia della Scienza come sola salvezza – ciò che s’è visto, infatti, durante l’emergenza).
Qui c’è, per i/le pronipot* del pensiero utopico e rivoluzionario, un nodo cruciale. Se ammettiamo che la modernità che ci plasma è fatta di colonialismo, capitalismo, scientismo, stato e individuo monadico, dobbiamo per forza porci una serie di domande scomode: si può essere anticapitalisti senza essere anche antiscientisti? si può criticare lo stato e continuare a pensare che i popoli amazzonici sono arretrati? si può stare nella complessità senza mettere in discussione la scissione fra res cogitans e res extensa? si può immaginare un modo diverso di vita senza mettere in discussione l’individuo monadico? Secondo noi, no.
Sempre secondo noi, stare nella complessità significa oggi essere in grado di rivolgersi anche al di fuori del nostro mondo per progettare la nostra società, strutturare le nostre relazioni con gli umani e non umani, rivedere il nostro rapporto con la vita e la morte. Abbiamo bisogno di punti prospettici lontani, di esperienze e costruzioni di senso supplementari, per affrontare le questioni del presente, sia quello ordinario che quello straordinario.
Su questo sentiero non ci sono certezze né risposte assolute, la possibilità d’errore è ineliminabile. Il che significa che bisogna fare continuamente attenzione, e cioè uscire dalla presunzione di oggettività e di verità assoluta di cui, come bambini, continuiamo ad aver bisogno. Qualche traduzione operativa, in linea con gli eventi:
(1) affidarsi alla presunta oggettività assoluta dei numeri e al verbo dei tecnici è ciò che ha fatto il governo, esautorando la discussione parlamentare e la complessità che questa avrebbe portato;
(2) la presunzione di superiorità del nostro mondo rispetto a tutti gli altri è ciò che ha impedito di applicare fin da subito i protocolli ampiamente sperimentati, con professionalità elevatissime, nelle molte epidemie extraoccidentali degli scorsi decenni e ben noti in letteratura – “tanto le malattie infettive sono un problema da sottosviluppati…”;
(3) l’adesione alla separazione cartesiana fra soggetto intenzionato e mondo inanimato ci impedisce di vedere che le cause di malattia non sono solo interne ma anche esterne: sociali, relazionali, ambientali ecc.; e rende opachi i rapporti fra quel che pensiamo, quel che ci dicono, quel che crediamo e ciò che succede ai nostri corpi (non per niente, son vent’anni che metà di noi arriva a fine giornata solo grazie a supplementi farmacologici, legali o illegali, e neppure ci sogniamo di mettere in causa le ragioni sociali della depressione).
(4) il contatto fra persone e il saluto ai morti possono essere considerati superflui solo in un mondo già organizzato per isolare i soggetti e renderli dipendenti dalla connessione in rete e dal consumo, anziché dalla presenza di altri e da relazioni sensate, politiche, fra umani. Se temiamo le derive moralistiche di una medicina che “cura il paziente” anziché la malattia, che dire della politica medico-igienica che pretende, oggi, di normare globalmente le distanze interpersonali, dettando a tutti una vita a “tolleranza zero”?
La vita è intrinsecamente rischiosa, e lo è su tutti i fronti. Ci servono piste, modi e sperimentazioni per affrontare il rischio, qualunque esso sia, con intelligenza e sensibilità. E anche con una certa allegria: “Rendo noto che tra i partigiani non c’è melanconia!”, scriveva, in tempi cupi, un giornale murale ligure partigiano.
Grazie della lunga risposta collettiva.
Io che leggo “cose” senza averne i requisiti ho cercato un bignamino del pensiero di Feyerabend su Wikipedia per capire più o meno di cosa si trattava :)
Mi è piaciuto molto quel che ho letto.
Aggiungo una mia risposta personale alle vostre domande scomode:
«si può essere anticapitalisti senza essere anche antiscientisti? si può criticare lo stato e continuare a pensare che i popoli amazzonici sono arretrati?»
No a tutte e due le domande. Che poi erano tre ma su monadico mi fermo.
No soprattutto se per “scientista” si intende la scienza “di regime”, quella che qui abbiamo imparato a conoscere come “non neutrale”.
Il che però è problematico perché rischia di aprire la porta non, come sarebbe necessario, a “altri punti di vista scientifici” anche completamente al di fuori del paradigma accettato, ma a punti di vista che negano la scienza pur stando interamente e comodamente nel paradigma occidentale.
Ripeto, lo vedo in parallelo nel mio ristretto ambito, dove allo sfruttatore ambientale (magari negazionista climatico o abile nel greenwashing) si oppone l’ambientalista “da salotto” senza nessuna base scientifica né vera esperienza della gestione dei sistemi naturali.
Devo dire che io ho fortissimi dubbi sugli enunciati 1 e 2, soprattutto sull’1. Il “governo” (nel senso più ampio del termine, io non credo certo che a decidere sia Conte) secondo me ha solo alluso a dei numeri ma si è guardato bene dall’analizzarli “oggettivamente”, ammesso e per nulla concesso che esistano i numeri oggettivi. Anzi, i numeri avrebbero portato da un’altra parte. Purtroppo io non ho strumenti e competenza per discutere approfonditamente delle questioni sollevate dalle autrici, però mi piacerebbe che si facesse una qualche distinzione tra “scienza” e “scientismo”, perché un effetto perverso del dibattito alimentato dai blastatori è quello di convincere la gente che siano la stessa cosa. Almeno a mio parere non lo sono e vorrei non correre il rischio per questo di buttare a mare la “scienza”, intesa come processo di conoscenza continuo, con la possibilità di fissare dei punti, fermi ma non immutabili. Di “oggettivo”, in qualsiasi senso si intenda il termine, nei provvedimenti italiani, c’è pochissimo, quasi niente.
Sul punto 2 non so, sono perplesso, perché lo vedo più legato al punto 1 che ad una modalità, scusate la banalizzazione, “che ci frega di cosa hanno fatto quei selvaggi asiatici”. Potreste avere ragione voi (potrei anche non aver bene afferrato il vostro punto per la verità) ma a me sembra che non si sia guardato neanche cos’ha fatto il Veneto, per esempio.
La questione del Contro Transfert Culturale, accennata qui sopra, ci pare avere molto a che fare con l’assenza dello sguardo antropologico dall’orizzonte concettuale di discipline che partecipano a definire le politiche sociali in generale e quelle dell’emergenza in particolare. La ricerca in modalità analogica per mezzo della giustapposizione di sguardi “da fuori” non permette di mantenere la linearità e l’incrementalità (=il “progresso”) del discorso scientista occidentale. La nostra esperienza di ricerca, così come quella applicata, ci obbliga continuamente a prendere atto che non si riesce a muovere alcun passo propriamente antropologico prima di avere lavorato, e quindi iniziato a decostruire, la colonizzazione di corpi, menti, anime e processi nostri e altrui. Senza questo passaggio non è possibile lasciare andare realmente della posizione di superiorità epistemologica, ci si limita a moralizzarla. È proprio lo scandalo epistemologico di questioni irriducibili come la morte per voodoo a rendere lo sguardo da fuori, “il giro lungo dell’antropologia” di cui Francesco Remotti discute in diversi testi, così scomodo. Eppure così fecondo.
A Giovenale
Ragionevole, ma i conti non tornano lo stesso. Il 10% tra febbraio e marzo è un numero grosso, e non mi è chiaro affatto allora quale sia l’impatto del COVID a Roma e provincia. Se per il resto d’Italia vale la logica che il numero in piu’ di decessi è grosso modo da inputare al COVID, a Roma quale è questo impatto? Come minimo trascurabile, dato che il saldo con la diminuzione delle altre maltattie (essenzialmente influenza) è largamente positivo. Seguendo questa logica ogni anno dovremmo fare un bel lock down a Roma, si salverebbero molte persone. E’ cosi?
Il periodo di riferimento va dal 20 febbraio al 31 marzo 2020.
I decessi totali nel periodo di riferimento sono stati 3757 rispetto ai 4122 che sono una media dei decessi totali nel periodo 20 febbraio 31 marzo negli anni 2015-2019. L’impatto del COVID-19 sui decessi a Roma e provincia è stato, al 31 marzo 2020, di 133 decessi.
Fermo restando che è presto per analizzare questi numeri, e che andrà visto il rapporto sul secondo trimestre, si può intanto osservare che il periodo di riferimento per il 2020 include un lockdown totale di 20 giorni (11 marzo- 31 marzo), che in una provincia a bassa diffusione può almeno in parte giustificare il calo percentuale di decessi, che in valore assoluto si traduce in 365 decessi in meno.
Ovviamente ciò NON motiva in nessun modo l’eventualità di un lockdown annuale nel dato periodo.
Per chi fosse interessato al rapporto aggiungo il link diretto:
https://www.istat.it/it/files//2020/05/Rapporto_Istat_ISS.pdf
Da antropologo mi fa molto piacere trovare un articolo di colleghi, e vi ringrazio di averlo postato. Confesso però che mi ha lasciato molto perplesso perché da un punto di vista epistemologico lascia abbastanza a desiderare. Le autrici prendono una teoria studiata su altri contesti e la applicano su un nuovo contesto senza averlo studiato! Cioè le autrici non hanno fatto nessuno studio, ma si basano sulla lettura di giornali e sulla loro esperienza… come tutti noi. L’antropologia si basa su un metodo induttivo, cioè che prima studi il particolare e poi, se riesci, vai verso il generale, ma non che c’è una teoria generale e tu la applichi dove vuoi tu. La paura può certo aumentare la mortalità, ma in modo cosi rilevante? E siamo sicuri che il fatto che il governo abbia risposto con misure estreme non abbia anche tranquillizzato alcune persone mostrando di essere presente e di non abbandona i cittadini? Non ho le risposte a queste domande, ma non bisognerebbe darle per scontato come fanno le autrici.
Chiusura su Agamben. Mi sembra abbastanza superficiale dire che le critiche a Agamben denotino un accettazione acritica del lockdown. Agamben nei sui articoli sul Covid ha solo confermato le sue due teorie che ci propina da 30 anni. Atteggiamento ben poco scientifico vedere nella nuova realtà la conferma di quanto uno dice da decenni. Agamben ha sostenuto di aver trovato il “paradigma della modernità” (parole del suo ego) basandosi su pochi esempi generalizzati a tutta la modernità. Ci sono molti studi che le confutano infatti. Forse uno degli effetti positivi di questa pandemia potrebbe essere di prendere meno sul serio Agamben.
Io non sono un fan di Agamben, del suo approccio, dell’alone che ha intorno, del suo stile apodittico che a volte mi sembra fare da paravento retorico a una certa faciloneria. Faciloneria in cui a mio avviso è incorso anche negli scritti di questa fase, pure caratterizzati da preoccupazioni giuste e denunce non lontane dalle nostre. A volte ha dato l’impressione di leggere se stesso e nessun altro, e abbiamo dovuto farlo notare, come quando ha parlato di “silenzio dei giuristi” (!) sui dpcm e i divieti. L’articolo più “tirato via” era il primo, ormai famigerato, dove c’era un monito importante, purtroppo rovinato da un excursus sulla “epidemia inventata”, ma ha tirato via anche dopo.
Detto questo, Agamben non è stato attaccato principalmente da altri filosofi nell’ambito di una tenzone (o regolamento di conti) tra “scuole” e correnti. C’è stato anche questo, sì, diversi accademici di spicco o di sottobosco hanno pensato che, durante una pandemia e mentre ci mettevano in massa agli arresti domiciliari, la priorità fosse cogliere le balle al balzo per una rivalsa su Agamben. Ma questo è accaduto in una nicchia al limite dell’irrilevante (e, va bene, può anche darsi che in certi casi non sia stato fatto in nome di un elogio acritico del lockdown).
La stragrande maggioranza degli attacchi Agamben li ha subiti da “profani”, giornalisti, “influencer” da quattro soldi, iene da social, wannabe vigilantes dell’opinione pubblica, agitatori (ma soprattutto agitati) di complemento al terrorismo mediatico, tutti intenti a descrivere l’odiato intellettuale come fosse un criminale stragista, ed è ben difficile sostenere che la linea di costoro non fosse l’apologia del lockdown. Insomma, cerchiamo di guardare oltre la staccionata che delimita l’orticello dell’accademia. Anche perché l’anti-intellettualismo emerso – anche e soprattutto a “sinistra” – durante il linciaggio socialmediatico di Agamben è un problema che riguarda tutte e tutti noi.
Temevo che il mio punto di vista potesse essere troppo “accademico”, ma visto che l’articolo partiva proprio da un approccio così mi sono sentito di far comunque quel commento.
Sono d’accordo con te riguardo Aganbem, soprattutto sui problemi dell’anti-intellettualismo, anche di sinistra.
Uso i social, ma non abbastanza da farmi un’idea completa sui vari dibatti (come magari potete fare voi). Segnalo una cosa curiosa, senza pretendere di confutare quello che tu dici perché probabilmente è un fatto minoritario: ho visto citare Aganbem soprattutto da complottisti (amici miei) che lo usavano per criticare il lockdown.
Sì, sappiamo. Qui si stratificano due questioni, e ogni strato è un patchwork di cazzi amari tipo inner sleeve di Frankenchrist dei Dead Kennedys.
La prima questione è che, avendo la “sinistra” in buona parte delle sue varianti sposato il lockdown e attaccato chi lo problematizzava, si sono lasciate vaste praterie libere allo scorrazzare complottistico;
la seconda è che, mentre noi siamo stati attentissimi a non giocare nemmeno inavvertitamente di sponda con cospirazionismi e neppure con “riaperturismi” destrorsi, mettendo sempre paletti, rimuovendo eventuali link lasciati da utenti verso Byoblu, Luogo Comune, Oltre la linea e siti simili, Agamben non sembra aver avuto preoccupazioni analoghe, visto che ha rilasciato un’intervista a La Verità. Noi non lo avremmo mai fatto né mai lo faremo. Se un convento “di sinistra” (o persino “di movimento”) ci rifiuta l’accoglienza per la notte, non bussiamo certo a un convento di destra: dormiamo sotto il cielo stellato. E se piove, cerchiamo un portico, una tettoia, una sporgenza di roccia.
L’avvertimento sui rischi di un punto di vista limitato al perimetro dell’accademia non riguardava la parte antropologica del tuo commento, ma appunto il pensare che Agamben sia stato attaccato solo da chi trova inconsistenti o sbagliate le sue teorie filosofiche. No, è stato attaccato principalmente per difendere il governo.
Mi scoccia far la parte del rompipalle e cerco perciò di non soffiare sul fuoco, ma mi pare che la tua digressione epistemologica, Subatra, sia male indirizzata. Le due colleghe fanno un lavoro egregio che non fonda nessuna teoria più generale – o inedita – di quelle ipotizzate dai nomi importanti che anzi, con una certa generosità, citano. Le analogie possono essere contestate, alla bisogna, nel merito. Odio il clima da parrocchia (sono anche io del ramo) ma, specie su Agamben e sui tuoi amici sui social, forse come “accademico” devi aggiornare le tue letture, se non le frequentazioni. Trovo che WM1 abbia descritto con buona fedeltà cosa è accaduto ad Agamben, detto da me che non l’ho mai amato. Grasso ha detto cazzate incredibili e pure Nancy si è accartocciato su quella storia dell’operazione al cuore che è quanto di più intellettualmente obliquo si potesse scrivere. Ma appunto, mi fermo qui. Scusate.
Non ho detto che hanno preteso di fondare una nuova teoria, ho detto che prendere studi fatti su un contesto X non possono essere applicati, senza nuovi studi, in un nuovo contesto. Soprattutto in antropologia che è una scienza del particolare.
Magari il mio commento può essere stato troppo tecnico, e un po’ duro, ma non sono mancato di rispetto alle autrici, cose che mi pare tu stia facendo con me. Mettere accademico tra virgolette… dirmi di cambiare letture quando neanche sai che cosa leggo. Per non parlare dell’invito a cambiare frequentazioni… Solo perché ho tra i miei contatti qualche persona complottista? Sai, io non tolgo il saluto a una persona perché questa ha idee strampalate.
In un paio di commenti che ha lasciato questo pomeriggio, Arcybasev non ha proprio azzeccato i toni. Glielo abbiamo fatto notare in due, confidiamo che ne userà di meno taglienti. Su questo blog teniamo molto alla possibilità di discutere anche a lungo e anche con durezza senza affondi «ad hominem».
Leggo solo ora questo commento e sono dispostissimo a mettere in discussione il modo in cui mi posso, qualche volta e – temo – per una forma un po’ aberrata di “familiarità”, esprimermi. Permettetemi però di suggerire metodologicamente un po’ di flessibilità, per non far tracimare così facilmente questioni di buona educazione (legittime) nel campo della sostanza. Faccio ammenda, per me è una questione importante la tutela di spazi come questo e il loro funzionamento; a ruota anche il rispetto dei padroni di casa. Credo tuttavia che si possano accogliere critiche (in un caso ieri semplici osservazioni dialogiche) senza lanciarsi in profilazioni un po’ premature. In soldoni: vi chiederei un po’ di buona volontà, necessaria soprattutto quando si dispone solo del testo scritto. Forse ne chiedo troppa? Può essere, complice la mia inesperienza in questa sede. Non torno su ciò che ho detto perché mi pare noioso per tutti, preciso solo che, Subatra, non dubito affatto delle tue titolarità accademiche – intrattengo rapporti di convergenza e non con personale perfettamente strutturato – e io stesso non sono affatto un accademico (almeno fino a quando l’istituzione non mi mollerà cento lire, quindi per ora sono salvo). Ho utilizzato l’enfasi solo perché non ho trovato particolarmente pertinente la accademicità (autoattribuita) delle tue osservazioni, il connotato. È senza dubbio la mia opinione, si parva licet, ma mi aspetterei qualcosa di più della sufficienza con cui hai giudicato questo scritto, così come non ho trovato particolarmente “dure” o “tecniche” le tue argomentazioni critiche (che sarebbero tali proprio in quanto accademiche). Insomma l’accademia è piagata da mali orrendi e lo sappiamo tutti, cerchiamo di non diffamarla ulteriormente con l’uso non necessario di etichette un po’ stereotipate da circolo dei capiscioni. Io cerco di non farlo, ciò comunque non ha niente a che fare con la perfetta liceità della tua opinione e di tutte le altre espresse, che come ribadisco considero preziose.
Ho già detto altrove che Agamben e la polemica contro Agamben mi hanno rotto il cazzo, quindi non ripeterò la mia invettiva. Però vorrei dire che di riffa o di raffa ormai esiste un “dispositivo agamben” che serve a troncare ogni discorso critico e di prospettiva sul “dispositivo lockdown”, in un gioco paralizzante di interdizioni simile a quello costruito a partire dalle foibe. Allora fanculo Agamben, e facciamo parlare direttamente Carlo Calenda, il quale oggi ha twittato così:
“Durante questo lockdown abbiamo capito che se lo Stato vuole controllare il territorio ha i mezzi per farlo. Forse dobbiamo capire perché non accade in tempi normali. Approfondiremo.”
https://nitter.net/CarloCalenda/status/1258710796642762752#m
Se anche il fantasma di Sabin arrivasse qua domani col vaccino, e noi organizzassimo un esercito popolare per vaccinare tutta l’umanità, ormai il dispositivo lockdown è entrato nel novero delle cose possibili, e ha acquisito vita propria indipendente dallo stato di pandemia, e non ce ne libereremo tanto facilmente.
Aggiungo che in Slovenia sono settimane che la gente protesta contro lo stato di emergenza imposto dal governo parafascista di Janez Janša, occupando le città con biciclettate antifasciste partecipatissime.
https://nitter.net/karsolin/status/1258818761601228805#m
La Slovenia rispetto all’Italia nel suo complesso è stata colpita di meno dal virus, ma rispetto al confinante Friuli Venezia Giulia, o al mezzogiorno d’Italia, l’incidenza invece è dello stesso ordine di grandezza.
Manifestazioni come quelle di Lubiana in Italia verrebbero stigmatizzate come agambeniane da consistenti pezzi di movimento, anche se si svolgessero in Lucania…
2 mie sensazioni opposte su questo punto (tutte le misure sono qui per restare).
1 – vedo molto nero, e nel mio orticello di genitore penso in primis alla scuola (qui è OT ma sto rispondendo a un discorso più generale).
C’era un articolo del messaggero ieri in cui si parlava delle misure prese a settembre “almeno fino a quando il virus non farà più male a nessuno”.
Il che, con quanto abbiamo visto finora (stesse misure governative per intensità di contagio variabili dalla val Seriana alla Lucania), vuol dire “per sempre”, perché “a qualcuno” il virus continuerà a far male e la situazione della sanità italiana non migliorerà certo.
Anche oggi circolano su chat di wathsapp scenari di lezioni metà in classe e metà a casa in videoconferenza, che sono semplicemente deliranti (devi avere un computer per ogni figlio in videoconferenza, oltre a quello per lo smartworking, e devi avere qualcuno – genitore in smartworking o nonno tecnologico – che si occupi dei bambini nel corso della videoconferenza e della giornata).
Il punto è che se non c’è un soggetto politico che si faccia carico pubblicamente della questione e metta all’angolo le scelte raffazzonate, pigre e autotutelanti del governo, a settembre ci si troverà di fronte al fatto compiuto.
e 2:
di senso assolutamente opposto come sensazione c’è che “la natura” preme, e con l’estate in arrivo e con i problemi economici, logistici delle famiglie e di lavoro che interesseranno milioni di persone forse la “tanatofobia collettiva” lascerà il posto a qualche presa di coscienza più pragmatica.
Abito in provincia e lo sto vedendo succedere.
Le persone escono e si sente che, pur con tutta la diffidenza ormai incancrenita e con le preoccupazioni che tutti abbiamo per i familiari anziani, qualcosa nel “clima generale” è cambiato.
Adesso, secondo me, c’è lo spazio perché molti nodi sollevati nei diari e rimasti inascoltati e respinti nei momenti più caldi della fase 1, vengano finalmente al pettine.
Il “bonus” emergenza e solidarietà nazionale di cui ha goduto il governo finora sta per finire se non è già finito.
Ora, e torno al pessimismo:
qual è il soggetto politico che si farà interprete e portavoce di tutto quello che non è andato bene nella gestione dell’emergenza, e che faccia proposte costruttive e immediatamente applicabili?
Che veda io, a sinistra non c’è nessuno.
Questo intervento mi era sfuggito, come tanti altri (ne leggo giusto qualcuno, non sono un “consumista di commenti”). Ora, mi è chiaro che, da un certo momento in poi, per una serie di motivi, il nome del noto filosofo citato qui compare su questo blog sempre più avvolto in un’aura negativa (parafrasando un altro commento di non so più chi). Non sono un partigiano di GA, non darei la mia vita per lui, soprattutto non la mia libertà di pensiero, ma gli sarò sempre grato per avere preso, a partire dal 26 febbraio, quindi in anticipo sui tempi (anche se devo ammettere che avendo iniziato a visitare Giap soltanto verso metà marzo, non so cosa si scrisse sui post dell’epoca), posizioni del tutto anomale rispetto al mainstream, che personalmente mi sono state di grande aiuto. Poi, non adorandolo, ma leggendolo sempre attentamente, concordo con molto di ciò che dice ma non su tutto. In merito a questo intervento di WM1, ho notato il passaggio in cui si allude a un fatto di cui non so nulla, l’intervista ad A di una testata di destra. Mi ha colpito quel che WM1 dice dopo, “Se un convento “di sinistra” (o persino “di movimento”) ci rifiuta l’accoglienza per la notte, non bussiamo certo a un convento di destra: dormiamo sotto il cielo stellato. E se piove, cerchiamo un portico, una tettoia, una sporgenza di roccia.”. Cosa vuol dire? Davvero A, con il suo indiscusso prestigio, si è comportato così? Mi pare poco credibile, ma chissà, e comunque è un’accusa grave, non tanto aver rilasciato un’intervista a un giornale di destra, ma averlo fatto perché uno ‘degli altri, ovvero di noi’, gliela aveva rifiutata. Sono molto perplesso, e, ripeto, incredulo.
Infine, WM1 chiude escludendo che A “sia stato attaccato solo da chi trova inconsistenti o sbagliate le sue teorie filosofiche. No, è stato attaccato principalmente per difendere il governo”. Non sono d’accordo: avevo letto velocemente l’attacco di Micromega, ma ricordo che il suo direttore ne parlava proprio come di un “cattivo filosofo, d’altronde le prime dichiarazioni di A erano precedenti al lockdown, non (ancora) anti-governative. E soprattutto, se vai su wiki, quel tizio ha una pagina, che lo presenta proprio come filosofo, prima ancora che pubblicista.
Puoi essere incredulo finché vuoi, ma l’intervista è lì per chiunque voglia leggerla. Noialtri a un foglio d’agitazione di estrema destra, che ogni giorno veicola con lo stile che conosciamo contenuti razzisti, sessisti e omofobi un’intervista non l’avremmo mai rilasciata. Poiché Agamben non ci sembra un ingenuo e non è uno alle prime armi, si sarà fatto le sue considerazioni. Quali che fossero, non le condividiamo.
Qui proprio dal 26 febbraio (data di pubblicazione del primo Diario virale) ci facciamo un mazzo incredibile per mantenere fissi certi paletti, per non fornire facili appigli a chi vorrebbe gettarci nel mucchio con complottari e fasci, per non ritrovarci a giocare di sponda con quel mondo. La fase è delicatissima, la sfera di discorso che stiamo mantenendo in realtà non è una sfera, è una fune, bisogna maneggiare la pertica con la massima accortezza, in modo da non cadere né da una parte né dall’altra. Ecco un’altra allegoria, se non ti piaceva quella dei conventi e del dormire all’addiaccio.
Quanto all’altra questione, la maggior parte di quelli che hanno attaccato Agamben dei suoi scritti filosofici non conoscono nemmeno i titoli, non sono nemmeno andati a vederli su wikipedia. Poi c’è una parte che li conosce o almeno li ha orecchiati e, come Flores, vi ha fatto cenno, ma non lo ha comunque attaccato per quelli bensì per difendere lockdown e governo. Infine, c’è una piccolissima minoranza di persone che hanno approfittato del lockdown per regolare con Agamben conti filosofici. Quest’ultima fetta di opinione pubblica è talmente sottile che ci vedi attraverso, come certe “pellicole” di prosciutto con cui alcuni chef fanno precari e pretenziosi origami.
Riporto quanto scritto poco fa: “Mi ha colpito quel che WM1 dice dopo, “Se un convento “di sinistra” (o persino “di movimento”) ci rifiuta l’accoglienza per la notte, non bussiamo certo a un convento di destra: dormiamo sotto il cielo stellato. E se piove, cerchiamo un portico, una tettoia, una sporgenza di roccia.”. Cosa vuol dire? Davvero A, con il suo indiscusso prestigio, si è comportato così? Mi pare poco credibile, ma chissà, e comunque è un’accusa grave, non tanto aver rilasciato un’intervista a un giornale di destra, ma averlo fatto perché uno ‘degli altri, ovvero di noi’, gliela aveva rifiutata. Sono molto perplesso, e, ripeto, incredulo.”
Come mi sembra chiarissimo (e se non lo è si rilegge) la mia incredulità non si riferiva alla pubblicazione dell’intervista su La Verità. Grazie comunque per avermi chiarito che avete cominciato anche voi il 26 febbraio (come lo stesso filosofo di cui si discute) ad occuparvi di questa questione cruciale: davvero non lo sapevo. Buona domenica.
Scusa, ma tocca pure spiegare che un’allegoria ha per definizione un senso figurato, non va intesa alla lettera e il più delle volte vi si ricorre per “mettere in scena” un principio generale? E che quell’allegoria enunciava la nostra linea? È peggio che spiegare una barzelletta…
Sei di Torino, giusto? Conoscerai il caso Costanzo Preve. Molti altri esempi potremmo fare, non riguardassero personaggi ormai innominabili e numerosi scalzacani. Sono tutti cautionary tales: il fatto che il dialogo si faccia più difficile “a sinistra” ha spesso portato questo o quell’intellettuale a dirsi: «Vabbe’, in fondo che c’è di male se rilascio la tal intervista, se partecipo al tal convegno di destra ecc.? Io mantengo la mia indipendenza intellettuale, loro stanno sulle loro posizioni, io rimango sulle mie, allargare il confronto arricchisce ecc. Tanto, la sinistra è ridotta com’è ridotta, cosa devo mai difendere? Parlo solo per me stesso ecc. ecc.»
Ecco, lì comincia il piano inclinato. L’esito della «mossa Preve» è… Fusaro, per capirci.
Ora, quand’anche noi, ipoteticamente, dovessimo ritrovarci nella condizione di ostracizzati, quella mossa lì non la faremmo mai. Meglio dormire all’addiaccio che entrare in certi conventi.
Tornando ad Agamben, rilasciare un’intervista a La Verità è un evidente – nonché l’ennesimo – segnale del fatto che lui non sta camminando sulla nostra stessa fune, si preoccupa poco di eventuali “sbavature” (e nel caso in oggetto è un eufemismo), non sta monitorando le “derive” in corso nella galassia complottista dove i suoi scritti vengono citati strumentalmente.
Ognuno ha il proprio approccio. Il nostro e quello di Agamben sono diversi, e lo diventano sempre di più col passare del tempo.
Mi spiace davvero sapere che il signor Wu Ming 1 abbia dovuto scendere al mio livello per spiegarmi, non una barzelletta, no, di più (o di meno): un’allegoria, Comunque non so chi sia Costanzo Preve, e francamente non potrebbe importarmene di meno (per citare Guzzanti), non vedo cosa ci azzecchi in questa discussione. Rimane che la mia incredulità si riferiva all’affermazione (del genere “qui lo dico e qui lo nego”), piuttosto grave a mio parere, da lui fatta a proposito del noto filosofo, secondo la quale egli, vistosi rifiutare la proposta di rilasciare un’intervista a una testata o un blog di sinistra “(o persino “di movimento” [v. intervento delle 2:15 pm di venerdì 8 maggio])” si è allora rivolto, con assoluta noncuranza e sprezzo delle conseguenze del suo gesto, a un giornale di destra. Ben due risposte di Wu Ming 1 eludono la mia domanda, che rimane, e penso rimarrà, senza risposta. In bella evidenza in entrambe le risposte, l’arroganza del personaggio, tratto grazie al quale ho imparato a distinguerlo facilmente, fra i quattro diversi componenti del collettivo che gestisce questo interessante, e stimolante, blog.
Santa pazienza… Ma chi l’ha scritto che Agamben si sarebbe vista rifiutata un’intervista da un quotidiano di sinistra? Dove l’hai letto? È un’inferenza tutta tua, hai letto nel modo più angusto e pedestre possibile un ragionamento generale sul non fornire sponde alla destra. Che ne sappiamo noi di che rapporti intrattiene Agamben coi giornali “di sinistra”, che ce ne importa?
Ti ho pure fatto un esempio preciso di cos’abbia comportato in passato il “dare sponda”: la deriva innescata da Costanzo Preve negli anni Novanta, sfociata nel fusarismo.
Ebbene, se uno avesse davvero interesse a capire di cosa stiamo parlando e perché ci teniamo a ribadire questi punti, si sarebbe detto: «Uhm, no, di questa storia di Preve non so niente, aspetta che faccio almeno una rapida ricerca in rete…»
Invece no, tu rispondi: «Non ne so niente, non me ne frega niente, non c’entra niente».
Separiamo tra loro le affermazioni:
1) che non te ne «freghi niente» è pure legittimo, ci mancherebbe, ma allora non chiedere spiegazioni, se quando te le danno rispondi che te ne fotti.
2) come fai a sapere che «non c’entra» se non ne sai niente? Magari, informandoti un minimo, avresti capito che c’entra eccome.
Riguardo al resto del tuo ultimo commento, cioè al piagnisteo passivo-aggressivo, sappi che io qui sono quello con più pazienza. Uno qualunque degli altri due membri di Wu Ming – infatti scazzi pure nel contarci: siamo tre, non «quattro» – ti avrebbe già mandato a quel paese.
Qui si viene a discutere, a confrontarsi, e non ci sono santi o guru da venerare.
O si è disposti al confronto, ma disposti davvero, o si va da un’altra parte, l’Internet è grande.
Se uno si aspetta che di Agamben – o di chiunque altro – scriviamo in termini oleografici solo perché “sta dalla nostra parte della barricata”, anziché criticarlo quando pensiamo vada fatto, allora ha decisamente sbagliato blog.
Spero di essere stato chiaro, e che venga apprezzato il mio sforzo di non mandarti dove ti avrebbero già mandato i miei compadres.
Cito, poi mi spiego:
«Sono tutti cautionary tales: il fatto che il dialogo si faccia più difficile “a sinistra” ha spesso portato questo o quell’intellettuale a dirsi: “Vabbe’, in fondo che c’è di male se rilascio la tal intervista, se partecipo al tal convegno di destra ecc.? […]” Ecco, lì comincia il piano inclinato. L’esito della «mossa Preve» è… Fusaro, per capirci.»
Non conosco le realtà di movimento e ormai nemmeno più “di partito”, sono un generico utente con idee di sinistra, e mi ha fatto piacere e incuriosito leggere nel commento sopra dell’inizio del piano inclinato che porta a “Fusaro” e tutta la questione dei conventi in cui cercare riparo per la notte.
Sono dinamiche che mi interessano perché trovo problematico che le “discussioni a sinistra” non escano e non arrivino se non a un ristretto ambiente.
Certo, se uno si interessa, approfondisce, ed è parte di una realtà certe cose le sa e di quel dibattito ha seguito tutti gli sviluppi: colpa se vogliamo “di quelli come me” che, mezzi imborghesiti, ne siamo fuori e che abbiamo “smesso” di informarci sui canali giusti.
Però trovo che sia una spirale (vista da me) da cui la sinistra non uscirà più:
i media mainstream si piazzano nell’arco parlamentare da Renzi vs destra.
[segue]
i media di destra hanno le controindicazioni che hai ben spiegato sopra e in altri commenti e vanno giustamente evitati.
A sinistra c’è una certa qual frammentazione che, parlo per me, a un certo punto non sono più riuscito a seguire.
La domanda / spunto di riflessione non del tutto pertinente è: come fa un elettore di sinistra, magari uno non proprio giovanissimo, che non legge questo blog, a ricevere un flusso di formazione e informazione “da sinistra”?
Come fai (sempre se sei come me un “non addetto ai lavori”) ad accorgerti che il politico tizio per cui magari hai votato negli ultimi 20 anni è diventato rossobruno? (devi avere degli anticorpi e delle basi concettuali belle grosse, per accorgertene da solo, secondo me! Già per capire che cosa si intende per rossobrunismo).
Come fai ad avere il polso di un dibattito come quello che è nato qui sulla pandemia?
Come fai, se persino persone molto istruite con l’abbonamento a internazionale hanno ceduto alla visione mainstream e aderito senza dubbio alcuno alle misure di lockdown?
Per fortuna che c’è Giap.
C’era poi un’altra cosa su cui ho sorvolato prima, anche perché spossato dalla lotta contro il limite massimo di battute. Qualcosa di, palesemente, analogo è accaduto a Zerocalcare, che ha deciso, per motivi suoi, di pubblicare una miniserie di video su repubblica.it, sempre sulla questione lockdown. Lui è molto bravo, e poi mi è simpatico, ci berrei una birra insieme, facendo due chiacchiere. Ma questa sua decisione non mi è piaciuta, probabilmente è un naif, ma chissà. Fra l’altro, io non li ho visti, i video, mi è bastato leggere la presentazione ipocrita e fuorviante che ne faceva la testata ospitante. Si riconosceva, nel frame, la fisionomia, resa con feroce precisione, del governatore lombardo, e il testo parlava di “amara ironia”… Così, come sempre, si stemperava e banalizzava quel che può essere pericolosamente vero e puntuale. Non so se qualcuno ne abbia mai parlato qui, ultimamente, a me pare ne varrebbe la pena: Zerocalcare, perché? Insomma, mi piacerebbe poterglielo chiedere.
A rischio di andare OT, ma da ultra-appassionato di fumetti non posso fare a meno di chiederlo: @musikarol a che serie di video ti riferisci? A quelli di “Rebibbia Quarantine”?
Se ti riferisci a questi, allora devi sapere che è una serie di tv che ZeroCalcare fa all’interno della trasmissione propaganda live tutti i venerdi. l’editore di riferimento è quindi la7, non la repubblica, e non so quanto ZC abbia voce in capitolo sulla rivendita dei contenuti video prodotti per conto dell’emittente di Cairo a terzi.
Aggiungo (per arrivare alle 550 battute) che ho provato a ricercare anche la presentazione sui siti di entrambi per capire dove stava l’ipocrisia che hai riscontrato, ma è stata infruottosa.
Non ci va di infliggere al blog questioni da enclave accademica, quindi procediamo a velocità massima.
(1) L’articolo presenta un’ipotesi, non una teoria. In epistemologia è una differenza cruciale. Infatti abbiamo usato moltissimi congiuntivi e tutte le smorzature linguistiche possibili. Non è dunque “una teoria studiata su altri contesti applica[ta] su un nuovo contesto senza averlo studiato” ma “un’ipotesi timida e minimalista costruita in base a dati relativi ad altri contesti”.
(2) “Le autrici non hanno fatto nessuno studio, ma si basano sulla lettura di giornali e sulla loro esperienza… come tutti noi”: esatto! Come tutti noi. E senza altre possibilità: “fare campo” significa, per definizione, esplorare qualcosa che sta fuori dall’ordinario del ricercatore; con il Covid-19, però, tutto il mondo è stato preso nell’emergenza: non c’è più un esterno. Parlarne significa quindi, per forza di cose, fare auto-etnografia. Pratica discutibile, la cui unica alternativa è il silenzio. Tenuto conto che si tratta di un post su uno dei luoghi più politici della nazione, e che l’intento era quello di mettere la teoria antropologica a servizio del pensiero critico, il silenzio non ci pareva praticabile.
(3) L’antropologia culturale ha passato gli ultimi settant’anno a domandarsi se sia migliore uno sguardo eminentemente locale o se sia più degno il solo approccio comparativo e globale. Oggi, però, il quadro della “conoscenza polverizzata” è abbastanza superato e si può sostenere (con Remotti e Ingold, ad esempio) che non c’è crescita conoscitiva, né utilità sociale, se non si usano i dati, le ipotesi e le teorie in modo enzimatico. Perché infine, come scrive Ingold, “Anthropology is not ethnology”.
è vero che avete detto che era un’ipotesi, ma poi il tono e gli argomenti di tutto l’articolo non sono quelli di chi formula timidamente un’ipotesi.
Comunque non voglio affliggere agli altri lettori una discussione accademica sull’antropologia (che non finirebbe più), quindi mi fermo qui lasciando solo un ultimo commento. Avete fatto bene dire la vostra, e ho letto il vostro articolo con molto interesse. Il punto 2 che avete scritto è un po’ tagliato con l’accetta perché ci sarebbe una terza opzione: prendere un po’ di distanza (ci sono vari modi, il più scontato è prendere tempo). Io ho bisogno di tempo per capire quello che sta succedendo, ma trovo giusto che chi se la sente prenda la parola.
Bravissime, per quanto mi riguarda. Sono stato tentato di intervenire più in alto ma sapevo che sarebbe stato inutile se non paternalistico. Ribadisco, comunque, che alcune contestazioni mi sono parse del tutto bislacche da un “collega”. Non metto in dubbio nulla, ma questa sensazione la devo dichiarare.
Buon lavoro a voi! Lo dico un’altra volta perché ho paura di rimanere sotto il numero di battute: buon lavoro e tante belle cose. Un po’ di antropologia ci voleva, già. Proprio così. Indubbiamente. Eh, si! Chiedo scusa a tutti i 無名 per questo stratagemma abbastanza patetico, ma animato da buone intenzioni.
Purtroppo per me, seguo il dibattito con una certa difficoltà. Ad esempio, non riesco a comprendere la connessione tra anticapitalismo e antiscientismo. Non capisco perché l’uno escluda l’altro o implichi l’altro. L’esclusione è legittima solo se, come indica il cugino di alf, si parla di scienza di regime (ma ricordo anche Lysenko).
Se è vero come è vero che lo scientismo prima o poi sfocia nella fede assoluta nell’uomo, si potrebbe tranquillamente dire, credo, che questa fede può essere sia nell’uomo borghese sia nell’uomo nuovo. Si può trascinare dietro anche la negazione del divino, ma questa è prerogativa sia del capitalismo sia del comunismo.
Non è una questione così teologica, non si tratta di discutere “visioni del mondo”, ma posizioni filosofiche con ricadute pratiche precise. “Scientista” si dice di una posizione per la quale il metodo scientifico applicato e applicabile nelle scienze cosidette “della natura” (in contrapposizione alle scienze umane, il che già è politicamente rilevante) è l’unico valido metodo per produrre conoscenza. Ne consegue uno svilimento di qualsiasi dominio di conoscenza in cui non sia applicabile il metodo sperimentale. Attenzione, perché qui sta la differenza tra scienza e scientismo, per quanto riguarda i temi oggetto di dibattito in questi commenti: non si tratta di uno svilimento di punti di vista non basati sul metodo sperimentale all’interno di un dominio di conoscenza, svilimento col quale molti di noi potrebbero essere d’accordo, ma di uno svilimento di interi campi della conoscenza, perché richiedono altri approcci metodologici e altri tipi di accuratezza.
Lo scientismo è positivista, implica la credenza nella neutralità della scienza e della tecnica, e si fonda sulla dicotomia cartesiana tra soggetti-mente e oggetti-corpo, in quanto afferma che l’unica vera scienza sia qualla che studia gli oggetti-corpo. D’altronde la stessa rigida distinzione tra scienze naturali e scienze umane si fonda sul dualismo cartesiano, e già il giovane Marx aveva qualcosa da dire al riguardo (“nel comunismo non esisterà che una sola scienza!” diceva, più o meno, nei manoscritti del ’44.) Ma, per dirne una, tutta la critica dell’economia politica di Marx sarebbe un’immensa corbelleria per uno scientista. Indagare i rapporti sociali come un qualcosa che si oggettiva alle spalle degli stessi soggetti che producono quei rapporti sociali indirizzando in maniera sostanziale il loro agire soggettivo? E come la fai stare sta roba nella dicotomia cartesiana??
Termino qui il mio intervento da filosofo. Sulle conseguenze più concrete dello scientismo c’è già chi ha detto parecchio (anche nel bell’articolo che stiamo discutendo).
Oggi mi è tornato in mente questo post sull’effetto nocebo leggendo che sembra provato per i canarini che i sintomi di una malattia sui propri simili possono sviluppare risposte immunitarie anche negli individui in cui non ci sia traccia di patogeni. Non è chiaro in che misura serva a difendere i sani da un attacco imminente e se possa rappresentare un pericolo se la risposta risultasse troppo massiccia. D’altro canto, se questa capacità esiste, deve aver avuto un vantaggio evoluzionistico.
Tornando alpost, si potrebbe chiedersi se l’isolamento degli umani ha fatto sì che il SarsCov2 ci ha fatto trovare impreparati oppure la sovraesposizione mediatica ci ha fatto sviluppare risposte immunitarie più aggressive del dovuto (che è un pò il riassunto di cosa è il Covid). Ci sarebbe da capire se siamo come i canarini ed abbiamo bisogno di vedere fisicamente i malati (ed in questo caso non ne abbiamo visti) o basta l’astrazione (numeri giornalieri, polizia, bare di Bergamo).
Paper canarini: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2021.0125
Effetto simile su esseri umani: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797610368064
Riassunto: https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/06/visual-immune-response-birds/619137/