Ci sono coincidenze che hanno l’effetto immediato di schiarirti le idee. Così succede che mentre hai appena finito di leggere il secondo libro di D. Hunter, Tute, traumi e traditori di classe (Alegre, €15), ti capiti sott’occhio l’intervista al direttore del Salone del libro di Torino, lo scrittore Nicola Lagioia, pubblicata sul Corriere il 15 aprile scorso.
La riflessione te la tieni lì a sedimentare, finché scatta la seconda coincidenza: Hunter sarà uno degli ospiti del Salone, cioè in un certo senso ospite del collega Lagioia. E siccome nel frattempo è passata qualche settimana, decidi che quella cosa che hai lasciato lì a macerare, devi buttarla fuori, altrimenti irrancidirà e ti pungerà il fegato.
Cos’aveva dichiarato Lagioia? È presto detto: che nel dibattito sulla guerra in corso in Ucraina manca «un ragionamento sul fallimento del genere umano». Secondo Lagioia sarebbe necessario riflettere sul fatto che se l’umanità, dopo millenni, non ha ancora trovato un modo di risolvere le controversie senza usare la violenza, allora è davvero fottuta. Una considerazione questa che, ti sovviene, gareggia per profondità con quella che era solita ripetere tua nonna: «Più conosco gli uomini, più amo gli animali».
Nella stessa intervista però Lagioia affermava anche che «la democrazia è molto meno contagiosa del previsto. Eppure è preferibile vivere in Europa e negli Usa piuttosto che in Russia, India o Cina. In assoluto l’Europa resta il posto migliore: un luogo dove si può dissentire».
Insomma, a dispetto del proprio pessimismo cosmico, Lagioia ribadiva la buona vecchia superiorità occidentale e in particolare europea. Il nostro è il posto migliore, non c’è gara, quindi sappiamo da che parte stare: dalla nostra e di quelli come noi. E giù a citare gli intellettuali italiani, dei quali «si percepisce il travaglio interiore, ma anche un lavoro in profondità atto a minare le proprie certezze» (ah, sì?), nonché gli immancabili mostri sacri Dostoevskij e Mann, perché «la letteratura può fare poco, però allo stesso tempo ci consente di rimanere umani» (wow!), e infine a rammaricarsi che in giro si veda così poca «umiltà» (ecco).
Nessun accenno alle specifiche cause politiche ed economiche della guerra. Nessun accenno, così, tanto per salvare le apparenze di uno spirito critico, alla dimensione geopolitica, all’espansionismo della Nato a cui la Russia dà una risposta militare (anzi, a dire il vero per Lagioia questo collegamento «sfocia pericolosamente nella giustificazione», quindi guai a farlo). Nessun accenno all’intruppamento dei suddetti intellettuali – che dura da due anni, non da tre mesi – o alle liste di proscrizione dei “No War”, che ne hanno soppiantate altre senza soluzione di continuità. Nessun accenno alle ragioni storiche e materiali per cui l’Europa è il posto in cui si vive meglio: secoli di sfruttamento e bombardamento del resto del mondo da parte dell’Occidente dovrebbero quanto meno suggerirci che la nostra libertà di dissentire, la nostra “democrazia”, è stata messa sul conto di qualcun altro, altrove, ma non solo. Qualcuno che coltiva, produce, assembla, trasporta, più o meno tutto quello che utilizziamo nella nostra bella società libera e consumistica. Qualcuno che spesso crepa in guerre nelle quali sono prima di tutto i nostri interessi a essere implicati. Qualcuno che crepa perfino qui, nel migliore dei mondi possibili, in fondo alla scala sociale.
Ecco, quando leggi le storie di D. Hunter hai la netta sensazione che riguardino tutto ciò che non rientra nel discorso degli intellettuali appiattiti sul pensiero dominante, quelli che trovi sul giornale o in tv.
Perché Hunter a ogni pagina ti spinge la faccia a un millimetro dalle situazioni e dalle persone, e senza bisogno di parlare (superficialmente) dei massimi sistemi ti manda a sbattere contro l’analisi materialistica della realtà. Per ogni personaggio della sua storia – sua letteralmente, oltre che letterariamente –, anche per quello più rovinato e incattivito dalla vita, quello dal quale lui stesso ha subito violenze e umiliazioni, Hunter ha una descrizione folgorante. Questo non significa soltanto vedere in una madre “snaturata” o in un padre violento e razzista le prime vittime del patriarcato, del sessismo e del capitalismo, che li condanna a essere ciò che sono, ma soprattutto rivendicare e restituire la complessità di un’intera classe sociale. Quella dei coatti, dei border line, della “feccia” del regno, in lotta per la salvezza e l’emancipazione. Quella a cui Hunter sente di appartenere e per la quale rivendica una soggettività, proprio a partire dalla dimensione del racconto, sottraendola alla morsa tra condanna e compassione, buona per le campagne elettorali.
L’esigenza dichiarata dall’autore stesso all’inizio di questa seconda prova narrativa è quella di correggere il tiro, per rimediare all’equivoco in cui i lettori del suo primo libro sono caduti. La sua storia, dice, non ha né vuole avere nulla di esemplare, non è un apologo socio-politico, non è una favola morale per le buone coscienze di sinistra. Era ben altro che Hunter voleva raccontare, e allora ci riprova: racconta la stessa storia in una veste completamente diversa, non più mettendo sé stesso al centro, ma i personaggi che ha incontrato e quello che gli hanno insegnato o gli hanno fatto capire.
«Sto scrivendo queste righe ventitré anni dopo la sua morte e a volte ormai passano settimane e mesi senza che io pensi a lei. So che una parte di lei è dentro di me. Quando riposa, appoggiata contro un muro a fumare una sigaretta, con l’alito che sa di alcol, la camicia sbottonata, le clavicole delle spalle sporgenti, i capelli tirati all’indietro, il rossetto sbaffato, lei che danza senza musica, lei che ride senza che si scherzi. È in un angolo dei miei ricordi. Non so se mia madre provava l’amore verso i propri figli e le proprie figlie che, socialmente e culturalmente, ci si aspetta dalla madri. Se non mi ha amato, non ce l’ho per questo con lei. […] Ogni volta che mia madre rideva, che danzava, ogni volta che giocava con le mie sorelle… erano atti di resistenza.»
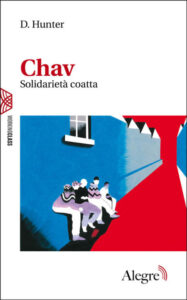 Ciò che colpisce nella scrittura di questo autore è proprio la capacità di descrivere con poche efficacissime pennellate le persone importanti della sua vita, di cogliere con brevi cenni, sketch, aneddoti, l’umanità di ciascuna di loro. Ecco, questo è talento letterario, non c’è altro modo di definirlo, e il racconto di quei tipi umani è letteratura (e bisognerebbe aggiungere che il capitolo intitolato “Padre nostro” è un gioiello, che vale il libro già da solo). Lo sarebbe anche se Hunter non scrivesse mai più un libro in vita sua. È un racconto svolto esattamente al livello della realtà che affronta, senza alcuna indulgenza pasoliniana, per così dire, bensì appunto con il rispetto per la complessità, più che per la semplicità, di quei soggetti. Soggetti che di naif non hanno proprio niente, non sono belli né ammirevoli, ma brutti sporchi e cattivi. Sono quelli che anche alla nostra latitudine fanno vite di merda, a dispetto della preziosa libertà di dissentire. Hunter li racconta come sono, senza assolverli né condannarli e mettendosi in mezzo a loro. Perché è la sua gente, e perché, come ricordava già nel libro precedente, la “chav solidarity”, la solidarietà tra i paria che ha conosciuto nei bassifondi, è qualcosa che tiene viva l’umanità perfino in mezzo agli stupri, alle botte e alla miseria, con buona pace di chi evoca il fallimento della specie guardando la guerra in tv. L’impressione è che ci sia più empatia e fiducia nella cura vicendevole degli esseri umani in una singola pagina di D. Hunter che in interi libri di un qualsivoglia scrittore à la page, impegnato a lamentare la mancanza d’umiltà altrui mentre dispensa giudizi sull’umanità e i suoi fallimenti.
Ciò che colpisce nella scrittura di questo autore è proprio la capacità di descrivere con poche efficacissime pennellate le persone importanti della sua vita, di cogliere con brevi cenni, sketch, aneddoti, l’umanità di ciascuna di loro. Ecco, questo è talento letterario, non c’è altro modo di definirlo, e il racconto di quei tipi umani è letteratura (e bisognerebbe aggiungere che il capitolo intitolato “Padre nostro” è un gioiello, che vale il libro già da solo). Lo sarebbe anche se Hunter non scrivesse mai più un libro in vita sua. È un racconto svolto esattamente al livello della realtà che affronta, senza alcuna indulgenza pasoliniana, per così dire, bensì appunto con il rispetto per la complessità, più che per la semplicità, di quei soggetti. Soggetti che di naif non hanno proprio niente, non sono belli né ammirevoli, ma brutti sporchi e cattivi. Sono quelli che anche alla nostra latitudine fanno vite di merda, a dispetto della preziosa libertà di dissentire. Hunter li racconta come sono, senza assolverli né condannarli e mettendosi in mezzo a loro. Perché è la sua gente, e perché, come ricordava già nel libro precedente, la “chav solidarity”, la solidarietà tra i paria che ha conosciuto nei bassifondi, è qualcosa che tiene viva l’umanità perfino in mezzo agli stupri, alle botte e alla miseria, con buona pace di chi evoca il fallimento della specie guardando la guerra in tv. L’impressione è che ci sia più empatia e fiducia nella cura vicendevole degli esseri umani in una singola pagina di D. Hunter che in interi libri di un qualsivoglia scrittore à la page, impegnato a lamentare la mancanza d’umiltà altrui mentre dispensa giudizi sull’umanità e i suoi fallimenti.
«Non ho dubbi che le botte che mio padre ha ricevuto da piccolo siano state spietate. Quando mi picchiava mi diceva sempre che anche suo padre lo picchiava e che lui ci andava con la mano più leggera. Lo immagino a scuola a nove o dieci anni, col corpo dolorante, i lividi gonfi, le ossa che cercavano di non spezzarsi, i vestiti sporchi e lo stomaco brontolante per la fame. Me lo immagino seduto in fondo alla classe mentre cerca di trattenere ogni emozione, sperando che passi un’ora senza che l’insegnante gli dica che è uno stupido, senza che qualcuno gli ricordi la sua posizione sociale. Posso immaginare gli altri scolari che ridono per le sue risposte mentre la maestra lo interroga, posso sentire il suo sangue che ribolle. Posso sentire la campanella della ricreazione che suona, lui che esce nel giardino alla ricerca di qualcuno da colpire e umiliare. […]
Mio padre non è nato come un uomo che ferisce, domina e sfrutta le persone fisicamente più deboli di lui. Nel corso del tempo ha imparato a diventare una persona del genere. E quel che si può apprendere, si può disimparare.»
 Qualcuno potrebbe pure pensare che la scrittura di Hunter sia una sorta di terapia, come per i reduci. Magari è anche questo. In fondo Hunter – approdato all’attivismo anticapitalista grazie a una serie di incontri fortunati, alla letteratura e alla lettura di Gramsci dietro le sbarre – è cresciuto tra le rovine di una guerra di classe perduta, nella parte traumatizzata e sconfitta. Sconfitta perché da un lato non ha trovato in se stessa la forza di reagire alla neoliberalizzazione e atomizzazione della società, dall’altro è stata soverchiata dal realismo capitalista, diventato l’unica ideologia dominante, fino a saturare l’orizzonte degli eventi.
Qualcuno potrebbe pure pensare che la scrittura di Hunter sia una sorta di terapia, come per i reduci. Magari è anche questo. In fondo Hunter – approdato all’attivismo anticapitalista grazie a una serie di incontri fortunati, alla letteratura e alla lettura di Gramsci dietro le sbarre – è cresciuto tra le rovine di una guerra di classe perduta, nella parte traumatizzata e sconfitta. Sconfitta perché da un lato non ha trovato in se stessa la forza di reagire alla neoliberalizzazione e atomizzazione della società, dall’altro è stata soverchiata dal realismo capitalista, diventato l’unica ideologia dominante, fino a saturare l’orizzonte degli eventi.
In questo scenario si consuma il tradimento di classe. Che però Hunter definisce come una cosa diffusa, che riguarda tutti, incluso sé stesso:
«Siamo milioni di persone che hanno vissuto tutta la vita sotto un capitalismo che prende le forme del patriarcato, del suprematismo bianco e dell’etero-normatività. Alcuni di noi aderiscono completamente a questo sistema, lo prendono per buono anche se tende a farli a pezzi. Altri lo respingono ma non possono comunque fare a meno di esserne pervasi perché cresce dentro di noi come un cancro, perché questo sistema influenza le nostre azioni e i nostri pensieri anche quando facciamo di tutto per tenerlo lontano. Più lo facciamo entrare nelle nostre vite più le divisioni tra noi si riproducono. Così ripresentiamo nei nostri gruppi sociali le logiche carcerarie del capitalismo e demonizziamo quelli che “non sono come noi”. In questo modo finiamo per tradire la nostra classe.»
Ogni volta che traiamo vantaggio dal privilegio piccolo o grande in cui viviamo immersi, sia esso legato alla classe, al capitale culturale, al genere, all’etnia, all’orientamento sessuale; ogni volta che consciamente o inconsciamente sfruttiamo il nostro status agevolato rispetto a chi sta messo peggio, stiamo tradendo la working class e il suo potenziale riscatto. E lo facciamo tutti, in misura diversa, chi più chi meno, perché non viviamo all’esterno del sistema di potere e dei rapporti di forza, ci stiamo dentro fino ai capelli. Con questo aspetto contraddittorio e problematico dobbiamo confrontarci se vogliamo essere onesti prima di tutto con noi stessi.
 Continua a stupire la capacità di questa storia di metterci allo specchio. Esercizio a cui nemmeno l’io narrante si sottrae, ovviamente. Un’io diviso in due, che nella sua nuova veste di attivista politico tenta di abbozzare un approccio possibile al problema, rimanendo incastrato nella contraddizione. Da un lato è innegabile che la sua gente abbia bisogno di aiuto, dice il narratore. Dall’altro lato questo aiuto dovrebbe essere un risarcimento sociale che non pretende di “correggere”, di trasformare i chav in schiavi autodisciplinati o in piccoli borghesi, privandoli del senso di comunità e di appartenenza, della solidarietà, o anche della diffidenza per l’autorità e per chi la solidarietà la fa calare dall’alto. Dovrebbe essere un sostegno senza interessi, per così dire, nel rispetto della diversità e della dignità altrui. Qualcosa che nel summenzionato migliore dei mondi possibili non si dà, per ovvie ragioni. Per questo, all’alba del nostro presente, qualcuno aveva ipotizzato la necessità di trasformare quell’alterità e marginalità in consapevolezza politica e unità, cioè in una leva talmente forte da sollevare il mondo.
Continua a stupire la capacità di questa storia di metterci allo specchio. Esercizio a cui nemmeno l’io narrante si sottrae, ovviamente. Un’io diviso in due, che nella sua nuova veste di attivista politico tenta di abbozzare un approccio possibile al problema, rimanendo incastrato nella contraddizione. Da un lato è innegabile che la sua gente abbia bisogno di aiuto, dice il narratore. Dall’altro lato questo aiuto dovrebbe essere un risarcimento sociale che non pretende di “correggere”, di trasformare i chav in schiavi autodisciplinati o in piccoli borghesi, privandoli del senso di comunità e di appartenenza, della solidarietà, o anche della diffidenza per l’autorità e per chi la solidarietà la fa calare dall’alto. Dovrebbe essere un sostegno senza interessi, per così dire, nel rispetto della diversità e della dignità altrui. Qualcosa che nel summenzionato migliore dei mondi possibili non si dà, per ovvie ragioni. Per questo, all’alba del nostro presente, qualcuno aveva ipotizzato la necessità di trasformare quell’alterità e marginalità in consapevolezza politica e unità, cioè in una leva talmente forte da sollevare il mondo.
Ancora una volta, il racconto di Hunter mette il dito nella piaga della nostra identità politica e del nostro barcamenarci a mezza via tra le macerie ideologiche del Novecento e la costruzione di un nuova prospettiva. Insomma, raccontando un viaggio attraverso i casi di una vita ci parla di noi, senza fare sconti a nessuno. Che poi è quello che fa la buona letteratura.
Mercoledì 18 maggio, libreria Modo Infoshop, via Mascarella 24/b, Bologna, ore 18:30, Wu Ming 4 introduce D. Hunter, Tute traumi e traditori di classe.
–
Come spiegato nell’ultimo aggiornamento complessivo (ne faremo un altro a giugno), in questa fase Giap funziona “col motore al minimo”. Soprattutto, mancano le energie per gestire lo spazio commenti. Ecco perché sotto i nuovi post mettiamo il “lucchetto”. Ce ne scusiamo, purtroppo va così.



 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
