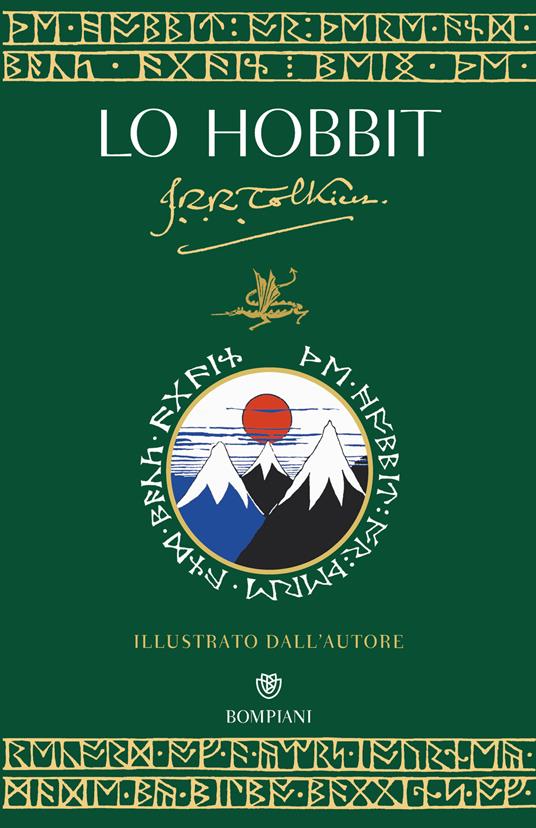
La prima fiaba
Forse perché Lo Hobbit è all’apparenza un romanzo per ragazzi, cioè scritto come una fiaba, in un linguaggio molto semplice e con una trama poco intricata, in Italia non aveva mai avuto un trattamento adeguato. Non che all’altro romanzo di Tolkien fosse andata meglio, anzi, ma per motivi diversi. Non era infatti lo stile letterario dello Hobbit ad avere bisogno di un occhio di riguardo, come è stato per il suo celeberrimo sequel finalmente ritradotto nel 2020, quanto piuttosto la coerenza d’insieme. Sembra incredibile, ma a mezzo secolo dalla prima pubblicazione in Italia, quella che verrà pubblicata a novembre è la prima traduzione integrale e coerente. È integrale, perché non ha sottotitoli posticci o fantasiosi, e presenta la nota introduttiva per intero, senza tagli, come invece era stato nelle edizioni precedenti; ed è coerente perché le scelte traduttive provano a rispecchiare l’originale senza modifiche per i palati italiani. Sul sito dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani si può leggere un articolo che spiega bene tutto questo.
Ma questa edizione è integrale anche in un altro senso. Infatti per la prima volta insieme al romanzo compaiono anche tutti i disegni preparatori e d’accompagnamento realizzati da Tolkien – che era un illustratore dilettante niente male e con un tratto particolarissimo, vagamente naif: dai bozzetti, agli sketch delle mappe, fino alle illustrazioni rifinite per la stampa e in certi casi anche colorate in post-produzione. Si potrà leggere il romanzo seguendone passo passo anche l’ideazione visiva da parte dell’autore. Ne esce un volume veramente pregiato, all’immodica cifra di €30, che però li vale tutti.
Dopo averlo studiato per anni, averci fatto sopra laboratori di lettura e scrittura creativa all’università, Wu Ming 4 ha accettato la proposta di ritradurlo da parte dell’editore Bompiani. In questi giorni è stato annunciato che sarà in libreria il 6 novembre, ma ci saranno anticipazioni qua e là. Quindi chi nutre interesse per la materia resti con le antenne dritte.
 Lo Hobbit è il punto d’inizio della carriera narrativa di Tolkien. La cosa non può non esercitare un fascino particolare per chi apprezza l’autore. Dopo essere tornato dai pantani della Prima guerra mondiale, Tolkien aveva lavorato alla stesura delle storie di un mondo fantastico, una sorta di versione alternativa del nostro mondo, dalla cosmogonia fino all’avvio del tempo storico. Parallelamente però, aveva l’abitudine di raccontare storie ai suoi figli, la sera, davanti al camino, e di metterle per iscritto. Al centro di queste storie c’era spesso un omuncolo con i piedi pelosi, che battezzò “hobbit”.
Lo Hobbit è il punto d’inizio della carriera narrativa di Tolkien. La cosa non può non esercitare un fascino particolare per chi apprezza l’autore. Dopo essere tornato dai pantani della Prima guerra mondiale, Tolkien aveva lavorato alla stesura delle storie di un mondo fantastico, una sorta di versione alternativa del nostro mondo, dalla cosmogonia fino all’avvio del tempo storico. Parallelamente però, aveva l’abitudine di raccontare storie ai suoi figli, la sera, davanti al camino, e di metterle per iscritto. Al centro di queste storie c’era spesso un omuncolo con i piedi pelosi, che battezzò “hobbit”.
Piano piano la storia di questo personaggio finì per insinuarsi nel quadro più ampio del mondo che stava edificando. Entrò dalla porta di servizio, ma finì per prendersi il posto da protagonista, perché nel 1937 quel “manoscritto domestico” guadagnò la via della pubblicazione, apprestandosi a diventare un classico della letteratura per ragazzi. Il successo di pubblico spinse l’editore a chiedere “più hobbit”, cioè un sequel. Tolkien avrebbe voluto continuare a scrivere e pubblicare le storie antiche di quel mondo fantastico, che avevano al centro gli affascinanti elfi, nobili uomini e donne, demoni e dèi, ma l’editore voleva altro, voleva gli hobbit, con la loro modernità e comicità. E così Tolkien si spremette le meningi per farsi venire in mente una nuova storia dello stesso genere. Ci avrebbe messo una dozzina d’anni a scriverla e altri cinque a pubblicarla. Il Nuovo Hobbit sarebbe diventato Il Signore degli Anelli, ovvero l’unione definitiva tra il suo mondo creato e le vicende di quei buffi esseri singolarmente fuori posto.
Un ragazzo di mezza età, la distopia di genere e la menzogna dell’epica
Dunque lo hobbit è stato l’intruso che si è imposto al centro del grandioso scenario della Terra di Mezzo come fulcro decisamente inaspettato. Bilbo è un cinquantenne che non ha mai fatto niente di interessante nella vita, finché un vecchio mago vagabondo non lo trascina fuori di casa insieme a una compagnia di nani squinternati, in un’avventura dalla quale tornerà cambiato, consapevole, e felicemente privato della sua rispettabilità borghese. Lo Hobbit è un romanzo di formazione il cui protagonista è un uomo di mezza età che deve scoprire chi è, perché fino a quel momento si è negato questa possibilità. Non proprio la premessa di un romanzo “per ragazzi”, se non fosse che quella consapevolezza di sé passa attraverso la riscoperta di uno sguardo infantile sul mondo, un “credere alle favole” che non è autoillusione, ma proiezione di sé oltre il dato, oltre le consuetudini consolidate, non accettazione del discorso dominante (“adulto”) per cui l’unico mondo possibile è quello fatto di solida materia tangibile e misurabile.
Ma Lo Hobbit è anche la riflessione narrativa di un reduce della battaglia della Somme, che come tanti reduci si sarebbe semplicemente e nevroticamente raggomitolato al calduccio del focolare domestico, se non fosse stato infatuato di fiabe, storie, miti, saghe… e non avesse deciso che il trauma, la perdita dell’innocenza di una generazione, doveva essere rielaborato in una chiave narrativa fantastica. Una saga destinata a diventare pietra miliare per un intero genere letterario e tra le più lette di tutti i tempi.
Nello Hobbit salta agli occhi una cosa enorme: la totale assenza di personaggi femminili. Nemmeno tra le comparse ci sono donne. Ne sono nominate appena tre (la madre di Bilbo, la nonna di Gollum, la sorella di Thorin) ma non compaiono nella storia. L’apparente distopia di genere non è altro che la proiezione di un’esperienza – quella sotto le armi, al fronte, che a sua volta era la prosecuzione della vita nei college di Oxford – che fu la più grande e tragica avventura vissuta dall’autore. Forse Lo Hobbit potrebbe essere letto come uno studio narrativo sui rapporti maschili nelle loro varie sfaccettature (al netto di ogni sfumatura omoerotica, se non implicita e inconscia, perché il Nostro era cattolicissimo).
Non a caso il gran finale è una battaglia di carneficina che con la fiaba ha veramente poco a che spartire, in quella che è forse una delle più clamorose torsioni di genere narrativo mai azzardate, quando perfino quelli che all’inizio sembravano i nani di Biancaneve si trasformano in guerrieri. Una battaglia, quella dei Cinque Eserciti, nella quale il protagonista non ha ruolo alcuno. Correva l’anno 1937, l’Europa marciava al passo dell’oca verso un’altra guerra mondiale, i cui prodromi già si consumavano in Spagna, mentre in Germania il revival dell’eroismo nordico, il culto della bella morte e del “vincere morendo” (F. Jesi) era uno dei pilastri retorici su cui Hitler aveva edificato il nuovo Reich. Il protagonista dello Hobbit, trovandosi nel mezzo di uno scontro campale che volge al peggio, circondato da orde di goblin e branchi di lupi feroci, prevede di averne ancora per poco, e formula un pensiero, una manciata di frasi con le quali J.R.R. Tolkien disintegra ogni appiglio revanscista che gli sia mai stato attribuito:
«“Non ci vorrà ancora molto,” pensò Bilbo, “prima che i goblin conquistino la Porta e noi veniamo tutti massacrati o spinti giù e fatti prigionieri. Vien voglia di mettersi a piangere, dopo tutto quello che uno ha passato. Preferirei che quel maledetto tesoro fosse rimasto al vecchio Smaug piuttosto che lo prendano queste ignobili creature, e che il povero vecchio Bombur, Balin, Fili e Kili e tutti gli altri facciano una brutta fine; e anche Bard, e gli Uomini del Lago e gli allegri elfi. Misero me! Ho ascoltato canzoni su molte battaglie, e ho sempre inteso che la sconfitta potesse essere gloriosa. Sembra molto spiacevole, invece, per non dire angosciosa. Quanto vorrei esserne fuori”.»
I poemi epici mentono. Le canzoni di guerra mentono. La retorica militarista mente. La sconfitta non è gloriosa, crepare e veder crepare i propri compagni non è bello, e l’unica cosa che desidereremmo legittimamente è esserne fuori, scamparla. Qui è il reduce della guerra vera che parla, uno che nel fango della Somme c’era stato e ci aveva lasciato anche un paio dei suoi migliori amici. Perché solo chi non ha vissuto la guerra nei ranghi bassi può credere alla retorica eroico-militarista, appunto (o schermarsi col suo contrario: il cinismo, il distacco, o l’argomento della “triste necessità”). L’uomo comune Bilbo – che pure eroe lo è e lo dimostra in altri frangenti della storia – al massacro si sottrae, grazie a un anello dell’invisibilità, per essere poi sottratto del tutto da una botta in testa che lo lascia svenuto.
La conservazione del mondo e la menzogna della politica
Certo il conservatorismo dell’autore traspare ampiamente da tutta la storia. Il rimpianto per un tempo in cui persisteva la «quiete del mondo, quando c’erano meno rumore e più verde» è palpabile. Ma al tempo stesso c’è la consapevolezza che quel mondo non possa tornare, che il nastro della storia non possa essere riavvolto, perché nella finzione narrativa gli hobbit esisterebbero ancora, nascosti agli sguardi di noi rumorosa Gente Grossa, rimasti in pochi, ormai prossimi all’estinzione. E non c’è nulla che si possa fare per evitarlo.
Ed è vero che alla moderna società mercantile di Città del Lago, dove demagogia e affari sono intrinsecamente legati, si contrappone la città di Vallea, che alla fine viene rifondata dall’erede del suo antico re, uccisore del drago Smaug. Modernità e antichità convivono fianco a fianco, ma la morale della favola è che la brama di ricchezza porta alla rovina non solo quando è sete di profitti, ma anche e soprattutto quando dell’oro si fa feticcio, simbolo del retaggio famigliare e patriarcale, fino a rimanere psichicamente schiacciati sotto il peso di quel cumulo dorato, come capiterà a Thorin Scudodiquercia, il deuteragonista della storia. Bilbo invece troverà l’equilibrio tra eredità paterna ed eredità materna, e non già in forma di beni e retaggio, ma di consapevolezza e saggezza. Di individuazione, direbbero gli psicologi. L’innegabile conservatorismo che emerge da questa storia mantiene una stranezza e una singolarità irriducibili a qualsivoglia ideologia.
 A questo proposito non meraviglia scoprire che perfino l’opportunistico giovane delfino di Donald Trump, quel J.D. Vance classe 1984 che sembra incarnare il punto di congiunzione tra neocon e alt right, è un superappassionato dell’opera di Tolkien. In Italia di politici che leggono quelle storie in chiave ultrareazionaria ne sappiamo qualcosa. Tuttavia fa riflettere proprio quanto un certo tipo di lettura sia legato a quella retorica del rimpianto e della conservazione che Tolkien trattava con le pinze. Rimpianto per un fantomatico “prima”… prima che quei borghesi sinistrorsi e snob liberassero nella società i grilli che hanno per la testa… prima che la working class bianca venisse lasciata senza lavoro e sostituita etnicamente… prima che le donne volessero decidere la sorte della vita che hanno in grembo… ecc. In realtà è il rimpianto per ciò che quegli stessi politici/opinionisti non possono essere, è una menzogna per non dover ammettere che a vincere è sempre il banco, cioè il sistema di cui loro sono soltanto uno dei tanti ingranaggi, quando non proprio i solerti oliatori del meccanismo stesso a caccia di fortuna personale.
A questo proposito non meraviglia scoprire che perfino l’opportunistico giovane delfino di Donald Trump, quel J.D. Vance classe 1984 che sembra incarnare il punto di congiunzione tra neocon e alt right, è un superappassionato dell’opera di Tolkien. In Italia di politici che leggono quelle storie in chiave ultrareazionaria ne sappiamo qualcosa. Tuttavia fa riflettere proprio quanto un certo tipo di lettura sia legato a quella retorica del rimpianto e della conservazione che Tolkien trattava con le pinze. Rimpianto per un fantomatico “prima”… prima che quei borghesi sinistrorsi e snob liberassero nella società i grilli che hanno per la testa… prima che la working class bianca venisse lasciata senza lavoro e sostituita etnicamente… prima che le donne volessero decidere la sorte della vita che hanno in grembo… ecc. In realtà è il rimpianto per ciò che quegli stessi politici/opinionisti non possono essere, è una menzogna per non dover ammettere che a vincere è sempre il banco, cioè il sistema di cui loro sono soltanto uno dei tanti ingranaggi, quando non proprio i solerti oliatori del meccanismo stesso a caccia di fortuna personale.
Ognuno di questi rampanti conservatori ultramoderni (i famigerati “sovranisti”), quale che sia la sponda dell’Atlantico su cui si trova, si accanisce a immaginarsi come un Bilbo, un Frodo, o magari un Gandalf (una Galadriel?), che rimpiange la quiete e il verde perduti del mondo, perché in realtà guardando nello specchio con la coda dell’occhio vede un goblin/orco sfruttatore d’umani e abbattitore d’alberi non meno di tutti gli altri. C’è qualcosa di patetico e vagamente autolesionistico in questi politici “ispirati” dalla Terra di Mezzo che vorrebbero essere Théoden e riescono solo a essere Lotho Sackville-Baggins (per chi ha orecchie tolkieniane per intendere).
 C’è invece un cuore cristiano nel romanzo d’esordio di Tolkien che è irriducibile a qualsivoglia autoinfingimento postmoderno. Lo si incontra quando, nelle grotte sotto le montagne, Bilbo compie il suo atto di pietà per Gollum e lo grazia, evitando di ucciderlo. In quel momento Bilbo si identifica con quell’individuo dissociato, schizofrenico, abbrutito, addicted, che non gli ricambierebbe mai la cortesia, anzi che vuole proprio ucciderlo, e che è il personaggio letterariamente più geniale e inquietante messo sulla pagina da Tolkien. Quella del protagonista del romanzo è una manifestazione di sym pàtheia, simpatia come compassione, un soffrire della sofferenza altrui che impedisce a Bilbo il distacco necessario per affondare la spada e che lo fa restare umano nel frangente più critico. Sappiamo che questo gesto, molti anni dopo – sia nel mondo primario, sia in quello secondario – consentirà a Gollum di essere nel posto giusto al momento giusto per cadere con l’Anello in fondo al baratro dove questo verrà distrutto. Ma se la provvidenza si spiega e dispiega sempre ex post, è la salvezza di Bilbo a essere in gioco lì. Lo dirà Gandalf a Frodo nel Signore degli Anelli: Bilbo ha ottenuto l’Anello senza nuocere a nessuno, nemmeno quando avrebbe avuto l’opportunità e forse perfino la ragione di farlo, e questo rifiuto di farsi giustiziere lo ha reso più resistente alla dipendenza, al potere dell’artefatto infernale. Scegliendo la compassione, salvando il più viscido e miserabile essere sulla faccia della terra, Bilbo salva se stesso e si impedisce di diventare davvero come lui.
C’è invece un cuore cristiano nel romanzo d’esordio di Tolkien che è irriducibile a qualsivoglia autoinfingimento postmoderno. Lo si incontra quando, nelle grotte sotto le montagne, Bilbo compie il suo atto di pietà per Gollum e lo grazia, evitando di ucciderlo. In quel momento Bilbo si identifica con quell’individuo dissociato, schizofrenico, abbrutito, addicted, che non gli ricambierebbe mai la cortesia, anzi che vuole proprio ucciderlo, e che è il personaggio letterariamente più geniale e inquietante messo sulla pagina da Tolkien. Quella del protagonista del romanzo è una manifestazione di sym pàtheia, simpatia come compassione, un soffrire della sofferenza altrui che impedisce a Bilbo il distacco necessario per affondare la spada e che lo fa restare umano nel frangente più critico. Sappiamo che questo gesto, molti anni dopo – sia nel mondo primario, sia in quello secondario – consentirà a Gollum di essere nel posto giusto al momento giusto per cadere con l’Anello in fondo al baratro dove questo verrà distrutto. Ma se la provvidenza si spiega e dispiega sempre ex post, è la salvezza di Bilbo a essere in gioco lì. Lo dirà Gandalf a Frodo nel Signore degli Anelli: Bilbo ha ottenuto l’Anello senza nuocere a nessuno, nemmeno quando avrebbe avuto l’opportunità e forse perfino la ragione di farlo, e questo rifiuto di farsi giustiziere lo ha reso più resistente alla dipendenza, al potere dell’artefatto infernale. Scegliendo la compassione, salvando il più viscido e miserabile essere sulla faccia della terra, Bilbo salva se stesso e si impedisce di diventare davvero come lui.
Ecco
Ecco, con questi pochi cenni si è provato a dare almeno l’idea del perché anche Lo Hobbit – che passa spesso per il fratello minore del Signore degli Anelli – meritasse una nuova traduzione e un’edizione italiana coerente. In fondo, come si diceva, è il commovente punto d’inizio della bizzarra carriera editoriale di Tolkien, che mezzo secolo dopo la sua morte prosegue ancora.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Questa è una bella notizia.
Confesso: lo Hobbit non è mai riuscito a affascinarmi davvero, contrariamente a SdA che ho letto non so quante volte. L’ho sempre finito con fatica, a volte lasciato li’ senza completare la rilettura intrapresa con la speranza di trovarci qualcosa in più finora non riscontrata. L’ho sempre trovato senza ritmo, fatto di quadri staccati anche brillanti, ma troppo effimeri. Magari era colpa della traduzione.
Invece so niente degli studi tolkeniani, per cui conoscere la genesi editoriale di SdA è una gradita sorpresa. Forse Tolkien per primo ha percepito la necessità di staccarsi da quello stile, pur mantenendo di fatto il tema del borghese di campagna proiettato giocoforza nelle battaglie del mondo e che ne esce peraltro annientato, contrariamente a Bilbo che, magari per semplici motivi di continuità letteraria, rimane l’eccezione tra i proprietari di SdA.
Rimango incerta sul peso dell’evoluzione di Bilbo: tornato a casa cambia realmente qualcosa nella sua vita? Il borghese si è formato o ha semplicemente tirato fuori un po’ per caso quel che da sempre esisteva in lui? Forse perché non conosco a fondo il romanzo, la mia impressione è di un individuo spaesato, curioso certo, ma sostanzialmente buttato in circostanze che non comprende che cerca di cavarsela come può restando come estraneo a ciò che si vede capitare attorno.
Frodo finisce con l’ assumersi un compito, pur con paura e fatica, per due volte, la prima con Gandalf e la seconda al Consiglio dei matti. Questa risoluzione in Bilbo è molto più impalpabile, viene cooptato come scassinatore senza neanche capirlo e ogni volta ha l’aria di agire d’istinto. Le cose cambiano dopo l’incontro con Smaug, e l’episodio degli elfi in cui diventa attivamente solidale con i suoi compagni e cerca di ristabilire un giusto equilibrio nelle contese.
Forse questa distanza gli consente di non farsi divorare dall’anello dopotutto.
L’odissea di Bilbo e quella di Frodo sono molto diverse. Bilbo torna a se stesso, rinnovato, eccome, straniero in patria, ma felice di esserlo. Frodo torna con una ferita insanabile, autoemarginato, destinato a ripartire per provare a salvarsi. La differenza è proprio che Frodo la linea dell’ombra l’ha varcata, sul ciglio del vulcano, mentre Bilbo no, è rimasto dalla parte luminosa della storia. Bilbo insomma il suo percorso di individuazione lo realizza, Frodo rimane inconcluso, smarrito, è un personaggio dolente e tragico come Bilbo non sarà mai, e forse in questo molto moderno e adatto ai tempi che viviamo.
Comunque anche nella prima guerra mondiale c’erano donne impiegate in vari modi, pur se non a combattere nelle trincee – magari a costruirle si’, in certe regioni, come portatrici o altro e nella guerra di Spagna ovviamente come combattenti. In quei decenni i personaggi femminili potevano restare fuori dalla letteratura, era assolutamente normale, pur se non obbligatorio ovviamente, oppure diciamo fuori dai romanzi d’avventura e di esplorazione dell’esterno? In Verne che scrive un po’ prima, ma nel genere è importante, accade lo stesso: è un affare di uomini, le donne sono pallide figurine convenzionali. A volte ci sono delle bambine, nella letteratura per ragazzi. Salgari è già in parte diverso, con personaggi femminili decisamente più attivi. Bisogna farci pace.
Trovo invece stiracchiato il paragone politico, pur ignorando tutto del personaggio in questione: un libro diffuso su scala planetaria non può non avere lettori di qualsiasi tipo e totalmente trasversali. Certe letture sono state giustamente qui più volte smantellate ribadendo che si tratta di fenomeno prettamente italico di mistificazione del testo, anzi “patrio”, giusto? Peraltro pure i cattolici sdilinquiscono e frignano sul famoso “quanti avrebbero meritato la vita, sei tu in grado di dargliela ecc.” facendone la frase che per loro riassume tutto il libro in un esercizio di devozione.
E il primo a non lasciarsi prendere dal mito della guerra (non dalla foga) è Achille.
Bene che l’editore non ripeta la furbata dei tre tomi dello SdA che fa si’ che con la nuova traduzione sia ancora ferma al primo.
Credo veramente che Lo Hobbit – consapevolemnte o no – sia il racconto del mondo al maschile, una distopia fantastica in cui delle donne si può fare a meno. Per certi versi la compagnia di Thorin a cui Bilbo viene aggregato è una banda di nerd appassionati di fantasy alla ricerca d’avventure senza costrutto, tant’è che è soltanto per un caso fortuito o una bella mano della provvidenza che riescono ad avere successo nella loro missione. La presenza femminile, o anche solo l’ingresso dell’erotico (etero o omo che sia), rovinerebbe l’idillio, farebbe scoppiare la bolla in cui quei maschi vogliono vivere. Non solo non incontrano donne, ma nessuno di loro fa mai nemmeno riferimento a eventuali mogli o fidanzate lasciate a casa. Sono come dei monaci che bastano a se stessi. Bilbo in particolare rimarrà celibe tutta la vita. Come accadrà a Frodo, del resto.
Sì è un’interpretazione sensata. Peraltro per valutare a fondo la cosa sarebbe da capire fino a che punto la costruzione di un simile mondo mono e asessuato a un tempo si inserisca in una tradizione letteraria britannica e nella stessa mentalità (vittoriana?), senz’altro più ipocrita che realistica.
Conosco poco il resto di Tolkien, ma gli amori di Luthien/Edith sembrano assorbire quasi tutta l’énergia erotica della sua opera, e alla fin fine restano fuori dello SdA, persino nella trasposizione Arwen/Aragorn dove sono appena accennati. Oppure si risolve nel soffocante e venefico amplesso di Shelob, sarò strana io ma mi ha sempre evocato il terrore mascolino della donna, in un romanzo in cui praticamente non ce ne sono, questa femmina giganteggiante e divoratrice letale da infilzare nel ventre enorme con un minuscolo luminoso pugnale.
«[…] sarebbe da capire fino a che punto la costruzione di un simile mondo mono e asessuato a un tempo si inserisca in una tradizione letteraria britannica e nella stessa mentalità (vittoriana?), senz’altro più ipocrita che realistica».
È un mondo asessuato in maniera evidente non per una qualche adesione all’ipocrisia di una tradizione letteraria ma, azzardo, per una questione paradossalmente realista.
Tolkien voleva scrivere e pubblicare. Questo è.
Farsi pubblicare un’opera nella quale si narra di personaggi femminili pronti a sacrificare la propria vita in preposterous battaglie campali sarebbe stato magari un idea geniale per il rappeesentante di un qualche movimento, letterario o politico. Mi viene in mente R. Hubbard, per esempio, qualche anno più tardi.
Tolkien però era un medievalista che intendeva trattare di ciò che lo interessava, e cioè di un Inghilterra premoderna, pre cristiana, della mitologia pagana largamente obliterata e all’interno della quale l’immanenza rappresentava una delle caratteristiche fondamentali.
A proposito di immanenza, all’inizio dell’inaspettata avventura, prima di imporre a chi legge la prospettiva insindacabile di una «banda di nerd appassionati di fantasy alla ricerca di avventure senza costrutto», Tolkien ci informa che:
«It was often said that long ago one of the Took ancestors must have taken a fairy wife […] Bilbo got something a bit queer in his make up from his Took side.»
Non so perché non riesco a rispondere sotto ciascun commento.
Proprio non riesco a ricordare un cambiamento così netto di Bilbo al ritorno dal suo viaggio. Oltretutto in SdA la sua scomparsa è abbastanza da misantropo. Devo rileggerlo.
Questione Frodo vs. Bilbo: se vogliamo vedere nello Hobbit un romanzo di formazione – e perché no – ecco, ciò che m’interroga è quale differenza essenziale ci sia fino all’episodio delle rispettive partenze tra Frodo e lui che possa spiegarne l’evoluzione successiva. Certo, c’è un allenamento dell’autore alla scrittura diverso anzitutto, poi Frodo ha legami affettivi e amicali strettissimi e essenziali alla storia che Bilbo apparentemente non ha con nessuno, se non con Gandalf e dopo il ritorno con Frodo stesso. Ma in sé sono poi così diversi nei loro anni della Contea? Rentier, notabili, affezionati alla loro bella casa, infastiditi dal parentado, la loro vita e i loro pensieri appaiono molto simili. Frodo è un personaggio affettuoso e felice pur se segnato dalla scomparsa di Bilbo. Il disastro comincia con la ferita del pugnale di Mordor quando per la prima volta infila l’anello e non per caso come a Brea. Si può dire che inizi a cedere li’, il primo orlo del vulcano.
Forse una differenza risiede nella consapevolezza relativa all’anello: Frodo sa cosa sia, Bilbo no e non lo saprà per quasi tutto il tempo che lo possiede. Sapere è rischioso? E SdA non è comunque un romanzo di formazione? Cambiano però la scelta e la meta: Bilbo si fa trasportare, frastornato ma conquistato (il famoso fazzoletto) in un ruolo alquanto ambiguo di scassinatore, Frodo no e si fa da subito strumento per scongiurare la dominazione del tiranno. La differenza nell’Odissea comincia così. Il borghese non può essere eroe o meglio assumersi compiti sovrumani, quindi?
Il cambiamento di Bilbo al ritorno del suo viaggio non è “netto”, ma è significativo. Se prima di partire Bilbo era «la seconda edizione del solido e tranquillo padre», al ritorno è diventato amico degli elfi, e riceverà a casa nani, maghi e varia gente stramba che mai prima si sarebbe sognato di invitare per il tè. Per questo sarà ritenuto «strano» dal bigotto vicinato. Non solo. Si metterà anche a scrivere poesie e a fare a sua volta visita agli elfi, una delle quali visite è quella che ha progettato all’inizio del Signore degli Anelli, dato che dopo la plateale scomparsa, se ne va a stare a Rivendell. Quindi sì, la sua vita cambia, soprattutto però cambiano la sua mentalità e i suoi interessi.
Bilbo e Frodo nei loro anni nella Contea hanno dei punti di somiglianza e dei punti che li distanziano. In comune hanno la voglia di camminare, di percorre i sentieri della Contea, un’attitudine che nasconde la loro inconscia attrazione per l’ignoto e la scoperta. Sono entrambi figli unici orfani ed entrambi riservati, quindi diciamo che si trovano l’un l’altro. Però hanno caratteri molto diversi. Frodo sviluppa un rapporto d’amicizia particolare con Merry e Pippin, nonché con il domestico Sam. Non risulta che Bilbo abbia grandi amici hobbit. Dopo l’avventura le sue frequentazioni saranno rivolte appunto a nani, elfi e maghi.
Ma soprattutto Bilbo in qualche modo si risolve come persona, Frodo no, e infatti il secondo rimane un personaggio sfuggente. Per questo Il SdA non è un romanzo di formazione, se non forse per Sam, che è il vero eroe della storia, ma che all’inizio sembra una mera spalla comica del protagonista. Quale sia il movente di Frodo rimane abbastanza oscuro. Anche lui viene trascinato fuori casa, certo non dalla provocazione/ manipolazione di Gandalf, come era stato per Bilbo, ma dal senso del dovere, per portare l’Anello lontano dai Cavalieri Neri che lo stanno cercando. Se poi al “consiglio dei matti” sia l’altruismo o la volontà dell’Anello stesso a farlo offrire volontario come Portatore il romanzo non lo dice, Tolkien lo lascia volutamente indefinito. E quel non detto è cruciale per mettere il personaggio tra luce e ombra.
Frodo è un personaggio molto più complesso del solare Bilbo, forse perché tanto più grande è l’impresa che gli tocca in sorte. Per Bilbo i dilemmi sono psicologici (io chi sono?) ed etici (cosa è giusto fare?), mentre per Frodo sono, per così dire, politici (di chi posso fidarmi?) ed esistenziali (sono disposto a sacrificarmi?). Bilbo si rivelerà scaltro, oltreché equo ed altruista, lui è in effetti un Odisseo moderno, la versione tolkieniana di Leopold Bloom (al ritorno trova perfino degli usurpatori che gli stanno svaligiando e occupando casa dopo averlo dato per morto…); Frodo invece è un eroe tragico, assai più che epico, un eroe che implode, mano a mano che risulta chiaro a lui e a chi legge che il suo è un sacrificio estremo e che un vero ritorno a se stesso non sarà possibile.
Bilbo è il reduce che – come Tolkien, il quale si identificava molto con lui – riesce a ritrovare un equilibrio e a vivere felice e contento fino alla fine dei suoi giorni straordinariamente lunghi. Frodo è il reduce che, come tanti che Tolkien doveva aver visto, quell’equilibrio non riesce più a trovarlo, troppo traumatizzato da ciò che ha passato per tornare a una vita normale. In definitiva, pur avendo una condizione di partenza comune, i due protagonisti dei rispettivi romanzi rappresentano esiti nettamente contrapposti.
Ovviamente bisogna aggiungere che nel SdA troviamo Bilbo sotto gli effetti – per quanto rarefatti – dell’Anello, e quindi non solo voglioso di “rivedere le montagne”, ma anche stiracchiato “come del burro su una fetta di pane troppo grande”. Ma questa è ovviamente l’evoluzione delle idee di Tolkien sull’Anello negli anni che separano la stesura dello Hobbit da quella del SdA. L’Anello dello Hobbit non è ancora l’Anello del SdA. resta il fatto che tutto sommato Bilbo in qualche modo riesce a salvarsi dai suoi effetti, mentre Frodo no.
1)Quando ho riletto il SdA mi è venuto da pensare al Bilbo “stiracchiato”, lentamente avvelenato da un “male oscuro” che lo rode dentro, come all’Ivan Il’ič di Tolkien.
2)Nella “Critica del Programma di Gotha” Marx parla della “stigmate ” della vecchia società che la “nuova” società dovrà portare nelle sue carni. Leggendo questo passo io ho sempre pensato a Frodo e al dito mozzato e alla ferita che non si rimargina. Poi Tolkien credeva che ci fosse una nave ad aspettarci e un Rifugio dall’altra parte del mondo. Noi “materialisti” sappiamo che non c’è niente di tutto questo.
WOW, WOW, WOW!
Ne spenderei pure 60 di euro per questa traduzione. E lo farò perché un libro del genere va regalato agli amici cari.
Grazie WM4.
Lessi “Lo hobbit” da ragazzino, mi piacque ma restò un po’ così “nel vuoto”. L’ho poi riletto da grande ed è cambiata per me la reazione: uno straordinario capolavoro di avventura, ironia (Bilbo che nella battaglia campale finale epica è svenuto), dialoghi frizzanti, e una smontatura delle figure epiche (qui i Nani) fatta con gentilezza ma anche intelligenza raffinata. L’ho letto pure in Inglese, faticando ma senza troppi inciampi (credo).
Un libro per “ragazzi”, su cui poi mi piacerebbe – visto che il traduttore se ne intende – anche aprire una discussione. Perché oggi si sente la mancanza ENORME di libri per ragazzi, realmente d’avventura, con personaggi fiabeschi, in cui i “messaggi” non vengono spiattellati ogni 3 righe. Oggi il romanzo “standard” per l’infanzia vede come protagonisti bambini più o meno con bisogni educativi speciali, circondato da gruppi multietnici, mamme straordinarie, e padri amanti dei lavori domestici, ma… non accade mai niente. Mentre in 2 capitoli de “Lo hobbit” trovi “trama” per 15 di questi libri.
WOW WOW WOW!
Credo che questa specie di appropriazione culturale del legendarium tolkeniano da parte dei sovranisti a cui si accenna nel post sia da attribuire, in parte, all’idea, popolarissima tra i “fans” , che l’intenzione di Tolkien fosse quella di create una mitologia per l’Inghilterra.
Non conosco benissimo l’argomento ma mi sembra di capire che, per quanto JRRT abbia indubbiamente fatto cenno nella sua corrispondenza privata ad una simile idea, la considerasse in realtà: «Absurd».
Sicuramente il dispositivo letterario che usa rimanda alla mitologia; mi chiedevo quindi quale fosse la posizione maggioritaria a proposito, tra chi studia queste cose e il tuo punto di vista in particolare?
Grazie.
La comunità degli studiosi tolkieniani è disparata, ma di certo non è maggioritario un approccio “sovranista”, diciamo. Anzi, dalle accademie angloamericane negli ultimi anni è venuta avanti la lettura “queer”, in ossequio alle tendenze wokiste, che si scervella per trovare cripto-riferimenti di quel tipo nell’opera di Tolkien.
Come si legge nel post, la passione di neoconservatori, ultracattolici, veteroreazionari, fascistoidi, ecc. per Tolkien nasce dal conservatorismo di fondo che emerge dalla sua narrativa. La storia per T. è «storia della Caduta», cioè un progressivo allontanarsi dell’umanità da ciò a cui era originariamente destinata. Una tendenza che si risolverà soltanto alla fine della storia. Nel frattempo tutto quello che si può fare è provare a resistere, a fare riverberare in noi e negli eventi intorno a noi un riflesso della luce originaria, cioè «mettercela tutta a sostegno degli anni a noi assegnati, estirpando il male dai campi che conosciamo, in modo che chi vivrà dopo abbia terra sana da coltivare», come dice Gandalf.
A questo va aggiunto quello a cui accenna dude, o meglio, non tanto l’idea «assurda» della creazione di una mitologia per l’Inghilterra, quanto piuttosto il fatto che Tolkien riprenda gran parte del patrimonio mitico-leggendario dell’Europa occidentale e lo rigiochi in una storia in cui l’Occidente deve resistere a un male che viene da Oriente e da Sud (e che ha i tratti asiatici degli invasori storici dell’Europa Occidentale).
Questi sono gli elementi che hanno sempre reso caro Tolkien a una parte politico-culturale. La quale ovviamente si ferma lì, incapace – forse anche più per limiti intellettivi che politici – di cogliere gli elementi che problematizzano la suddetta visione e la rendono molto più complessa. In estrema sintesi, per non essere ripetitivo:
– il paradosso dell’accettazione della nostalgia come condizione psicologica umana a fronte del rifiuto della stessa come bussola d’azione storica;
– la stigmatizzazione del razzismo degli Elfi e l’orizzonte della «fellowship» multirazziale;
– la critica al maschilismo patriarcale;
– la pietà cristiana come elemento irriducibile e imprevedibile che realizza il piano provvidenziale;
– l’affermazione del primato della cultura sulla forza;
– la critica all’«ofermod» eroico e il rifiuto del germanico «vincere morendo»;
Rispetto a quelli come Vance… o come Meloni, andrebbe aggiunta la critica alla plutocrazia capitalistica e alla distruzione del paesaggio con cui si conclude Il SdA (di fatto questo realizza Saruman nella Contea), nonché il cruciale messaggio in difesa dell’ambiente e degli alberi che pervade l’intera opera di Tolkien fin dall’inizio, da quando Melkor, il “Satana” della cosmogonia di Arda, compie uno dei più gravi atti di sabotaggio del creato avvelenando i due alberi di Valinor, Telperion e Laurelin, che davano luce al mondo e origine al tempo, e facendoli morire (ed è l’inizio di una catena di eventi che porterà a varie catastrofi).
Grazie per la risposta.
Mi sembra di capire che, in un certo senso, chi ha letto Tolkien somtanto in lingua italiana può ritenersi fortunatx. La terra di mezzo rimane ancora oggi un mondo solo parzialmente esplorato. Esiste un potenziale immaginifico ancora ampio, sopratutto in età scolastica/pre-scolastica.
Parlo però di testo scritto. Per chi si approccia alla terra di mezzo attraverso la cinematografia andrebbe fatto un discorso a parte.
Io di Tolkien lessi prima “The Hobbit”, per caso. Conoscevo l’autore per sentito dire, ma non lo snobbavo perché di destra. Semplicemente non pensavo mi potesse interessare il “genere”.
Finché mi ritrovai in UK e notai che era come “I Quindici”, omnipresente su tutti gli scaffali.
Ne prelevai una copia ingiallita dalla stanza che affittavo in un cottage del Buckinghamshire e mi feci aiutare con le fantaparole dal mio host.
C’è poco da dire: in quella cultura quelle parole erano, a mia insaputa, coordinate socio-culturali.
Oggi credo che T. intendesse qualcosa di simile quando scriveva di un «[…] something [of the same sort] that belonged to the English».
Per quanto riguarda il problema dell’appropriazione culturale da parte delle destre, tendo ad essere daccordo con la definizione che usò China Miéville in occasione dell’uscita del primo film di Jackson riferendosi al rapporto tra il professore e le varie sinistre, quella radicale in particolare: «non era un alleato politico»
Rimane sempre e comunque, citando ancora l’articolo linkato, il «Gran Daddy Edipico» del genere Fantasy. “The Hobbit” è il primogenito e merita quindi una traduzione adeguata.
May the hair on your toes never fall out.
Quella di Mieville è la classica lettura marxista (anarchica, nella versione di Moorcock) della narrativa di Tolkien. Al fondo è condivisibile nei contenuti – anche se magari un pelo riduttiva – ed è ovvio che T. non è un nostro “alleato politico”. Ma anche “e sti cazzi?”, mi viene da dire, perché mica leggiamo la letteratura in base a questo, no? Ma in base alle suggestioni che ci suscita. Io almeno ho sempre letto Tolkien così e conosco un sacco di gente che lo legge così. Credo che valga anche per Mieville, forse meno per Moorcock, che nel suo furore da uccisione edipica del padre a suo tempo pisciò un po’ fuori dal vaso, poi magari potrei spiegare anche perché, ma tant’è, a ciascuno i suoi complessi.
Detto questo, quello che secondo me i lettori marxisti di T. non hanno mai colto è qualcosa su cui da un po’ di tempo sto provando a raccogliere appunti per riuscire un giorno a scriverlo per bene. Mi scuserà, dude, se approfitto del suo gancio per condividerli qui un po’ alla rinfusa. Proverò comunque a farlo nella maniera più sintetica che mi viene.
La mia tesi è che paradossalmente quello che manca nella narrativa di Tolkien – i conflitti di classe, il sesso, gli aspetti realistici del feudalesimo, la durezza della vita “bucolica” o dei conflitti di genere, ecc. – è precisamente ciò che conferma la visione materialistica della storia. È quella stessa assenza a confermarla.
Mi spiego. Nel suo mondo Tolkien non prevede alcuno sviluppo materiale. Dalle prime società umane nella TdM fino alla fine della Terza Era – migliaia e migliaia di anni – la cultura materiale rimane sempre la stessa, cioè più o meno ferma al nostro Medioevo (a parte gli Woses/Druedain, che sono all’età della pietra). Tolkien – come tutti i romanzieri fantasy del suo genere – è costretto a farlo, perché se la cultura materiale avesse uno sviluppo, allora – come ci insegna Marx – ne seguirebbe anche inevitabilmente uno sviluppo delle forze produttive, una trasformazione sociale, i conflitti di classe, ecc.
Questo trova il suo punto critico di caduta quando Tolkien nel suo mondo immaginario si affaccia sulla soglia della modernità, cioè quando concepisce la società degli Hobbit nella Terza Era, che è già proto-borghese. Ecco, lì non può non affrontare il nodo dell’economia politica. Per prendere il potere nella Contea Saruman infatti non può fare come ha fatto a Rohan, non può condizionare il re, perché gli hobbit non hanno nessun re e la loro non è una società piramidale-feudale, ma una società fondamentalmente anarchica e autoregolata. Saruman entra nella Contea passando proprio dall’economia, e ci instaura un regime plutocratico sfruttando precisamente le dinamiche capitalistiche.
La reazione alla dittatura del più ricco da parte degli hobbit si manifesta in forma di rivolta che ripristina lo status quo ante, e non già di rivoluzione sociale. Gli hobbit si rivoltano ma non cambiano nulla della loro struttura istituzionale, perché se lo facessero, se Tolkien glielo consentisse, per così dire, starebbe già ammettendo che la struttura economica conta eccome e determina i cambiamenti sovrastrutturali.
Dopo il trionfo contro i cattivi, re Elessar/Aragorn promulga addirittura un editto che impedisce alla Gente Grossa di mettere piede nella Contea, come se potesse preservare la società degli hobbit sotto una campana di vetro. Ma Saruman non ha affatto avuto bisogno di entrare nella Contea per infiltrarci il proprio potere, perché appunto ha usato il commercio e l’accumulazione dei mezzi di produzione, sfruttando un “hobbit di paglia” (Lotho Sackville-Baggins). L’unico rimedio ovvio sarebbe l’introduzione di una legge che impedisca l’accumulazione, altrimenti quello che ha fatto Saruman potrà essere rifatto da chiunque in qualunque momento. Ma se gli hobbit introducessero quella legge “rivoluzionaria”, una legge che mette un tetto all’accumulazione, da un lato questo implicherebbe un soggetto politico-istituzionale che la imponesse, dall’altro starebbero già reagendo “in avanti” agli effetti della mutazione economica. E questo T. non può consentirlo, perché l’intera sua costruzione di mondo rischierebbe di crollare. Lasciare entrare l’economia nella storia è precisamente quello che non può permettersi.
Tolkien è costretto a tenere la cultura materiale fuori dal divenire storico, e questo – insieme alla totale assenza di una religione strutturata – è forse l’elemento più “fantastico” della sua creazione letteraria. Solo così il suo mondo può funzionare e rimanere intonso dai conflitti reali del nostro mondo. Ecco perché sostengo che non c’è niente di più involontariamente “marxista” di questa sua necessità, perché non fa che confermare quello che noi materialisti storici sappiamo: è lo sviluppo della cultura materiale e delle forze produttive che muove la storia creando i conflitti di classe, di genere, ecc. Se vuoi schivare quei conflitti, devi tenere fuori l’economia, perché questa poi si trasforma sempre in politica. Per dirla con Frederic Jameson: è massimamente interessante l’inconscio politico che l’opera di Tolkien rivela.
In buona sostanza quello che i commentatori marxisti stigmatizzano di Tolkien, cioè, come afferma Mieville, che l’escapismo tolkieniano non mette in discussione il capitalismo, è del tutto insufficiente. Non lo mette in discussione nella misura in cui non può accettarlo, tanto che non appena si affaccia nella TdM è necessario bloccarlo e cancellarlo… ma senza poter trovare un rimedio, perché questo implicherebbe in qualche modo accettare l’influenza dell’economia nella storia (intesa anche come narrazione) e – dettaglio nient’affatto irrilevante – sull’etica tanto cara a Tolkien.
Detto in maniera ancora più secca: il “free will” cattolico su cui Tolkien impernia tutta la sua filosofia narrativa, si complicherebbe alquanto se dovesse fare i conti con la lezione dei tre grandi eretici del XIX secolo (Marx, Nietzsche e Freud) e cioè che noi non siamo quello che pensiamo, bensì pensiamo quello che siamo.
Chiedo venia per il pippone.
Riflessione molto originale e interessante, grazie!
Forse, oltre a un inconscio “non potere”, visto che all’epoca non c’era ancora stata la new age della psicologia cognitiva, né la proposizione sistemico-relazionale, cioè mancavano le acquisizioni scientifiche e culturali per lasciarsi dietro Freud e superare il dualismo tra natura e cultura (e continuare a immaginare storie fantastiche), c’è anche un inconscio non volere, nel senso che forse anche Tolkien, come essere umano, aveva le sue colonne d’Ercole che non intendeva oltrepassare.
Interiorizzare il materialismo storico, ridimensionare il libero arbitrio, sostituire il caso alla provvidenza, abbandonare il concetto di “Uomo” per considerare qiello di “essere umano” (inteso come un particolare essere vivente) avrebbe significato mettere in discussione la sua fede cattolica.
Comunque condivido la tua idea, se l’ho intesa bene, per cui è davvero complicato far coesistere magia e divenire storico e materiale.
Forse la magia, come dio, semplicemente è (quindi, senza storia).
P.s.
Quando scrivi “qualcosa su cui da un po’ di tempo sto provando a raccogliere appunti per riuscire un giorno a scriverlo per bene” immagini una estensione di Difendere la Terra di Mezzo?
Bella tesi. E, di nuovo, grazie per quella che sembrerebbe un’anticipazione.
Al netto dei personaggi, la contraddizione, o, se si preferisce, il problema principale della vita sociale dell’Inghilterra di quell’epoca che preoccupava il filologo Tolkien e che immagino si sia sforzato di risolvere attraverso la sua produzione letteraria, è probabilmente quella della tangibile scomparsa dalla vita di quelle genti della possibilità stessa dell’incanto. La caduta nell’oblio di trolls, goblins, elves and fairies:
«[…] that very primitive undergrowth that the literature of Europe has on the whole been steadily cutting and reducing for many centuries […] (non cito la traduzione italiana che so, anche quella, controversa).
Cutting and reducing. Rings any bells?
Da questa prospettiva la tesi di WM4 non fa una grinza. Nella TdM semplicemente la cultura materiale che muove la storia nella realtà non ha bisogno di esistere, di essere messa in moto, perchè la sua assenza la rende, magicamente e in maniera paradossale, manifesta.
In virtù di questa interpretazione mi sento quasi in vena di perdonare al prof. quell’odioso “lunatic fringe”.
Quasi.
Rispondo qui sotto al cosiddetto pippone di WM4 perché evidentemente il s/w dei commenti e io non andiamo d’accordo e non riesco mai a commentare nel luogo appropriato.
Be’ a me non sembra affatto un pippone, forse perché sono alquanto logorroica io per prima e mi piacciono i testi lunghi e dettagliati, altrimenti non leggerei T.
Soprattutto lo trovo un ottimo spunto assolutamente meritevole di approfondimento, quello sul silenzio eloquente su tutto ciò che evoca la concezione materialistica della storia per impossibilità di accettare la visionner del modo che ne consegue. Di nuovo aprirebbe alla ricerca di paragoni nel contesto letterario e storico, ma è interessante anche così.
Dopotutto Tolkien inventa un mondo e una lingua, e guarda caso lascia da parte proprio tutte quelle cose lì, il conflitto di classe ecc. che sono parte fondamentale del mondo e non potevano essergli ignote. Diciamo pure che l’economia stessa entra come distruzione, nella Contea e nel romanzo, perché prima dell’instaurazione del régime mercantilista di Saruman, basato sull’impoverimento interno, il lavoro forzato e le esportazioni (il tabacco trovato a Isengard), nella Contea di cosa si viva non si sa (un po’ di servizi domestici, un mugnaio, una fattoria quasi autosufficiente, e il misterioso castello semifeudale dei Tuck).
Il sesso io penso che entri con Shelob e come distruzione siamo lì.
Pure l’amore se pensiamo a Éowyn è qualcosa di malato e distruttivo, un impulso cieco e irragionevole, tanto più se si sposa a una rivendicazione di genere. Insomma tutte queste cose non solo non ci sono nei momenti pacificati del romanzo, ma quando si affacciano sono proprio disastrose.
Non stupisce allora che il romanzo finis à négliger anni 50 con il discorso del mondial descritto
L’ultima frase del commento precedente è incomprensibile perché il correttore ha preso lui la penna, anzi la tastiera:
“Non stupisce allora che negli anni ’50 il romanzo di Tolkien finisca con il disfarsi del mondo descritto” pur se in perfetta armonia con il modello epico della fine dell’età eroica.
Per tornare al discorso dei primi commenti, anche Merry e Pipino tornano cresciuti, compreso in senso fisico, dal viaggio e sono pronti a resistere senza paura e poi a guidare una ribellione all’oppressione, mentre Frodo se ne lava le mani, ma ovviamente non a fare una rivoluzione. Anche perché, in un mondo idilliaco e bucolico come la Contea, sembra suggerire Tolkien, dove la trovi la necessità di una rivoluzione, non ce n’è mica bisogno, contro l’ingiustizia si è sempre (quasi) tutti uniti.
Il legame tra questo tipo di assenze e la Cultura materiale forse lo dettaglierei ulteriormente, perché in un romanzo lo sviluppo materiale potrebbe anche coesistere volendo, con l’esclusione delle tematiche scomode dei rapporti di produzione.
Ultima osservazione sulla denuncia del maschilismo patriarcale: sì certo, le cose atroci che alcuni personaggi femminili subiscono nel Silmarillion e lo strazio senza un perché imposto da Elrond alla figlia e al suo innamorato cui loro si piegano peraltro con “cristiana” rassegnazione rappresentano il patriarcato in maniera poco elogiativa – ai nostri occhi odierni. Ma anche lì non bisogna esagerare, non proprio rivoluzionare sembra dire Tolkien.
Molto interessante. Attendo fiducioso sperando di non leggere Borsi Sacconi da qualche parte. La mancanza di figure femminili è forse spiegabile col fatto che gli Hobbit vengono trattati come figure al limite dell’ asessuato, anche in Lord of the ring assistiamo a un unico matrimonio tra gli Hobbit.
Amore e relazioni sembrano solo ad appannaggio di Elfi e Uomini. Non ci sono neppure nane, goblesse o streghe. Gli Elfi e gli Uomini ogni tanto si mischiano e danno origine alle dinastie più interessanti dal punto di vista della narrazione. I mezzi Elfi, che fanno capo a Elrond, ed Elros che darà origine ai Numenoreani.