
In occasione dell’uscita di Beren e Lúthien, l’ultimo volume curato da Christopher Tolkien, figlio del più illustre genitore, si è prodotto un bel dibattito su due quotidiani nazionali. Alla recensione dello scrittore Michele Mari ha replicato Roberto Arduini, presidente dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, e vale la pena leggere entrambi gli articoli, se non altro per rendersi conto di come sia cambiato il trattamento riservato a Tolkien sulla stampa mainstream. Soltanto cinque o sei anni fa sarebbe stato impensabile uno scambio a questo livello in quelle sedi. È il segnale che, dài e dài, la percezione di questo autore è finalmente mutata (nessuna medaglietta, ma un po’ di soddisfazione ce la si può concedere).
Mari e Arduini discutono intorno all’annoso problema rappresentato dalla figura di Christopher Tolkien e dal ruolo di esecutore testamentario sui generis che ha esercitato nell’arco di quarant’anni. È il momento di farlo, perché nell’introduzione del volume appena pubblicato Christopher stesso annuncia che alla veneranda età di novantatré anni passa infine la mano. L’argomento è tutt’altro che specioso, dato che Beren e Lúthien è l’esempio di uno dei vari modi con i quali Christopher ha lavorato sulla materia paterna, cioè sul mare magnum di appunti e testi inediti più o meno incompiuti nel quale nuota dal lontano 1973, quanto Tolkien senior morì. La metafora del mare (o addirittura dell’oceano, come dice Mari) però potrebbe essere sostituita con un’altra, suggerita da Tom Shippey in una conferenza tenuta a Modena qualche anno fa, in occasione dell’uscita del primo film tratto da Lo Hobbit. Shippey paragonò bonariamente Christopher Tolkien al drago Smaug, «assiso sul tesoro».
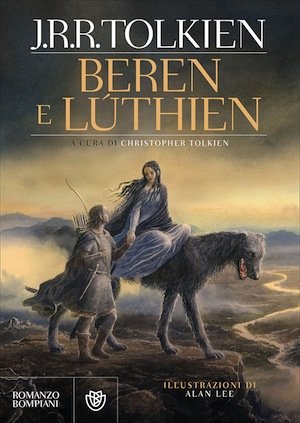 Ecco, queste due immagini: il navigatore che cerca una rotta e il drago che custodisce gelosamente una montagna d’oro colgono l’essenza del ruolo giocato da Tolkien junior, il quale ha dedicato metà della sua vita allo studio e alla pubblicazione degli inediti paterni. C’è un andamento dialettico che ha caratterizzato l’impegno di Christopher e che lui stesso ha tematizzato, illustrato, discusso pubblicamente (Arduini lo fa giustamente notare, al contrario di Mari: tutto si può dire di Christopher Tolkien eccetto che non abbia sempre problematizzato e spiegato il proprio agire davanti a tutti).
Ecco, queste due immagini: il navigatore che cerca una rotta e il drago che custodisce gelosamente una montagna d’oro colgono l’essenza del ruolo giocato da Tolkien junior, il quale ha dedicato metà della sua vita allo studio e alla pubblicazione degli inediti paterni. C’è un andamento dialettico che ha caratterizzato l’impegno di Christopher e che lui stesso ha tematizzato, illustrato, discusso pubblicamente (Arduini lo fa giustamente notare, al contrario di Mari: tutto si può dire di Christopher Tolkien eccetto che non abbia sempre problematizzato e spiegato il proprio agire davanti a tutti).
Osservare questo andamento diacronico, questo oscillare tra un estremo e l’altro, passando per le vie di mezzo, e leggere ogni volta le riflessioni di Christopher sui problemi incontrati e sulle scelte fatte, equivale a osservare il lavoro di un filologo creativo. Come se Christopher avesse ereditato il mestiere del padre (la sua formazione in effetti è analoga) e lo avesse applicato alla produzione narrativa del medesimo.
Se Il Silmarillion (1977) è quasi una sorta di apocrifo, laddove Christopher ha selezionato e rimaneggiato il materiale sulla cosmogonia e sui tempi antichi per trarne una narrazione romanzata, efficace sul piano letterario, questo ha poi prodotto in lui una sorta di pentimento e la reazione in direzione opposta, vale a dire la History of Middle-Earth (1983-1996). Tredici volumi pubblicati tra gli anni Ottanta e Novanta, che espongono diacronicamente gli appunti, le varie versioni, i materiali collaterali, che sarebbero potuti diventare libri, o che avrebbero potuto comporre “Il Silmarillion” immaginato da J.R.R. Tolkien e mai realizzato. Il primo è un caso di editing coautoriale, il secondo un’esposizione critica di materiali inediti. Il primo è il lavoro di un narratore, il secondo quello di un filologo.
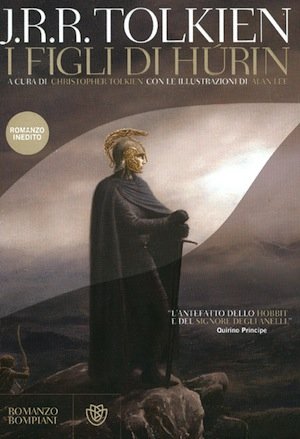 Allo stesso modo, se con I Figli di Húrin (2007) Christopher era sembrato voler privilegiare la leggibilità e la compattezza del testo letterario, traendo fuori dall’ipotetico “Silmarillion” una delle storie portanti, ecco invece che con Beren e Lúthien ritorna alla modalità della History, ma con una selezione tematica. Il libro infatti si compone di materiali non già inediti, ma ripescati dall’oceano di cui sopra in modo da andare a comporre una storia specifica, quella di Beren e Lúthien, appunto, una delle più belle dei tempi antichi, nelle sue mutazioni attraverso le varie versioni. Tolkien infatti scrisse e riscrisse questa storia nell’arco di una vita, e non liquidò mai una versione definitiva per la pubblicazione (basti dire che la natura di Beren muta da uomo a elfo e di nuovo a uomo nell’arco degli anni e delle stesure). Insomma Beren e Lúthien è un volume da filologi tolkieniani. Un libro non letterario. Un libro illeggibile come una storia, e invece affascinante per tutto ciò che vuole mostrare, quasi fosse il testamento del curatore testamentario (e forse lo è). A tratti la scrittura di Christopher diventa invasiva, come nei volumi della History, si confonde quasi con quella del padre, il lettore fatica a distinguerli: chi sta parlando? L’autore, il curatore? Da quali meandri del ventesimo secolo arrivano questi appunti? E queste riflessioni? Christopher parla del lavoro del padre nell’arco dei decenni (e dice «mio padre», come ha sempre fatto), ma parla anche del proprio lavoro attraverso i decenni, fatto anche di ripensamenti, cambi di rotta, nuove scoperte. Sono due vite che insieme toccano tre secoli e che in Beren e Lúthien sembrano quasi fondersi o piuttosto collegarsi senza soluzione di continuità. La sensazione a tratti è di straniamento, come di essersi persi dentro un labirinto, e non si è sicuri di volere raggiungere il centro oppure l’uscita. È infatti facile perdercisi dentro, in questa storia che è un punto d’origine di tutta la subcreazione tolkieniana, se non altro in senso tematico (e anche biografico, come testimonia la lapide coniugale dei Tolkien). L’amore ostacolato, la missione impossibile, il viaggio inferico, la scelta tra mortalità e immortalità, il libero arbitrio, saranno i grandi temi-pilastri della narrativa tolkieniana. In un certo senso sono già tutti lì, in quella meravigliosa riscrittura del mito di Orfeo a ruoli invertiti e con il lieto fine che è appunto la storia di Beren Erchamion e Lúthien Tinúviel.
Allo stesso modo, se con I Figli di Húrin (2007) Christopher era sembrato voler privilegiare la leggibilità e la compattezza del testo letterario, traendo fuori dall’ipotetico “Silmarillion” una delle storie portanti, ecco invece che con Beren e Lúthien ritorna alla modalità della History, ma con una selezione tematica. Il libro infatti si compone di materiali non già inediti, ma ripescati dall’oceano di cui sopra in modo da andare a comporre una storia specifica, quella di Beren e Lúthien, appunto, una delle più belle dei tempi antichi, nelle sue mutazioni attraverso le varie versioni. Tolkien infatti scrisse e riscrisse questa storia nell’arco di una vita, e non liquidò mai una versione definitiva per la pubblicazione (basti dire che la natura di Beren muta da uomo a elfo e di nuovo a uomo nell’arco degli anni e delle stesure). Insomma Beren e Lúthien è un volume da filologi tolkieniani. Un libro non letterario. Un libro illeggibile come una storia, e invece affascinante per tutto ciò che vuole mostrare, quasi fosse il testamento del curatore testamentario (e forse lo è). A tratti la scrittura di Christopher diventa invasiva, come nei volumi della History, si confonde quasi con quella del padre, il lettore fatica a distinguerli: chi sta parlando? L’autore, il curatore? Da quali meandri del ventesimo secolo arrivano questi appunti? E queste riflessioni? Christopher parla del lavoro del padre nell’arco dei decenni (e dice «mio padre», come ha sempre fatto), ma parla anche del proprio lavoro attraverso i decenni, fatto anche di ripensamenti, cambi di rotta, nuove scoperte. Sono due vite che insieme toccano tre secoli e che in Beren e Lúthien sembrano quasi fondersi o piuttosto collegarsi senza soluzione di continuità. La sensazione a tratti è di straniamento, come di essersi persi dentro un labirinto, e non si è sicuri di volere raggiungere il centro oppure l’uscita. È infatti facile perdercisi dentro, in questa storia che è un punto d’origine di tutta la subcreazione tolkieniana, se non altro in senso tematico (e anche biografico, come testimonia la lapide coniugale dei Tolkien). L’amore ostacolato, la missione impossibile, il viaggio inferico, la scelta tra mortalità e immortalità, il libero arbitrio, saranno i grandi temi-pilastri della narrativa tolkieniana. In un certo senso sono già tutti lì, in quella meravigliosa riscrittura del mito di Orfeo a ruoli invertiti e con il lieto fine che è appunto la storia di Beren Erchamion e Lúthien Tinúviel.
 Difficile non subirne il fascino. Così come è difficile sottrarsi al quesito che aleggia su tutta l’operazione: «E adesso?».
Difficile non subirne il fascino. Così come è difficile sottrarsi al quesito che aleggia su tutta l’operazione: «E adesso?».
Adesso che anche la seconda vita di Tolkien, ovvero quella del secondo Tolkien, si è consumata tutta, cosa succederà al tesoro? Chi erediterà quell’amore “fiero e geloso”?
Verrebbe da augurarsi nessuno. Il punto di convergenza tra gli interessi tutelativi della Tolkien Estate e quelli economici di Harper & Collins (editore di Tolkien) imporrà forse che le cose continuino così, al ritmo di un ripescaggio o due all’anno di un qualche inedito dagli archivi tolkieniani (ma siamo già arrivati agli scritti degli anni in cui era matricola all’università), per lanciarlo come il nuovo libro di JRRT al quinto decennio dalla morte.
Ciò nonostante è bello almeno fantasticare un’apertura degli archivi, il libero accesso al tesoro, la possibilità che quel patrimonio dia origine a mille storie, invece di essere passato al setaccio del feticismo filologico a discapito della narratività. Il racconto, ogni racconto, pretende di essere aperto, policentrico, collettivo. Era così la letteratura che Tolkien studiò per una vita e che provò anche a imitare negli anni giovanili; è così un libro come Il Silmarillion di Tolkien & figlio, o I Figli di Húrin; ed è così la narrazione contemporanea 2.0, partecipata e transmediale, che apre porte d’accesso a mondi secondari e consente al lettore di proseguire il racconto, di non essere soltanto un passivo contemplatore, ma di prendere parte attiva alla subcreazone. I grandi racconti non hanno mai una fine, è proprio la lezione tolkieniana.
Questo è sempre stato il destino naturale dell’opera di Tolkien, «simile alla crescita delle leggende tra i popoli, al prodotto di molte menti e generazioni», come dice Christopher, e che quindi travalica il destino naturale del suo autore o dei suoi due autori. Come ci insegna Frodo: «non terminano mai i racconti. Sono i personaggi che vengono e se ne vanno, quando è terminata la loro parte.»
Piace immaginare che il commiato di Christopher John Reuel Tolkien non sia che un nuovo inizio.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
