
Come annunciato esattamente un anno fa, il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki sta conducendo estese ricerche d’archivio sul caso Giuseppina Ghersi. I risultati di tali ricerche verranno diffusi quando sarà tempo, ma ci sono risultati “collaterali” già pubblicabili. La fabulazione neofascista sulla morte di Giuseppina Ghersi è infatti legata ad altre narrazioni ricorrenti in quegli ambienti. Una volta sottoposte anche solo alle più elementari verifiche, tali narrazioni si sono rivelate nient’altro che bufale. Le smonteremo una dopo l’altra. Cominciamo oggi, dal mai avvenuto «Eccidio di Monte Manfrei». [WM]
INDICE DELLA PRIMA PUNTATA
1. Introduzione
2. Cosa intendono i neofascisti per «Eccidio di Monte Manfrei»?
3. È andata così. Anzi, no: così. Anche se…
4. I peli ma non i vizi: foto fake e scorribande su Wikipedia
«Vedi, i morti possono essere molto utili. A me, personalmente, hanno risolto situazioni difficili più di una volta. Primo perché non parlano. Secondo, perché, se aggiustati bene, possono sembrare vivi. E terzo, anche se gli spari non succede niente perché al massimo dovrebbero morire, ma sono già morti.».
(Sergio Leone, Per un pugno di dollari)
1. Introduzione
Durante le ricerche sulla morte di Giuseppina Ghersi ci siamo ripetutamente imbattuti nel cosiddetto «Eccidio di Monte Manfrei». Di cosa si tratta?
A ridosso del 25 aprile 1945, una non ben precisata brigata partigiana avrebbe ucciso 200 marò tuttora senza nome, seppellendone i corpi in introvabili fosse sui monti della Liguria.
Un episodio a dir poco nebuloso, ma divenuto cavallo di battaglia di molti pubblicisti e agitatori revisionisti, se non tout court neofascisti. Si tratta degli stessi personaggi visti in azione sul caso Ghersi. Anche il tema sotteso alla vicenda è lo stesso del caso Ghersi: l’«odiosa crudeltà partigiana» contro persone «colpevoli solo di non condividerne il fanatismo ideologico».
Dare un’occhiata era dunque doveroso.
2. Cosa intendono i neofascisti per «Eccidio di Monte Manfrei»?
Prima di esaminare le fonti, proviamo a tracciare gli eventi così come li raccontano e commemorano i neofascisti.
Val d’Orba, Liguria. Nei giorni della Liberazione – o addirittura a maggio – circa duecento marò della San Marco – più, secondo alcune versioni, alpini collaborazionisti della Monterosa – si consegnarono a imprecisati partigiani, sconosciuti o di formazioni fuori controllo. Il comandante dei marò, il tenente Giorgio Giorgi, avrebbe contrattato con questi partigiani, scambiando la vita dei 200 per aver salva la propria, oppure fu tradito. Forse, oltre ai 200, c’erano anche altre persone (civili o forze militari naziste).
Dopo una prima marcia i soldati sarebbero stati rinchiusi per due o tre giorni nella villa «La Romana». Durante tale permanenza i pochi partigiani a loro guardia avrebbero fatto avanti e indietro armati di pale e picconi tra la villa e luoghi inaccessibili tra i monti della zona, per scavare una cinquantina di piccole fosse. Dopodiché, i partigiani avrebbero portato i soldati, a piccoli gruppi, legando a ognuno mani e piedi per renderne difficoltosi i movimenti e rallentarne l’andamento, verso quelle fosse dove li avrebbero uccisi a colpi di mitragliatrice – o di piccone, o con coltelli – per poi coprirne i corpi con una manciata di terra e foglie. Il tutto in un’area molto vasta e senza che nessuna persona del luogo vedesse né sentisse alcunché. Tra la fine della guerra e oggi sarebbe stata trovata qualche decina di corpi – 50, 60 o 61 – mentre la maggior parte delle fosse con i relativi cadaveri sarebbe ancora introvabile.
Questa, a grandi linee, la narrazione-base, grossomodo condivisa dalla maggior parte delle versioni, ognuna delle quali però presenta elementi che la porta a divergere notevolmente dalle altre. Un puzzle di tessere male incastrate. O forse calza di più la metafora del caleidoscopio: i pezzi principali possono comparire in forme e combinazioni diverse, ma resta un nocciolo narrativo invariabile, che possiamo sintetizzare così: «alcuni partigiani hanno ucciso dei fascisti indifesi e ne hanno occultato benissimo i corpi».
Pur trattandosi di gravissime accuse nei confronti delle forze partigiane, le narrazioni del Manfrei sono assai incerte su chi indicare come colpevole. Tra gli accusati troviamo nominati un partigiano di nome Triste, un altro di nome Mingo e uno di nome Vanni; volta per volta vengono additate la brigata «Buranello», la brigata «Emilio Vecchia», la divisione «Mingo», fantomatiche «formazioni bianche», o formazioni partigiane mai identificate. Nella maggior parte delle versioni si attribuisce la responsabilità a una brigata partigiana o a due brigate che collaborarono tra loro, anche se vi è pure chi sostiene che i marò, una volta consegnati (o catturati) sarebbero invece stati contesi fra diverse formazioni.
3. È andata così. Anzi, no: così. Anche se…
Gli anni dell’immediato dopoguerra. Case distrutte, strade e ferrovie da ricostruire, scuole, ospedali e uffici pubblici chiusi o che funzionano a stento, città alla fame, episodi di sciacallaggio e furti, l’amministrazione ordinaria portata avanti da enti straordinari che spesso si arrangiano come possono. È in queste condizioni che, anche in Italia, uomini e donne devono riavviare le proprie vite, dovendo al tempo stesso mettere la parola «fine» alla sequela di drammi e ingiustizie degli anni precedenti.
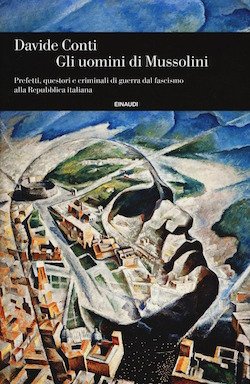 Tutto ciò in un clima che vede convivere la speranza in un nuovo assetto democratico e la sempre maggior consapevolezza che, fatta eccezione per le figure più ingombranti e compromesse, i fascisti che hanno contribuito alla distruzione del paese rimarranno ai loro posti, impuniti. Gli stessi magistrati, carabinieri, militari, insegnanti, funzionari pubblici di vario genere continueranno ad amministrare la nazione, seppur formalmente sotto un diverso cappello (cfr. Davide Conti, Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, Einaudi, 2017).
Tutto ciò in un clima che vede convivere la speranza in un nuovo assetto democratico e la sempre maggior consapevolezza che, fatta eccezione per le figure più ingombranti e compromesse, i fascisti che hanno contribuito alla distruzione del paese rimarranno ai loro posti, impuniti. Gli stessi magistrati, carabinieri, militari, insegnanti, funzionari pubblici di vario genere continueranno ad amministrare la nazione, seppur formalmente sotto un diverso cappello (cfr. Davide Conti, Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, Einaudi, 2017).
Mentre l’Italia vive una serie di cambiamenti intensi ed estremamente rapidi i fascisti, silenziosamente, “scompaiono”. Persone iscritte al PNF dalla prima ora improvvisamente dichiarano di esser state costrette a farlo; chi manifestava sostegno al regime si giustifica dicendo che era “posa obbligata”, e così via. Fatta eccezione per pochi irriducibili, tutt’a un tratto sembra che nessuno in Italia abbia mai avuto a che fare con la dittatura.
La narrazione fascista degli eventi resta viva, ma s’inabissa, diviene sotterranea, manifestandosi in forme e approcci diversi che spaziano dall’esplicita nostalgia, ristretta quasi solo agli ambiti missini, alla ben più diffusa litania qualunquista e deresponsabilizzante, quel giustificazionismo di stampo montanelliano di cui ha scritto anche lo storico Mimmo Franzinelli:
«[Montanelli] veicola la propria interpretazione del fascismo come regime tutto sommato accettabile, la cui caduta si deve unicamente alla cospirazione interna dei gerarchi, con buona pace degli antifascisti illusi e ininfluenti. L’autoassoluzione del Mussolini buonuomo non è soltanto il frutto di un animo generoso e incline al perdono, ma – e qui entra in gioco il vissuto di Montanelli – rappresenta l’autoassoluzione dell’entourage del dittatore: dai gerarchi che in buona fede avevano costruito il piedistallo al duce sino ai milioni di italiani sedotti dall’uomo di Predappio.»
Non stupisce, dunque, che in un paese disastrato e con identità in fase di cambiamento, operazioni come il recupero delle salme siano svolte in maniera disomogenea, divise tra lungaggini burocratiche, voglia di chiudere rapidamente con il passato e desiderio di giustizia.

Noemi Serra Castagnone
Con queste premesse e in questo clima avvengono le esumazioni dei corpi sepolti nei dintorni di Urbe, nel savonese. Sulla scena troviamo alcuni personaggi del luogo, legati a vario titolo al regime, che seguono le ricerche svolte dai carabinieri tra il 1948 e il 1956. Si tratta di Noemi Serra Castagnone, vedova di uno squadrista e milite GNR [Guardia Nazionale Repubblicana] ucciso nel 1945 e successivamente delegata nazionale dell’Associazione famiglie caduti RSI, del sindaco di Urbe Giulio Zunini, segretario politico durante la Repubblica di Salò, la cui moglie venne rasata a zero dopo la Liberazione in quanto collaboratrice dei fascisti, e di un sacerdote giunto nel dopoguerra, don Enrico Principe.
Non è chiaro che ruolo ebbero costoro nelle esumazioni, ma l’impressione che si ricava dalle diverse narrazioni è che soprattutto la Castagnone abbia, da un lato, agito di sponda con i carabinieri addirittura effettuando scavi indipendenti e, dall’altro, portato avanti diverse attività per circonfondere di mito i corpi recuperati.
È in questo contesto che al Cimitero delle Croci Bianche di Altare, in provincia di Savona, avvengono le inumazioni dei corpi recuperati e l’erezione – secondo diverse fonti nel 1958(ad esempio Oddone e Viale, Fratricidio! I caduti della RSI nelle stragi dell’entroterra ligure, Novantico, 1998), ma altre dicono nel 1954 – della prima croce sul Manfrei. La croce verrà però abbattuta poco dopo, da mano ignota, almeno stando a quanto sostenuto nelle stesse fonti che ne narrano la messa in posa.
Non si capisce perché, tra tutti i luoghi possibili in cui erigere una croce simbolica, sia stato scelto proprio il Manfrei, dato che, a quanto sembra di capire, il grosso delle fosse venne ritrovato in tutt’altri luoghi (ci arriviamo).
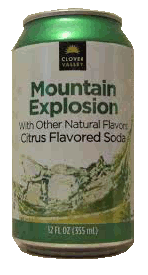 Le notizie riguardo le esumazioni e l’operato della Castagnone provengono principalmente dai racconti fatti negli anni Novanta da coloro che si sono fatti portabandiera delle narrazioni del Manfrei. Sono racconti assai imprecisi e contraddittori, in cui è impossibile discernere le testimonianze affidabili dalle chiacchiere.
Le notizie riguardo le esumazioni e l’operato della Castagnone provengono principalmente dai racconti fatti negli anni Novanta da coloro che si sono fatti portabandiera delle narrazioni del Manfrei. Sono racconti assai imprecisi e contraddittori, in cui è impossibile discernere le testimonianze affidabili dalle chiacchiere.
■ Si parla di 50 corpi recuperati (Pansa, Il mio viaggio tra i vinti, Rizzoli, 2017), o di 50 fosse e 61 corpi (Brenna, Monte Manfrei: storia di un olocausto, in: San Marco n. 20, anno IV, giugno 1998);
■ ci si riferisce alla «memoria» della Castagnone, senza specificare se si tratti di una memoria scritta o meno;
■ si accenna all’esistenza di documenti redatti dalla Curia di Acqui Terme, dal Comune di Urbe e dai Carabinieri che tuttavia non vengono mai mostrati e i cui contenuti, riportati solo in forma estremamente sintetizzata (ad esempio in: Oddone, Viale, op.cit.), sembrano consistere perlopiù in ipotesi scritte e/o verbalizzazione di voci di paese;
■ si racconta di interi costoni di montagna fatti esplodere per seppellire i corpi in una fantomatica grande fossa comune, che però non è mai stata trovata (vi ricorda qualcosa?). Del resto, non risulta vi sia alcun «pezzo di monte esploso», né esiste alcuna testimonianza di tale esplosione.
Non è dato sapere con esattezza che forme avessero le narrazioni del Manfrei tra il dopoguerra e gli anni Ottanta, cioè risalire i rigagnoli fino alla fonte, ma visto l’alto grado di incertezza dei testi degli anni Novanta si può supporre che in quegli anni circolassero giusto alcune idee sommarie, intessute sulla base di alcuni elementi di base: diversi corpi rinvenuti nel dopoguerra, una formazione di soldati della San Marco rinchiusi al Rostiolo e poi fatti marciare verso chissà dove. È però abbastanza chiaro che in quegli anni almeno alcune di queste narrazioni indicavano come supposto responsabile il capo partigiano che nell’aprile 1945 controllava la zona del Manfrei: Domenico Patrone, all’epoca comandante del distaccamento «Calcagno» della brigata «Buranello», inizialmente col nome di battaglia «Triste» e successivamente col nome «Mingo». A volte erroneamente indicato come «don» Domenico Patrone (Patrone, Toscani, Triste. Storia, L. Editrice, 2010, pp. 95-98). Superfluo far notare che nessuno degli accusatori di Patrone ha mai prodotto alcuna prova o testimonianza a supporto di quanto sostenuto. Gli echi di questa attribuzione di responsabilità si sono protratti per decenni, sfociando in minacce anonime allo stesso Patrone e in ulteriori polemiche dopo la sua morte, avvenuta nel 2011.
Patrone ribadì per anni di non saper nulla della supposta sparizione di duecento marò, aggiungendo che a suo avviso la diceria derivava da un episodio riguardante
«un gruppo dei san Marco che si presentarono al mio Distaccamento poco prima del 25 aprile 1945, portando come prigioniero il loro comandante, sottotenente Fantoni, processato e condannato a morte mediante fucilazione, e gli stessi San Marco si incaricarono del plotone di esecuzione. Comunque non era un folto gruppo, quindi venti uomini poco più poco meno, di loro non seppi più nulla, essendo prossima l’ora dell’Insurrezione Generale; io con tutto il mio Distaccamento ricevetti l’ordine di recarmi a Genova per contribuire alla sua liberazione e subito partimmo. Sentii parlare di questo fatto [il supposto eccidio del Manfrei, N.d.R.] molto tempo dopo, ma non gli diedi peso in quanto era un periodo che se ne dicevano di tutti i colori, ma mentre tutto si attenuava, Monte Manfrei ebbe un seguito protraendosi fino ai nostri giorni, perciò ritengo sia doveroso finirla con le maldicenze sul mio nome e su quello della Brigata “Buranello”.» (Patrone, Toscani, op.cit., p.96)
Dall’Albo Caduti e dispersi dell’RSI – Edizione 2017 – su cui torneremo più avanti – effettivamente risulta un sottotenente Fantoni della San Marco caduto il 13 aprile 1945 ad Urbe, seppure con una divergenza sul nome: Giuseppe secondo Patrone, Elis secondo l’Albo. I venti marò consegnatisi furono aggregati al distaccamento di Patrone. (Patrone, Toscani, op. cit., pp. 78-79)
A metà degli anni Ottanta, quando la Castagnone muore, nuove persone entrano in scena a mantenere in vita la narrazione del Manfrei: si tratta di Rosa Melai, Ernesto Grosso e Michele Giusto (nel 1943, diciassettenne, è volontario della RSI ma presta servizio lontano dalla Liguria). Il secondo si occupa di cercare nuove fosse (ma non risulta abbia trovato alcunché), la prima si dà da fare per far mettere una nuova croce sul Manfrei nel 1984 e farvi celebrare la prima messa.

Massimo Numa
All’inizio degli anni Novanta gli “Amici di Fra Ginepro” pubblicano il primo volume di I Caduti della RSI a Genova 1943-1946 (Tipo-Lito F.S., Genova 1993), un elenco che contiene i nomi dei caduti a Urbe e Sassello che verranno spesso indicati come caduti «del Manfrei». Nello stesso periodo Massimo Numa, vecchia conoscenza per chi segue le nostre inchieste e altro personaggio già incontrato nella prima ricognizione del “caso Ghersi”, pubblica La stagione del sangue (Ed. La Ricerca, 1992), in cui per la prima volta compare in forma scritta una narrazione completa dell’eccidio (pp. 55-64). La versione di Numa è probabilmente basata su quanto riportatogli da Grosso e Melai, ed è interessante osservare come certi elementi narrativi ivi contenuti verranno ripresi, alterati o cancellati nelle versioni successive.
La data proposta da Numa è incerta (24-28 aprile), così come il numero dei marò («decine, forse oltre duecento»), che vengono indicati come appartenenti al V reggimento della San Marco. Il tenente Giorgio Giorgi consegnò gli uomini a un distaccamento sconosciuto della divisione garibaldina «Mingo», e questi vennero rinchiusi per due-tre giorni in un casolare in località Romana, sorvegliati da una piccola squadra di partigiani. Successivamente si aggiunse una trentina di militari provenienti da un altro reparto della San Marco.
Dopodiché Numa sostiene che quel che avvenne fu un eccidio misterioso, in quanto non se ne conoscono ordinanti né esecutori né responsabili, non si conosce il numero e la posizione delle fosse, nulla sulle modalità in cui sarebbero avvenute le uccisioni, né il movente, così come non risulta alcuna prova documentale. Vengono citati misteriosi «testimoni», «documenti della curia di Acqui Terme», un ex partigiano che invece parla di uccisioni diverse fatte in tempi diversi. Numa scrive che i marò erano «estremamente giovani» e cita il dettaglio che ai loro corpi sarebbero state tolte le piastrine di riconoscimento. Dice che Giorgi sparì nel nulla, che i corpi ritrovati furono 61, divisi in una quindicina di fosse, che erano svestiti e senza divise. Dice che per lunghi anni i sindaci vietarono la raccolta di funghi e frutti di bosco per la presenza di salme e resti umani nei boschi, che alle 61 salme non è stato possibile dare un nome, che si sospetta che ex partigiani conservino le piastrine in “luoghi oscuri”. Tutto senza mai indicare i riferimenti di eventuali riscontri documentali.

I «Ragazzi del Manfrei» durante una commemorazione.
Al 1950 va fatta risalire (almeno stando a quanto riportato dallo stesso sodalizio) la fondazione dell’Associazione Ragazzi del Manfrei. Li abbiamo conosciuti tra gli agitatori del “caso Ghersi”. A fondarla – con la finalità di raccogliere le «testimonianze e le voci di storie negate» –, Stelvio Murialdo, colui che da anni si presenta come testimone oculare nel caso Ghersi. Classe 1935: avrebbe dunque fondato l’associazione quando aveva 15 anni.
Strano che – fatto salvo un video, datato 1993, che anticipa in qualche modo la narrazione di riferimento, ossia le poche pagine dedicate al Manfrei nel volume di Carlo Viale e Pietro Giulio Oddone Fratricidio! I caduti della RSI nelle stragi dell’entroterra ligure – le uniche tracce di tale associazione risalgano al secolo in corso: una copia archiviata del loro sito, una serie di video sul loro canale YouTube, tra cui due che testimoniano la partecipazione alla cerimonia di celebrazione al Manfrei del 2011.
Nel 1996 Cesare Brenna e Mario Abriani – repubblichini della San Marco che durante la guerra non ebbero a che fare con i “fatti del Manfrei” – rilasciano interviste per la trasmissione radiofonica Rai dal titolo La voce dei vinti, in cui vengono presentate interviste a ex combattenti della RSI raccolte tra il 1994 e il 1996. Brenna, in particolare, dice di avere solo notizie de relato sul Manfrei e, sostanzialmente, di non saperne nulla.
Arriviamo infine al 1998, anno in cui l’accavallarsi di una serie di eventi contribuirà a consolidare definitivamente la narrazione del Manfrei, preparandola al “boost” che riceverà negli anni successivi.
Innanzitutto, Carlo Viale e Pietro Giulio Oddone pubblica Fratricidio!, in cui propongono una versione che ricalca quella di Numa e che diventerà la base per le versioni successive.
Sul trimestrale dei reduci repubblichini della San Marco (n. 20, anno IV, aprile-giugno 1998), invece, Mario Abriani, all’epoca segretario dell’associazione San Marco e direttore dello stesso periodico, pubblica uno stralcio di quelle che vengono indicate come «parti non pubblicate del diario della San Marco», diario redatto dal generale Amilcare Farina e contenente la testimonianza del tenente Giorgi in cui, sostanzialmente, questi dice solo di aver consegnato gli uomini e che questi ultimi sono poi stati portati in un campo di concentramento.
Notiamo qui un’operazione interessante.
La prima parte della testimonianza di Giorgi, che Abriani descrive come veritiera, viene pubblicata in virgolettato:
«Carcere di Savona, 23 giugno 1946.
Il 25 aprile 1945, nel pomeriggio, io sottoscritto tenente Giorgi Giorgio, assumendone tutte le responsabilità, presentavo l’intera Compagnia che comandavo (duecento uomini circa di cui cinque ufficiali, armata ed equipaggiata al completo, ai partigiani della Brigata E. Vecchia, Divisione MINGO, in località Palo, pattuendo l’incolumità assoluta di tutti i dipendenti, cosa che fu accordata dal partigiano “Vanni” comandante la brigata. Da Palo, avvenuto il disarmo e la consegna dei materiali, fummo condotti a Vara ed ivi internati.
Dopo tre giorni fui segregato dai soldati e condotto a Piancastagna, sotto la sorveglianza dei partigiani del posto».
La parte successiva della testimonianza è però rifiutata da Abriani, perché non avvalora la narrazione dell’«Eccidio del Manfrei». Giorgi dice che i marò vennero portati a Sestri Ponente e lì consegnati agli alleati per essere trasferiti al campo di concentramento di Coltano. Dunque tutta la seconda parte del testo, che Abriani bolla come poco verosimile pur non indicando in base a cosa sia giunto a questa conclusione, anziché essere riportata integralmente è soltanto parafrasata:
«Poi continua, sostenendo che i detenuti del campo di Vara sarebbero stati trasferiti a Sestri Ponente per consegnarli agli alleati che li avrebbero condotti al campo di concentramento di Coltano, ad eccezione di sei uomini, sottotenente Crupi, maresciallo Ameri, caporalmaggiore Bertelli, sergente Piochi, caporalmaggiore Tedeschi [sic. in realtà Todeschini] e caporale Ballo, tutti del plotone ciclisti della Compagnia Comando reggimentale, che, denunciati da tali Boccardo e Alamanni, vennero fucilati la sera del 1° maggio nei pressi del cimitero di Sestri Ponente».
Abriani prosegue riportando che Farina redarguisce Giorgi, poiché quest’ultimo non aveva autorità per trattare alcuna resa. In conclusione, Abriani mette in dubbio l’intera testimonianza di Giorgi partendo dal presupposto indiscutibile che «i marò erano stati trucidati a centinaia».
Non abbiamo accesso alle parti non pubblicate del diario di Farina, ma è assai curioso che l’unica testimonianza diretta citata a proposito del Manfrei non parli di strage, bensì di una mera consegna di prigionieri. Tanto che i sostenitori dell’ipotesi dell’eccidio devono correre ai ripari presentandola tagliata, negando l’attendibilità della parte – e solo di quella parte – che non collima con la loro ricostruzione. Lo stralcio della testimonianza Giorgi invece trova ottima corrispondenza nella testimonianza di prima mano della partigiana Fausta Siri riportata in E ma riordu (2015).
La maestra Fausta Siri, 93enne partigiana – nome di battaglia «Rita» – e testimone oculare della consegna dei marò, è molto nota ad Urbe e dintorni. Descritta come personalità vitalissima dalla memoria fotografica, da anni si batte contro le false narrazioni sul Manfrei.
Sullo stesso numero della rivista, Brenna riporta grossomodo la versione di Fratricidio!, ma ibridandola con quella di altre fonti. Diversamente che in Fratricidio!, infatti, il “partigiano cattivo” è Domenico Patrone, nome di battaglia «Triste», con l’assistenza di… Mingo.
«Per almeno 48 ore rimasero lì rinchiusi, ed intanto quelli della Brigata Buranello, secondo gli ordini di Don Domenico Patrone, detto “Triste”, e con l’assistenza di “Mingo” capo di stato maggiore dell’omonima banda che operava tra Crevari e l’Alta Valle dell’Orba, preparavano le fosse.»
Qui Brenna deve aver fatto confusione, ritenendo che «Domenico Patrone detto Triste» e Mingo «dell’omonima banda» fossero due persone diverse, mentre in realtà si tratta della stessa. Confusione dettata probabilmente dal fatto che il nome «Mingo», oltre ad essere quello il nome della Divisione partigiana è un soprannome comune in Liguria (è il diminutivo di Domenico) ed era il nome di battaglia di diversi partigiani locali.
La maggior parte delle narrazioni sul Manfrei comparse negli anni Novanta e Duemila indicheranno altri responsabili, ma la versione che indica i colpevoli in «Triste e Mingo» non scomparirà mai del tutto, come dimostrano le minacce a Patrone e le polemiche post mortem. La si ritroverà tale e quale, per fare un esempio, nel libro di storia locale Alta Val d’Orba & Sassello (don Enrico Principe, Grifl, 2003), che riporta testualmente la versione di Brenna.
Quindi, riepilogando, nelle poche pagine di questo numero del notiziario San Marco la responsabilità del fumoso eccidio viene attribuita a Triste, a Mingo, a Vanni della brigata «Emilio Vecchia».
Dagli anni Duemila a oggi la narrazione del Manfrei è stata ripresa dal circuito mainstream attraverso scrittori come Marco Pirina [del quale abbiamo tracciato un profilo qui] e, soprattutto, Giampaolo Pansa (che ha scritto del Manfrei principalmente in I figli dell’aquila, Sperling & Kupfer, 2002), ogni volta aggiungendo elementi e levigando le versioni precedenti, con dettagli che variabilmente vengono dati certi per uno, incerti per l’altro e poi di nuovo certi per quello successivo ancora. Mancano, invariabilmente, le fonti.

Roberto Nicolick
Da qui in poi è tutto un susseguirsi di versioni copiaincollate e gonfiate. Basti un esempio: l’ex partigiano che negava la strage e l’assenza di piastrine, citato da Numa nel 1992, in diverse narrazioni successive – quella proposta nel video dei “Ragazzi del Manfrei” e, nel 2011, quella riportata in questo articolo del sedicente «ricercatore» Roberto Nicolick pubblicato su Savona News – diventa un «ex partigiano che, intervistato al telefono, si diverte a far tintinnare attraverso l’apparecchio il mazzo di piastrine in sfregio all’intervistatore». E sempre Nicolick, al quale vengono spesso concessi spazi su quotidiani o siti d’informazione locali (come appunto Savona News) non si fa problemi ad attribuire responsabilità in maniera confusa a «Vanni, comandante della divisione Mingo», confondendosi con il Vanni al comando della brigata Emilio Vecchia.
4. I peli ma non i vizi: foto fake e scorribande su Wikipedia
4.1. Foto di strage? Sì, ma strage nazifascista
Ad attirare la nostra attenzione sul caso è stata anche l’iconografia della narrazione che circolava in rete: un’unica illustrazione, una foto d’epoca, cadaveri singolarmente scomposti ma collettivamente allineati in un fosso. La testimonianza di una fucilazione di massa.

«Eccidio di Monte Manfrei»? Acqua.
La foto è stata postata nel 2007 sul blog di Nicolick accompagnata dalla didascalia «INIZIA COSI’ L’INCUBO…» (Sic!).
Successivamente è stata inserita nella – sconclusionatissima e, come vedremo, ora cancellata – voce di Wikipedia «Eccidio di Monte Manfrei», quindi nel 2011 è comparsa in un articolo su SavonaNews, a firma sempre di Nicolick.
Fino a oggi. Sui social la foto viene condivisa, scuote gli animi ed è capace di montare l’indignazione delle destre per almeno cinque minuti.
Ma c’è qualcosa che non va, ce lo diciamo subito: i cadaveri.
I cadaveri nella foto hanno vestiti normali, abiti civili, non militari.
Come per il caso Ghersi e tanti altri casi analoghi, cominciamo a sospettare che probabilmente ci troviamo di fronte a un’immagine vera ma rubata a un’altra storia.
Da una ricerca inversa su Google immagini ricaviamo questo risultato: «Migliore ipotesi per questa immagine: Sant’Anna di Stazzema».

Fuochino. «Migliore ipotesi», ma nemmeno questa è giusta.
Anche Repubblica, Famiglia Cristiana, Fanpage e altri organi di informazione la attribuiscono a Sant’Anna di Stazzema, senza indicare alcun riferimento alla fonte primaria.
Dopo una prima ricognizione, occorre trovare le fonti primarie negli archivi. Del resto, una foto è – o almeno era, prima dell’avvento del digitale – un oggetto fisico: c’è un negativo, c’è un originale.
Su Twitter spunta un’ipotesi: la strage di Castello di Godego.
Indaghiamo.
Troviamo velocemente una fonte: Centro di Ateneo per le Biblioteche – Università degli Studi di Padova. Quest’istituzione ha digitalizzato e reso disponibili online parecchie foto originali dell’eccidio di Castello di Godego (Treviso), avvenuto il 29 aprile 1945 e compiuto dai nazisti in ritirata, con la complicità di fascisti locali.
Scorriamo la galleria fotografica… ed ecco la nostra foto!
L’originale è fisicamente in un archivio: AIVSREC Foto: Scatola 7, n. 603. I diritti di utilizzo di questa fotografia, tra l’altro, sono riservati.
Per l’ennesima volta, i fascisti spacciano per testimonianza fotografica di un «eccidio partigiano» (farlocco, ovviamente) una foto di vittime del nazifascismo. Non può essere un “errore”, è una condotta sistematica. Ormai abbiamo decine di casi.
— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) 2 febbraio 2018
Repubblica e altri l’hanno usata per illustrare il racconto della strage di Sant’Anna di Stazzema, uccisione di civili italiani da parte di truppe naziste. Un errore, ma almeno sono rimaste inalterate le parti vittime/carnefici. Nicolick invece ha rovesciato le parti mostrando i corpi di povera gente sterminata dai nazisti e scrivendo che sono stati uccisi dai partigiani.
La foto circolava in rete da oltre dieci anni. Per scoprirne l’attribuzione falsa e l’utilizzo disonesto sono bastate poche ore.
A quel punto contattiamo Savona News, ottenendo almeno la rimozione della falsa foto.
4.2. La voce «Eccidio di Monte Manfrei» su Wikipedia
In quegli stessi giorni, febbraio 2018, dopo circa otto anni di non molto onorato servizio, viene cancellata anche la voce di Wikipedia dedicata al presunto eccidio di Monte Manfrei. Creata prima del 18 marzo 2010 da un utente che si firmava – alquanto immodestamente, ma in modo sintomatico – «Ernst Junger», al momento della sua cancellazione la voce non brillava certo per affidabilità e precisione. L’incipit ricordava piuttosto certi indimenticati sketch comici di Pier Francesco Loche: «Il presunto eccidio di Monte Manfrei sarebbe avvenuto in una località in provincia di Savona»…
Scorrendo la cronologia degli edit della voce, salta all’occhio la presenza di un utente a noi noto: Jose Antonio, delle cui scorribande nelle voci dell’enciclopedia libera ci siamo occupati in maniera approfondita nelle due puntate del post La strategia del ratto. Manomissioni, fandonie e propaganda fascista su Wikipedia: il caso «Jose Antonio». Jose Antonio – che dopo la nostra inchiesta è scomparso da Wikipedia – si era premurato di caricare nella voce «Eccidio di Monte Manfrei» la fotografia, parrebbe scattata di suo pugno, della «croce del Manfrei» – foto ancora presente nell’archivio immagini di it.wiki, insieme a quella della «targa del Manfrei» – e, in generale, di “presidiare” la voce.

La «targa del Manfrei». Foto scattata e caricata su Wikipedia dal bufalaro neofascista che si firmava «Jose Antonio».
La cancellazione della voce è avvenuta in «modalità semplificata», ovvero senza discussione, secondo il principio del silenzio-assenso, sette giorni dopo la proposta avanzata da un utente che rilevava la mancanza di fonti attendibili e la palese faziosità della bibliografia. È eloquente il commento con cui l’utente Mandalorian rilevava come non fosse nemmeno il caso di aprire una votazione:
«facendo una ricerca online ho trovato riferimenti a questo eccidio solo in forum e siti tipo “Il primato nazionale”, Stragipartigiane.blogspot, www.italia-rsi.it e altre amenità; c’è qualche menzione anche in quotidiani online locali ma la trattazione che ne fanno si basa esclusivamente sugli scritti di uno storico dilettante [Nicolick, N.d.R.] che non è esattamente il massimo dell’attendibilità e della neutralità. Se questo è tutto quello che si trova si può ben capire come di fatto stiamo parlando del nulla. – Mandalorian 21:37, 2 feb 2018».
La procedura di cancellazione in it.wiki si può leggere qui.
A seguito della cancellazione, la pagina è naturalmente sparita da Wikipedia. Per chi fosse curioso di conoscerne il contenuto, a oggi ne rimane una copia fattane da un altro sito e conservata nella cache di Google, visionabile qui.
1 di 2 – Prosegue.
N.B. I commenti a quest’inchiesta saranno aperti 72 ore dopo la pubblicazione della seconda e ultima puntata, programmata per il 27 settembre 2018.
Aggiornamento 27/09: la seconda puntata è on line qui.
INDICE DELLA SECONDA PUNTATA
6. Urbe e Sassello, primavera 1945: gli eventi accertati
7. Nomi, cifre, fosse, luoghi, salme
8. Spostamenti supersonici di partigiani
9. I fantaelenchi dei caduti repubblichini
10. Cui prodest?
11. Appendice: visita a Monte Manfrei
 * Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulle ideologie neofasciste, nato nel 2012 durante una discussione su Giap, il blog di Wu Ming. Ne fanno parte storici, ricercatori di varie discipline, scrittori, attivisti e semplici appassionati di storia. Il nome allude al collettivo di matematici noto con lo pseudonimo collettivo «Nicolas Bourbaki», attivo in Francia dagli anni Trenta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.
* Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulle ideologie neofasciste, nato nel 2012 durante una discussione su Giap, il blog di Wu Ming. Ne fanno parte storici, ricercatori di varie discipline, scrittori, attivisti e semplici appassionati di storia. Il nome allude al collettivo di matematici noto con lo pseudonimo collettivo «Nicolas Bourbaki», attivo in Francia dagli anni Trenta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.
Il metodo di lavoro di Nicoletta Bourbaki è illustrato nell’ebook Questo chi lo dice? E perché? (2018). Il gruppo ha all’attivo diverse inchieste – pubblicate su Giap – sulle manipolazioni neofasciste della Wikipedia in lingua italiana e sui falsi storici in tema di foibe. Tra i vari risultati, ha contribuito a smontare la bufala della cosiddetta «foiba di Rosazzo», altrimenti detta «foiba volante».
Per l’edizione on line della rivista Internazionale, in occasione del Giorno del Ricordo 2017, Nicoletta Bourbaki ha curato lo speciale La storia intorno alle foibe.
Al momento, Nicoletta Bourbaki, coi suoi ricercatori sparsi in tutta Italia, sta lavorando sui materiali di diversi archivi per ricostruire, per la prima volta in modo storiograficamente sensato e accurato, il caso Giuseppina Ghersi.
Nicoletta Bourbaki è su Facebook.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

[…] di Nicoletta Bourbaki * – La prima puntata si trova qui […]
[…] Ghersi, Norma Cossetto… – e in ogni caso crudi torturatori. Dopo essersi interessata al mai avvenuto «eccidio di Monte Manfrei», questa volta Nicoletta Bourbaki si occupa della Colonia di Rovegno, un edificio che qualcuno […]