
di Wu Ming 4
I romanzi di Anthony Cartwright sono atti d’amore. Amore per chi ha perso: calciatori fuori tempo massimo; ex-pugili che rimpiangono il ring; madri di vent’anni o di quaranta, con due lavori o nessun lavoro, con figli piccoli o già troppo grandi. Amore per la gloriosa classe operaia del Regno Unito, quella che costruì l’impero e la ferrovia (i navigator di cui cantavano i Pogues, che non andavano per mare, ma sulle rotaie); quella che ha sputato sangue nelle miniere di carbone e nelle acciaierie della rivoluzione industriale e che di rivoluzione ne sognò un’altra, almeno finché l’orgoglio, le lotte sindacali e la prospettiva di un futuro migliore rimasero qualcosa di tangibile sull’isola dove nacque il marxismo.
Un sogno che andò via via annacquandosi fino a quando l’avvento del liberismo, là prima che altrove, mise fine al futuro in nome dell’eterno presente della merce. Avvenne dopo l’ultima grande prova di resistenza operaia del Novecento europeo, la lotta dei minatori di metà anni Ottanta. Vinsero i Conservatori, vinse l’antropoide signora Thatcher, che in cambio aveva rinverdito la grandeur imperialista con la facile vittoria militare alle isole Falkland.
 Da allora la sconfitta ha proceduto imperterrita, scavando gallerie profonde sotto la superficie della società britannica, fino a farla scricchiolare, fino a rendere il terreno instabile e insidioso. Nel frattempo mezzo continente ha fatto proprie le politiche economiche sperimentate Oltremanica, e dopo il crollo del Muro di Berlino, anche l’altra metà si è convertita alla nuova fede liberista. Un’ideologia che ha tenuto a battesimo l’Unione Europea, con l’imposizione di pareggi di bilancio ai governi nazionali e di manganellate (e qualche proiettile) a chi fin dall’inizio urlava che un’unione dei mercati e non dei diritti sociali nasceva tarata.
Da allora la sconfitta ha proceduto imperterrita, scavando gallerie profonde sotto la superficie della società britannica, fino a farla scricchiolare, fino a rendere il terreno instabile e insidioso. Nel frattempo mezzo continente ha fatto proprie le politiche economiche sperimentate Oltremanica, e dopo il crollo del Muro di Berlino, anche l’altra metà si è convertita alla nuova fede liberista. Un’ideologia che ha tenuto a battesimo l’Unione Europea, con l’imposizione di pareggi di bilancio ai governi nazionali e di manganellate (e qualche proiettile) a chi fin dall’inizio urlava che un’unione dei mercati e non dei diritti sociali nasceva tarata.
Questa è la nostra storia, laddove il plurale non è maiestatis, ché qua di maestà non ce n’è alcuna, ma è proprio quella di Anthony Cartwright e di chi scrive, nati nello stesso anno, cresciuti durante la stessa sconfitta. Gente per cui scrivere è forse l’unico modo di esorcizzare l’essere orfani del futuro, come l’aver scelto d’essere padri, nonostante tutto, o forse proprio per questo, consapevoli di camminare nel tempo presente con l’imprinting sbagliato.
Nel suo romanzo più recente, appena pubblicato in Italia, Cartwright racconta il passaggio attuale del suo paese, quella Brexit di cui tutti parlano e nessuno sa granché. I suoi antieroi ne sanno meno di tutti, anche se la evocano come una vendetta.
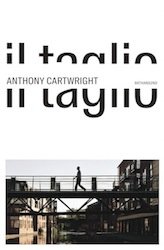 Il taglio (66thand2nd, €15) si legge come un dramma shakespeariano scritto sotto il cielo cupo delle Midlands Occidentali. Dudley, la cittadina nella pancia dell’Inghilterra, il Black Country, l’ex-distretto minerario e industriale oltre la grande conurbazione di Birmingham, è il luogo dove nascono e muoiono tutti i sogni, all’ombra del castello su cui sventola la bandiera crociata, per ricordare a tutti che il Galles è un po’ più in là e invece lì Britain Rules. Alle pendici della collina, lo zoo, costruito nel 1937, sotto il quale si dipanano cunicoli, gallerie abbandonate, un ossario di carcasse d’animali esotici. La storia si svolge sull’orlo di quel cimitero d’elefanti e di speranze, e strappa lacrime di commozione. Perché è una storia d’amore impossibile. Romeo e Giulietta ai tempi della Brexit.
Il taglio (66thand2nd, €15) si legge come un dramma shakespeariano scritto sotto il cielo cupo delle Midlands Occidentali. Dudley, la cittadina nella pancia dell’Inghilterra, il Black Country, l’ex-distretto minerario e industriale oltre la grande conurbazione di Birmingham, è il luogo dove nascono e muoiono tutti i sogni, all’ombra del castello su cui sventola la bandiera crociata, per ricordare a tutti che il Galles è un po’ più in là e invece lì Britain Rules. Alle pendici della collina, lo zoo, costruito nel 1937, sotto il quale si dipanano cunicoli, gallerie abbandonate, un ossario di carcasse d’animali esotici. La storia si svolge sull’orlo di quel cimitero d’elefanti e di speranze, e strappa lacrime di commozione. Perché è una storia d’amore impossibile. Romeo e Giulietta ai tempi della Brexit.
Lui ha un nome che sa di antichi fasti coloniali, l’hanno battezzato Cairo. Faceva il pugile incassatore, la spalla ideale per far brillare le giovani stelle. Cairo Jukes non andava mai al tappeto, si faceva gonfiare la faccia ma non cadeva, troppo duro, troppo coriaceo. E perfino bello, d’una bellezza che la boxe non è riuscita a rovinare. Passati i quaranta, Cairo pensa di tornare a combattere, per arrotondare, per restituire i soldi che gli ha prestato l’ex-moglie, per aiutare una figlia che è già ragazza madre. Dudley è la città in cui è nato e in cui sa che un giorno morirà, al centro di tutte le storie famigliari, generazioni di lavoratori, alberi genealogici anneriti dal carbone. Ora di quel passato non resta più niente, se non ricordi, rovine, macerie. È questo che fa Cairo, insieme a colleghi di ogni provenienza geografica: smaltisce rottami e ciarpame. L’ex-classe operaia è diventata la spazzina delle macerie dell’industrialismo. E per quanto a fottergli la vita (e la moglie) sia il padroncino di turno, ben piazzato un gradino più in alto di lui nella scala sociale, Cairo se la prende con chi è lontano e irraggiungibile, a Londra, a Bruxelles. Per stornare il senso di colpa e di fallimento. Per accusare l’altro che sta altrove della propria sconfitta, anche quando lo sfruttatore lo incontra tutte le mattine che si degna di farlo lavorare.
 Lei ha un nome che è già un programma di redenzione: Grace. E viene da Londra. È una giornalista free lance, documentarista, per la precisione. Il suo mondo non ha confini, è fatto di melting pot, metropoli, viaggi, intelligenza collettiva messa al lavoro dal capitalismo globalizzato. Il suo cameraman si chiama Franco. Grace ha vinto un premio per un documentario sui villaggi dei Balcani a vent’anni dalla guerra. Ha raccontato l’origine della catena di concause che porta la gente dell’Est Europa verso Occidente. Cairo vive il punto d’arrivo, il precipitato lavorativo e sociale di quella catena. Grace, direttamente dalla metropoli multiculturale, è a Dudley per documentare il referendum Leave/Remain dall’angolazione di una cittadina dell’Inghilterra profonda. Ecco come due stelle così distanti si incontrano, due mondi collidono, gli stessi che si sfidano nelle urne. Un “voi” e “noi” ripetuto, ma dai confini poco chiari, che da un lato incanala la frustrazione e l’odio per una vita grama verso un nemico di classe generico, ineffabile, fatto coincidere di volta in volta con i mass media, i politici, i ricchi, amici dell’Europa; dall’altro lato spiega il rancore sovranista con l’ignoranza e la paura, anziché con la sconfitta di classe. Sconfitta il cui segno è proprio questo: avere portato i ceti non tutelati a rimpiangere il passato in cui la Gran Bretagna dominava sola contro tutti (quanti film e serial su Churchill e i Windsor sono stati prodotti negli ultimi anni…), come se non dominasse anche e soprattutto sui lavoratori indigeni e su quelli delle colonie, spremendone il sudore e il sangue. Come se non fosse stato proprio l’imperialismo britannico (e occidentale) a precedere la globalizzazione capitalistica e a suggerire a un paio di tedeschi residenti in Inghilterra alcune considerazioni fondamentali sull’unione dei lavoratori come risposta all’unione dei capitali. Una considerazione questa che smaschera anche la cattiva coscienza dei “buoni”, coloro che contro il sovranismo vagheggiano un unionismo “spinelliano” e giammai l’internazionalismo di classe. Le parole di Cairo, in questo senso, suonano come un epitaffio e una profezia al tempo stesso:
Lei ha un nome che è già un programma di redenzione: Grace. E viene da Londra. È una giornalista free lance, documentarista, per la precisione. Il suo mondo non ha confini, è fatto di melting pot, metropoli, viaggi, intelligenza collettiva messa al lavoro dal capitalismo globalizzato. Il suo cameraman si chiama Franco. Grace ha vinto un premio per un documentario sui villaggi dei Balcani a vent’anni dalla guerra. Ha raccontato l’origine della catena di concause che porta la gente dell’Est Europa verso Occidente. Cairo vive il punto d’arrivo, il precipitato lavorativo e sociale di quella catena. Grace, direttamente dalla metropoli multiculturale, è a Dudley per documentare il referendum Leave/Remain dall’angolazione di una cittadina dell’Inghilterra profonda. Ecco come due stelle così distanti si incontrano, due mondi collidono, gli stessi che si sfidano nelle urne. Un “voi” e “noi” ripetuto, ma dai confini poco chiari, che da un lato incanala la frustrazione e l’odio per una vita grama verso un nemico di classe generico, ineffabile, fatto coincidere di volta in volta con i mass media, i politici, i ricchi, amici dell’Europa; dall’altro lato spiega il rancore sovranista con l’ignoranza e la paura, anziché con la sconfitta di classe. Sconfitta il cui segno è proprio questo: avere portato i ceti non tutelati a rimpiangere il passato in cui la Gran Bretagna dominava sola contro tutti (quanti film e serial su Churchill e i Windsor sono stati prodotti negli ultimi anni…), come se non dominasse anche e soprattutto sui lavoratori indigeni e su quelli delle colonie, spremendone il sudore e il sangue. Come se non fosse stato proprio l’imperialismo britannico (e occidentale) a precedere la globalizzazione capitalistica e a suggerire a un paio di tedeschi residenti in Inghilterra alcune considerazioni fondamentali sull’unione dei lavoratori come risposta all’unione dei capitali. Una considerazione questa che smaschera anche la cattiva coscienza dei “buoni”, coloro che contro il sovranismo vagheggiano un unionismo “spinelliano” e giammai l’internazionalismo di classe. Le parole di Cairo, in questo senso, suonano come un epitaffio e una profezia al tempo stesso:
«Parecchie cose non ci sono più, cancellate. Il passato industriale. In gran parte viene nascosto. Il punto è che la gente qui ha costruito quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi comportate – anzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsi in quello che abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. In un modo o nell’altro, vorreste che scomparissimo. Andrà a finire che sorgeranno i campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai, e non sarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, con le buone maniere che usate voi.»
 L’amore dell’autore per i suoi personaggi traspare nella capacità di renderli assolutamente credibili e di accettarli per come sono. Tipi umani in carne e ossa e inchiostro su una pagina, che Cartwright non pretende di giudicare, proprio perché non assomiglia agli snob londinesi stigmatizzati dai proletari di Dudley, lui che a Dudley ci è nato e cresciuto. La sua capacità poetica è quella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo a tesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali prima che politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse dei protagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in un pub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo credere che Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Lo vorremmo perché se lo meriterebbero, bloody hell… Vorremmo che sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra le bancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncan Edwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito e birra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigio cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così. Si consuma come un fiammifero nel tentativo di strappare ancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di una voragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. La nostra.
L’amore dell’autore per i suoi personaggi traspare nella capacità di renderli assolutamente credibili e di accettarli per come sono. Tipi umani in carne e ossa e inchiostro su una pagina, che Cartwright non pretende di giudicare, proprio perché non assomiglia agli snob londinesi stigmatizzati dai proletari di Dudley, lui che a Dudley ci è nato e cresciuto. La sua capacità poetica è quella di chi mette in scena una tragedia e non un romanzo a tesi, laddove le ragioni dei personaggi sono esistenziali prima che politiche, e l’amore è strangolato dalle vite stesse dei protagonisti, talmente vividi che vorremmo incontrarli in un pub per offrire loro un paio di pinte. Come vorremmo credere che Cairo e Grace possano farcela, che possano essere felici. Lo vorremmo perché se lo meriterebbero, bloody hell… Vorremmo che sul palcoscenico della piazza del mercato di Dudley, tra le bancarelle multietniche, sotto la statua del grande Duncan Edwards, con il piedistallo macchiato di schizzi di vomito e birra, il campanile gotico sullo sfondo, e quel cielo sempre grigio cenere, si coronasse la loro storia d’amore. E forse è proprio così. Si consuma come un fiammifero nel tentativo di strappare ancora vita al destino di un paese in bilico, sull’orlo di una voragine che si è prodotta nell’arco di una generazione. La nostra.
Quando volti l’ultima pagina sai già che nel giro di un attimo sentirai la mancanza di tutti loro. E vorresti stringere la mano all’autore per avere dimostrato ancora una volta che la letteratura può dire la verità attraverso la finzione. E forse, sottovoce, sussurrargli un paio di parole in una lingua antica. Grazie, compagno.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Atro libro che mi permetto di menzionare e’ Gb84 di David Peace .