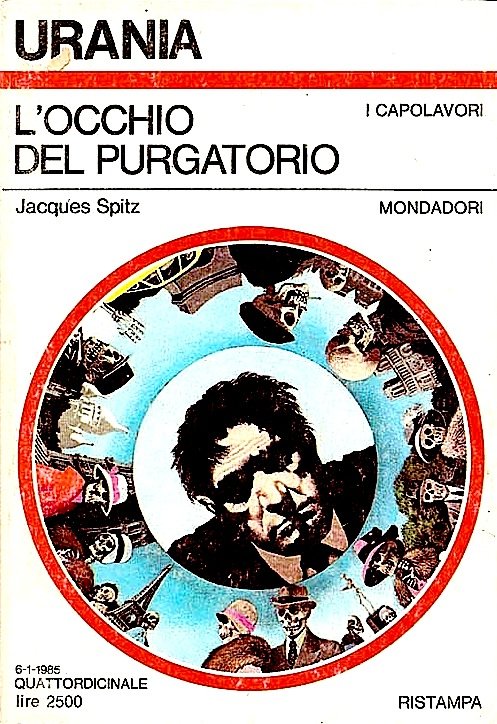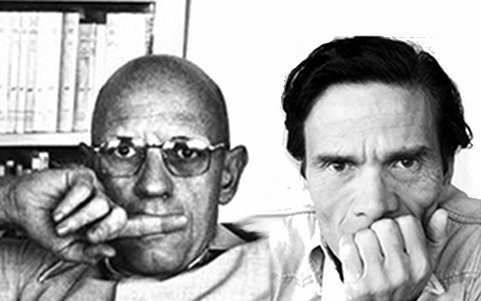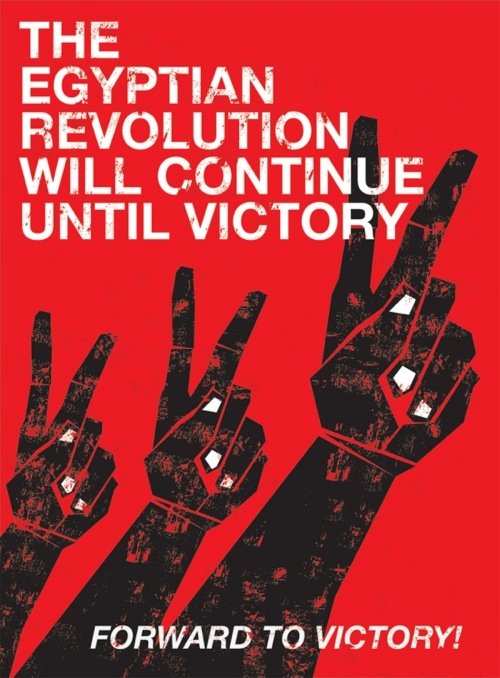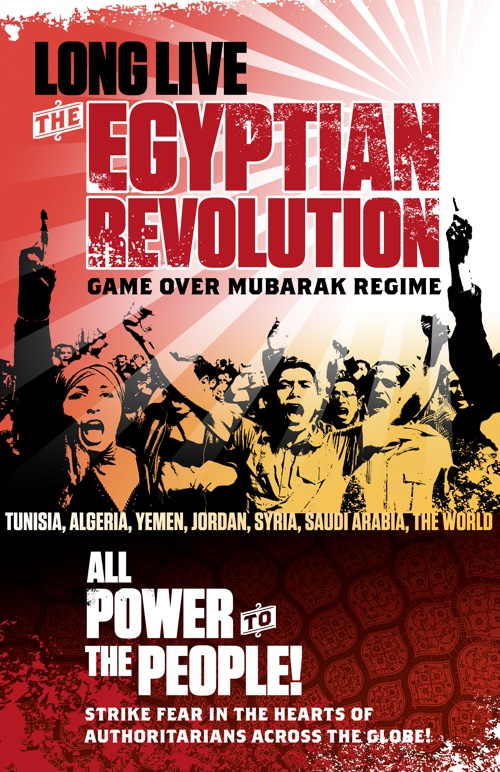–
L’arte di camminare è un’arte visiva: la si potrebbe chiamare passoscopia. Ecco perché, seguendo i preziosi consigli del libro Luca Gianotti, L’arte del camminare [Ediciclo], non si apprendono solo i trucchi e le liturgie del viandante, ma si acquista la capacità di guardare al mondo in maniera diversa. Buono a sapersi, direte: ma in cosa consiste tanta diversità?
Esistono molti modi di viaggiare alternativi rispetto all’andare a piedi: il treno, l’auto, la bici, l’aereo. Della motocicletta non posso dire nulla, non sono competente, ma grazie all’etimologia la immagino come un ibrido tra ciclo e motore, con alcune caratteristiche del mezzo a pedali e altre dell’automobile. I centauri mi scuseranno se non è proprio così. In compenso conosco bene il treno e condivido quel che ne ha scritto Michel de Certeau: il vagone ferroviario produce nostalgia. Salgo in stazione, cerco un posto, mi accomodo. Il convoglio parte e il paesaggio si mette a scorrere in due strisce separate, come le fette di pane di un tramezzino imbottito. In mezzo, al posto del tonno e della maionese, ci sta lo scompartimento: gli altri passeggeri, il corridoio, il controllore che punzona i biglietti. Io non mi muovo, sto seduto in poltrona come se fossi al cinema, solo che lo schermo è sdoppiato e laterale: un pezzo a destra e uno a sinistra. Oltre i finestrini, anche il mondo è immobile, se si esclude la rotazione terrestre. Sta fermo, eppure lo vedo fuggire, non posso afferrarlo. Ci sfioriamo, facciamo le presentazioni, ma non c’è tempo di conoscersi: resta l’amaro in bocca delle occasioni perdute. Ecco un filare d’uva che avrei voluto assaggiare o un torrente d’acqua limpida dove sarebbe bello tuffarsi. Ecco un cantiere stradale che devasta la campagna, mentre io passo e non ne so nulla; ecco un paese arroccato su un colle, del quale non conosco nemmeno il nome. Apro il giornale, lo sfoglio e per una mezz’ora mi perdo dietro alle notizie. Ogni tanto il treno rallenta, si ferma in stazione, ma non sono io a decidere le soste. Guardo i binari, leggo le insegne degli alberghi di là dalle rotaie e se mai scopro con gli occhi un angolo interessante, è già tempo di andarsene, di ripartire. Nostalgia dell’abbandono: mi si chiudono le palpebre, dormo, sogno di camminare sulla strada bianca intravista poco fa.
Viaggiare in auto è molto diverso. Paul Virilio ha chiamato dromoscopia le immagini che si proiettano sul parabrezza, in faccia al guidatore, anche se sarebbe più corretto dire che è il guidatore a proiettarsi contro le immagini, non viceversa. Se il treno taglia il paesaggio in due fette, l’auto lo buca, ci scava dentro, lo rivolta come un guanto. Apro lo sportello, mi metto al volante, giro la chiave per avviare il motore. Parto. Ora l’orizzonte mi viene incontro alla velocità che preferisco, anche se devo tenere conto del traffico e della segnaletica. Ho gli occhi sulla strada, attento alle curve, alle altre auto, agli ostacoli che mi si possono presentare. Più che vedere, sono costretto a prevedere: l’arte del pilota consiste nella capacità di anticipare gli eventi, via via che il mondo compare sul parabrezza, si apre davanti al cofano come una gelatina e subito si richiude dietro il lunotto posteriore. Se voglio evitare incidenti, devo attribuire un valore diverso a ogni cosa che vedo. Devo stabilire una gerarchia tra gli elementi del paesaggio, in base alla loro distanza da me e alla loro consistenza. Questi platani sul ciglio della strada, contro i quali potrei andare a sbattere da un momento all’altro, sono molto più importanti per me di quella fattoria laggiù, innocua, in mezzo a un campo di girasoli. Ai primi, devo prestare un’attenzione costante, alla seconda, posso dedicare soltanto uno sguardo di sbieco. Questi ciclisti che non si tolgono di mezzo mi mettono addosso più rabbia di quelle trenta palazzine in colori geometrili, piantate come giganti cattivi sul crinale alla mia sinistra. Guidando, devo tenere il mondo a distanza di sicurezza, evitare di andargli incontro attraverso il vetro che ho di fronte. La cintura che mi attraversa il petto proprio a questo serve: a non farmi sbattere contro la realtà, mandando in pezzi la simulazione.
La bici è un mezzo di trasporto molto meno virtuale degli altri due: quando salgo in sella e pedalo, il paesaggio mi circonda, ci sto in mezzo, non è una videosequenza muta spalmata sul cristallo di un finestrino. Cionostante, la mia visuale è limitata dalla postura e dalla fatica: se voglio evitarmi fastidiosi torcicolli, non posso far girare lo sguardo oltre i 270 gradi e se devo affrontare una dura salita, difficilmente avrò occhi per qualcos’altro che non sia nei dintorni della mia ruota anteriore. Allo stesso modo, nelle discese ripide devo star concentrato sulla strada, le buche, le curve. Il rischio di andare a sbattere e rompermi la testa mi costringe – come in auto – a dividere il mondo tra ostacoli e scenografia. In compenso, posso fermarmi quando voglio, senza bisogno di stazioni o parcheggi, e cedere al desiderio di guardarmi intorno con calma. Mi basta togliere i piedi dai pedali e scendere dal sellino, ma la posizione non è delle più comode e alla lunga influisce sulla mia voglia di fare soste. Così pedalo, pedalo a lungo, e quando mi fermo, preferisco lasciare la bici, e trasformarmi da ciclista in camminatore.
Di solito l’aereo non è davvero alternativo rispetto ai passi del viandante: il più delle volte si vola lungo distanze che non si farebbero a piedi e si cammina tra luoghi che non sarebbero collegati da un areoplano. Ma non è sempre così e allora la prima cosa che andrebbe notata è che i tragitti aerei si misurano in ore e minuti, non in chilometri. Chiunque sia andato in jet da Roma a Berlino sa quanto dura il volo tra le due città, ma solo i maniaci dei dettagli si ricordano la distanza percorsa. Questo per dire quanto poco interessa lo spazio a chi viaggia in aereo: scopo del passeggero è andare dal punto A fino al punto B e poco importa se in mezzo ci sono le Alpi o soltanto nubi. Poco importa, ma quando la terra si mostra è sempre uno spettacolo, come studiare una mappa vivente. Ci sforziamo di riconoscere i paesi, le anse di un fiume, il percorso di una strada, un casolare isolato. Se abbiamo la fortuna di sedere accanto al finestrino, lo trasformiamo subito in un buco della serratura, ritagliato nell’acciaio della fusoliera. Come vecchi guardoni, scrutiamo il mondo da fuori senza essere visti, lo dominiamo dall’alto come padreterni. Siamo puro sguardo, occhi che non si sporcano le mani, piccoli geografi senza cittadinanza.
A differenza di tutti questi viaggiatori, l’artista viandante non conosce schermi, nostalgie fittizie, gerarchie visive, torcicolli, soste scomode, voyeurismi. La sua visione del mondo è la più vicina che si possa immaginare alla verità pulsante, caotica e indifferenziata della vita. Quando vuole voltarsi, si volta: per lanciare un’occhiata all’altro lato delle cose. Quando vuole fermarsi, si ferma: non ha che da interrompere il ritmo dei passi. Se vede qualcuno e vuole parlargli, deve soltanto decidere di andargli incontro. Per evitare gli ostacoli, non ha bisogno di prevederli con grande anticipo: gli basta stare attento a dove mette i piedi, ma è raro che quest’operazione gli ingombri davvero la vista. Così, mentre le gambe lo portano da un luogo all’altro, senza soluzione di continuità, il paesaggio prende forma davanti ai suoi occhi, ed è un coacervo indistinto di sfondi e dettagli: un’ape su un fiore e le colline all’orizzonte, un minerale sul sentiero e un mulino a fondovalle, la storia di quel mulino e macchie di sole nel bosco, foglie di faggio, il segno biancorosso su un tronco e il fruscio di una biscia, i nomi sulla mappa, il rombo di un’automobile, un gregge di nuvole, il pensiero di una pecora, le strofe di una canzone ripetute come un’ipnosi, le scarpe slacciate e ancora le colline, in distanza, con il loro profilo appena cambiato rispetto a un minuto prima.
Camminando, mi sono convinto che il piacere ultimo del viandante sta proprio in questo: mai come quando andiamo a piedi il nostro modo di guardare si avvicina alla realtà in dissolubile del mondo. Uno sguardo oltre lo sguardo: senza filtri, senza obiettivi, senza inquadrature. Non a caso, credo che passeggiare sia il modo di spostarsi più interessante anche per chi non vede. Ma perché la magia si sprigioni, bisogna aver appreso i segreti dell’arte. Il glaucoma del turista – che vede soltanto ciò che ha già visto in foto o nelle parole di una guida – e la cataratta del pilota – che ci tormenta anche quando non siamo al volante – sono sempre in agguato per confonderci la vista. Andare a piedi non basta, e la lentezza non è solo questione di chilometri all’ora: benvenuto a questo libro, che può curarci lo sguardo.